…stavolta ho incominciato a creare immagini narrative evocandole sul momento. Questa piena libertà che mi sono preso mi obbligava paradossalmente a un’estrema concentrazione sul soggetto e sulla composizione del disegno. Tutto doveva essere contenuto, svolgersi in quell’unica tavola e possedere abbastanza forza da stimolare l’immaginazione di chi l’avrebbe guardata. Ho l’impressione che la mente, in questi casi, si metta all’ascolto di lontani echi narrativi, di storie, simboli e immagini, visti in altri periodi della mia vita. Scava nella memoria e va a pescare immagini rimaste impresse nella mia pinacoteca personale, creando strane associazioni, mescolando miti, personaggi, luoghi. È stato come se l’improvvisazione scartasse le idee di superficie, le inutili decorazioni, e puntasse direttamente all’essenza, potente, nascosta, sotterranea, della visione. Piano piano, si è concretizzato un universo fiabesco senza riferimenti precisi a storie esistenti, un racconto per immagini molto personale. Il pennello e il nero permettono questo linguaggio diretto, senza fronzoli, evocatore ma non descrittivo, misterioso, dove la luce e il buio vestono un ruolo da protagonisti. Sono disegni enigmatici anche per me, fanno parte di quell’esplorazione del “dentro” che ho intrapreso da un bel po’ di tempo ormai e che, in questo caso, si è indirizzata piuttosto verso i luoghi della fiaba, del mito, del fantastico. Ho l’impressione che le immagini si raccontino da sole, in maniera libera, indipendenti da qualsiasi frase con cui avrei potuto accompagnarle. Mi è parso che qualunque parola avessi aggiunto alla loro autonoma narrazione avrebbe solamente limitato l’evocazione affabulatoria che quelle immagini hanno in sé…
 Lorenzo Mattotti, Oltremai (1) Mi fa sorridere pensare che i tre mondi del fumetto, dell’illustrazione e della pittura rivendicheranno come propria quest’opera di Lorenzo Mattotti. Tutti e tre hanno infatti ragioni per farlo, visto che l’autore vive tutte e tre queste realtà. Però Oltremai non è facilmente descrivibile come fumetto, perché non c’è né una sequenza né una storia; non è facilmente descrivibile come illustrazione perché non illustra nulla, e non c’è nessun testo di riferimento; non è facilmente descrivibile come pittura perché supporto e strumento sono atipici, e soprattutto perché fatica a inserirsi nel discorso corrente delle arti visive. Ma “pittura” è comunque il termine più generico dei tre, e solo per questo motivo alla fin fine Oltremai sarà riconosciuta nel suo ambito.
È la terza volta che mi trovo davanti a questi lavori. La prima mi trovavo nello studio di Lorenzo, mentre ancora li stava realizzando. La seconda, era nello splendore del salone della Pinacoteca di Bologna, dove sono stati esposti tutti e 53, uno dopo l’altro in una lunga fila, sino a pochi giorni fa.
Adesso sono a casa mia, e ho davanti il libro, pubblicato da Logos di Modena, stampato e confezionato con estrema cura, che vale pienamente il suo (non indifferente) prezzo. Certo, non sono gli originali; però adesso di fronte a queste curatissime riproduzioni posso prendermi tutto il tempo che voglio, guardare, osservare, tornare indietro, confrontare, ripensarci, metterle via, ripensarci ancora, tirarle fuori, confrontare quel dettaglio con un certo dipinto che ricordavo, pensarci ancora, guardare ancora, rimandare a domani, e poi guardare ancora…
Questi disegni mi fanno un po’ paura. E non sono i mostri che vi appaiono, a spaventarmi. O almeno, non loro direttamente. Ogni tanto mi viene da pensare che questi mostri sono solo i fratelli cresciuti di quelli (selvaggi) di Maurice Sendak. Quindi non spaventano: inquietano.
Ma inquieta anche la bambina, e il bosco, e l’acqua, e il cielo, e persino il paesaggio lontano. Tutte queste cose inquietano, e questo sommarsi di inquietudini mette un po’ i brividi. Ma quello che fa paura davvero è il fatto di riconoscere in queste immagini un sacco di cose che già conosco, e queste cose, qui, non si trovano al loro posto, oppure non stanno nel rapporto corretto tra loro: insomma, sono loro e insieme non lo sono. È così anche per gli stessi mostri, la bambina, i boschi, le acque, i cieli e i paesaggi lontani; ma è così soprattutto per tutti quegli echi di forme che riconosco e che in parte sono come dovrebbero essere e in parte no.
Nelle parole che ho citato all’inizio del post (tratte dall’introduzione del volume), Mattotti spiega come ha lavorato su queste immagini. Sono tutte improvvisazioni, spesso realizzate in un’unica sessione di lavoro (sto aggiungendo qui anche qualche informazione avuta dalla sua stessa voce). Si parte da un segno qualsiasi del pennello sul cartoncino bianco (di grande formato, 100×70), e quel segno ne evoca altri, e questi a loro volta evocano figure, e l’immagine così progressivamente si compone.
Una delle cose che mi piace fare su queste immagini è seguire con l’occhio il gesto del pennello: il gesto che traccia grosse linee ondulate, il gesto che affianca sottili linee diritte, quello che lascia sequenze di macchie vagamente regolari… e poi la rottura improvvisa, quando a un tipo di gesto se ne sostituisce un altro, più netto, più violento, meno iterativo.
È come ascoltare un brano di musica. Ci sono dei temi che ritornano, dei leitmotif, cioè dei motivi portanti (il mostro, la bambina, l’oscurità, il bosco, l’acqua…), ci sono degli andamenti armonici che si susseguono (le varie tessiture, i vari andamenti del gesto…), e c’è questo loro stupefacente avvicendamento. Non c’è una storia?
In verità di storie ce ne sono tante quante sono le immagini, e hanno tutte qualche relazione tra loro; ma non c’è tra loro una continuità. Il che rende tutte queste storie molto vaghe, e non interessanti di per sé. Proprio come in un brano di musica: magari riconosci il momento di furore, o il momento di gioia, o quello di contemplazione estatica, ma non c’è modo di collegarli in un racconto. Eppure la musica funziona lo stesso.
Il fatto è che una storia è già, in sé, una spiegazione. Poter descrivere ciò che osserviamo come parti di una sequenza dotata di senso è qualcosa di confortante, che ci dà l’idea che il mondo sia, almeno in parte, spiegato; e quindi, almeno per quella parte, sotto controllo. In queste immagini, proprio come in musica, questo conforto non c’è. Queste immagini fanno paura perché non sono spiegate, non sono inseribili in un racconto. Sono come quei frammenti di sogno che non riesci a collegare alla sequenza principale, e non sei capace di dar loro un senso, una coerenza narrativa – e per questo motivo o li dimentichi subito (li rimuovi), oppure non li dimentichi mai più.
Un primo riferimento istintivo, per queste immagini di Oltremai, sono le Carceri d’invenzione di Giovanni Battista Piranesi. Certo, in Piranesi c’è molto più progetto di quanto non ci sia qui, non foss’altro per la differenza nella tecnica: l’incisione non permette di sicuro questa libertà d’improvvisazione. Tuttavia, l’oscurità, il senso di grandioso e di oppressivo, e la tessitura fitta delle linee, sono elementi comuni, che portano a un comune senso di inquietudine.
L’altro riferimento inevitabile è quello a Breton e all’automatismo surrealista. Ma in Mattotti è presente una consapevolezza che ai surrealisti era ancora sconosciuta: non si tratta di esplorare l’inconscio alla ricerca della sua forza distruttiva e rivoluzionaria. L’inconscio è forse anche distruttivo e rivoluzionario, ma è pure un sacco di altro cose, e contiene pure il proprio specifico ordine, quell’ordine che l’ordine consapevole non conosce.
L’ordine dell’inconscio è fatto di ritmi e di contrasti, di continuità e di rotture improvvise, di figure note che si rivelano improvvisamente collegate con altre figure note con cui il collegamento non ci dovrebbe essere. Non è l’inconscio di Lorenzo Mattotti quello che mi interessa, bensì piuttosto il fatto che attraverso la sua espressione il mio stesso inconscio si trova a lavorare. È questo che fa la differenza tra il lavoro di Mattotti che sfrutta il proprio inconscio e il lavoro di un Pinco Pallino qualsiasi che va dallo psicoanalista: non a caso Pinco Pallino deve pagare per trovare qualcuno che lo ascolti, mentre qui sono io, piuttosto, a pagare, per ascoltare Mattotti.
Ciò che rende interessante il lavoro di Mattotti non è quindi la scoperta del suo mondo personale interiore, che è probabilmente interessante, in sé, quanto quello di qualsiasi altro essere umano. È piuttosto la sua capacità di entrare in sintonia con qualcosa che, se fossimo junghiani, dovremmo chiamare inconscio collettivo, ma che io preferisco chiamare mito.
Il mito è ciò che non si comprende, non si racconta (quando lo si fa, si ottiene la mitologia, che è già un prodotto consapevole del mito), ma sta lì, sotto o dietro a tutti i nostri criteri di azione e valutazione del mondo. Spesso i racconti sono, appunto, mitologie, cioè parola del mito, ovvero mito spiegato, portato a coscienza. Anche i sogni, nella visione della psicoanalisi, portano a galla elementi del mito; e poi il racconto del sogno completa il quadro; e poi la spiegazione del racconto lo perfeziona ulteriormente, fornendoci l’illusione del controllo razionale.
Del mito però si possono rivelare solo brandelli. E nella misura in cui questi brandelli si rivelano è perché già non sono più centrali. Ci è comunque necessario tentare di rivelare quanto più possiamo, per poi poter raccontare, e poi spiegare, e infine illuderci di controllare. I disegni di Mattotti sono come sogni, però sogni collettivi, in cui possiamo tutti riconoscerci. Non sono i suoi sogni privati, bensì quella parte dei suoi sogni privati che coincide con i sogni privati di tutti. In loro il mito viene fuori con inquietante potenza, proprio perché non arrivano al racconto, ma danno la sensazione di essere sul punto di farlo, e ci sono, in loro, le figure e i ritmi e le armonie, ma con un ordine che non è quello del mondo esterno.
Ecco perché questi disegni mi fanno un po’ paura: perché ci cado dentro, mi ci perdo, mi tengono lì, fatico terribilmente a uscirne. Mi danno continuamente l’illusione di essere sul punto di tenerli, di capire, di raccontare, di spiegare, di controllare; e un attimo dopo l’illusione si disfa; e poi si ricrea, e poi si disfa di nuovo…
Nelle illustrazioni a colori di Mattotti, spesso quello che mi affascina sono le geometrie della costruzione, che forniscono al mondo rappresentato qualcosa come una seconda e differente dimensione di senso, e le figure di quel mondo finiscono così per essere al tempo stesso se stesse e anche qualcos’altro. Qui non ci sono geometrie, e di differenti dimensioni di senso ce ne sono ben più di due.
 Lorenzo Mattotti, Oltremai (8)
6 Marzo 2013 | Tags: Arte, arti, cinema, critica, estetica, fumetto, musica, poesia | Category: estetica, fumetto, musica, poesia |  Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente. Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.
Ma se ne producono tanti! o almeno, vengono prodotti tanti testi che aspirano a essere artistici, cioè a ricoprire questo ruolo mitologizzante, che trasforma la quotidianità in leggenda, fornendo un senso alla banalità del mondo. Ne vengono prodotti tanti, ma sono pochi quelli che riescono davvero ad assolvere il proprio ruolo.
La critica non serve principalmente a fornire delle chiavi di lettura dei testi artistici, anche se qualche volta per fortuna lo fa. Il suo scopo principale, mi sembra, è sacralizzare, mitologizzare i testi (gli autori) di cui sceglie di occuparsi. Insomma, se gli artisti, quelli veri, sono i sacerdoti del mondo, poiché producono opere che danno senso al mondo, i critici sono i sacerdoti degli artisti, poiché fanno sì che un artista (un creatore di miti) possa essere riconosciuto come tale.
Così, artisti e critici sono tutti creatori di miti, pur secondo ambiti diversi e con strumenti diversi. I critici rendono mitici gli artisti che sanno rendere mitico il mondo.
E chi rende mitici i critici? Be’, di nuovo i critici stessi, citandosi e riferendosi a.
(In questo senso, in forma più debole, anche il pubblico è formato di critici, almeno nella misura in cui si scambia opinioni su quello che ha letto/visto/ascoltato)
Si può fare a meno dei critici? Evidentemente no. Se non si rendono mitici i testi, questi non possono rendere mitico il mondo. Quando i testi sono già mitici, come quelli di Omero, è proprio perché generazioni di critici (lettori compresi, evidentemente) li hanno resi tali. Senza Omero (o chi per lui) saremmo tutti più poveri; ma lo saremmo anche senza coloro che lo hanno reso un mito.
L’universo del senso è, a quanto pare, un universo di valorizzazioni intrecciate, un castello di carte in cui la parte tiene su il tutto, e il tutto tiene su la parte. Quando crolla una carta, che cosa succede?
 Come post di oggi inserisco un breve (ma non brevissimo) saggio che avevo scritto alcuni mesi fa per una collana di microlibri progettati dalle edizioni CFR di Gianmario Lucini (Poiein). La collana non ha avuto successo, e il mio testo è rimasto inedito. Come post di oggi inserisco un breve (ma non brevissimo) saggio che avevo scritto alcuni mesi fa per una collana di microlibri progettati dalle edizioni CFR di Gianmario Lucini (Poiein). La collana non ha avuto successo, e il mio testo è rimasto inedito.
Il saggio sviluppa in maniera molto più ampia alcune riflessioni che avevo anticipato in un post di questo blog: “Di Goethe, dell’azione e della poesia”, apparso il 31 marzo 2011. Vi si parte da una riflessione filosofica ispirata ad alcuni versi del Faust per parlare del rapporto tra poesia e senso della collettività, lirica e poesia civile.
Mi piacerebbe che su questi temi si potesse dibattere. Il saggio è qui: La poesia e il collettivo.
 Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno. Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno.
Eppure esiste, e io lo so. Persino in questa stanza in cui sto scrivendo, che mi è estremamente familiare, vi sono innumerevoli aspetti e dettagli non percepiti, mai percepiti – non solo particolari che non c’è motivo di osservare, ma anche relazioni inosservate tra dettagli osservati e quindi noti. Insomma, io so di non sapere tutto della stanza in cui passo tante ore, e questo fatto non mi preoccupa minimamente: è normale che si viva in una realtà che sfugge in gran parte al senso, e non perché sia insensata, ma perché in gran parte non chiede di essere osservata – almeno sino a quando non arriva il suo momento.
Tutto sommato, è una sensazione confortante quella di vivere in un mondo che mi permette di vivere (e magari pure con una certa comodità) anche se non lo comprendo del tutto. Non lo comprendo ma lo vivo, cioè lo attraverso trovando senso, volta per volta, in qualche sua parte. Naturalmente qualcosa devo capire, del mondo che ho attorno, e più ne capisco e meglio è. Ma vivere in un ambiente è accettare la dose di rischio che deriva dal fatto che qualche sua parte è ancora priva di senso per me; e che qualche sua parte priva di senso ci sarà sempre, per quanto io lo esplori e analizzi.
Quando si ascolta un brano musicale, si legge una poesia, un racconto, una storia a fumetti, si guarda un film, un’immagine, e così via, ci si trova nella medesima situazione, con una differenza. L’ambiente in cui ci stiamo muovendo non è naturale, ma artificiale, cioè prodotto dall’uomo. Questo comporta che oltre al senso di base che hanno le cose in quanto percepite e interpretate, è presumibilmente presente anche un senso secondo, di carattere simbolico, attraverso cui passa la comunicazione umana. Anche qui, però, non tutto è percepito e non tutto, di conseguenza, arriva ad avere un senso: il testo viene vissuto, proprio come accade con un ambiente, e nel viverlo si sa di non sapere tutto, si sa che ci sono mille aspetti e dettagli che restano in attesa di arrivare a percezione.
Questi aspetti e dettagli possono però agire su di noi anche se non ci accorgiamo esplicitamente di loro, anche se non siamo arrivati a dare loro un senso. L’andamento delle cose attorno a noi ci coinvolge anche se non ce ne rendiamo conto. Seguiamo un ritmo, per esempio.
I testi artistici, o in generale estetici, vengono vissuti né più né meno degli ambienti del mondo. In questo senso non sono propriamente testi, nel senso in cui lo sono i testi informativi o persuasivi, cioè oggetti costruiti per trasmettere un discorso (che talvolta ha le forme del racconto). Poi, magari un testo artistico sarà anche informativo o persuasivo, perché comunque, sempre, il senso lo attraversa, in quanto prodotto da un autore umano. Tuttavia, ciò che lo rende tale è proprio la sua natura di ambiente, di luogo che va vissuto, attraversato, abitato.
Per questo, anche se il lavoro sul significato è importantissimo per l’opera d’arte, l’opera d’arte non si esaurisce nel suo significato, proprio come il mondo stesso non si esaurisce nel senso che gli attribuiamo, perché le scoperte possibili che potrebbero rivoluzionare il senso già assestato sono sempre infinite e potenzialmente imminenti. E se l’opera non si esaurisce nel suo significato, vuol dire che c’è, nel rapporto che intratteniamo con lei, una dimensione di vissuto che rimane cruciale, un sapere che c’è qualcosa che non si sa, e ciononostante la realtà non ci rifiuta, anzi ci accetta, e ci permette di vivere con lei e in lei.
L’opera d’arte è una realtà artificiale, fatta dall’uomo per l’uomo. Anche per questo, quando funziona, ci stiamo così bene dentro. Poesia e musica, e molto altro, sono discorsi fatti di mondo, e mondi costruiti di discorso. Una poesia non viene scritta per trasmettere un significato, ma per essere vissuta anche nel significato dei segni che la compongono. Ma siccome, in quel momento, la abitiamo, pure il suono, e l’aspetto visivo dei suoi segni sarà rilevante, proprio come nel mondo – a dispetto del fatto che non sappiamo che senso dare loro, o che non abbiamo la sensazione di accorgercene.
Il fraintendimento corrente sta nel fatto che, siccome è fatta di parole, la poesia debba essere interpretata come un normale atto di parola, cioè per comunicare un discorso. Ma chi l’ha detto che un normale atto di parola serve solo a questo? In poesia è evidente che c’è dell’altro. La musica, non possedendo parole, ha evitato questo fraintendimento, ma il problema del suo significato ha ossessionato (e continua a ossessionare) generazioni di studiosi. Io credo che, per il bene del significato, dovremmo accorgerci che non sempre il significato è cruciale. Anche la musica vive una relazione dialettica tra significato e ambiente, dove spesso, sino a qualche secolo fa, il ruolo di trasmettere il significato era di nuovo demandato alla parola (e musica e poesia vivevano a stretto contatto). Poi la musica ha imparato a costruirsi i propri discorsi da sé, ed è diventata un poco più simile alla poesia anche senza fare uso di parole. Nonostante questo, anche nella più concettuosa e intellettuale musica di oggi, è del tutto evidente che per poter cogliere un qualsiasi senso bisogna già esservisi immersi, bisogna già attraversarla e abitarla.
29 Ottobre 2012 | Tags: estetica, fumetto, ribaltamento | Category: estetica, fumetto |  Kazuo Koike e Goseki Kojima, Kozure Okami / Lone Wolf and Cub Per tutti coloro che litigano sul verso in cui vanno stampati i fumetti giapponesi è uscito un numero della rivista Aisthesis tutto dedicato al verso dell’immagine, a cura di Alice Barale e Andrea Pinotti. Insieme ad altri dotti (e interessanti) interventi, c’è anche il mio: “Annunciazioni, rotazioni e samurai mancini. Il verso di lettura delle immagini e la scrittura”. Fate conto quindi che il post di oggi si trovi lì.
Però, se davvero volete sapere tutto sulla questione del senso orizzontale delle immagini (e di conseguenza, del loro eventuale ribaltamento), del dibattito secolare sul tema nonché delle problematiche conclusioni, potete anche comperarvi il bel libro di Andrea Pinotti, Il rovescio dell’immagine (Mantova, Tre lune Edizioni, 2010). Vi si racconta tutto quello che è possibile raccontare sul tema, affrontato con intelligente e mai esausto spirito critico. Ne uscirete con più dubbi che certezze, ma è giusto che sia così, perché il tema è davvero intricato e delicato.
Inoltre, vi troverete in appendice alcuni tra i principali saggi che hanno alimentato il dibattito nel corso del secolo, di Anton Faistauer, di Heinrich Wölfflin, di Julius von Schlosser, di Boris Uspenskij. Leggete tutto, così alla prossima occasione abbiamo tutti più strumenti per azzuffarci.
Ah, giusto! Qual è la versione di Itto Ogami non ribaltata, qui sopra? E, una volta individuata, racconta davvero la stessa storia dell’altra?
10 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, estetica, poesia | Category: estetica, poesia | Un po’ me la prendo, in effetti, con l’avanguardia. Potrei fingere che non esiste, e parlare di altro. Invece mi accanisco, e ci torno sopra, e discuto con chi ne sostiene le ragioni (il che non implica, di per sé, che ne faccia parte – non so nemmeno se sia corretto dire che un’avanguardia esiste, in Italia oggi; quello che esiste è comunque l’idea di avanguardia, e l’atteggiamento avanguardista). Il semplice fatto di non condividerne le posizioni non basta a spiegare perché me la debba prendere così. Sarebbe molto più semplice ignorare il problema, e dichiararlo, così facendo, di fatto finito. Ma non è così; e soprattutto, evidentemente, non è così per me.
Il problema non è certo la sperimentazione in sé. Non si fa poesia, non si fa nessun prodotto culturale di valore senza ricerca e senza esperimenti. E un buon numero di esperimenti falliti è il prezzo naturale da pagare. D’altra parte, anche le avanguardie hanno i loro prodotti riusciti, che non ho problemi ad apprezzare. Apprezzo i prodotti, e apprezzo la sperimentazione; ma mi resta l’avanguardia come problema.
Sì, confesso che provo una qualche irritazione quando qualcuno si lamenta che in verità chi fa quel tipo di sperimentazione non è amato dai festival e dai premi letterari. C’è del vero nel fatto che il mercato culturale ha di solito difetti assai peggiori di quelli delle avanguardie. Però non si può negare che i fasti ormai passati della Neoavanguardia italiana abbiano lasciato comunque dei privilegi critici alle posizioni che le sono vicine; e questo fa sì che comunque gli spazi non manchino (nella generale scarsità) a chi fa parte dell’ambiente. Ma non è davvero questo il problema! Non ho nessuna posizione di scuola o di cordata da difendere. Mi irrita qualunque lamentela di questo genere, che provenga dall’avanguardia o dalla retroguardia. Sembra sempre di dover piangere una qualche miseria per colpa di qualcun altro; e gridare tu hai avuto abbastanza, lasciane un poco anche a me!
Il problema ha piuttosto a che fare con l’etica. Un’avanguardia è un gruppo che si muove attorno a un’idea, politica o artistica che sia. In campo politico le versioni estreme delle avanguardie sono i fondamentalismi (quello bolscevico fece la Rivoluzione d’Ottobre, in una Russia dove la Rivoluzione c’era già stata, e lo Zar era già stato deposto; quello islamico ha fatto l’Iran di oggi). In campo artistico magari i fondamentalismi ci sono lo stesso, ma siccome non sono particolarmente pericolosi, non ci importa di definirli come tali – e non mi interessa parlarne qui.
Le avanguardie che mi turbano sono quelle che vivono attorno a un’idea che io trovo, in linea di principio, condivisibile. Per esempio, che la poesia debba esprimere la banalità dei discorsi della società di massa, o che debba esprimere le tensioni o le emozioni politiche, o lo sdegno per l’ingiustizia sociale… sono tutte cose con cui non posso che trovarmi d’accordo. Il problema è semmai che, quando una di queste idee diventa l’unico o anche solo il principale motore di una produzione artistica, si scopre d’improvviso che non è del tutto compatibile con le altre; e soprattutto che non è del tutto compatibile con altre cose che continuiamo ad aver bisogno di esprimere, ma che non sono sostenute da un afflato ideale, perché sono più semplicemente legate alla normalità quotidiana, o magari al dubbio e alla diffidenza verso le idee che si pongono con troppe certezze.
Se io fossi un personaggio letterario, sarei Amleto, sempre in preda al dubbio. Credo che la mia posizione sia corretta, e porto avanti la mia piccola battaglia contro la critica prescrittiva e contro chi ritiene di sapere che cosa si debba fare in campo artistico (contro le ideologie; non contro le opere, che vanno sempre valutate indipendentemente dalle ideologie vicino a cui nascono). Ma siccome a dubitare si dubita anche di sé, mi vengono dei dubbi etici, e mi chiedo se non sto esagerando, se non sto perseguendo l’ideologia della non ideologia, e questo non mi condanni all’immobilismo.
Rimprovero alle avanguardie di avere messo l’etica davanti all’estetica anche là dove non lo si dovrebbe fare. L’etica è importante, anche più dell’estetica. Ma se non lasciamo qualche campo anche in noi stessi alle idee diverse dalle nostre, finiremo per essere dei fondamentalisti di qualche tipo, senza rendercene conto. L’estetica è il campo dove queste idee possono presentarsi e germinare. Questo campo deve essere libero dall’etica, perché è da questo campo che proviene la possibilità di cambiare idea, di trasformare le nostre ideologie. Tuttavia proprio per questo è un campo pericoloso, e a lasciargli troppo spazio nessuna idea, nessuna prospettiva etica può davvero avere forza.
Io percorro le strade dell’estetica cercando suggerimenti etici. Ma non ho mai la certezza che non sto esagerando. Non posso mai essere certo che avrei già dovuto fare una scelta, optando risolutamente per quella. L’atteggiamento avanguardistico è quello di chi questa scelta l’ha fatta. Per questo mi affascina, benché lo ritenga estremo e sbagliato. Per questo probabilmente lo devo esorcizzare scrivendone. Il fantasma di Adorno mi perseguita, come il fantasma di un padre giustamente assassinato; e continuo a ritrovare sulla mia strada tanto i suoi errori quanto le sue intuizioni corrette, grandi gli uni quanto le altre.
(su Adorno, e la sua concezione etica dell’arte, avevo scritto qualche anno fa su Tempo Fermo. Ora lo si può leggere qui)
Provo a riprendere le fila, o almeno qualche filo, del discorso aperto con Marco Giovenale nel post del 12 settembre. È un discorso complesso, complicato, dove i vari fili si intrecciano e ingarbugliano, e io stesso non sono sicuro di vederci chiaro. Cominciamo dalla fine, cioè dall’ultima parte del commento di Giovenale al mio post, dove dice:
Che un cambiamento, un mutamento di qualche genere, si sia dato, sia avvenuto, lo considero in ogni caso difficilmente contestabile; anche su questo mi sembra concordiamo.
Personalmente, l’impressione che ho, a prescindere dall’atteggiamento che la poesia e le poetiche assumono o dalle loro prassi, e a prescindere dallo studio che la critica letteraria fa di poesia e poetiche, è però che di quel mutamento si diano e si siano date inevitabili incarnazioni e evidenze nella vita quotidiana, nel dialogo banale, nei media, nel discorrere comune, nei videogiochi, nella scienza, nell’arte: in tutto tranne che nel 90% della poesia contemporanea.
Come se la gente vestisse in camicia o maglietta e pantaloni in tutte le stanze dell’edificio sociale, ma nella stanza dei poeti vigesse l’obbligo di indossare l’armatura e la cotta del crociato. La grammatica della complessità è cambiata nei nostri discorsi più banali e in quelli più articolati; ma in poesia la postura assertiva – erede di un’assertività religiosa? – non riesce a mettere in crisi se stessa.
Non vorrei che ci fosse qui un, come dire, abbaglio di prospettiva. La trasformazione sociale c’è stata, non c’è dubbio, e si rispecchia nei nostri discorsi, non c’è dubbio. Ma siamo davvero sicuri che i nostri discorsi non assomiglino al 90% a quelli dei nostri nonni, differenziandosi per un solo 10%? Non c’è dubbio che quel 10% sarebbe quello che sentiamo più rappresentativo, più identificante di noi stessi rispetto a chi ci ha preceduto – però resterebbe comunque un 10% (d’altra parte, per fare un’analogia, il 99,99% del DNA di tutti gli umani è identico, e la nostra cruciale differenza individuale si annida nel restante 0,01). Se così fosse, non ci sarebbe da stupirsi che il 90% della poesia contemporanea continui ad esprimersi come quella dei nostri nonni (o bisnonni): non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità. Quello che le chiediamo è di parlare a noi, e non si parla solo di quello che è nuovo o recente; e nemmeno si parla solo nelle modalità nuove o recenti. Quel 90% di zoccolo duro resta lì, a fianco del 10%. Che sopra abbiamo camicia e pantaloni, oppure l’armatura, sotto portiamo comunque le mutande, e la pelle, e i muscoli, e il desiderio sessuale e l’appetito e il bisogno di fare pipì. Non c’è da stupirsi che la poesia continui a parlarne.
In aggiunta, può ben darsi, come suggerisce Giovenale, che vi sia in poesia l’eredità di un’assertività religiosa, o comunque (non sono certo di capire bene del tutto l’uso che lui fa del termine assertivo/assertività) qualcosa di ereditato con forza. D’altra parte, la poesia (e proprio la poesia, non la prosa) viene sentita come qualcosa di particolarmente profondo, qualcosa che, anche se parla della banalità del quotidiano, in verità non si ferma mai alla banalità del quotidiano – quindi qualcosa che ha in comune con la religione un atteggiamento di fondo, io direi una sacralità (che è un concetto che non ha necessariamente a che fare con la divinità). Trovare questa sacralità nelle modalità di un presente frenetico ed estremamente secolarizzato è molto difficile; mentre esiste in maniera “naturale” nelle strutture che la poesia si è tramandata.
Questa risposta a due facce è comunque soddisfacente solo in parte. E infatti c’è inevitabilmente dell’altro, che viene già un po’ suggerito dalla seconda faccia. Può darsi che quello che Giovenale sente e che le sue parole esprimono sia proprio la necessità di una sacralità che possa essere trovata nelle forme del presente, quelle del suddetto 10%; poiché quelle del rimanente 90%, per quanto possano essere state a loro tempo autentiche, oggi non lo sono più (e Adorno sta occhieggiando dalla finestra).
Io temo però che ci troviamo di fronte a un altro abbaglio prospettico, che potrei descrivere come segue. La poesia riuscita, che ci piace, che definiremmo bella, è quella che mette in crisi il moi (con la sua assertività, suppongo) e che esprime dunque, in qualche modo, il presente. Questa è un’asserzione che sottoscriverei, a patto di non confonderla con il suo converso, che è questo: la poesia che mette in crisi il moi e che esprime dunque, in qualche modo, il presente, è quella riuscita, che ci piace, che definiremmo bella. Questa seconda, a differenza della prima, è un’asserzione prescrittiva, che ci dice che attraverso questi mezzi possiamo arrivare al fine della buona poesia; ma riduzione dell’io ed espressione del presente non sono mezzi, bensì fini. Comunque sia scritta una poesia, di qualunque cosa parli, siano anche coniglietti, se è una poesia interessante, complessa, ricca, bella, è una poesia che ci parla del presente e in cui l’io (il moi) del poeta non campeggia. Qualche volta potrà sembrare che lo faccia, ma sarà un effetto di superficie: pensiamo a – per fare un esempio di qualche anno fa – le poesie di Sandro Penna. Apparentemente centrate sull’io, sentimentali, banali come lessico e come sintassi; ma appena le si guarda più da vicino complessissime e strapiene di ragioni di interesse – in barba alla complicazione esibita delle poesie ermetiche loro coeve!
Questo mi rimanda all’altro punto cruciale su cui Giovenale insiste nel suo commento, cioè la questione dell’oscurità. Avevo affrontato una questione simile in un post di qualche mese fa (Del diritto della poesia a essere incomprensibile). In quel post distinguevo tra il diritto che la poesia ha all’oscurità (e dei suoi fondati motivi), e l’opportunità di non essere invece oscuri, e arrivavo a dire:
Entriamo più facilmente in un testo se abbiamo la sensazione di seguirne il discorso, e la poesia non fa eccezione. Per molti lettori, poi, specie se poco avvezzi alla poesia, se non c’è discorso non c’è nemmeno testo, e si abbandona presto la lettura di una siffatta assurdità. Se accettiamo che il discorso possa non essere coglibile, dobbiamo essere molto più disponibili alla sua ricerca, e persino al fallimento di questa ricerca.
Ma Giovenale sostiene che non sono oscuri testi (come quelli di Broggi o Zaffarano) che a me (e suppongo non solo a me) appaiono tali. Ha ragione solo in un senso banale. Se provo a leggere un testo come L’invenzione della scrittura, di Michele Zaffarano, tutto quello che leggo è immediatamente comprensibile, si parla di cose ed eventi storici. Quello che è oscuro è come si debba interpretare, in quanto poesia, un testo di questo tipo. Credo che la maggior parte dei lettori arriverebbero, al più, a considerarlo una sorta di provocazione neo-dadaista; però molto datata, se considerata così. Voglio sperare che ci sia un’altra interpretazione chiave, che mi permetta una lettura a più strati, ricca e complessa; tuttavia, sinché io non la trovo, questo mi appare come un testo vuoto, non interessante. Poiché è sufficientemente evidente che si tratta di un’operazione colta, non banale, le concederò il beneficio del dubbio, e riconoscerò che si tratta comunque di un tentativo. Ma nella misura in cui non colgo l’interesse del testo, esso non mi parla, non mi rappresenta; e non riduce affatto il moi dell’autore: semplicemente lo afferma in un altro modo, più indiretto e astuto, ma non meno forte. (Poi, certo, sarebbe compito della critica fornirmi spunti per cogliere l’interesse del testo. Ma se la critica non lo fa, con chi me la prendo? con l’incapacità dei critici o con l’oscurità dell’autore? Posso sempre sperare, certo, che sia uscito qualche intervento critico di cui non ho avuto notizia. Però, sinché non ne ho notizia, siamo da capo.)
Il primo pregio delle poesie di Amelia Rosselli è quello di essere (almeno per me) fortemente coinvolgenti. Esprimerebbero una riduzione dell’io anche se non la tematizzassero; in più la tematizzano, spesso.
Per quanto riguarda Le petit bidon di Tarkos, ho la sensazione che il fascino di questo testo orale stia in gran parte nella capacità espressiva orale di Tarkos stesso. Non ne ho trovato on line la versione scritta, il che mi fa pensare che sia un testo fatto per l’oralità e basta. E questo va benissimo. Ma se ne esistesse una versione scritta, dubito che sarebbe capace di trasmettermi un fascino comparabile a quello che la sua voce costruisce. Magari il testo di Zaffarano è oral poetry, un semplice canovaccio per l’esecuzione, ma allora il testo (come nel caso di Tarkos) dovrebbe essere l’esecuzione e non la partitura da leggere con gli occhi. Se però accettiamo questo, accettiamo anche che entrino in gioco elementi espressivi, del suono e della voce, molto diversi e già autonomamente significativi. Esagerando un po’, Tarkos avrebbe potuto ottenere lo stesso effetto affascinante anche con un testo verbale molto diverso, fatti salvi gli andamenti dell’esecuzione orale. Ma senza arrivare a questo, io credo che sia per l’effetto dell’andamento della voce che il piccolo bidone e gli spostamenti dell’aria al suo interno finiscono per diventare così interessanti, e fascinosa metafora di chissà cosa…
Dove voglio arrivare non lo so. Quello che mi è ben chiaro è che la poesia è una cosa e le poetiche ne sono un’altra, che sta già sul versante della critica. Per questo la poesia possiede un diritto ad essere oscura che la critica invece non ha. Certo l’oscurità di un testo poetico aumenta la sua probabilità di non poter essere inteso, e senza un’intesa (il gioco di parole è voluto) tra il testo e il lettore non parte il meccanismo che ci permette di entrare nel gioco, di essere coinvolti, di trovare interessante la casa, l’ambiente che ci circonda. Oltre un certo limite di oscurità l’intesa non viene trovata più da nessuno, e il testo poetico è come una casa (magari meravigliosa) di cui nessuno possiede la chiave. Un oggetto inutile, insomma.
(continua – molto molto a lungo, probabilmente)
24 Settembre 2012 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, poetry comics, semiotica, Winsor McCay | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, semiotica |  Winsor McCay, Little Nemo, tavola del 22.10.1905 Venerdì scorso, a Pordenonelegge, ho discusso con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo di “La poesia a fumetti”. Ecco, più o meno, (almeno in parte) quello che sono andato a dire.
Credo che per discutere su questo tema si debba fare chiarezza su alcuni aspetti, relativi da un lato alla letteratura verbale e dall’altro alla letteratura a fumetti. Una prima osservazione, preliminare (ma su cui tornerò alla fine), riguarda il fatto che siamo abituati a considerare il campo della poesia come un sottocampo della letteratura verbale; un sottocampo che si contrappone a quello della prosa, di modo che assumiamo di solito che il campo della letteratura verbale sia diviso in poesia e prosa. La letteratura verbale può essere divisa anche in altri modi, e alcuni tra questi hanno un corrispondente anche per i fumetti (per esempio le divisioni per generi, o per formati di pubblicazione); ma nel fumetto non esiste una distinzione analoga a quella tra poesia e prosa. Forse per questo parlare di poesia a fumetti può suonare strano.
Ma cosa distingue la poesia dalla prosa? Una risposta facile, che va nella direzione giusta pur essendo imprecisa, è che la poesia è caratterizzata dalla presenza del verso. La risposta è imprecisa perché esiste anche la cosiddetta poesia in prosa, che resta poesia facendo a meno del verso, e la poesia concreta, che è una forma puramente visiva di poesia… Tuttavia la risposta va nella direzione giusta perché l’insistenza sul verso mette in luce una caratteristica che la poesia ha sempre, che molto spesso si esprime attraverso il verso e il suo uso, ma che si esprime anche in altri modi, persino quando il verso non c’è.
Quello che distingue la poesia dalla prosa è insomma una differente attenzione verso il cosiddetto aspetto formale, cioè verso il modo in cui il testo (orale, scritto, visivo che sia) si presenta, indipendentemente dal significato delle parole che usa, o anche solo indipendentemente dal discorso o dal racconto che le parole sembrano trasmettere. Nella prosa, in altre parole, la parola è trasparente, nel senso in cui gli informatici usano questo termine: nel leggere prosa, cioè, ci focalizziamo sul significato delle parole, su ciò a cui rimandano, sul discorso che esse costruiscono, e non percepiamo se non funzionalmente la forma stessa della parola (la sua forma visiva o sonora). Questo è così vero che, nel riportare la prosa, tolleriamo più facilmente le parafrasi o le sostituzioni con sinonimi. Certo, non è vero del tutto; e la parola non è mai del tutto trasparente: però possiamo considerare la prosa come quell’ambito letterario in cui la parola tendenzialmente lo è.
In poesia, la parola è al contrario molto opaca. Continua certo a rimandare al suo significato, ma chiede al lettore di essere percepita anche di per sé, e per le relazioni visive e/o sonore che ha con le parole circostanti. Ho usato anch’io, prima, la parola formalismo, ma è una parola fuorviante, a cui bisogna fare molta attenzione: non c’è qui in gioco, infatti, una forma che si vorrebbe contrapporre a una sostanza; ci sono piuttosto due forme semiotiche (o se preferite due sostanze) dal funzionamento differente. Da un lato c’è la forma linguistica, in cui dei simboli (le parole) rimandano convenzionalmente a dei significati secondo delle regole di correlazione altrettanto convenzionali (salvo che l’uso e il contesto agiscono comunque pesantemente anche qui); dall’altro c’è quella che potremmo chiamare la significazione naturale, quella stessa per cui le cose del mondo e la loro organizzazione non sono mute per noi, perché l’esperienza ce le ha riempite di significato.
Quando io entro in una città che non conosco, per esempio, sono comunque in grado di dar senso a moltissime cose: riconosco case e strade, distinguo gli edifici pubblici da quelli privati, gli spazi per i pedoni da quelli per le auto, gli edifici storici da quelli nuovi, e così via. La città è uno spazio fin dall’inizio pieno di senso, e questo senso aumenta a mano a mano che la conosco meglio.
La forma sonora e/o visiva di una poesia è come lo spazio di una città: è concreto ed esiste; non è stato costruito principalmente per comunicare qualcosa (anche se è fitto di segnali impliciti, oltre a quelli espliciti) ma per essere utilizzato, e quindi a questo scopo deve essere comprensibile, rimandando allo spazio di tante altre città preesistenti. La forma di una poesia è un luogo da vivere, che ha una vita significativa autonoma dai contenuti del discorso che la poesia trasmette. La poesia, rispetto alla prosa, è una forma di letteratura che mette molto più in evidenza questi aspetti di carattere ambientale, indipendenti dal discorso o racconto che le sue stesse parole trasmettono.
Osserviamo adesso la tavola di Little Nemo riportata qui sopra. Non posso dire che questa attenzione alla forma della gabbia grafica si manifesti qui storicamente per la prima volta (o meglio per la seconda, la prima essendo stata la settimana precedente – visto che questa è la seconda tavola della serie), perché per dirlo con certezza dovrei conoscere tutto quello che è stato pubblicato nei dieci anni precedenti di vita del fumetto. Ma questa è certamente la prima volta importante, la prima volta che ha lasciato il segno nella storia del fumetto.
Quello che è interessante, in questa tavola, è che la costruzione grafica non si risolve in una tecnica per raccontare meglio la storiella del sogno di Nemo (che le immagini permettono di ricostruire con una certa facilità, non meno di quanto facciano le parole della prosa verbale). Certo questo comunque lo fa: la divisione della prima striscia in tre zone fa percepire con più forza lo scorrere del tempo tra l’ordine del re e la risposta del maggiordomo; la ripetizione dell’inquadratura nella seconda striscia enfatizza la discesa del letto e prepara la discesa per le scale delle vignette successive; nel seguito della pagina, l’abbassarsi della base delle vignette corrisponde alla discesa di Nemo nella foresta dei funghi, mentre il conseguente successivo abbassarsi del tetto delle immagini contribuisce all’effetto di schiacciamento. La costruzione grafica aiuta davvero – e come! – l’efficacia del racconto.
Tuttavia c’è dell’altro: la struttura verticale in basso e orizzontale in alto ricorda delle forme architettoniche (colonne e architrave) continuamente riecheggiate anche nelle immagini; la scala delle vignette rimanda – invertita – alla scala del palazzo del re; la struttura con orizzontali e verticali rimanda a quella delle prime pagine dei quotidiani (testata e colonne di testo). Ci sono una grande quantità di echi visivi che esistono indipendentemente dalla storia che viene raccontata, e che mi fanno immediatamente rendere conto che Little Nemo è diverso da qualsiasi fumetto che si sia realizzato prima. Prima di allora (e naturalmente anche nella maggior parte dei fumetti successivi) l’organizzazione visiva, planare, è in larghissima misura funzionale a esprimere meglio il racconto, proprio come le parole nella prosa. In Little Nemo, viceversa, e in un certo insieme di opere a fumetti successive, l’organizzazione visiva gioca contemporaneamente su due campi, dei quali l’uno autonomo (“formale”) e l’altro funzionale alla storia: in questo senso, Little Nemo potrebbe essere definito “poesia”, in quanto contrapposto – per esempio – a Tintin, come esempio di ottima prosa.
Nella letteratura verbale, l’opposizione poesia/prosa è antichissima, ha radici storiche profonde e una tradizione molto forte. Ma in quella a fumetti non ci sono state vere ragioni per creare un’opposizione analoga, e il campo è rimasto fluido. Che cosa vuol dire allora, fare poesia a fumetti? Forse non basta prendere un testo poetico e aggiungergli delle immagini. Forse non serve avere un testo poetico per aggiungergli delle immagini. Magari bisogna lavorare più da dentro, pensare a un ambiente visivo che abbia senso come tale; e che come tale sia già interessante, ancora prima di quello che andrà poi a comunicare. Pensare a una sorta di metrica visiva, ovvero un sistema di rimandi, una struttura plastica, che mentre è anche funzionale al racconto, possiede un senso autonomo, più relazionale che referenziale.
(prosegue, spero)
Caro Marco Giovenale
voglio rispondere qui a una serie di questioni da te aperte nel tuo post del 25 agosto “scritture di ricerca: dopo il paradigma” (anche riproposto in versione più breve il 10 settembre su punto critico). Rispondo da qui perché i commenti da te sono chiusi, perché avrei comunque troppe cose da dire per rinchiuderle nello spazio di un commento, e perché – su sponde per certi versi opposte – mi ritrovo a guardarmi attorno su percorsi che mi paiono simili a quelli che lasci trasparire dal tuo intervento, cogliendo l’occasione per un chiarimento anche a me stesso su alcuni concetti.
In primo luogo, una precisazione doverosa su polemiche passate, rispetto al cambio di paradigma (per esempio, qui da me, e su Nazione Indiana). Se lo posizioni nei primi anni Sessanta, cioè agli inizi della Neoavanguardia italiana, non ho nulla da obiettare. D’altra parte, quello è il periodo in cui i cambi di paradigma di sprecano, nella cultura occidentale: solo per citarne alcuni a me cari, la musica colta ha attraversato Darmstadt da pochissimi anni, e quella di ascolto più diffuso sta incontrando la nascita del Rock e dei Beatles (una via senza ritorno); gli studenti si stanno politicizzando e di lì a poco ci sarà Berkeley e il maggio parigino; il fumetto inizia timidamente (specie in Francia e in Italia) a rivolgersi a un pubblico colto.
Tutti questi cambiamenti rispecchiano evidentemente l’assunzione diffusa di una trasformazione sociale, e potrebbe essere benissimo – come dici tu – “la sovrapposizione di due onde sonore contrapposte nella storia – distruzione e ricostruzione (guerra e “boom”)”; ma evidentemente anche – e credo che me lo concederai facilmente – le peculiari caratteristiche di questa ricostruzione, con l’apertura radicale (e quasi improvvisa) di una società mediatizzata e di massa.
In secondo luogo, ti ringrazio perché mi hai fornito l’occasione per rileggere il saggio di Eco che citi (“Del modo di formare come impegno sulla realtà”, uscito su Il Menabò nel 1962, poi in Opera aperta), che avevo letto troppi anni fa, e troppo presto; e perché mi hai costretto, per risponderti, ad andarmi a cercare il saggio di Lacan (Dei nomi del padre, che contiene anche il saggio del 1953 “Simbolico immaginario e reale”) che non conoscevo nello specifico, anche se giro da tempo attorno a quegli stessi temi lacaniani attraverso altri scritti.
Ed ora veniamo al punto, anzi ai punti – sempre considerando che le tue non sono tesi scolpite nel marmo (mi pare di capire), bensì proposte; e come tali le discuto, pregando chi mi legge di considerare allo stesso modo quello che scrivo qui.
Ecco, quindi, la premessa lacaniana del tuo intervento, che trovo, devo dire, un po’ pretestuosa. Capisco bene la posizione di Lacan, pur espressa con la sua solita indelicatezza, che lamenta il fatto che il paziente voglia, in qualche modo, sostituirsi all’analista, cercando di analizzare da sé le proprie esperienze. Tuttavia non capisco affatto come si possa in qualsiasi modo avvicinare la relazione (psico)analitica alla relazione autore-lettore, se non magari sul solo piano del narcisismo (dell’autore che vuole sostituirsi al lettore, così come del paziente che vuole sostituirsi all’analista). Tuttavia, la medesima accusa di narcisismo potrebbe essere rivolta anche all’autore che si esprima con strutture linguistiche e/o concettuali del tutto proprie, e pretenda (narcisisticamente) che il suo pubblico (che non è un terapeuta raffinato, non è pagato per farlo, e non è Lacan, con il suo acume e la sua cultura) lo segua, lo intenda, o perlomeno si sforzi di farlo. Narcisismo per narcisismo, non so quale sia peggio, visto che ambedue questi autori (il tuo e il mio narciso) ignorano evidentemente alcuni fatti di linguaggio piuttosto basilari.
Poi, in quello che segue nel tuo intervento mi ritrovo abbastanza, a parte alcuni accostamenti che mi paiono davvero forzosi, come quello tra il suicidio di Vittorio Reta nel 1977 e l’uscita della Parola innamorata nel ’78, o (idem) quello tra il suicidio della Rosselli e l’uscita nel ’96 dell’antologia dei “cannibali”. Ma le prendo come provocazioni evocative, e magari un po’ nostalgiche.
Piuttosto, è proprio là dove parli di Amelia Rosselli che la mia attenzione si è improvvisamente risvegliata, per esempio là dove dici “Rosselli era soggetto (oscuro) di scrittura (oscura), brutalmente sintetizzando: un je (quasi) senza moi.” Questo mi piace molto, mi ci ritrovo, lo pensavo anch’io, ma indubbiamente l’uso dell’antinomia lacaniana rende molto più chiara la cosa.
Credo che valga la pena di andare maggiormente in profondità, non tanto su Rosselli (già lo faccio parecchio in un saggio sulla metrica della poesia italiana recente, in uscita tra poco su L’Ulisse) quanto in generale sulla questione della lirica e dell’io. L’ipotesi (ed è davvero un’ipotesi, perché sto scrivendo senza avere troppo chiaro a che conclusioni arriverò) è che la distinzione lacaniana tra je (il “soggetto inconscio”, soggetto del desiderio e delle pulsioni) e moi (la sovrastruttura costruita socialmente in cui riconosciamo noi stessi, inevitabile ma inevitabilmente fittizia – una finzione di cui non si può fare a meno per esistere, insomma) possa gettar luce su cosa si intende con espressioni quali “riduzione dell’io”, “dopo la lirica” ecc.
Mi sembra abbastanza evidente che l‘io di cui si parla nei dibattiti attuali sulla poesia dovrebbe essere il moi, non certo il je, cioè la sovrastruttura apparentemente coerente con cui ci rivolgiamo al mondo: siccome questa sovrastruttura è costruita a partire da questo stesso mondo che ci circonda, un certo accordo tra moi e mondo circostante sarebbe dunque garantito. Una delle tesi del nuovo paradigma (dagli anni Sessanta a oggi) dovrebbe essere dunque che va smascherata la natura fittizia del moi, in quanto sodale a una natura fittizia e costruita del mondo circostante. Poiché (lacanamente, ma non solo) il linguaggio (nietzschianamente, ma non solo) è il principale garante di questa apparenza di coerenza, il linguaggio va decostruito, e tanto peggio se questo produce delle difficoltà di comunicazione: la facilità di comunicazione non è che un’altra delle illusioni che tengono insieme il moi e il mondo circostante! Si tratta (riferimenti lacaniani a parte) grosso modo di una delle tesi esposte da Eco nel 1962 nel saggio da te ricordato, e che ho citato sopra.
Le cose, però, come sempre, non sono così semplici. Intanto il moi c’è, e non se ne può fare a meno, anche se è un’illusione. L’idea che se ne possa sollevare la coperta per vedere la realtà che si trova sotto è a sua volta una illusione; per bene che vada vi si troverà infatti un altro moi, magari più complesso e (forse) meno narcisistico, auspicabilmente meno tormentato (se si tratta del moi di un paziente che si rivolge a un terapeuta). Si tratta del paradosso dello “schema concettuale alternativo” portato in luce da Donald Davidson e sottolineato da Richard Rorty (in Conseguenze del pragmatismo, mi pare): lo “schema concettuale alternativo” è solo una possibilità virtuale, visto che non possiamo concepirlo che nei termini del nostro proprio sistema concettuale. Però, certo, il nostro sistema concettuale può cambiare: ma allora siamo noi stessi che cambiamo, e il nuovo sistema concettuale non è più alternativo; è semplicemente, adesso, il nostro, e ci siamo dentro, e magari leggiamo nei suoi termini quello dentro cui vivevamo prima – ma non possiamo tornare indietro, o, peggio, saltare un po’ di qua e un po’ di là per comparare i due punti di vista.
Però, si dirà, la poesia non è filosofia, e non deve spiegare, ma solo esprimere, o meglio, direi io, far vivere al suo lettore una certa condizione. Allora vogliamo dire che se la poesia non fa vivere al suo lettore una certa condizione di problematicità del moi, si tratta di poesia inautentica, falsa? Mi sembra una conclusione eccessiva, che presume che la poesia debba avere sempre a che fare con i massimi sistemi (di questo ho parlato ampiamente in un post della scorsa settimana), e che sia comunque vincolata a dire sempre il vero al livello più profondo possibile, assumendo che il livello più profondo possibile sia quello del rapporto tra je e moi. Potrei aggiungere che quando mi trovo di fronte a una poesia riuscita, fosse anche il prototipo petrarchesco della lirica, un certo superamento del moi è comunque presente, se solo si va oltre, nell’interpretazione, al significato letterale delle parole; perché è la forma stessa della composizione a richiamare qualcosa che non riguarda strettamente l’io. Poi, certo, il tipo di strutture di riferimento che un sonetto di Petrarca richiama è abbastanza diverso da quello delle nostre – anche se non del tutto. Una certa parte di verità gli rimane anche per noi; altrimenti non avremmo alcun modo di apprezzarlo.
Ma restiamo sul punto, e assumiamo che, se pure la tematizzazione della finzionalità del moi non sia indispensabile, certo per la poesia del nuovo paradigma essa è importante, e va tenuta in posizione centrale. Anche a queste condizioni, resta comunque la questione del quasi, nel senso in cui la poesia di Rosselli è un je (quasi) senza moi. Dal quasi, evidentemente, non si scappa, per le ragioni dette sopra. Di conseguenza, qualsiasi destrutturazione è, implicitamente, una nuova strutturazione.
Io credo (sottolineo io; non so cosa ne pensasse Lacan in proposito) che nella cultura occidentale il moi individuale si sia molto rafforzato negli ultimi due secoli, contestualmente al trionfo della ragione positiva (e poco importa che Kant avesse già dimostrato nella sua prima Critica l’insostenibilità razionale dell’idea di Io – insieme a quelle di Mondo e di Dio), e all’indebolimento delle strutture sociali tradizionali, molto più collettive e comunitarie di quelle moderne. La messa in crisi del moi in poesia diventerebbe perciò un tema caldo solo nella modernità, nel momento in cui questa sovrastruttura diventa sovrabbondante – e al tempo stesso vanno in crisi tutte le Weltanschauung globalizzanti, a partire dalla ragione logica stessa (Gödel docet).
Ma credo anche che la prima conseguenza storica (nel nostro campo) di questo predominio del moi sia stato il predominio della lirica in poesia, a danno degli altri generi tradizionali. Sino al punto che qualsiasi epica pensabile oggi è comunque epica di individui, un’epica lirica, come ne “La ragazza Carla”. Paradossalmente, persino la centralità del tema della riduzione dell’io in poesia è espressione della centralità dell’io, del moi. Lo potremmo pensare come un tentativo, consapevole della propria impossibilità, di guardare sotto la superficie del moi, da apprezzare come tentativo eroico, e non per quello che (non) troverà. Una sorta di convivenza della letteratura con la modalità del labirinto, facendosi magari labirinto a sua volta (tanto per chiudere il cerchio con l’altro critico che tu stesso citi, cioè Calvino).
Comunque sia, Amelia Rosselli riesce in qualche modo a costruire l’impressione di una destrutturazione del moi. L’impressione conta: magari, lavorandoci sopra, troverò la coerenza nascosta nel suo sistema. Ma intanto l’impressione di scarsa strutturazione del moi c’è già stata, e ha già agito su di me, il suo lettore.
Amelia Rosselli, tuttavia, non scrive in maniera incomprensibile. Elimina o trasforma dei nessi, ma ne conserva altri. Scrive, insomma, in maniera da risvegliare continuamente la mia curiosità, e mi spinge ad andare avanti, e ad accorgermi, in qualche modo vivendola, della sua difformità.
Molti testi di scrittura di ricerca non sono capaci di fare questo: mi si pongono davanti, semmai, come rebus, e si aspettano che sia io a essere interessato a loro, senza fare nulla per venire verso di me. Sappiamo bene come quello dell’interpretazione sia un campo strano: la Qabbala stessa ci insegna come da qualsiasi sequenza di lettere e/o numeri si possano ricavare un’eternità di significati differenti. Se quello che mi piace è avere un testo che non mi sveli dove sta andando, affinché sia io (lettore) a trovarlo, basta seguire l’indicazione data a suo tempo da Tristan Tzara, costruendo una poesia con le parole estratte a caso da un sacchetto. Ne ricaveremo certamente un testo che sembra esprimere un je (quasi) senza un moi.
Quello che io trovo interessante nella poesia di Rosselli, viceversa, non è che sia stata capace di destrutturare (in parte, in apparenza…) il moi, ma che sia stata capace di farlo continuando ugualmente a richiamare il mio interesse di lettore. Per farlo, evidentemente, Rosselli deve giocare su delle strutture semiotiche (cioè linguistiche, ma non solo) condivise, e deve darmi continuamente la sensazione di stare comunicando qualcosa di rilevante. Insomma, deve presentarsi inevitabilmente come un moi che comunica a un altro moi. Certo, se si fermasse lì, probabilmente il nostro interesse non andrebbe molto più in là; ma se di lì non passasse, non vi sarebbe nemmeno motivo di interesse – come di solito non ce n’è per i prodotti del caso, se non, talvolta, come curiosità.
Detto questo, la destrutturazione del moi (o almeno la sua impressione) è più una questione di gradi che non di presenza/assenza assolute. E siccome l’interpretazione ha numerosi (tendenzialmente infiniti) livelli, non è difficile accorgersi che a uno di questi livelli persino il crepuscolare pascoliano Pasolini arriva a destrutturare il suo moi nel mito della collettività dei sottoproletari o dell’icona collettiva di Gramsci, benché si esprima con forme canoniche nel linguaggio e nel racconto. Ed è magari anche per questo che comunque noi apprezziamo la sua poesia. E, magari, ciò che è assertivo a un livello si rivela non assertivo a un altro; oppure addirittura viceversa. Mai fidarsi delle apparenze, nel campo della parola.
Forse il cambio di paradigma, da questo punto di vista, non ha fatto che spostare più in superficie il livello della destrutturazione dell’io richiesta. Certo non ha cambiato la centralità del moi, anche se magari l’ha ribaltata (apparentemente) in negativo.
O forse è proprio l’espressione paradigma a essere fuorviante. Kuhn la impone all’uso parlando delle rivoluzioni scientifiche; e il paradigma è un po’ il criterio soggiacente ai dibattiti scientifici di una certa epoca, quella cosa che, quando cambia, impone una riconsiderazione globale delle verità assodate sino a ora. Forzando un poco (non molto), può aver senso usare la parola paradigma per la critica, anche se lo statuto delle verità critiche è diverso da quello delle verità scientifiche – ma si tratta comunque di un campo caratterizzato da un pubblico dibattito tra i soggetti che ne fanno parte attivamente. Però la poesia, in sé, non è un campo di discussione; le opere d’arte non sono tesi, o asserzioni vere o false. Magari lo diventano attraverso l’occhio della critica; ma questo riguarda la critica, non la poesia. Pensare che ci possa essere un paradigma (e quindi dei cambi di paradigma) in poesia, a me sembra legato all’idea che ci possa essere uno schema di fondo che regoli tutta la poesia di un’epoca; e la poesia che non si adegua si trova fuori dal dibattito. Ma il campo della poesia non è fatto così: solo se lo confondiamo con quello della critica che se ne occupa possiamo pensare che lo sia. È nel campo della critica che il dibattito avviene.
Per concludere, due osservazioni su un paio di testi che mi arrivano contestualmente alle tue riflessioni. Uno è quello di Jean-Marie Gleize che citi tu stesso nel post del 26 agosto sulla mimesi (non condivido le riflessioni che fai sulla mimesi, ma ne parliamo un’altra volta); l’altro è una coppia di poesie di Andrea Inglese apparse su poetarumsilva il 24 agosto, attaccate con curiosa violenza da qualche lettore. Il testo di Gleize non è privo di attrattiva, ma sembra uscire dalla prescrizioni di Marinetti (e forse Soffici – entrambi comunque quanto a virulenza del moi non scherzavano) nel Manifesto della letteratura futurista: alla fin fine, “La passeggiata” di Aldo Palazzeschi mi diverte molto di più. Viceversa, trovo molto intrigante l’apparente pochezza delle poesie di Inglese, persino l’apparente ostensione dell’io: c’è qualcosa, in loro, che continua a trattenere l’attenzione, e lo straniamento dell’io ne esce progressivamente e nettamente. Certo, ne emerge, inevitabilmente, anche un’altro moi, più ricco e più critico, che osserva “dall’alto”; però, appunto, della finzione del moi non è possibile fare a meno.
A presto, e à suivre.
Visto che mi occupo di ambedue le cose, il fatto mi salta inevitabilmente all’occhio. E il fatto non è che tra l’universo della critica poetica e quello della critica fumettistica ci siano, come è ovvio, numerose differenze. Semmai è che in mezzo a queste ce ne sia una meno ovvia delle altre, su cui vale la pena di indagare.
Non è difficile osservare che nell’universo della critica poetica è frequente un genere di critica che potremmo denominare prescrittiva, che è invece del tutto assente nella critica del fumetto. Non si tratta solo che chi scrive esprima più o meno esplicitamente delle preferenze personali: anche il critico dei fumetti è inevitabilmente schierato (chi con maggiore, chi con minore virulenza) nei confronti di un genere o di alcuni autori. Non esiste la critica oggettiva: il critico parla di ciò che conosce, giustamente; e conosce quello che gli interessa, giustamente. Persino se nutre ambizioni di esperto complessivo, o magari di storico, è naturale che finisca per propendere in qualche direzione, pur cercando di tenersi aggiornato a tutto campo.
Tuttavia nessun critico di fumetti, per quanto schierato, si sognerà mai di dichiarare che il fumetto vero si fa in un certo modo e non in altri; e che tutto il resto è inautentico, inattuale, sorpassato e, in ultima istanza, falso o mistificante. In altre parole, a nessun critico di fumetti è mai venuto in mente di scrivere in termini prescrittivi, dichiarando quale sia il modo giusto, corretto ed esclusivo di fare fumetti; oppure (versione appena più blanda della precedente) quali siano i modi sbagliati, scorretti e da abbandonare, indipendentemente dalla qualità degli autori e delle loro opere.
Sarà perché la critica del fumetto è giovane, o sarà perché quasi mai i critici sono anche gli autori stessi, o perché la posta culturale in gioco appare meno impegnativa. La critica poetica ha una lunga storia; molti critici sono anche autori, che si sentono in dovere di sostenere teoricamente le proprie scelte di poetica; la posta in gioco si presenta come altissima, perché, anche se i lettori di poesia in Italia sono molti meno dei lettori di fumetti, ancora, per chi se ne occupa, “quel che resta lo fondano i poeti”, come ebbe a dire Hölderlin una ventina di decenni fa.
O sarà anche perché, data la sua giovane età, il fumetto vive un’epoca felice in cui tra le produzioni più popolari e quelle più di elite esiste una continuità di produzioni intermedie e uno scambio continuo; e se pur qualche volta è chiaro cosa sia popolare e cosa sia di elite, in altri casi è, felicemente, impossibile (e inutile) distinguere davvero. La poesia (e quella italiana in particolare) ha tagliato i ponti da secoli con la sua versione popolare, al punto di escluderla dal campo stesso che la definisce, lasciandoci persino il dubbio rispetto a che cosa, oggi, potrebbe essere definita come tale: la canzone, forse? Basta leggere i dibattiti in rete al proposito (ad esempio qui) per capire quanto problematicamente sia vissuta questa ipotesi.
La critica prescrittiva non è ovviamente sempre così becera da dire esplicitamente “si fa così” o “così non si può fare”, ma non è, in ogni caso, affatto difficile ritrovare nel suo discorso queste morali. A titolo di esempio, uno per tutti, si può citare intervento e dibattito (specialmente il dibattito) tenuto in questa sede a proposito della poesia di Milo De Angelis. Nel dibattito vi sono anche numerosi interventi interessanti, e una lodevolissima documentazione su interventi critici di difficile riperimento, riportati interamente o in parte, pro o contro De Angelis (cui è seguita nel medesimo sito/blog poesia2punto0, nei giorni successivi, la pubblicazione di altri interventi critici su De Angelis, e sul post in oggetto, e altre polemiche ancora altrove); mi vi è anche un’interminabile serie di interventi volti a dimostrare (quasi more matematico) che la poesia di De Angelis è sbagliata, e che così non si fa, sino ad affermare testualmente (Laura Canciani): “NO, la poesia deangelisiana non può essere affatto utile all’obiettivo da conseguire, integralmente tardo novecentesca nella sua impostazione di fondo e nella sua costituzione, non ci può dire nulla di nuovo di ciò che sapevamo già”.
Parlare in questi termini (tutto sommato piuttosto frequenti nella critica poetica) vuol dire condannare De Angelis non tanto per la qualità della sua poesia, quanto perché le prescrizioni che da essa sarebbero ricavabili non sono utili all’obiettivo da conseguire, anzi controproducenti. L’intervento è rivelatorio proprio a causa della sua rozzezza, perché esplicita quello che critici più raffinati stanno attenti a non esplicitare, o danno per scontato: cioè che ci siano degli obiettivi da conseguire, e che tali obiettivi siano sufficientemente chiari.
Ora, è evidente che una critica prescrittiva si giustifica soltanto se ci sono degli obiettivi chiari e condivisi da conseguire. Quali sono questi obiettivi? E, per quanto riguarda il fumetto, tali obiettivi non esistono, oppure esistono ma la critica preferisce ignorarli, o non scontrarsi sul loro campo?
Cerchiamo di far qualche luce sulla prima delle due questioni, lasciando la seconda a una riflessione futura. Quali possono essere gli obiettivi della poesia, così chiari e condivisi da poter pensare di dimostrare che la poesia di De Angelis non è adatta a dare indicazioni per conseguirli? Suppongo che siano qualcosa come: testimoniare il proprio tempo, esprimere la condizione umana nel presente (nella fattispecie nell’epoca dell’abbrutimento e dell’alienazione tardo-capitalista). Qualcosa di questo genere salta fuori in generale sempre quando si cerca di capire a cosa serva la poesia.
Sono asserzioni generiche, anche la seconda (pur se meno della prima). Da sole non giustificherebbero né potrebbero sostenere alcun livello di critica prescrittiva. È perciò necessario che il critico, che egli lo espliciti o meno, abbia opinioni molto più dettagliate di queste. Nel post citato, per esempio, l’autore Giorgio Linguaglossa cerca di esplicitarle almeno in parte in uno dei commenti, come spiegazione a posteriori delle ragioni del suo attacco a De Angelis.
Quello che mi colpisce, di queste esplicitazioni, o di quello che si può intuire di implicito ogni volta che la critica assume colorazioni prescrittive, è che il critico mostra di avere un’idea molto chiara di quello che è il nostro tempo, di quale sia il suo problema, e di conseguenza di come la poesia dovrebbe fare per esprimerlo. Personalmente, in questi casi, sono sempre incerto tra l’essere ammirato e l’essere imbarazzato: ammirato perché piacerebbe tanto anche a me possedere certezze del medesimo livello; imbarazzato perché ho la sensazione netta di vedere quello che il critico in questione non vede, ovvero i limiti abissali delle sue certezze.
Giusto per fare un esempio. È un luogo comune della critica poetica che noi si viva in una società alienata e inautentica, e che la poesia che non esprima questo sia per forza necessariamente inautentica (anche di questo si accusa, per esempio, De Angelis, in molti dei commenti di cui sopra). La neoavanguardia italiana, come tanta arte cresciuta sulle teorizzazioni di Adorno, vive integralmente su questo presupposto; e vi continuano a vivere tanti suoi epigoni.
Ora, non si tratta di negare che esista l’alienazione e l’inautenticità, perché basta accendere il televisore per accorgersene; o nemmeno di negare l’importanza sociale di questa condizione disumanante. Ma sostenere che la poesia debba necessariamente confrontarsi con questa condizione, e tacciare di inautenticità la poesia che parla d’altro, significa pensare che, poiché il centro è importante, le periferie non esistono. È probabile che nel nostro tempo l’autenticità (qualunque cosa si voglia intendere con questa brutta e oscura e intollerante parola) sia relegata davvero nella periferia dell’esperienza: ma per quale ragione la poesia non dovrebbe convivere ed esprimere questa periferia?
Si dice anche che l’inautenticità abbia pervaso tutto, e che non siamo in grado di provare nessun sentimento autentico. Mi piacerebbe però sapere se ci sia qualcuno in grado davvero di riconoscere un sentimento autentico da uno che non lo è. Ma se non siamo in grado di operare questo riconoscimento, come possiamo permetterci di dire che l’autenticità è stata scacciata, e che la poesia, dopo Auschwitz, non può che esprimere quel male? Come potrà permettersi di parlare di autenticità chi non sia in grado di riconoscerla? Non sarà, l’autenticità, proprio quel mito oscuro e impossibile, che è utile perché ci permette di dire che il nostro mondo non è così, e che bisogna operare, di conseguenza, in un determinato modo, per recuperarne almeno l’espressione (l’espressione autentica di un mondo inautentico!)?
In alternativa, il mito oscuro potrà trovarsi anche nel politico, anzi in una precisa concezione del politico. Poiché De Angelis, in generale, parla d’altro, De Angelis allora non ci servirà. Ammesso e non concesso che il centro del nostro tempo sia correttamente identificato in questo modo, anche in questo caso, che diritto avrebbe il centro di escludere le sue periferie dall’esercizio poetico? Mi importa assai poco, in verità, di decidere quale sia il centro. Personalmente, poiché apprezzo De Angelis, ritengo che un qualche centro le sue poesie lo colgano. E poiché apprezzo Fortini, ritengo che un qualche altro centro sia colto pure da lui. E continuo a non capire perché se l’uno è giusto l’altro debba essere sbagliato.
Ho già difeso De Angelis altrove (qui e qui, per esempio), e non è per difendere la sua poesia che ho scritto queste righe. Il punto è che trovo qualcosa di insopportabile nel sentirmi dire che cosa sia giusto fare, senza che vengano esplicitati gli obiettivi di questo fare (e quindi senza discuterne). Con i miei versi (come con quelli di chiunque altro) io mi auguro che i lettori possano trovarsi in sintonia, e quindi giudicarli belli; mentre magari, al contrario, non riusciranno a trovare nessuna sintonia, e li riterranno brutti. I miei versi, come quelli di chiunque altro, sono belli, oppure sono brutti; ma non sono giusti o sbagliati. Quello che potrà essere giusto o sbagliato sarà un intervento critico, non un’operazione artistica – e parlare di un’operazione artistica in termini di giusto o sbagliato è perciò parlarne come se si trattasse di un intervento critico.
La critica del fumetto, pur nella sua pochezza (quantitativa), mi sembra che resti ancora estranea a questo fraintendimento. Per quanto mi riguarda continuerò a fare il critico di fumetti anche di fronte alla poesia. Non mi piace rendermi ridicolo.
Qui mi metto nei pasticci da solo. Ci sono queste tre nozioni, dionisiaco, immersivo, improvvisazione, che sono imparentate ma non coincidono: stanno grosso modo dalla stessa parte, contrapponendosi ad apollineo, frontale, progetto. Tuttavia non coincidono perché posso immaginare un testo dionisiaco e immersivo ma progettato, qual è tutta la musica scritta; un testo dionisiaco e improvvisato ma frontale, come i dipinti di Pollock e i Kuang Cao di Zhang Xu, a meno che non fossero più studiati a tavolino di quanto sembrano, nel qual caso sarebbero ancora dionisiaci, ma frontali e progettati – quale può essere la musica stessa di fronte a un ascolto strutturale. Più difficile è immaginare un testo apollineo che non sia anche perlomeno progettato, ma potrebbe poi essere immersivo, come certamente era il teatro greco sognato da Nietzsche. L’apollineo semprerebbe incompatibile con l’improvvisazione, ma resta compatibile, seppur con qualche difficoltà, con l’immersione.
Non c’è bisogno di spiegare le due coppie più note: apollineo vs dionisiaco, e progetto vs improvvisazione. Qualche parole va invece spesa sull’opposizione frontale vs immersivo, di cui faccio uso nel mio libro Il linguaggio della poesia. Cito dall’Introduzione, che si può leggere interamente su questo blog:
La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui.
Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona.
Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato.
Un’esperienza immersiva è quindi una condizione favorevole, ma non esclusiva, al presentarsi del dionisiaco: posso comunque immaginare una musica (tendenzialmente) apollinea, o un dipinto (tendenzialmente) dionisiaco. Immersivo e frontale sono perfettamente compatibili entrambi con il progettato e con l’improvvisato: eppure, quando si parla di musica scritta, non si può trascurare la componente dell’interpretazione musicale, e la sua parte inevitabile di improvvisazione – per cui può benissimo capitare che lo stesso brano interpretato dal medesimo interprete in due occasioni diverse possa entusiasmarci in un caso e deluderci in un altro. E, d’altra parte, i pittori non sono tutti iperprogettuali come Mondrian, e sappiamo bene quanta parte del gusto della fruizione stia nel vedere la pennellata, che rimanda al gesto della mano dell’artista, che possiamo quasi sentire nella nostra carne – anche senza arrivare agli estremi di Pollock e Zhang Xu.
Da che parte sta la poesia? Finché la poesia sta scritta, sembra un’arte frontale; ma la poesia chiede di essere recitata, almeno interiormente; e, chiedendo la voce, diventa suono, e si manifesta come un’arte immersiva quasi quanto la musica. Ci chiede di andare col suo ritmo, di intonarci col suo senso: può assumere certo anche aspetti apollinei, specie se se ne enfatizza la dimensione scritta, visiva (come, per esempio, nella poesia concreta), ma la sua natura è dionisiaca, specie da un secolo (o poco più) a questa parte. Non è improvvisata ma progettata, lungamente e con attenzione; anche se, certo, qualche elemento di improvvisazione rimane nella lettura ad alta voce, proprio come nell’esecuzione musicale. Tuttavia, mentre in musica si può improvvisare anche tutto, questo in poesia è quasi impossibile – e anche i poeti da braccio, per quel che ne rimane, lavorano su canovacci ben assestati; e gli aedi dell’antichità o dei Balcani o dei LoDagaa facevano variazioni su sequenze tradizionali ben note.
L’opposizione progetto vs improvvisazione riguarda l’esperienza del produttore; quella frontale vs immersivo riguarda il canale e l’esperienza percettiva del fruitore; quella apollineo vs dionisiaco riguarda l’esperienza emotiva del fruitore. La musica ci fornisce i casi canonici in cui l’improvvisazione del produttore si trasmette come trasporto emotivo al fruitore per comune immersione nel suono; la scultura (tanto per essere nietzschiani sino in fondo) ci fornisce i casi canonici in cui il progetto del produttore produce un’esperienza apollinea attraverso il distacco frontale del vedere. Ma i casi intrecciati sono innumerevoli. La tragedia che incantava il giovane Nietzsche si vedeva e si ascoltava insieme, era progettata in quanto scritta e improvvisata in quanto recitata in pubblico: per questo poteva apparire ai suoi occhi un perfetto equilibrio di apollineo e dionisiaco.
Socrate e Platone, agli occhi di Nietzsche, hanno decretato il trionfo dell’apollineo. Ma, con un certo numero di eccezioni, la modernità sembra votata piuttosto al dionisiaco. Che rapporto c’è tra il dionisiaco nietzschiano e il sublime di Boileau, di Burke e di Kant? Guardando le cose in questo modo, ci appare dionisiaca persino l’arte di Mondrian, che certamente non era né improvvisata né immersiva.
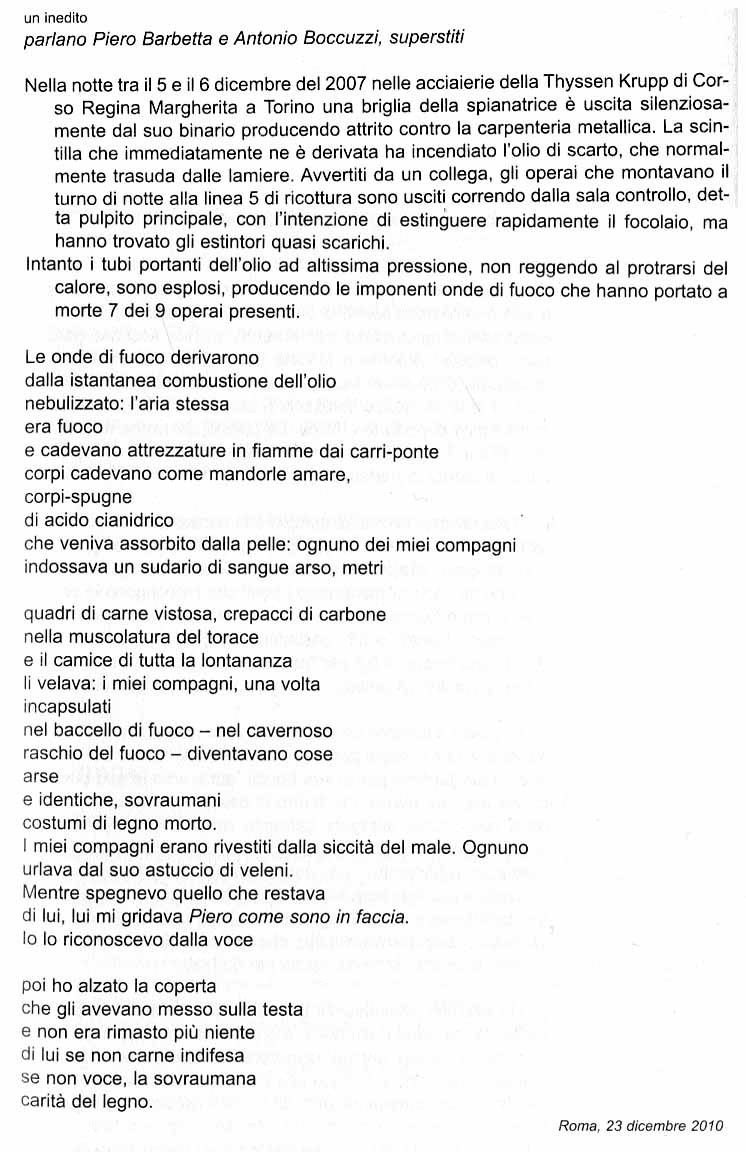 Maria Grazia Calandrone, inedito Sono stato a una presentazione, a Bologna, dell’antologia Poeti degli Anni Zero, di cui ho già avuto occasione di parlare, e su cui spero di avere occasione di tornare. Mi ha colpito, nel corso dell’evento, la lettura della poesia di Maria Grazia Calandrone che ho riportato qui sopra.
Più tardi, rileggendola nel volume, mi sono emerse in forma più compiuta delle riflessioni che covavano da tempo, e che voglio riportare qui, con tutta la forza dubitativa e interlocutoria che meritano.
Il tema è la possibilità della poesia di esprimere l’orrore. Anzi, meglio: il tema è la possibilità della buona poesia, della poesia di valore, di affrontare direttamente l’orrore, quello vero. La poesia da poco, come ogni cosa da poco, non fa problema: quando si cade nella retorica (cosa assai facile di fronte a temi molto forti) si è comunque sbagliato il bersaglio. Il lettore resta annoiato o infastidito e l’orrore in quanto tale scompare, diventando un soggetto di maniera, buono come tanti altri.
Il problema mi si pone di fronte a testi riusciti, come questo, testi che in qualche modo sono in grado di farci rivivere l’orrore, di metterlo di fronte a noi in forma diversa, in forma di parole.
L’esempio inevitabile è quello di alcuni notissimi versi di Salvatore Quasimodo, quelli che dicono:
E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.
Io non posso evitare di pensare che ci sia qualcosa di scandaloso nel rapporto tra il nitore cristallino di questi classicheggianti endecasillabi e ciò di cui questi stessi versi stanno parlando. Il componimento parla di un orrore, ma per farlo lo inserisce in un contesto elegante, classicamente bello. L’orrore, certo, viene detto, espresso, ma al tempo stesso si trova negato, risolto, trasformato in motivo ornamentale, fondamentalmente neutralizzato dalla logica della composizione. Il fremito che pur ci prende al sentirlo nominare trova presto una soluzione confortante, nella stessa architettura classica che lo contiene: l’effetto di “bello” che questa poesia magistralmente costruisce non può davvero dare espressione all’orrore; al massimo potrà dar nome a una sua apparizione immediatamente risolta in sé. Perché se non si risolvesse, il “bello” non si darebbe: l’orrore, quello che ci si pone davanti davvero, non è e non può essere “bello”.
Per riprendere un’opposizione tradizionale, l’orrore può però essere “sublime”. Il sublime è qualcosa che ci sovrasta, che ci meraviglia o terrorizza, ma percepito da una condizione che ci permette di contemplarlo, senza troppo timore di patirne le conseguenze materiali. C’è certamente qualcosa di affascinante in un grande disastro, ma se noi stessi ne fossimo le vittime non avremmo modo di sentire questo fascino. Dobbiamo esserne fuori per poter com-patire, per essere inorriditi e affascinati. Il sublime ha in sé, potenzialmente, specie quando è in gioco l’orrore, qualcosa di morboso, qualcosa di scandaloso, qualcosa che insieme nasconde e rivela la domanda: perché loro, e non io?
È a queste condizioni che si parla dell’orrore; con una punta di cattiva coscienza (perché loro, e non io?) perché ci rendiamo conto che non è giusto essere affascinati dal male degli altri, ma non possiamo farne a meno. Questa natura contorta del sublime non riguarda però il bello, che rimane una manifestazione di classica armonia, proprio come negli scolpiti endecasillabi di Quasimodo.
La poesia, dal Romanticismo in poi, ha decisamente imboccato la strada del sublime, e a questa dimensione appartiene indubbiamente anche il componimento della Calandrone, così come le appartengono pure i versi di altri poeti di cui ho parlato in questo blog, come Giuliano Mesa, o Alessandra Carnaroli, o ancora, in diverso modo, Sergio Rotino. Non c’è dubbio che il tema affascini anche me, visto che io stesso inclino a restare colpito da testi che affrontano queste tematiche. Magari è proprio il contrasto tra la qualità della parola poetica e il male estremo che si trova ad essere messo in scena, a provocare il mio interesse. Ma questo non cambia la natura del problema; anzi forse è proprio questo il problema.
Parlare in generale dell’orrore è difficile, e insieme necessario. La forma più tollerabile di discorso su questo tema è quella giornalistica, quella puramente informativa, che cerca di descrivere i fatti con il massimo distacco e obiettività possibili (magari evitando – come spesso non fa – di calcare la mano sui dettagli più pietosi). Trovo ancora tollerabili i testi che riescono a costruire un qualche tipo di distacco, ben consapevoli che, anche velato, l’orrore trova ugualmente la sua strada per emergere: esemplare, da questo punto di vista, è il Maus di Art Spiegelman, che racconta lo sterminio degli ebrei attraverso il velo dell’ironia nei confronti delle piccole manie paterne; e questo continuo, insistente, riportarci alla banale quotidianità è proprio ciò che permette all’orrore di emergere, senza retorica da un lato, e senza patire troppo gli eccessi contraddittori del sublime – ma senza che nemmeno scompaiano, d’altra parte.
Maus ha poco a che fare con il bello, e il suo sublime è temperato dall’ironia; un procedimento difficile, che ha comunque dei precedenti. Solo per restare in ambito americano c’è senz’altro quel gioiello di Mattatoio 5 di Kurt Vonnegut.
L’oggettività e l’ironia sono modi, dunque, per raffreddare il sublime, e permetterci di stare di fronte abbastanza impunemente all’orrore in letteratura. Probabilmente non sono i soli modi di operare questo raffreddamento. L’oggettività è presente in Calandrone come in Mesa, mentre in Carnaroli gioca anche qualche elemento di ironia. Questo contribuisce a rendere il loro discorso sull’orrore molto più accettabile (almeno per me) di quello di Quasimodo. Ma non è sufficiente a dissolvere il problema. Più sottilmente, Rotino opera un altro tipo di distacco, parlando non direttamente dell’orrore a cui comunque allude, ma di ciò che gli sta attorno, di ciò che lo circonda.
Nella poesia che parla di orrore, nella buona poesia che lo fa, voglio dire, quella che riesce a parlarne senza troppa retorica, non c’è solo la dialettica della percezione del sublime, quel senso di colpa del sopravvissuto che aleggia sopra il fascino della tragedia. È che, per quanto si sia allontanata dal bello in direzione del sublime, la poesia non ha mai davvero tagliato i ponti con il bello in senso classico; né probabilmente avrebbe potuto farlo, pena il non essere percepita più come poesia.
La poesia è costruzione di un mondo con gli strumenti della parola, ma non soltanto e non principalmente attraverso il suo potere descrittivo – come invece accade con la prosa. Il mondo che la poesia costruisce è fatto del suono e del ritmo della parola non meno che del suo senso. Un componimento poetico è un oggetto, che si manifesta con la forma grafica e sonora delle parole e poi anche con il loro senso, ma spesso pure quest’ultimo viene trattato come materiale da costruzione, in modo decisamente non convenzionale.
Questo oggetto, che è il componimento poetico fatto di parole, è inevitabilmente un oggetto umano, un manufatto che richiama l’attenzione prima su se stesso che su ciò di cui parla, e il cui senso complessivo va trovato solo in parte in ciò di cui parla, perché questa parte del senso va rapportata a tutto il resto, e tutto il resto deriva da ciò che le parole (e le loro combinazioni) sono nel loro uso corrente. Proprio in quanto umana, manufatto, la poesia non può in sé essere sublime (anche se può parlare del sublime), e resta inevitabilmente legata in qualche modo alla dimensione armonica del bello.
La poesia del Novecento ha cercato in tutti i modi di incorporare il sublime anche nelle proprie forme, e il verso libero, il verso atonale, l’allontanamento dalla sintassi tradizionale sono tutte modulazioni di questo tentativo. Tuttavia, sinché la poesia non arrivasse a sposare la dominanza del significato lessicale e narrativo, non potrebbe davvero spostarsi del tutto nella dimensione del sublime; però se davvero sposasse questa dominanza, si ritroverebbe a essere non più poesia, bensì prosa – anzi una prosa idealizzata ed estrema, perché nemmeno in prosa si arriva del tutto sin qui.
Il sublime, specie quando è del tipo dell’orrore, è il non umano. L’orrore è orrore proprio perché non riusciamo a dargli un posto in ciò che sentiamo come nostra espressione; è l’assoluto altro, è il reale di cui parla Lacan, cioè quello che esiste al di fuori di qualsiasi comprensione umana (la morte, la divinità…).
La poesia potrà dire, dunque, l’orrore, ma scontando profondamente il proprio intimo non poterlo accettare. Per questo c’è qualcosa che suona falso anche nelle poesie più riuscite che lo affrontano direttamente. Forse per gli anni in cui Quasimodo scriveva i suoi versi, quello era quanto più in là la poesia potesse permettersi di andare, nella direzione del sublime irredimibile. Oggi la sua moneta ci suona fasulla; la poesia ha saputo andare molto più in là. Ma che effetto ci faranno i versi della Calandrone a rileggerli tra cinquant’anni? Rimarranno versi di qualità, e qualità anche alta, mi permetto di dire; ma forse sarà proprio questa qualità a emergere come eleganza, e l’eleganza come può stare a fianco dell’orrore, senza neutralizzarlo? Ci indurranno magari a capire che c’è una contraddizione intrinseca tra poesia e orrore? Che la poesia può solo sforzarsi di esprimere il male, ma esponendosi comunque all’accusa di Brecht e di Adorno, di non sapere fare altro, in fin dei conti, che parlare di alberi?
C’è una via di uscita da questo cul de sac?
Questa settimana questo blog ha avuto due differenti occasioni di lutto: a distanza di due giorni sono scomparsi Elio Pagliarani, uno dei maggiori poeti del Novecento italiano, e Jean Giraud Moebius, maestro internazionale del fumetto francese. Erano stati due autori, ciascuno nel suo campo, cruciali. Chi li conosce lo sa.
Questo blog si occupa di varie tematiche, ma non c’è dubbio che i campi di cui si parla con maggiore frequenza siano proprio quelli in cui Pagliarani e Giraud hanno primeggiato. Non parlerò di loro; o perlomeno non oggi. Ne stanno già parlando tutti, specie di Moebius.
Piuttosto, questo incrocio di lutti mi ha portato a domandarmi se, almeno per me, tra fumetto e poesia (e magari anche gli altri ambiti di cui mi occupo) ci siano degli aspetti in comune; oppure se più semplicemente sia io a essere un po’ scisso, come è peraltro normale essere: la coerenza e l’omogeneità dell’io caratterizza i personaggi, per ragioni narrative, non le persone, che sono per loro natura complesse.
Ho perciò riflettuto (aiutato dal fatto che non sarebbe la prima volta che me lo domando, certamente). Che io sia un po’ scisso è senz’altro vero; ma c’è ben altro, al di fuori dei miei gusti estetici, in cui la scissione si manifesta – e anche in questo sono normale. Ma c’è anche, almeno per me, un motivo di profonda vicinanza tra fumetto e poesia, o almeno un aspetto sotto il quale si contrappongono comunemente al romanzo, e rispetto al romanzo si schierano dallo stesso lato.
Per il fumetto è più facile dirlo. Il fumetto racconta storie, proprio come il romanzo, ma la materia di cui sono fatti i suoi sogni sono le immagini, disegnate. Le parole vi sono accessorie, quando ci sono. La forma microstrutturale del racconto non è quella ben definita della proposizione (soggetto-predicato-complementi) ma quella sfumata della figurazione, che mostra, allude e non dice, cioè, di fatto non racconta. Non racconta anche perché, non essendo fatta di parole (che, per loro natura, dichiarano il punto di vista temporale e personale da cui sono pronunciate: non si parla – o scrive – senza coniugare i verbi secondo la persona, il tempo e il modo), non implica necessariamente la presenza di un narratore (che può esserci, ove serva, ma che il più delle volte non c’è).
Questo vale certo anche per il cinema, ma il cinema fluisce autonomamente – e questo basta di per sé a farlo un’altra cosa, parente più della musica che del fumetto.
Potrei dire che l’aspetto della comunicazione che più mi affascina e a cui ho dedicato i miei interessi è quello che passa al di fuori delle parole e della loro costruzione del significato. Leggo (e scrivo) sufficiente critica e filosofia per averne abbastanza di comunicazione razionale basata sulla struttura della proposizione e del periodo, in grado di comunicare idee chiare e distinte di cartesiana memoria. Non che questa comunicazione verbale chiara e distinta sia da disprezzare: è ciò a cui tendo ogni volta che scrivo parole di carattere critico, come anche sto facendo ora. Ma è necessario riconoscere i suoi limiti. È necessario riconoscere che ci sono cose di cui non si può parlare, e, tanto per stracitare Wittgenstein, di queste cose è necessario tacere. Ma tacere non significa trascurare. Tacere, in questo senso, significa cercare modi di comunicare diversi dalla parola definitoria, razionale. Il disegno è uno di questi modi, attraverso cui può essere trasmesso ciò di cui non si può parlare.
La parola poetica è un altro di questi modi, per quanto paradossale possa apparire l’idea che un testo fatto solo di parole sia un testo che tace, nel senso detto sopra. Ma ciò che è interessante della parola poetica è che non si tratta di una parola definitoria, ovvero di una parola che fa uso della struttura proposizionale (soggetto-predicato-complementi) per trasmettere informazione. Quando ancora ne fa uso, sappiamo benissimo che si tratta di un uso strumentale. Se leggiamo la poesia come se fosse un discorso definitorio, razionale, come facciamo con queste stesse righe, allora non stiamo capendo nulla, e faremmo meglio a lasciar perdere. La poesia fa un uso alternativo delle parole, in cui tutta la loro natura, semantica quanto fonetica quanto prosodica, entra in gioco, a disegnare letteralmente un mondo. È un disegno più astratto di quello del fumetto, perché il suo oggetto è un altro, ed è forse l’universo stesso del senso, nel senso più vasto possibile (quello che comprende, per esempio, anche la dimensione emozionale, a giustificare in parte coloro che credono che la poesia sia semplicemente espressione di emozioni).
Pure qui, in poesia, poiché il senso passa attraverso un disegno, la parola definitoria è fuori gioco, ed è fuori gioco l’inevitabilità del riferimento all’io narrante (quello che esprime, nel verbo, la persona, il tempo, il modo, e continua a manifestarsi in altri modo nella struttura della proposizione). Quando questo riferimento c’è, in poesia, è in realtà accessorio, manifestazione superficiale; proprio come quando, nel fumetto, un personaggio parla attraverso la propria vignetta: dice “io”, certamente, e manifesta un soggetto e un punto di vista proposizionale sul mondo, ma non per questo assumiamo la sua posizione come indice della presenza di un narratore complessivo. Capisco bene che, in poesia, sia più facile confondersi, e scambiare l’io scritto con quello complessivo; ma se ci si rende conto che la poesia comunica al di là della struttura proposizionale (di cui al massimo fa un uso locale e strumentale), si capirà che, rispetto al proposizionalissimo romanzo, fumetto e poesia si trovano dallo stesso lato, quello del disegno, seppure attraverso strumenti del tutto differenti.
La poesia gode di un prestigio millenario, e le si dà grande spazio a scuola. Eppure siamo in pochi a interessarcene di fatto. Quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Elio Pagliarani? Il fumetto è stato a lungo un medium trascurato e vilipeso, anche se oggi le cose vanno meglio: alla scomparsa di Moebius, poi, hanno dato molto spazio i giornali e le TV. Ma questo dipende troppo dalla fama personale per farne una questione generale. Moebius deve la sua fama anche ai suoi influssi sul cinema, e questo ha indubbiamente pesato moltissimo.
Io continuo a pensarli come maestri, entrambi. E continuo a pensare che, quando scrivo poesie, sto in verità disegnando, o tracciando linee musicali, di cui le parole rappresentano l’inchiostro, o le forme base delle linee che si vanno a combinare, o la materia timbrica che va a costruire la melodia. Scrivere poesia è un’attività radicalmente diversa dall’esporre proposizionalmente pensieri organizzati, come sto facendo in questo istante (e il cui risultato state leggendo voi, ora). È un’attività che si impara nella prassi, magari imitando inizialmente dei maestri, magari imitando anche Elio Pagliarani, o Jean Giraud Moebius.
.
Quanto di morte noi circonda e quanto
tocca mutarne in vita per esistere
è diamante sul vetro, svolgimento
concreto d’uomo in storia che resiste
solo vivo scarnendosi al suo tempo
quando ristagna il ritmo e quando investe
lo stesso corpo umano a mutamento.
Ma non basta comprendere per dare
empito al volto e farsene diritto:
non c’è risoluzione nel conflitto
storia esistenza fuori dell’amare
altri, anche se amore importi amare
lacrime, se precipiti in errore
o bruci in folle o guasti nel convitto
la vivanda, o sradichi dal fitto
pietà di noi e orgoglio con dolore.
(Elio Pagliarani, da “La ragazza Carla” 1954-57)
Avevo programmato di scrivere questo post da un po’ di tempo, e buttato giù qualche appunto in attesa di stenderlo per bene. Poi c’è stato il dibattito sul post di Andrea Inglese su Nazione Indiana a proposito del libro di Alessandro Broggi, nel corso del quale sono uscite una serie di questioni interessanti, e non solo tra Andrea a me. Inevitabile quindi partire da lì.
Il tema è il ruolo della critica o, in altre parole, che cosa ci si debba aspettare dalla critica. Un tema trasversale: anche se l’intervento di Inglese riguarda un testo poetico, la questione della critica riguarda la poesia come il fumetto come qualsiasi altra forma espressiva su cui la critica si esprima. Sto parlando della critica, in senso ampio, “militante”, quella, cioè, che propone testi all’attenzione del pubblico – che ha un ruolo del tutto diverso dalla storiografia di settore (storia dell’arte, del fumetto, della poesia…) o dalle analisi testuali.
Ritrovo nei miei appunti la stessa parola chiave con cui Inglese a un certo punto del dibattito cerca di focalizzare la questione: rilevanza. Dice Andrea: “trovo molto azzeccato il termine ‘rilevanza’. Il critico non può che persuadere, attraverso prove specifiche – che sono le trame di relazioni, ecc. -, della rilevanza di un certo testo, come ‘testo poetico’, di un certo insieme di colori, come ‘dipinto’, ecc. Il lettore potrà poi farsi portare da questo tessuto ‘ricostruito’ verso il testo stesso, e sperimentare in proprio quanto può accadere. E qui può avvenire o non avvenire una risonanza tra testo e lettore, che in nessun modo può essere anticipata, inclusa, governata dal discorso critico.”
Il discorso di Inglese mi sembra sensato e condivisibile, ma si basa su una nozione a rischio, quella, appunto, di rilevanza. Che cosa vuol dire che un testo è rilevante? Rilevante per che cosa, insomma?
Le risposte possibili sono diverse. Ce n’è una, più diffusa di quanto non sembri a uno sguardo superficiale, che dipende ed è legata alla concezione storicista che la nostra cultura tende ad avere di se stessa, la stessa concezione, per intendersi, a cui è legata la nozione di progresso, o quella di crescita. Non intendo attaccare lo storicismo. È la stessa visione del mondo in cui mi muovo anch’io. Ogni concezione alternativa mi pare più primitiva e grossolana. E tuttavia non posso fare a meno anche di vederne i limiti e i problemi.
All’interno di una concezione storicista un testo artistico (permettetemi di usare qui questa nozione generica e imprecisa per intendere in un sol colpo i testi poetici, letterari, fumettistici, pittorici, filmici…) ha valore se contiene qualche elemento di novità rispetto al passato, o meglio di novità rilevante. Nel fare la storia di un ambito artistico (poesia, fumetto o quant’altro) è inevitabile e doveroso mettere in primo piano non tanto le opere (e i rispettivi autori) che sono state più apprezzate dal pubblico, bensì quelle che più hanno influenzato le opere (e gli autori) successivi, modificando il corso della storia. Spesso, ma non sempre, le opere più apprezzate sono state anche le più influenti; o perlomeno è difficile che un’opera molto apprezzata non sia anche in qualche modo influente. Ma capita anche che vi siano opere influenti che pur non hanno goduto di un grande apprezzamento. I due campi sono ampiamente sovrapposti, ma ben lontani dal coincidere.
Le opere influenti sono quelle che hanno introdotto molte novità rilevanti, quelle novità che poi sono diventate merce consueta negli autori successivi. Le opere apprezzate sono quelle che, in contesti più generali o più specifici, hanno avuto successo. L’atteggiamento storiografico non esclude le seconde solo perché esse di solito stanno anche tra le prime; ma non è raro il caso di autori baciati dal successo in vita, che poi la storia ha quasi dimenticato, non sapendo come posizionarli nella linea dello sviluppo evolutivo.
In un contesto culturale storicista, quando facciamo critica militante, tendiamo spesso a comportarci un po’ come degli storici. La rilevanza che attribuiamo al nostro oggetto di presentazione è, appunto, una supposta rilevanza storica, basata sulla presunzione di una qualche novità significativa, e quindi di un qualche apporto originale al dibattito complessivo. Presentiamo il nostro oggetto, insomma, come una migliore risposta a un qualche problema espressivo, almeno da un qualche punto di vista: certo non si tratta ogni volta di inventarsi un novello Dante Alighieri. La novità che pretendiamo di stare individuando può essere piccola, locale, minore, particolare; ma in quell’ambito così ristretto è nondimeno una novità, e il lavoro di cui parliamo è rilevante in quanto presenta una rilevante (piccola) novità.
Il problema, rispetto allo storico vero e proprio, è che il critico militante lavora sul presente. La novità, e tantopiù la novità rilevante, è qualcosa che può essere riconosciuto solo a patto che la direzione in cui si sta andando sia sufficientemente chiara al critico. Anche quando si sta facendo della storiografia, individuare le tendenze di un epoca artistica non è un fatto pacifico, ma almeno in questo caso esistono dei precedenti di riferimento, e qualche certezza è legittima (almeno sino al prossimo ribaltamento di paradigma). Ma se parliamo del presente, la tendenza rispetto alla quale decidiamo che qualcosa costituisce una novità non può che essere un’assunzione rischiosa, talora arbitraria. Sarà molto facile (e assai spesso accade proprio così) estrapolare una qualche tendenza della storia recente, estendendola al presente e all’immediato futuro; vedendo dunque come progressisti coloro che immettono qualche novità all’interno di un discorso già avviato e sostanzialmente assestato, ma magari essendo incapaci di riconoscere delle nuove e influenti tendenze, in quanto estranee o addirittura contrarie alla tendenza che stiamo privilegiando.
Tanto più saremo critici “di parte”, e tanto più questo rischio sarà forte, sino al caso limite del restare ciechi di fronte alle novità effettive, e ai cambiamenti storici veri e forti. Per questo, pure il critico “di parte” dovrebbe fare attenzione non solo alla novità rilevante, ma anche all’apprezzamento effettivo ottenuto da parte del pubblico, sforzandosi di comprenderne le ragioni, anche a costo di mettere in crisi le proprie ipotesi evolutive.
Ma questo significherà che il critico non può fare a meno di considerare l’apprezzamento, il successo, come indici di rilevanza. Non potrà ignorare se un certo testo piace o non piace al pubblico cui è destinato. Tuttavia, come si porrà se, da critico militante, sta presentando al pubblico un testo di fresca uscita, del quale evidentemente non potrà già conoscere l’esito di pubblico? Dovrà in questo caso basarsi solo sulla (ipotetica) tendenza, e valutare, ideologicamente, sulla base di ciò che ritiene progressivo? Un buon critico dovrà dunque, necessariamente, essere di parte? avere un’ideologia, qualunque essa sia, che lo guidi e lo illumini nelle sue scelte?
È evidente, comunque, che non esiste una critica neutra, cioè non esiste una critica che non abbia dei presupposti ideologici, perlomeno impliciti. Il punto non è quello di cercare di neutralizzare la critica, operazione che non farebbe che nascondere sotto il tappeto degli inevitabili presupposti ideologici. Il punto è semmai cercare di capire attraverso quale operazione questi presupposti possano diventare il più possibile espliciti, ed essere espressi insieme alle valutazioni specifiche che ne conseguono, a proposito del nostro oggetto di critica.
Tornando alla breve citazione di Andrea Inglese riportata sopra, si può osservare che viene fatta una netta opposizione tra critico e lettore: al critico spetta ricostruire le trame di relazioni che stanno alla base della rilevanza del testo, mentre il lettore troverà (o non troverà) una risonanza nel testo. Certo i ruoli sono diversi; ma il critico, prima di essere critico, non dovrà essere stato anche lettore, vivendo (o non vivendo) a sua volta quella risonanza? Se rispondiamo di no, decidendo di separare nettamente la lettura del critico da quella del lettore, dovremo rispondere a un’ulteriore domanda: visto che il critico non può basarsi sulla risonanza col testo per valutarne la rilevanza, su che cosa si baserà? In questo caso, non vedo altre risposte possibili: si baserà sull’aderenza del testo oggetto a un qualche canone che (ideologicamente) viene ritenuto valido. Se separiamo completamente l’azione del critico da quella del lettore, dunque, ricadiamo inevitabilmente nel caso descritto sopra, quello che facilmente sfocia nella cecità ideologica, malattia piuttosto diffusa nel XX secolo (e anche dopo).
Postulando dunque che critico e lettore siano sì figure diverse, ma che in qualche modo il ruolo di lettore debba far parte di quello di critico, si tratterà allora di cercare di capire in che modo questo debba o possa accadere. Suppongo che ci possano essere non uno, ma una serie di modus operandi positivi. Mi limiterò a esporre quello a cui io stesso cerco (non sempre con facilità, non sempre con coerenza) di attenermi.
Prima di tutto mi considero un lettore, e come lettore cerco una risonanza nel testo. Ma poiché so di essere un critico, e che prima o poi dovrò produrne una valutazione, il mio tentativo, costante e a monte, è quello di costruirmi come un lettore il più generico e aperto possibile, pronto a cogliere nell’opera aspetti positivi di qualsiasi tipo. Per fare questo cerco di aver già letto molto, e cose molto diversificate; cerco di aver già costruito il mio gusto come un potenziale gusto del pubblico. È ovvio che un compito di questo genere non può arrivare davvero a compimento, perché per quanto riesca ad ampliare i miei orizzonti, essi resteranno comunque i miei, inevitabilmente. E tuttavia la tensione verso questo (pur intattingibile) fine non è inutile, perché mi porterà sempre a domandarmi se non ci sia altro da prendere in considerazione.
Supponiamo che, in qualche modo, io trovi una risonanza nel testo, come lettore. A questo punto ha inizio il lavoro di critico, perché ora io ho l’obbligo di capire su che cosa si basi questa risonanza, e di trovare un modo di descrivere il testo che mi renda ragione di quello che provo leggendolo. Sarà questo, poi, che cercherò di trasmettere al mio lettore per presentargli il testo di cui sto parlando. Nel farlo, dovrò anche esplicitare i miei presupposti ideologici del caso, perché pure loro sono oggetto dell’analisi.
Se non trovo la risonanza, posso decidere che il testo è banale, senza scampo; posso decidere che il testo è banale, con riserva – perché non sono certo del mio giudizio e dovrò, prima o poi, provare a tornarci su; posso decidere che non capisco, e sospendere il giudizio. Quello che personalmente, in ogni caso, mi rifiuto di fare è promuovere un testo solo perché ideologicamente mi è sufficientemente vicino; se si trattasse di un testo critico, questa sarebbe invece, ovviamente, la cosa che conta di più – ma per un testo artistico non è una condizione sufficiente.
Questo metodo non è esente da errori. Per quanto io cerchi di affinare la mia sensibilità, posso trovarmi oggi in sintonia con testi che magari in seguito riconoscerò come banali, o non trovare sintonia con testi che in seguito mi si imporranno come interessanti. Mi è già successo e mi succederà ancora. Per questo è poi così importante la successiva fase di analisi ed esposizione, che costringe a riflettere sulla sensazione iniziale.
Ma questo metodo mi mette un po’ di più al sicuro dagli aspetti peggiori di una visione storicista del mondo, ovvero dal ritenere che ci sia una linea evolutiva vincente, progressiva, rispetto ad altre perdenti e regressive, e che sia la mia. Questo è stato (tra gli altri) il male del materialismo storico e il male delle avanguardie, che ha gettato forti ombre anche sul bene che materialismo storico e avanguardie hanno comunque portato. In altre parole, cerco di sfruttare il fatto di non essere un io, ma – come tutti – una costellazione di io che trovano, ciascuno, il proprio momento di espressione, per ritrovare in me delle differenze di giudizio e di impostazione ideologica che mi permettano di capire e di trovare risonanza anche al di là dell’accordo ideologico.
Una critica di questo genere segnalerà dunque la rilevanza di un testo, ma cercando di fornire al lettore ragioni per trovare a sua volta la risonanza che il critico ha trovato. Poi, certo, il lettore è libero; ed è diverso da me. Posso tentare di essere tanti. Non posso sperare di essere tutti.
30 Novembre 2011 | Tags: calligrafia, comunicazione visiva, Huai Su, improvvisazione, Jackson Pollock, musica, optocentrismo, pittura, progetto, sistemi di scrittura, Zhang Xu | Category: comunicazione visiva, estetica, musica, sistemi di scrittura |  Zhang Xu, VIII secolo, esempio di Kuang Cao, o corsivo selvaggio Mi domanda uno studente se non ci sia qualche relazione tra l’action painting di Jackson Pollock (cui ho già dedicato in questi giorni due post, qui e qui) e la calligrafia cinese. Gli rispondo che non ho notizie precise in merito, ma la cosa mi sembra ugualmente piuttosto probabile, soprattutto pensando a Zhang Xu, un calligrafo dell’VIII secolo, perché queste cose girano da tempo in Occidente – e senza arrivare a questo estremo di precisione, basta considerare l’importanza del giapponismo e la presenza costante dell’immaginario visivo giapponese, calligrafia artistica compresa (il Giappone non è la Cina, certo, ma le loro tradizioni calligrafiche sono molto vicine).
Poi faccio una ricerca rapida sul Web e trovo qua e là dei riferimenti non documentati, secondo i quali Pollock si sarebbe ispirato a Huai Su (il discepolo di Zhang Xu) e avrebbe dichiarato pubblicamente i propri debiti nei confronti della calligrafia cinese. Da nessuna parte mi viene fornito un riferimento preciso, per cui le propongo per come le ho trovate, mettendoci davanti un bel “è possibile che…”, “è plausibile che…”.
Non mi interessa in verità approfondire di più, dal punto di vista storico. Che Pollock sia arrivato alla propria procedura su ispirazione dalla calligrafia cinese (o giapponese) oppure che ci sia arrivato per altre vie, comunque la somiglianza formale tra le due procedure e i loro risultati esiste. Quello che mi colpisce è che mentre in Occidente questo modo di procedere appare come una novità del XX secolo, in Cina è invece una procedura antica e tradizionale, oggetto di innumerevoli aneddoti (come la storiella del pittore, dell’imperatore e del granchio riportata da Calvino nella sezione “Rapidità” delle sue Lezioni Americane). E in ogni caso, anche se davvero Pollock si è ispirato alla procedura cinese, bisognava che lui stesso e l’ambiente che lo riceveva fossero pronti ad accogliere un approccio davvero diverso da quello normale per noi.
 Huai Su (725-dopo il 777) Esempio di Kuang Cao, o corsivo selvaggio La novità di Pollock in Occidente non sta tanto nella priorità data alla fluidità e continuità del gesto, quanto nel fatto che l’opera, il dipinto, propone di essere visto più come un indizio della danza creativa che l’autore ha effettuato nel comporlo, che non come una composizione plastica. Naturalmente non è che la composizione nei suoi dipinti sia irrilevante, così come non era irrilevante, per la pittura occidentale prima di Pollock, la natura indiziale dei tratti di colore per ricostruire la manualità del pittore. Quello che cambia, con Pollock, è il maggiore o minore rilievo da attribuirsi all’una o all’altra: quando guardiamo un dipinto, poniamo, di Kandinsky, è certamente molto più importante comprenderne la composizione, che non analizzare le pennellate per vedere come l’autore si sia mosso nel realizzarla. In Pollock succede invece il contrario, e nel corsivo selvaggio dei calligrafi cinesi pure.
Questa differenza evidente ne sottende una più profonda, che riguarda il senso stesso della comunicazione espressiva: la potremmo descrivere come una differenza tra progettazione e improvvisazione. Questa opposizione, in Occidente, ci è tradizionalmente familiare in un contesto piuttosto piccolo, che contiene sostanzialmente la musica e il teatro, ed è dunque soltanto lì che possiamo facilmente analizzarla nel dettaglio. Tutte le altre arti, infatti, si basano su un supporto statico (o realizzano opere statiche, come la scultura o l’architettura); mentre la musica si manifesta soltanto nel divenire dell’esecuzione e dell’ascolto, e il teatro nel divenire della performance. Ma il teatro ha praticamente da sempre una sua versione scritta, e da oltre mille anni pure la musica può essere registrata su un supporto statico.
 Jackson Pollock, Red Painting 1, 1950 È per questo che la dialettica tra progetto e improvvisazione caratterizza in maniera sostanziale queste due arti, per le quali il supporto statico è soltanto un espediente mnemonico (e progettuale), ma che vivono sostanzialmente della propria natura dinamica nell’atto stesso del proprio realizzarsi di fronte al pubblico.
Prendiamo la musica, nella sua versione colta. L’a solo improvvisato (o cadenza) è una costante dei concerti per strumento e orchestra dal Settecento in poi, almeno sino a quando il fossilizzarsi della tradizione non lo trasforma a sua volta in un pezzo scritto, spesso da parte dell’autore medesimo del concerto; così che la libertà dell’esecutore si riduce alla scelta di una cadenza piuttosto che di un’altra. La musica colta occidentale è dunque nel corso della storia sempre più scritta, più progettata a monte. È solo nel momento in cui il jazz assume i caratteri della musica colta che il momento dell’improvvisazione torna in gioco, e ritorna legittimo nell’ascolto la comprensione della musica come tramite di uno stato del momento.
Per quanto la scrittura permetta alla musica di raggiungere livelli di complessità impensabili in sua assenza, configurando la partitura come progetto preciso di un’esecuzione, c’è qualcosa di cruciale che viene perduto in questo. L’idea della musica come progetto si basa su, e insieme sostiene, una concezione formalistica, plastica, del flusso musicale, mettendo in secondo piano gli elementi di compresenza, compartecipazione, consonanza tra i partecipanti – quegli stessi elementi che vengono invece enfatizzati dalle performance improvvisative.
 Jackson Pollock, Collage and Oil, 1951 Ma poiché la musica comunque non si risolve nella sua dimensione scritta, e comunque richiede di essere eseguita, essa non è mai del tutto riducibile alla propria costruzione formale, e le componenti gestuali, dirette, del momento, che caratterizzano l’esecuzione, non smettono mai di avere importanza.
In questa prospettiva di carattere optocentrico, è chiaro come invece la comunicazione visiva possa davvero interamente risolversi nella costruzione formale – poiché non c’è necessità di alcuna trasformazione successiva, che possa metterla in discussione. Ciò che Pollock e i calligrafi cinesi hanno in comune è dunque proprio una certa riduzione dell’optocentrismo, a vantaggio di una valutazione del segno grafico che ha aspetti di tipo musicale, poiché mette (tendenzialmente) in sintonia il gesto del fruitore (che segue l’andamento) col gesto dell’autore (che lo ha creato).
 Jackson Pollock, Number 23, 1948 Dovremmo assumere, in questa prospettiva, che la cultura cinese sia tradizionalmente meno optocentrica della nostra, visto che mentre da noi si tende a una concezione visiva anche del sonoro, in essa vi sono tracce di una concezione di carattere musicale anche del visivo. Da noi, la valorizzazione dell’improvvisazione al di fuori del campo musicale (e teatrale) si fonda sulle conseguenze di una concezione romantica dell’arte come espressione dell’io, o della sua variante surrealista dove al posto dell’io viene messo l’inconscio. Ma è difficile postulare qualcosa di simile per la Cina dell’ottavo secolo – tanto più che questa concezione non è affatto necessaria per valorizzare l’improvvisazione.
Magari è solo perché i Cinesi non hanno avuto Platone, e la scrittura è rimasta manifestazione della parola senza che la parola dovesse identificarsi col pensiero razionale, o logos. In principio c’era altro, evidentemente, là.
 Zhang Xu - Four poem calligraphy copybook
 Jackson Pollock, Autumn Rhythm, 1950 Restiamo ancora su Pollock, e – come si è detto l’altra settimana – sulla sua riformulazione della comunicazione della pittura attraverso il maggior peso attribuito al gesto piuttosto che al suo prodotto, o meglio, spingendo a interpretare il segno grafico più come indice (indizio) del gesto che come segno visivo (plastico e/o figurativo). Il lettore modello del dipinto di Pollock sarebbe dunque colui che legge l’intreccio delle linee come rinvio alla danza creativa dell’autore, un po’ come un a solo improvvisato, estremamente libero in linea di principio, ma, via via che l’operazione creativa procede, progressivamente sempre più vincolato dalle proprie scelte precedenti, in armonia e in contrappunto con i percorsi già registrati.
Nata in epoca di psicoanalisi come scienza nuova, come nuova spiegazione del mondo, la pittura di Pollock, se vista in questo modo, può essere certamente interpretata come una sorta di scrittura dell’inconscio e dei suoi ritmi, una sorta cioè di scrittura automatica, alla Breton. Quando si parla di scrittura dell’inconscio o scrittura automatica, non bisogna tuttavia pensare a una sorta di sfogo di forze brute, di pulsioni primordiali che escono e magicamente prendono forma visiva (o verbale). Indubbiamente il principio surrealista dell’automatismo può essere inteso anche così, cioè come una versione più moderna e più estrema dell’idea romantica dell’arte come espressione dell’io, una versione in cui all’io si è sostituito quello che gli sta sotto, in una ricerca di autenticità ed espressività ultima – nell’ipotesi, di matrice rivoluzionaria, che quello che gli sta sotto sia comunque eversivo, antiborghese, antinormale, unheimlich.
Eppure questa ipotesi, per quanto fascinosa essa sia, si trova falsificata dai fatti. L’automatismo surrealista ha dato vita certamente a molti testi interessanti, che rimangono tali anche a distanza di anni; ma ha prodotto pure una quantità di testi noiosi, banali e per niente rivoluzionari, segno o che il processo automatista non è sufficiente in sé a tirar fuori l’essenza sovversiva dell’inconscio, oppure che l’inconscio è in sé assai meno sovversivo di quanto si possa pensare.
La mia sensazione è che il principio surrealista dimentichi almeno una metà dei fattori in gioco, e che sia davvero in questo senso una propaggine (certamente un po’ deviante) dell’idea romantica dell’arte come espressione – non dell’io ma di quello che gli sta dietro: sempre di espressione, però, si tratta. Quello che Romantici e Surrealisti sembrano dimenticare è che un prodotto artistico è inevitabilmente un prodotto comunicativo, e che quindi mette in gioco (almeno) due parti; e la parte che riceve (cioè il fruitore) non è meno importante della parte che produce.
Un’opera che si vuole artistica che non riesca a trovare il proprio fruitore è infatti un’opera fallita (chiamatela – come si usa – brutta, noiosa, priva di interesse). Poco importa che essa intenda esprimere un inconscio sovversivo: alla fine dei conti non c’è niente di meno sovversivo del non sapere uscire da se stessi, del non sapere risvegliare l’interesse di qualcun altro.
Se non si arriva a produrre un qualche tipo di accordo, di consonanza, tra l’opera e il suo fruitore, un accordo o consonanza che renda possibile da parte di quest’ultimo un interesse e un conseguente lavoro di interpretazione, l’opera rimane muta e inutile (brutta, noiosa, priva di interesse…). E allora il punto non è se l’automatismo in sé come metodo funzioni, bensì semmai, visto che a volte funziona, perché succeda questo, e che cosa distingua un automatismo dall’altro, l’automatismo che produce opere interessanti da quello che produce banalità.
La risposta facile a questa domanda è che l’autore dell’opera apprezzabile, in qualche modo, abbia barato. In altre parole che abbia coscientemente e volontariamente utilizzato strutture comunicative tradizionali in modo da rendere più facilmente trasmissibile il suo discorso. In questa prospettiva il fruitore troverebbe l’accordo con il testo attraverso la familiarità di tali strutture, e sarebbe questo a permettere all’opera di esistere davvero, di vivere la sua vita comunicativa, permettendo a qualche fruitore di entrare in consonanza con lei, e di apprezzarla.
È probabile che molte opere surrealiste siano davvero costruite in questo modo, mediando l’automatismo attraverso un progetto che, in quanto tale, non ha nulla di automatico; e non ci sarebbe niente di male in questo. Si tratta certamente di un tradimento del principio surrealista, ma a noi fruitori interessa il risultato, e non la coerenza con un principio (discutibile) di poetica. L’arte si è sempre basata su strutture comunicative condivise, e non potrebbe essere altrimenti: che l’automatismo surrealista non sia che una rivoluzione parziale, molto meno influente di quanto pretenderebbe di essere, non è cosa che debba stupire, anche al di là delle dichiarazioni programmatiche delle avanguardie, le quali tipicamente esagerano – enfatizzando il fulcro dell’area di rottura con la tradizione – per ragioni di propaganda e autoaffermazione.
Eppure i dipinti di cui parliamo non sembrano situarsi nell’ambito di questa risposta facile. O ipotizziamo infatti in Jackson Pollock la presenza di una razionalità progettuale a monte, di una lucidità straordinaria, capace di guidare consapevolmente l’espressione del suo inconscio attraverso le strette di qualche principio compositivo assestato e riconosciuto, oppure la soluzione del controllo volontario per lui non regge. E non regge proprio perché parte del fascino dei dipinti di Pollock sta nella sensazione che il progetto a monte non ci sia affatto, e che la costruzione dell’accordo con il fruitore (con me che guardo) non si basi su quello. Se si fosse basato su quello, inoltre, cioè se il lavoro di Pollock fosse stato quello di un montaggio consapevole e progettuale di pulsioni inconsapevoli, non si spiegherebbe la sua sopravvenuta incapacità di produrre – per cui da un certo momento in poi l’autore smette di dipingere, portando a motivazione di questo il fatto che non troverebbe più il ritmo, non sentirebbe più la musica interiore che prima lo faceva danzare.
C’è allora un’altra soluzione al nostro problema, forse meno gratificante per Breton e compagnia, ma – mi pare – più ampiamente esplicativa. L’inconscio, io credo, non è affatto un blob destrutturato e potenzialmente sovversivo. Se lo intendiamo nel senso più della prima che della seconda topica freudiana (cioè come un magazzino profondo di esperienze, sia fattive (operative) che narrative, sia naturali che culturali, e non soltanto come il rifugio profondo del rimosso) l’inconscio conterrà anche le strutture, le forme, i ritmi, della natura come delle produzioni culturali e artistiche, e un automatismo autentico porterà alla luce inevitabilmente pure quelli.
Per questo poi molti testi automatici sono, alla fin fine, semplicemente banali: nell’ipotesi che l’automatismo porti a galla alla cieca dei brandelli di quello che si trova sotto, non è affatto detto che questi brandelli debbano essere sovversivi. Se l’inconscio è un magazzino generale dove si pesca a caso, se ne può portare a galla tanto la pulsione di morte quanto i ritmi di Carosello; ovvero tanto il diverso quanto l’uguale a quello che gli sta sopra. L’idea dell’arte intesa fondamentalmente come espressione di questo pre-io è sbagliata tanto quanto l’idea dell’arte come espressione dell’io: la banalità rimane in agguato nell’uno non meno che nell’altro caso.
Magari un filtro cosciente anche nel lavoro di Pollock c’è, come è auspicabile che ci sia: un’attenzione, cioè, a limitare l’emersione o l’espressione delle istanze più banali, troppo facili, troppo ovvie; quelle che renderebbero l’opera ininteressante, noiosa. A Pollock, come ai testi surrealisti riusciti, va riconosciuta questa capacità consapevole; la quale non è, però, in sé ancora un progetto, e non basta, da sé, ad assicurare la qualità del risultato. Sono tanti al mondo i filtratori attenti e responsabili della propria produzione che hanno finito per non rilasciare nulla nel corso della loro vita, perché tutto quello che usciva da loro appariva a loro stessi banale!
Io credo piuttosto che il genio automatista di Pollock stia nel fatto di avere interiorizzato profondamente, di avere reso inconsce, anche le regole, le buone forme, permettendo loro di uscire allo scoperto già amalgamate con il resto. Il contributo formale, cioè – filtraggio delle banalità a parte – non è qualcosa che venga esercitato razionalmente e coscientemente: è insito, piuttosto, nell’espressione stessa.
Quando uno strumentista musicale improvvisa, non si trova da solo: ha il feedback di un pubblico, e un immenso sistema di regole interiorizzate che lo guidano. Il solista di scarsa qualità non è meno in contatto con il proprio inconscio di quanto non lo sia – poniamo – John Coltrane: è il suo inconscio che è meno ricco, meno strutturato, più povero; o almeno è meno ricca la parte che riesce a esprimersi.
L’automatismo della produzione di Pollock richiede una ricchezza interiore straordinaria, e una straordinaria familiarità con le strutture culturali del visivo, comprese quelle tradizionali. Quello che emoziona, nel guardare un suo dipinto, è la continua comparazione tra il risultato formale, di grande equilibrio, e la danza convulsa, protratta, dionisiaca, che l’ha prodotto, e che si trova registrata nei percorsi del colore. Pollock ci conquista perché produce in noi l’idea che la mediazione razionale, costruttiva, progettuale, tra l’opera e noi sia ridotta al minimo, e il suo è davvero un automatismo; ma questo automatismo ha come prodotto un universo ricchissimo.
Pollock, nel dipingere i suoi quadri, ha insomma danzato con noi; e noi nel guardarli danziamo con lui, accorgendoci di quale straordinario danzatore fosse, di quanto ricca fosse la sua interiorità, e di conseguenza di quanto ricca sia la nostra, visto che siamo capaci di seguirlo. Nell’accordo che l’opera di Pollock in questo modo produce, noi riconosciamo (per tramite collettivo) la nostra stessa ricchezza profonda. L’automatismo di Pollock funziona perché rende non tanto il suo specifico inconscio, ma il nostro, e il mio, quello insomma che ci costruisce, nella nostra cultura, come persone, come soggetti, o anche solo come parte di un tutto collettivo.
 Il linguaggio della poesia .
Non posso negare un poco di emozione. Ieri sera, nel tornare a casa ho trovato un pacco con le copie di spettanza del mio nuovo libro. Ho controllato nelle librerie on line, ed è già in vendita. Non sono riuscito ad andare a vedere in quelle tradizionali, ma se ancora non c’è è questione di giorni.
Per dare un’idea di che cosa si tratta, ecco qui di seguito l’Indice del volume e l’Introduzione. Se cliccate qui o sulla copertina a sinistra, potete vedere la scheda del libro sul sito Bompiani.
.

Introduzione
0.1. Linguaggio
Argomento di questo libro è il linguaggio della poesia. La parola linguaggio, certo, può essere intesa in sensi abbastanza differenti: quando si parla, per esempio, del linguaggio di Alessandro Manzoni si può fare riferimento alle sue preferenze lessicali e di costruzione sintattica; ma quando si parla del linguaggio dell’arte visiva, o del linguaggio della musica, stiamo evidentemente parlando d’altro. Si parla persino del linguaggio delle api, o del linguaggio del DNA – e non abbiamo la sensazione che si tratti di estensioni metaforiche dell’uso di questo termine.
È bene puntualizzare da subito che l’oggetto di questo libro non è il linguaggio della poesia nel senso delle sue scelte lessicali e di costruzione sintattica. Anche di questi aspetti, senza dubbio, si parla in queste pagine – ma è piuttosto l’altra accezione di linguaggio quella che ci riguarda, quella che avvicina il problema del linguaggio della poesia a quello del linguaggio dell’arte visiva, o della musica, o persino delle api.
Per dirla con le parole più semplici possibili, l’oggetto di questo libro è il modo in cui la poesia comunica, o agisce su chi la legge. Questo modo è legato anche al problema delle scelte lessicali e sintattiche, ma è ben lontano dal ridursi a questo, così come il problema del linguaggio delle arti visive non si può ridurre al problema della scelta dei colori e delle forme, né il problema del linguaggio musicale può ridursi al problema della scelta delle note.
Si potrebbe discutere a lungo se il linguaggio delle api contempli davvero l’uso di un codice. Da fuori, si direbbe che possa essere così. Ma, anche ammettendo che un codice vi sia, nessun linguaggio naturale, compreso quello delle api, si limita e può essere ridotto alla sua componente codificata. Quando pensiamo al linguaggio della musica lo vediamo con chiarezza: la musica comunica, non ci sono dubbi, ma la sua componente codificata è talmente ridotta che la maggior parte della comunicazione ne passa al di fuori.
Ferdinand de Saussure (1922) ha parlato, a suo tempo, di fenomeni di langue – cioè legati alla componente codificata, più strettamente linguistica, del discorso verbale – e di fenomeni di parole – cioè dipendenti dalla situazione contingente, dalla particolare combinazione specifica di parole. Il significato delle nostre comunicazioni verbali è costituito sia da elementi di langue che da elementi di parole, e dunque il nostro linguaggio verbale è basato sugli uni non meno che sugli altri.
Il linguaggio della poesia enfatizza questa componente, locale e idiosincratica, di parole. Fa uso della langue, evidentemente, in quanto fa uso delle parole della lingua, e quindi del loro significato codificato; ma si allontana da questa base molto, molto di più di quanto non faccia il linguaggio ordinario, e anche più di quanto non faccia la prosa letteraria.
Il nostro intento, in queste pagine, è vedere da vicino alcuni degli aspetti di questo linguaggio della poesia, che prende il via dall’uso consueto della parola e arriva lontano.[1]
0.2. Comprensione, emozione e ritmo
Questo libro si occupa dunque del leggere la poesia, non solo del comprenderne il senso. Quando leggiamo cerchiamo sempre di comprendere, ma non leggiamo testi solo per comprenderli – cosa che è vera, in diversa misura, per tutti i tipi di testo, ma è particolarmente vera per i testi che hanno finalità estetiche: tra questi la poesia possiede un ulteriore statuto particolare.
Per esempio, non leggiamo un romanzo solo per capirne il significato. Se non ne comprendiamo almeno a qualche livello il significato non lo stiamo in realtà nemmeno leggendo; e, certo, più a fondo lo comprendiamo e più intensa potrà essere la nostra esperienza di lettore. Ma se un romanzo non ci coinvolgesse emotivamente e non ci portasse con sé in un viaggio di sensazioni vivide e profonde, che ragione avremmo di leggerlo? Quanto ci importa dell’ideologia dei nichilisti russi di fine Ottocento? Il nostro scarso interesse per questo specifico tema non ci impedisce di leggere appassionatamente I demoni di Fedor Dostoevskij. E che a un gentiluomo francese vissuto circa un secolo fa sia un giorno capitato di mangiare un biscottino che ha scatenato la sua memoria e la sua ossessione grafomaniacale, è qualcosa di davvero interessante per noi? Non è davvero per sapere che cosa sia accaduto al signor Proust che leggiamo la Recherche.
Dostoevskij, come Proust e come ogni altro scrittore di qualità, non ha mai pensato di produrre un semplice resoconto di fatti di relativo interesse. Ciò che ha fatto, piuttosto, è stato costruire un meccanismo emotivo, basato su questi fatti, in cui il lettore si possa immergere, e possa vivere, anche se in forma surrettizia, un percorso emotivo, con risvolti cognitivi (si impara senza dubbio un sacco di cose anche leggendo romanzi) ed etici.
Della poesia si può dire lo stesso, però in misura ancora maggiore. Se un qualche interesse a priori per la storia russa o per la vita quotidiana francese di inizio Novecento possono talvolta costituire una ragione per leggere i romanzi di Dostoevskij e di Proust, non riesco proprio a immaginare perché mi dovrei interessare alle fantasie di un signorotto marchigiano di inizio Ottocento al guardare la siepe del suo giardino. E nemmeno trovo particolarmente interessante, in sé, il pessimismo leopardiano, che non è una filosofia di particolare originalità storica, e che nessuno si sarebbe preoccupato di studiare se non stesse alla base di alcune tra le poesie più straordinarie che siano mai state scritte.
Ancora più che il romanzo, la poesia costruisce dentro di sé le proprie ragioni di interesse per il suo lettore. Essendo più breve, mira a costruire un’esperienza emotiva più intensa, e per farlo utilizza le risorse del linguaggio in maniera estrema, rendendo pertinenti aspetti che normalmente non lo sono o lo sono poco. Proprio come il romanzo, poi, ma con maggiore intensità, anche la poesia ci insegna qualcosa, ma lo fa a partire dall’esperienza emotiva che induce nel suo lettore.
Questa collina solitaria mi è sempre stata cara, come pure quella siepe, che mi impedisce di vedere oltre. Eppure, se mi siedo e guardo, io mi immagino spazi senza fine al di là, silenzi eccezionali e una grande tranquillità, al punto che quasi mi spavento. E quando sento il vento muovere gli alberi, mi viene da fare il paragone tra questo fruscio e quel silenzio: e così penso all’eternità, al passato, al presente e ai suoi rumori. E in questo senso di immensità il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo.
Questo breve racconto segue evidentemente la falsariga del discorso di Leopardi ne L’infinito. Potremmo considerarlo come una parafrasi molto libera del testo originale. Probabilmente non tutto il fascino del componimento leopardiano si perde, e qualche ragione di interesse interno continua a sussistere – ma questo testo non sarebbe mai passato alla storia emozionando innumerevoli lettori. Senza l’emozione non si genera l’interesse, e senza interesse non ci può essere acquisizione cognitiva.
I meccanismi di sollecitazione emotiva ci interessano dunque per due ragioni: in primo luogo perché sono alla base di una migliore comprensione del significato del testo, e in secondo luogo perché non sempre possono essere ridotti a questo, e possiedono una propria autonomia e un proprio valore intrinseco.
C’è una situazione in cui il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo. Infatti, quando mi siedo di fronte a questa collina solitaria, a me molto cara, e guardo quella siepe che mi impedisce di vedere oltre, finisco per immaginarmi al di là di quella un’enormità di spazio e di silenzio, quasi spaventandomi per questo. Ma poi, se paragono queste sensazioni al suono del vento tra gli alberi, mi viene da pensare all’eternità e alle epoche, e provo un senso di immensità che mi fa smarrire.
Confrontiamo ora questo breve testo con la parafrasi dell’Infinito proposta appena sopra. Qui non si può più nemmeno parlare di parafrasi, per quanto libera; al più parleremo di “liberamente tratto da”. Entrambe le versioni condividono con l’originale il mero resoconto dei fatti, ma la prima è abbastanza fedele all’originale anche per l’ordine in cui i fatti vengono esposti, e per il risalto che viene dato a ciascuno di loro, mentre la seconda stravolge sia l’ordine che il risalto.
Per quanto poco conservi dell’esperienza dell’originale, la prima versione conserva di più della seconda, ed è in grado di produrre nel lettore un percorso emotivo che, per quanto molto più blando, assomiglia a quello dell’originale più di quanto gli possa assomigliare quello prodotto dalla seconda versione.
La prima versione ha infatti (parzialmente) in comune con l’originale non solo un percorso discorsivo-narrativo ma anche un ritmo discorsivo-narrativo e un sistema di tensioni. Gli eventi raccontati si succedono grosso modo con lo stesso andamento e con lo stesso specifico rilievo, e producono quindi nel lettore un andamento di interesse simile.
In poesia, tradizionalmente, quando si parla di ritmo si fa riferimento a una regolarità di andamento di carattere prosodico e fonetico (ovvero relativo al succedersi delle sillabe e dei loro accenti, nonché di suoni sufficientemente simili) o al massimo sintattico. Quando si parla di ritmo poetico, cioè, si fa tradizionalmente riferimento a eventi situati sul piano del significante (che la semiotica chiama, più propriamente, piano dell’espressione).
Il ritmo discorsivo-narrativo si pone invece sul piano del significato (che la semiotica chiama piano del contenuto) e non è un fatto specifico della poesia: qualsiasi discorso verbale possiede un ritmo dell’esposizione dei propri concetti, qualsiasi racconto ha un ritmo narrativo, cioè un andamento del modo in cui gli eventi arrivano alla ricezione del fruitore.[2]
Anche i ritmi prosodici, fonetici e sintattici non sono specifici della poesia; tuttavia, mentre nel discorso in prosa sono di solito semplicemente non pertinenti o poco pertinenti, in poesia la relazione di contrasto con la dimensione metrica (che è a sua volta una dimensione ritmica) li rende significativi e influenti. Il ritmo discorsivo-narrativo è influente in qualsiasi tipo di testo, ma in poesia esiste una relazione di contrasto con altri tipi di ritmo dell’espressione e del contenuto – come vedremo più avanti – che modifica e spesso magnifica questa stessa influenza.
Analizzare la poesia e la sua efficacia emotiva significa dunque considerare non solo la dimensione ritmica tradizionale e la sua relazione con il metro, ed eventualmente le modalità in cui queste interagiscono con la dimensione del significato, ma anche tutta una sfera ritmica della dimensione del significato che produce effetti sia sul significato stesso che sul coinvolgimento emotivo diretto del lettore.
A questo si aggiunge la comprensione del sistema di aspettative e tensioni messo in moto dalla poesia. Anche in questo caso, tutti i testi generano aspettative nel loro fruitore, ma la poesia lo fa con le sue specifiche modalità e i suoi specifici effetti.
0.3. Leggere, guardare, ascoltare
Il leggere è naturalmente diverso dal guardare[3]. Certo per leggere è necessario guardare, ma qualsiasi guardare che non comporta un leggere è un guardare che segue regole diverse dal guardare per leggere. Nella sua bella storia dell’arte tipografica, Warren Chappell caratterizza come segue la differenza:
Molti dei lavori più notevoli del Settecento, dalle Médailles dell’Imprimerie Royal del 1702 al Manuale tipografico di Bodoni, testimoniano di vere e proprie innovazioni tecniche: una migliore fusione e giustificazione dei caratteri, carta con superfici di stampa più omogenee, inchiostri migliori e migliore impressione. La stampa assunse l’aspetto dell’incisione a un livello stupefacente. La tendenza era iniziata con le grazie artificiali del romain du roi di Grandjean per raggiungere piena espressione nelle lettere drammatiche e rigide di Bodoni e di Firmin Didot. Tali forme sono meravigliosamente immobili. Il carattere e la pagina chiedono di essere ammirati – cioè guardati – e in ciò niente di male, se non fosse per il fatto che guardare e leggere sono due azioni piuttosto diverse, anzi in contraddizione. Siamo legati a quello che leggiamo da un movimento ritmico. Per guardare le cose, o le liberiamo lasciandole vagare, oppure le blocchiamo nel loro movimento. Guardando, tratteniamo il respiro oppure (nel peggiore dei casi) ansimiamo. Leggendo invece respiriamo. (Chappell-Bringhurst 2004:194)
La differenza principale tra leggere e guardare è una differenza ritmica. Leggendo, respiriamo, ovvero seguiamo un percorso impostato in maniera più o meno diretta sui ritmi del respiro. Guardando, viceversa, seguiamo un percorso più o meno arbitrario a seconda del caso, ma in ogni caso del tutto indipendente da qualsiasi impostazione ritmica, in particolare da quella del respiro.
Per dirla in un altro modo, la scrittura è sì qualcosa che si guarda, ma che non perde mai del tutto la relazione che intrattiene con la dimensione lineare e sonora della lingua parlata. E la lingua parlata è per sua stessa natura impostata sul respiro, è emissione di fiato, ritmata dalla necessità di inspirare l’aria necessaria per produrre i suoni delle parole. Come vedremo tra breve, questa ineludibile natura sonora della lingua agisce in qualche modo anche attraverso la scrittura, e riverbera sulla parola scritta le proprie qualità.
La scrittura è però comunque un fatto grafico, ancor prima che sonoro. Di sicuro nella scrittura poetica la dimensione sonora procrastina la propria scomparsa molto più di quanto non faccia nella prosa – eppure sappiamo bene quanto i testi prodotti per essere letti con gli occhi siano differenti da quelli prodotti per essere ascoltati! E la poesia è fatta per essere letta o per essere ascoltata?
In questo libro assumiamo che la poesia sia fatta prima di tutto per essere letta, ma che, di questa lettura, una sorta di “recitazione ad alta voce interiore” sia una parte così importante che anche l’ascolto vero e proprio può giocare il suo ruolo. Non a caso una gran parte delle pagine di questo libro è dedicata alla dimensione sonora evocata dal testo poetico.
Di sicuro, la poesia è uno strano ibrido: gran parte dei testi poetici sono così complessi da pretendere di essere letti, piuttosto che ascoltati, per poter essere capiti; eppure per loro tradizione e natura sono così legati alla propria sostanza fonica da pretendere l’ascolto, almeno virtuale. Anche se dedicheremo molte pagine a questa sorta di ascolto che la poesia mette in scena, la natura scritta della poesia comporta inevitabilmente una certa rilevanza della sua dimensione visiva, ovvero di un qualche guardare che non si risolva in un leggere.
La lunghezza media dei versi, la divisione in strofe, la posizione sulla pagina, sono elementi tradizionali del testo poetico che non hanno necessariamente un effetto diretto nella dimensione sonora. Quando Stéphane Mallarmé scrive il suo Coup de dés[4], distribuendo graficamente i suoi versi sullo spazio bianco della pagina, sta sviluppando una possibilità che esiste da quando la poesia è sostanzialmente una testualità scritta. Nessuna recitazione del poemetto di Mallarmé può esprimere compiutamente la differenza tra la sua impaginazione e quella tradizionale. Quindi, l’impaginazione ha un valore visivo proprio, indipendente dalla qualità sonora della poesia, un valore che dipende da un guardare che, pur se accompagnato da un leggere, non si risolve in quel leggere.
All’esperimento di Mallarmé ne faranno seguito tanti, nel corso del Novecento, sino al costituirsi di una vera e propria poesia visiva, spesso molto più da guardare che non da leggere – anche se la componente della lettura non scompare mai del tutto.
Questa dimensione puramente visiva, legata al guardare, secondaria ma non assente nella poesia tradizionale e talvolta primaria nella poesia più recente, richiede di essere esplorata. Anche la componente visiva, cioè, contribuisce al significato di un testo poetico e alla sua sollecitazione emotiva. La natura ambigua della parola scritta costituisce un campo di possibilità espressive che la poesia può sfruttare, anche quando gioca soprattutto sull’evocazione della dimensione orale.
0.4. Immersivo vs frontale
Per capire la rilevanza specifica della dimensione orale, è necessario approfondire un poco le conseguenze delle differenze percettive che esistono tra visione e ascolto[5].
La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui.
Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona.
Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato.
Attraverso lo scambio di suoni un animale non si limita a segnalare ai suoi simili la propria presenza, o a comunicare la presenza di un pericolo o la propria disponibilità sessuale. Nelle specie più evolute il suono può essere usato a scopo empatico. Le vibrazioni sonore della madre possono ricreare la sensazione di unione che il piccolo ha perso con la nascita, e calmare il suo pianto o la sua paura; con le grida si può trasmettere l’eccitazione o la stessa paura, e comunque rafforzare il senso di appartenenza a una comunità, con la quale, appunto, ci si trova in sintonia.
Non c’è ragione di pensare che questa funzione empatica si perda quando nella specie umana il suono si evolve in linguaggio. Il comprendere il significato delle parole non inibisce il nostro vibrare al loro suono. Analogamente abbiamo ragione di pensare che la musica stessa nasca da un raffinamento delle potenzialità di questa dimensione compartecipativa su base immersiva.
Come vedremo meglio poco più avanti (par. 1.1), la musica non nasce per essere ascoltata, bensì compartecipata e vissuta, con un atteggiamento che ha caratteri simili a quelli che accompagnano il rito. La danza e la cerimonia sono i contesti in cui per molti secoli la musica viene eseguita, a cui si potrebbe aggiungere la dimensione empatica diretta del canto su base poetica. In questi contesti non esiste un ascoltatore come lo pensiamo oggi, posto di fronte alla musica in un’attività solo ricettiva-interpretativa. Nella danza come nella cerimonia – situazioni tradizionalmente rituali – la musica è il fattore socialmente unificante, è cioè il ritmo, l’andamento nel quale la collettività si può riconoscere come collettività.
In questa dimensione sostanzialmente immersiva, al suono, specie se prodotto dalla voce di qualcuno, non viene attribuita una funzione di informazione sul mondo come accade per l’immagine. Il suono è soprattutto latore di una funzione di consonanza, attraverso l’eventuale sintonia con chi lo produce o con gli altri che lo stanno percependo insieme a me: stiamo vibrando insieme, ondeggiando insieme, sentendo insieme.
L’andamento della vibrazione può finire per corrispondere all’andamento di sensazioni ed emozioni. Queste sensazioni ed emozioni possono essere comuni, compartecipate, condivise da tutti i presenti. E se questo andamento sonoro ed emotivo si accompagna a un discorso, per esempio sviluppato attraverso quelle stesse parole che sono state espresse con i suoni, inevitabilmente questo discorso verrà interpretato all’interno della dimensione sonora, sensitiva ed emotiva, e al senso di compartecipazione creato dai suoni.
Come vedremo in questo libro, la poesia ha una relazione complessa con la dimensione sonora, che necessita di un’analisi precisa. Tuttavia, pur con i limiti che vedremo, questa dimensione sonora è presente e determinante per la fruizione del testo poetico.
In altre parole, la fruizione di un testo poetico non si esaurisce nella sua comprensione. Benché la comprensione sia necessaria, l’esperienza del lettore di poesia non è fatta solo del capire quello che il testo gli sta dicendo. La poesia non è solo un discorso complesso e fascinoso, che sfrutta dimensioni del senso che la parola normalmente ignora: è anche l’occasione per un’esperienza immersiva, compartecipativa, rituale, con caratteristiche orfiche.
Capire le modalità di questa esperienza ci permette, in molti casi, anche di raggiungere un ulteriore livello di comprensione del testo poetico, e a sua volta questa comprensione può mettere in moto ulteriori risonanze orfiche, con un meccanismo che, nei casi più felici, davvero non si interrompe mai. Che continuiamo oggi a studiare Dante, Catullo, Saffo, a tanti secoli di distanza, è la dimostrazione che esistono testi poetici inesauribili, destinati a produrre nuove significazioni e nuove emozioni ogni volta che si confrontano con un’epoca nuova.
0.5. La questione della lirica
È ormai un luogo comune osservare che, dei diversi generi in cui era tradizionalmente divisa la poesia, solo la lirica è rimasto in auge, e che, di fatto, il campo della lirica oggi corrisponda a quello della poesia. La lirica è la poesia di espressione soggettiva, quella al centro della quale c’è un io, un io lirico, ingenuamente identificato di solito con l’io del poeta.
Ma non c’è bisogno di un io manifesto perché la poesia sia lirica. L’espressione può essere benissimo soggettiva anche se si sta utilizzando la terza persona. Il soggettivismo[6], cioè la tendenza a mettere il soggetto al centro del componimento poetico, si può esprimere anche, per esempio, attraverso la scelta di una forma metrico-ritmica particolare, al di fuori delle regole costituite. In questo senso, la nascita e lo sviluppo del verso libero a fine Ottocento è una conseguenza del dominio della lirica, perché il verso libero è quello attraverso cui il poeta esprime la propria soggettività anche nella forma metrica – che stia esplicitamente dicendo “io” oppure no.
Se vediamo le cose in questi termini, praticamente tutta la poesia del Novecento può essere vista come lirica, compresi i tentativi di riduzione dell’io, cioè i tentativi di costruire una modalità poetica che non si presenti come espressione del soggetto[7]. Il luogo comune che riduce la poesia a espressione spontanea della soggettività individuale è a sua voglia un figlio ingenuo di questa prospettiva. Ne riparleremo nelle ultimissime pagine.
Due cose vanno osservate a proposito del predominio della lirica. La prima è che esso corrisponde sì, certamente, a un imporsi del valore dell’individuo e del soggetto nella nostra società degli ultimi secoli[8]; ma all’interno di questo medesimo soggetto, la psicoanalisi e l’antropologia hanno situato delle aree che non gli appartengono affatto, e sono piuttosto sociali, condivise. Anche per questa acquisizione (o perdita intrinseca di soggettività, se preferiamo), la soggettività di oggi può pretendere di esprimere l’universale, visto che, in fin dei conti, essa ce l’ha, volente o nolente, dentro di sé.
La seconda è che la dimensione lirica si deve comunque confrontare con quella immersiva, rituale, di cui stiamo parlando in questo libro; e quindi confluire in un senso di condivisione sovra-soggettivo. Se non facesse questo, non sarebbe nemmeno riconoscibile come poesia.
0.6. Questo libro
Questo libro cerca di descrivere l’esperienza della fruizione poetica. Per fare questo deve parlare sia della dimensione discorsiva del testo poetico – che dipende dalla sequenza delle parole (proprio come nella prosa) ma anche dalle interazioni tra questa sequenza e una serie di caratteristiche specifiche della poesia – sia della sua dimensione immersiva, partecipativa, orfica. Questa seconda dimensione si articola in sistemi di ritmi e di tensioni che si manifestano sul piano dell’espressione come anche sul piano del contenuto: ritmi e tensioni morfologiche e sintattiche, ma anche ritmi e tensioni semantiche e narrative.
Inizieremo (cap. 1) parlando della fruizione musicale, cercando di definire che cosa caratterizzi l’esperienza sonora, quando è diretta a testi di carattere estetico. Questo ci sarà utile per capire subito dopo quale sia lo specifico sonoro della poesia; e su questo quadro di fondo esploreremo le caratteristiche del metro e del ritmo prosodico. Ma questa stessa comprensione ci sarà utile, nel capitolo successivo (cap. 2), anche per capire che cosa siano e come si manifestino i ritmi semantici e narrativi.
Un capitolo (cap. 3) sarà dedicato alla costruzione del discorso in prosa, ricercando al suo interno una serie di aspetti (alcuni anche di carattere emotivo) di cui pure la poesia fa uso. Ritroveremo questi aspetti anche nel capitolo 4, dedicato alla costruzione del discorso poetico, ma sarà a questo punto centrale la loro interazione con gli aspetti specificamente poetici che sono stati descritti nei capitoli precedenti.
Incominceremo ad avere, a questo punto, un quadro abbastanza dettagliato della situazione, e potremo permetterci di mettere in gioco (cap. 5) quegli elementi, puramente visivi, che non hanno nessuna relazione diretta con la dimensione sonora. La scrittura ha una sua specificità, come ce l’hanno una serie di aspetti visivi presenti da lungo tempo in poesia. Esiste però anche una poesia fortemente basata sulla dimensione visiva, cui è necessario dedicare uno spazio.
Nell’ultimo capitolo (cap. 6) cercheremo quindi di descrivere la fruizione poetica nella sua complessità, tracciando alcune linee di un’estetica poetica, con un accenno finale alla dimensione dello scrivere.
[1] Vedi il par.3.1, per un’espansione di questo discorso.
[2] Sui ritmi del contenuto, vedi sotto Cap. 2. Più in generale, su ritmi e tensioni nei testi, narrativi e non, cfr. Barbieri(2004).
[3] Al rapporto tra leggere e guardare nella comunicazione visiva (poesia visiva e poesia concreta incluse) ho dedicato il volume Barbieri (2011).
[4] Vedi sotto, par.5.2.1.
[5] Ho dedicato a questo tema diversi articoli (Barbieri 2008, 2009 e 2010), ma la problematica nasce in Ong (1967 e 1982). Per quanto riguarda la musica si trova affrontata anche in Piana (1991), in Capuano (2002) e in Sparti (2007).
[6] O meglio, quello che Guido Mazzoni (2005) chiama piuttosto espressivismo.
[7] Per lo sviluppo di questa tesi, vedi ancora Mazzoni (2005). L’espressione “riduzione dell’io” è invece di Alfredo Giuliani (1965), nell’Introduzione 1961 all’antologia de I Novissimi.
[8] Su questo tema, oltre a Mazzoni (2005) vedi anche Ferry (1990).
.
 Miles Qualche giorno fa, leggendo questo post di Sergio Pasquandrea, mi è venuto voglia di riascoltare Miles Davis. Con la musica di Miles ho uno strano rapporto. E non posso farci niente: ci ho già provato un sacco di volte. Insomma, finché suona il jazz tradizionale lo trovo noioso; non saprei neanche dire perché; so solo che la sua musica non mi prende, scorre su di me senza trovare appigli. Certo che come trombettista è bravo, ma è come se lui e io stessimo parlando lingue diverse: io sento che è fluente, e che può piacere, ma non capisco niente. Nei pezzi per il quartetto degli anni Cinquanta poi, quando ha al suo fianco il giovane Coltrane, la cosa mi diventa ancora più evidente, perché mi rendo conto che appena Coltrane attacca a suonare, di colpo sono tutto orecchi.
Poi c’è la svolta della fine dei Sessanta, e il mezzo milione di copie vendute di Bitches Brew, l’invenzione della fusion e le grida al tradimento, alla deriva commerciale. Bah. Sta di fatto che per me, Miles nasce con questo disco, che trovo straordinario – e gran parte di quello che ha fatto dopo mi piace da morire – al punto che non capisco bene come possa lo stesso musicista produrmi sensazioni così diverse.
Ora, io non sono un esperto di jazz e non ho nessuna pretesa di dire in merito qualcosa di interessante. Probabilmente c’è solo qualcosa che non capisco nel Miles classico, e sarei ben contento se qualcuno mi fornisse gli elementi per capire. A capire e a saper apprezzare c’è sempre solo da guadagnarci.
Quello, piuttosto, che sempre mi ha colpito, è l’anatema lanciato a suo tempo contro il Miles elettrico, e l’accusa di essere commerciale, di essersi venduto al successo. Mi colpisce, questa accusa, perché tradisce un certo atteggiamento purista che attraversa un po’ tutta la critica, di tutti i contesti, linguaggi e generi – con il correlato frequente di un atteggiamente contrario a quello che ho appena espresso, cioè il non voler apprezzare. Sembra quasi che il Miles del dopo la svolta non possa certamente fare della buona musica, perché siccome ha avuto successo commerciale quello che fa è necessariamente cattivo. Posso capire che il successo commerciale possa ingenerare dei sospetti sulla qualità, e che quello che ha avuto successo commerciale possa essere, abbia qualche probabilità in più, di essere cattivo. Ma poi le orecchie le abbiamo. I sospetti sono giustificati, ma solo finché non si tocca con mano come stanno le cose.
Eppure, stranamente, l’atteggiamento purista non solo esiste, ma è incredibilmente diffuso in tutti i contesti, e l’incapacità di apprezzare quello che esce dagli schemi è dilagante. Credo che contribuisca alla diffusione di questo atteggiamento anche un fraintendimento, sempre di origine aristocratica e adorniana come l’atteggiamento in sé: quando si parla di schemi (e dell’uscirne) sembra infatti che si parli necessariamente di industria culturale (e delle produzioni alternative, di nicchia, d’avanguardia, controcorrente). L’industria culturale ha i suoi schemi, certo, a cui di solito si deve adeguare un prodotto per essere commerciale; ma anche ciascuna delle sue alternative ce li ha (ce li hanno le produzioni alternative, quelle di nicchia, le avanguardie, l’essere controcorrente…). In una situazione di nicchia come quella del jazz degli anni Sessanta (una nicchia non troppo piccola, certo, ma sicuramente con le sue regole e il suo pubblico – e quindi i suoi schemi), andare verso il rock è certamente fare quello che non si deve fare, e quindi rompere lo schema.
Ora, essere puristi in una situazione di questo tipo vuol dire ritenere più importante lo schema dei risultati che si possono avere rompendolo. E questo non è un atteggiamento incomprensibile. Il rischio dell’operazione di Miles è quello – e tanto più se ha successo – di distruggere la nicchia; cioè, nello specifico, di distruggere il jazz, o almeno il jazz così come l’abbiamo amato sino a questo momento. La difesa dello schema è una difesa della casa in cui stiamo bene, che in qualche modo abitiamo, dove abbiamo amici con cui scambiamo opinioni, dove siamo riconosciuti e dove riconosciamo gli altri. Se la casa svanisce, come faremo? È per questo che la nuova musica di Miles, ancora prima che brutta, deve essere sbagliata, scorretta, intollerabile. In fin dei conti non abbiamo nemmeno bisogno di ascoltarla: questo è il senso dell’anatema.
Questo atteggiamento purista, di difesa degli schemi, non è una prerogativa di chi ama la tradizione. All’interno delle avanguardie, per esempio, è dominante. E tanto più piccolo è l’orto da salvaguardare, tanto più si sarà duri nel condannare ciò che ne fuoriesce; perché certo, se l’orto è piccolo, il pericolo che possa ridursi fino a scomparire è più grande, e sempre più grande.
Per la mia formazione e i miei interessi, io mi occupo di vari tipi di coltivazioni, tutti ambiti piuttosto piccoli, dove gli orti non hanno comunque modo di espandersi troppo. La varietà dei temi dei post di questo blog dà un’idea piuttosto chiara di quali siano queste coltivazioni. Tra loro, al giorno d’oggi, sicuramente la più piccola è quella del mondo poetico.
È la più piccola in termini quantitativi, di giro di affari e di visibilità pubblica, ma è anche quella che ha – e di gran lunga – la tradizione più antica. Questo produce un effetto paradossale: il prestigio dell’essere un poeta apprezzato non consiste tanto nel guadagno o nell’esposizione mediatica (quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Milo De Angelis, per esempio?), ma nel potersi presentare, prima di tutto a se stessi, come qualcuno che è riconosciuto come appartenente alla stessa tradizione di Omero, Dante, Leopardi e Montale. Si tratta di un prestigio virtuale, in termini commerciali, ma estremamente reale e vincente in termini psicologici. Il poeta di oggi riconosciuto grande nel suo ambito non sposta una virgola a livello di cultura dominante, ma per chi lo conosce (e per se stesso, di conseguenza) il suo prestigio è enorme, superiore a quello di un famoso regista, o di una rockstar.
Questo enorme prestigio è però legato alla dimensione minuscola della coltivazione, e a quella microscopica dell’orto di riferimento. C’è da stupirsi se nel mondo della poesia l’orticello venga difeso con le unghie e con i denti? C’è da stupirsi se ci siano critici che forniscono il decalogo di quella che è la poesia buona? Purtroppo non tutti coloro che rompono gli schemi consolidati lo fanno con qualcosa paragonabile a Bitches Brew, perché il talento è raro; ed è quindi facile ai puristi trovare dei controesempi di scarsa qualità, portandoli come prove della miseria in cui vive e produce chi è uscito dall’orto, o non ci è mai entrato.
Il campo del fumetto, che mi è altrettanto caro, mostra, da questo punto di vista, dialettiche molto meno irritanti, spesso fin troppo poco irritanti. Il campo è un po’ più grande (non molto più grande), vi gira più denaro (non granché, certo, ma decisamente di più) e più esposizione mediatica (almeno un poco), ma molto molto molto meno prestigio (quello virtuale di cui sopra). In poco più di un secolo di vita è dura avere degli antenati paragonabili a quelli dei poeti. Per questo le certezze e le difese che contraddistinguono i purismi hanno meno ragione di esistere – e non ci si scanna per decidere che tipo di fumetto sia più autentico, così come succede nel campo della poesia, e in altri. Ci si scanna magari per altro – ma è anche un altro discorso.
Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche cercare di spiegarmi perché il secondo Miles debba essere disprezzato, ma non credo che mi convincerà. Do invece qualche chance in più a chi mi volesse convincere della qualità del primo Miles – anche se ormai la vedo dura pure lì, ma non c’è nulla di ideologico in questo. Ci ho provato invano anche con Schumann a farmelo piacere, e lì non c’era né un Coltrane di riserva né una svolta elettrica a cambiare le carte in tavola. Quello che certamente non voglio è che le mie opinioni su ciò che è bene e ciò che è male determino i miei gusti. Se facessi così mi precluderei qualsiasi possibilità di cambiarle, le mie opinioni, qualsiasi possibilità di capire le cose meglio di quanto non le capisca adesso.
Nonostante le apparenze, questo non è un post (solo) sulla poesia. Ecco dunque queste apparenze.
Ci sono due eventi all’origine delle riflessioni che sto per esporre. Intanto, mi sono arrivate le bozze del mio libro sulla poesia (Il linguaggio della poesia, Bompiani – ne ho anticipato qualcosa qui), e nel correggerle mi si sono inevitabilmente scatenate varie riflessioni. L’altro è la segnalazione di un sonetto di Gongora (grande poeta spagnolo del Seicento), da parte di un’amica ispanista che mi ha promesso un riferimento più preciso di quello che ricordava a memoria e che, a quando ho capito, per parlare di una bellezza imperfetta, concluderebbe la sua sequenza con un endecasillabo eccedente e sgraziato, un po’ a modello di ciò di cui sta parlando.
Mentre sono in attesa del riferimento preciso, per leggermi davvero il sonetto, non posso fare a meno di pensare che l’uso di un verso a-metrico non fa certo di Gongora un precursore del verso libero. Anzi, se le cose stanno come ho capito, il verso “sbagliato” di Gongora deve la sua efficacia locale proprio al contesto in cui si trova, all’allusione che produce, e alla sostanziale validità del principio metrico: insomma, è la classica eccezione che conferma la regola, mettendola in evidenza proprio con il suo occasionale scarto.
Dunque, sinché lo scarto è occasionale, esso contribuisce a rafforzare la regola – ma quando comincia a diventare a sua volta regola, la nuova regola scaccia quella vecchia. E il verso libero vero e proprio non è in nessun senso una conferma della metrica tradizionale.
Nel mio libro sostengo, tra le altre cose, che la metrica tradizionale rappresenta un quadro regolare, sicuro e confortante, attraverso cui possono essere trasmessi anche i significati più inquietanti o spaventosi, rendendoli accettabili. Sono accettabili, in questi casi, perché la regolarità metrica funziona come metafora (o persino come locale implementazione) dell’ordine imposto dall’uomo alla natura selvaggia (ivi compresa quella, interiore, dei sentimenti). Il quadro regolare e assestato del sonetto, per esempio, fa da cornice, e rende più facilmente accettabili sin la disperazione e la tragedia, quando emergono. Proprio come gli elementi di antropizzazione del paesaggio, o il riconoscimento di una struttura narrativa in una situazione di angoscia incontrollata (e il mestiere degli psicoanalisti è fatto anche del saperla fare emergere dal caos mentale del paziente).
Così, possiamo pensare la metrica tradizionale come il corrispondente in poesia delle strutture sociali tradizionali – quelle al cui interno abbiamo vissuto per secoli, al riparo dagli eccessi della natura, esterna o interna a noi. Da questo punto di vista il sonetto di Gongora (così come me lo sto immaginando) non viola nulla: quello che fa è semplicemente giocare sul principio, suggerendo che l’imperfezione del suo oggetto possa riflettersi persino in un’imperfezione dell’ordine umano delle cose.
Ma il verso libero è un’altra cosa. Nel mio libro suggerisco che l’uscita dalle strette del metro permetta alla disperazione e alla tragedia (o a quant’altro) di esprimersi in maniera più diretta ed efficace, perché la cornice in cui vengono inserite è più leggera e meno distanziante. In altre parole, una poesia in versi liberi rimanderebbe molto meno (ma in qualche modo deve continuare a farlo) all’ordine umano e sociale imposto alla natura; e in questo modo ridurrebbe la distanza nei confronti del proprio oggetto emotivo, rendendolo più vivido ed efficace.
Continuo a pensarla così (nel libro tutto questo viene spiegato molto più ampiamente), ma ho la sensazione che ci sia dell’altro.
Il punto è che la poesia in versi libero non esclude il metro. Semmai, quello che è accaduto è che a una serie di strutture metriche (all’incirca) stabili da secoli si cerca di sostituire delle strutture nuove, adatte alla situazione espressiva particolare. Ma se la metafora (o locale implementazione) di cui parlavamo sopra resta valida, questo tentativo dovrebbe corrispondere anche a un tentativo di costruire strutture sociali nuove. È certamente un tentativo presuntuoso, ma è proprio quello che la modernità ha cercato di portare avanti, timidamente nel corso dell’Ottocento e poi molto più spavaldamente nel Novecento, sino alle utopie razionaliste del comunismo sovietico, che ha sognato di ricostruire l’ordine sociale da zero, coi risultati che sappiamo.
Senza arrivare a questi estremi, mi sembra comunque che il verso libero sia figlio della stessa presunzione che ci fa pensare di poter essere davvero i capitani della nostra stessa società e delle nostre vite, capaci di sottomettere tutto a un nuovo ordine, razionalmente fondato. Non è un’idea campata in aria, e soprattutto è l’idea dentro cui viviamo, ma ancora non sappiamo se sia destinata ad avere successo sul lungo termine, e in che misura andrà eventualmente emendata per poter funzionare a lungo. Rispetto alle società tradizionali, che funzionavano così perché si basavano su un ordine che, giusto o ingiusto che fosse, era validato da secoli o millenni di sopravvivenza, la nostra società pretende di sapersi progettare in termini nuovi, e magari anche più giusti. Allo stesso modo lo pretende la poesia moderna, che ha abbandonato le certezze dell’organizzazione assestata da secoli a favore delle incertezze del progetto.
Il punto non è, a questo punto, se il passato sia meglio del presente, o viceversa. Questo sarebbe oggi un problema unicamente virtuale, perché al punto in cui siamo non c’è possibilità di ritorno (se non attraverso una certo non auspicabile catastrofe). Nell’ambito ristretto del metro, non basta affatto recuperare la metrica tradizionale per ripristinare la situazione precedente. Oggi come oggi, dopo un secolo di intensivo verso libero (e a due secoli e passa dalla sua nascita), l’endecasillabo, per esempio, appare una possibilità come un’altra, e non come un obbligo. I poeti cosiddetti neo-metricisti non stanno riproponendo il passato, ma soltanto avanzando un progetto tra i tanti, magari profumato di classicismo, ma niente di più. Se anche una volta l’endecasillabo si contrapponeva (statisticamente vincente) ad altri metri ugualmente canonici, inevitabilmente in numero limitato, tra i quali era giocoforza scegliere, oggi l’endecasillabo non è che una scelta tra innumerevoli potenzialità progettuali per il quadro di riferimento.
La poesia, alla fin fine, socialmente ne patisce – ma non perché i poeti di oggi siano meno capaci di quelli di ieri (e certamente, oltretutto, ci rappresentano di più). È semmai perché quella funzione di conforto, di sostegno all’ordine umano e riconosciuto delle cose, non è più possibile – ed è passata, sostanzialmente, ad altre modalità di espressione. Nel leggere una poesia dell’ultimo secolo non posso contare su un quadro di sfondo condiviso: persino la presenza di un simile quadro (o la possibilità di condividerlo) va verificata caso per caso. È naturale che la situazione venga sentita come enormemente più complicata di prima: non solo sono scomparse le certezze, ma ciascuno ha il diritto di suggerire le proprie. Meraviglioso! e insieme devastante. Non ne possiamo fare a meno, perché ciò che non è così non ci rappresenta; ma questo non è necessariamente positivo.
Ancora un’osservazione: non sto parlando delle avanguardie, degli esperimenti estremi. Quello che ho detto vale per Sandro Penna come per Nanni Balestrini. E siccome, nonostante le apparenze, non sto parlando solo di poesia, vale per Frank Miller come per Lorenzo Mattotti o Chris Ware; con il vantaggio (o lo svantaggio) per il mondo del fumetto, di non avere secoli di tradizione regolatrice alle spalle, essendo nato già in un mondo orientato più al progetto che alla tradizione. Ma, di questo, in qualche prossimo post.
 Magnus, Le femmine incantate, pag11 Volevo parlare di tempo raccontato e tempo del racconto nel fumetto, ma nel cercare l’esempio giusto mi sono reso conto che le cose sono molto più complicate di quello che mi preparavo a dire. L’opposizione tra tempo raccontato e tempo del racconto è tradizionale in narratologia, e contrappone il tempo che trascorre nell’universo dei fatti narrati a quello che trascorre nell’universo reale, impegnato nel corso della lettura.
Volevo dire che il tempo del racconto non è solo un fatto empirico, ma che è tipicamente organizzato in modo da costruire nel lettore una durata interiore dell’evento che si sta raccontando. In altre parole, posso raccontare brevemente o a lungo un evento di durata narrata breve oppure lunga, senza nessun vincolo di corrispondenza; ma un evento che richiede un tempo di lettura maggiore impegnerà l’attenzione del lettore più a lungo, e sarà perciò sentito come più importante.
Così esposto, tuttavia, il principio non è corretto. In una sequenza narrativa complessiva, un evento può richiedere un tempo del racconto maggiore di un altro anche solo perché corrisponde a un tempo raccontato maggiore. In questo caso, la maggiore attenzione che richiede non rimanda a una sua maggiore importanza, ma solo a una sua maggiore durata. Quando invece si allunga il tempo di lettura (più tempo del racconto) a parità di tempo raccontato, allora è evidente che si sta dando particolare rilievo all’evento, perché il tempo psicologico (insieme con l’attenzione) che esso richiede/induce non è giustificato dal solo tempo raccontato.
Guardando questa tavola di Magnus, mi rendo però conto che anche questa formulazione non è ancora del tutto corretta. Infatti è evidente che l’evento di maggior rilievo qui è quello della vignetta centrale, ma possiamo davvero dubitare del fatto che il pure evidente rilievo visivo di cui essa gode abbia come effetto una sua maggiore durata percettiva da parte del lettore: in altre parole, la vignetta centrale chiederà certamente maggiore attenzione, ma non è affatto detto che richieda maggiore durata di lettura.
Forse dobbiamo riformulare il principio in questo modo: non è semplicemente il rapporto tra il tempo del racconto e il tempo raccontato a costruire in noi un’esperienza percettiva di maggior durata e intensità. Probabilmente è sufficiente il suggerimento che quel pezzo di racconto sia particolarmente importante, e che dunque andrebbe fruito più a lungo per meglio coglierne il valore. Non una durata effettiva della percezione è dunque in gioco, bensì il suggerimento dell’opportunità di una durata.
In questa pagina sono molti i fattori che concorrono alla valorizzazione della vignetta centrale: c’è la sua dimensione maggiore, la posizione centrale stessa, l’effetto passepartout attorno ai due volti centrali; e poi, narrativamente, essa contiene l’evento preparato nelle vignette precedenti; e poi, subito dopo di essa, il tono del racconto (e anche dei neri della pagina) cambia di colpo: dalle figure simmetriche ed eleganti e statiche delle prime vignette si passa a quelle asimmetriche e mosse e in apprensione delle ultime vignette.
Ma questa pagina non è fatta per essere letta solo in sequenza. Tutta la serie de Le femmine incantate è fatta per una rilettura ripetuta, destinata a nuove scoperte visive e narrative a ogni visita successiva. Leggendo e rileggendo questa pagina, il tempo del racconto dell’immagine centrale, ovvero la durata percettiva che le dedichiamo, finisce per essere molto maggiore di quella delle altre, non foss’altro perché l’occhio corre sempre lì, una volta che la curiosità del “come va a finire” che caratterizza ogni prima lettura si sia esaurita.
Così, l’evento dell’atto d’amore tra l’uomo e la dea, per quanto rinchiuso in una sola immagine, dura psicologicamente quanto il resto della storia, perché tutta la storia gira intorno a quello, prima preparandolo e poi traendone le conseguenze. Raccontare non è riportare dei fatti: è costruire un andamento ritmico dell’anima in cui le nostre stesse passioni si possano riconoscere, trovando in questo forma nuova.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|








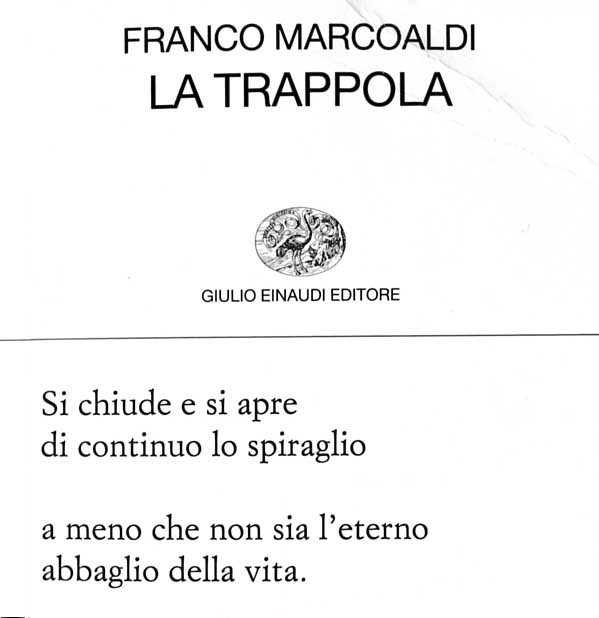

 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email

 Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.
Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.

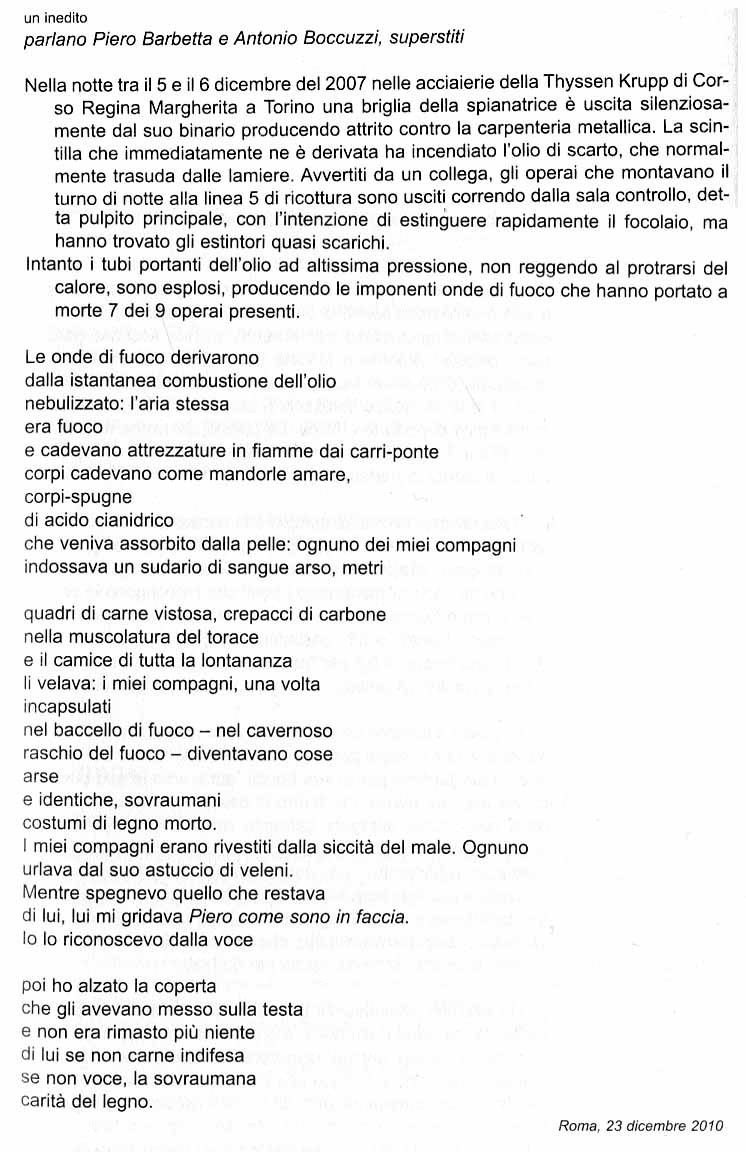































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco



Commenti recenti