Questa settimana questo blog ha avuto due differenti occasioni di lutto: a distanza di due giorni sono scomparsi Elio Pagliarani, uno dei maggiori poeti del Novecento italiano, e Jean Giraud Moebius, maestro internazionale del fumetto francese. Erano stati due autori, ciascuno nel suo campo, cruciali. Chi li conosce lo sa.
Questo blog si occupa di varie tematiche, ma non c’è dubbio che i campi di cui si parla con maggiore frequenza siano proprio quelli in cui Pagliarani e Giraud hanno primeggiato. Non parlerò di loro; o perlomeno non oggi. Ne stanno già parlando tutti, specie di Moebius.
Piuttosto, questo incrocio di lutti mi ha portato a domandarmi se, almeno per me, tra fumetto e poesia (e magari anche gli altri ambiti di cui mi occupo) ci siano degli aspetti in comune; oppure se più semplicemente sia io a essere un po’ scisso, come è peraltro normale essere: la coerenza e l’omogeneità dell’io caratterizza i personaggi, per ragioni narrative, non le persone, che sono per loro natura complesse.
Ho perciò riflettuto (aiutato dal fatto che non sarebbe la prima volta che me lo domando, certamente). Che io sia un po’ scisso è senz’altro vero; ma c’è ben altro, al di fuori dei miei gusti estetici, in cui la scissione si manifesta – e anche in questo sono normale. Ma c’è anche, almeno per me, un motivo di profonda vicinanza tra fumetto e poesia, o almeno un aspetto sotto il quale si contrappongono comunemente al romanzo, e rispetto al romanzo si schierano dallo stesso lato.
Per il fumetto è più facile dirlo. Il fumetto racconta storie, proprio come il romanzo, ma la materia di cui sono fatti i suoi sogni sono le immagini, disegnate. Le parole vi sono accessorie, quando ci sono. La forma microstrutturale del racconto non è quella ben definita della proposizione (soggetto-predicato-complementi) ma quella sfumata della figurazione, che mostra, allude e non dice, cioè, di fatto non racconta. Non racconta anche perché, non essendo fatta di parole (che, per loro natura, dichiarano il punto di vista temporale e personale da cui sono pronunciate: non si parla – o scrive – senza coniugare i verbi secondo la persona, il tempo e il modo), non implica necessariamente la presenza di un narratore (che può esserci, ove serva, ma che il più delle volte non c’è).
Questo vale certo anche per il cinema, ma il cinema fluisce autonomamente – e questo basta di per sé a farlo un’altra cosa, parente più della musica che del fumetto.
Potrei dire che l’aspetto della comunicazione che più mi affascina e a cui ho dedicato i miei interessi è quello che passa al di fuori delle parole e della loro costruzione del significato. Leggo (e scrivo) sufficiente critica e filosofia per averne abbastanza di comunicazione razionale basata sulla struttura della proposizione e del periodo, in grado di comunicare idee chiare e distinte di cartesiana memoria. Non che questa comunicazione verbale chiara e distinta sia da disprezzare: è ciò a cui tendo ogni volta che scrivo parole di carattere critico, come anche sto facendo ora. Ma è necessario riconoscere i suoi limiti. È necessario riconoscere che ci sono cose di cui non si può parlare, e, tanto per stracitare Wittgenstein, di queste cose è necessario tacere. Ma tacere non significa trascurare. Tacere, in questo senso, significa cercare modi di comunicare diversi dalla parola definitoria, razionale. Il disegno è uno di questi modi, attraverso cui può essere trasmesso ciò di cui non si può parlare.
La parola poetica è un altro di questi modi, per quanto paradossale possa apparire l’idea che un testo fatto solo di parole sia un testo che tace, nel senso detto sopra. Ma ciò che è interessante della parola poetica è che non si tratta di una parola definitoria, ovvero di una parola che fa uso della struttura proposizionale (soggetto-predicato-complementi) per trasmettere informazione. Quando ancora ne fa uso, sappiamo benissimo che si tratta di un uso strumentale. Se leggiamo la poesia come se fosse un discorso definitorio, razionale, come facciamo con queste stesse righe, allora non stiamo capendo nulla, e faremmo meglio a lasciar perdere. La poesia fa un uso alternativo delle parole, in cui tutta la loro natura, semantica quanto fonetica quanto prosodica, entra in gioco, a disegnare letteralmente un mondo. È un disegno più astratto di quello del fumetto, perché il suo oggetto è un altro, ed è forse l’universo stesso del senso, nel senso più vasto possibile (quello che comprende, per esempio, anche la dimensione emozionale, a giustificare in parte coloro che credono che la poesia sia semplicemente espressione di emozioni).
Pure qui, in poesia, poiché il senso passa attraverso un disegno, la parola definitoria è fuori gioco, ed è fuori gioco l’inevitabilità del riferimento all’io narrante (quello che esprime, nel verbo, la persona, il tempo, il modo, e continua a manifestarsi in altri modo nella struttura della proposizione). Quando questo riferimento c’è, in poesia, è in realtà accessorio, manifestazione superficiale; proprio come quando, nel fumetto, un personaggio parla attraverso la propria vignetta: dice “io”, certamente, e manifesta un soggetto e un punto di vista proposizionale sul mondo, ma non per questo assumiamo la sua posizione come indice della presenza di un narratore complessivo. Capisco bene che, in poesia, sia più facile confondersi, e scambiare l’io scritto con quello complessivo; ma se ci si rende conto che la poesia comunica al di là della struttura proposizionale (di cui al massimo fa un uso locale e strumentale), si capirà che, rispetto al proposizionalissimo romanzo, fumetto e poesia si trovano dallo stesso lato, quello del disegno, seppure attraverso strumenti del tutto differenti.
La poesia gode di un prestigio millenario, e le si dà grande spazio a scuola. Eppure siamo in pochi a interessarcene di fatto. Quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Elio Pagliarani? Il fumetto è stato a lungo un medium trascurato e vilipeso, anche se oggi le cose vanno meglio: alla scomparsa di Moebius, poi, hanno dato molto spazio i giornali e le TV. Ma questo dipende troppo dalla fama personale per farne una questione generale. Moebius deve la sua fama anche ai suoi influssi sul cinema, e questo ha indubbiamente pesato moltissimo.
Io continuo a pensarli come maestri, entrambi. E continuo a pensare che, quando scrivo poesie, sto in verità disegnando, o tracciando linee musicali, di cui le parole rappresentano l’inchiostro, o le forme base delle linee che si vanno a combinare, o la materia timbrica che va a costruire la melodia. Scrivere poesia è un’attività radicalmente diversa dall’esporre proposizionalmente pensieri organizzati, come sto facendo in questo istante (e il cui risultato state leggendo voi, ora). È un’attività che si impara nella prassi, magari imitando inizialmente dei maestri, magari imitando anche Elio Pagliarani, o Jean Giraud Moebius.
.
Quanto di morte noi circonda e quanto
tocca mutarne in vita per esistere
è diamante sul vetro, svolgimento
concreto d’uomo in storia che resiste
solo vivo scarnendosi al suo tempo
quando ristagna il ritmo e quando investe
lo stesso corpo umano a mutamento.
Ma non basta comprendere per dare
empito al volto e farsene diritto:
non c’è risoluzione nel conflitto
storia esistenza fuori dell’amare
altri, anche se amore importi amare
lacrime, se precipiti in errore
o bruci in folle o guasti nel convitto
la vivanda, o sradichi dal fitto
pietà di noi e orgoglio con dolore.
(Elio Pagliarani, da “La ragazza Carla” 1954-57)
 Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.
Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.



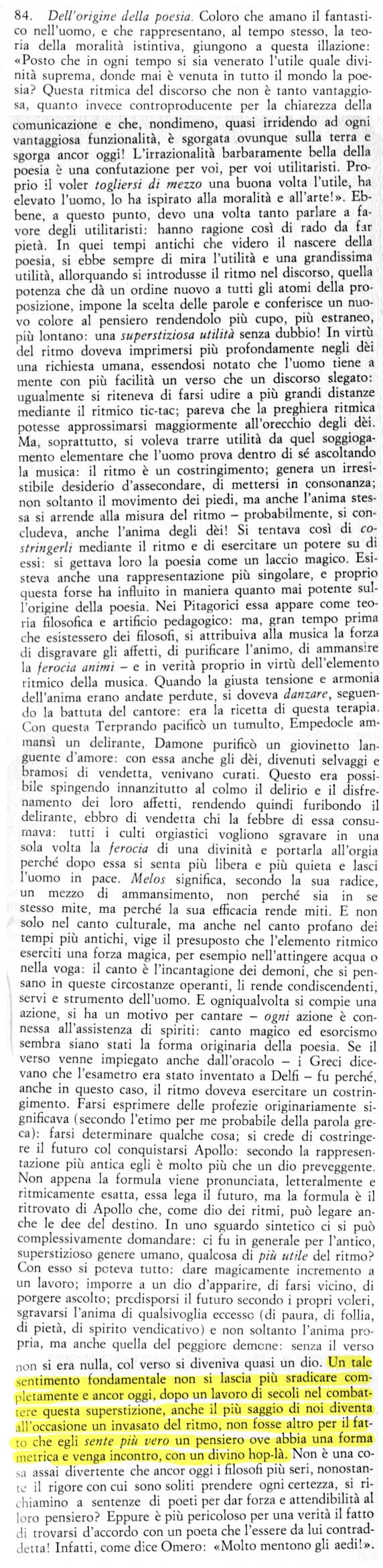




 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco








Commenti recenti