Amelia Rosselli, l’io, l’avanguardia
di Daniele Barbieri
Ho trovato in un aforisma di Nietzsche la chiave per capire il metodo compositivo di Amelia Rosselli, e la relazione tra quel metodo e il problema dell’io, anzi della sua riduzione. Ecco le parole di Nietzsche (da Il crepuscolo degli idoli, La “ragione” nella filosofia, 5, trad. Mirella Ulivieri) :
Il linguaggio appartiene, secondo la sua origine nel tempo, alla forma più rudimentale di psicologia: se prendiamo coscienza dei presupposti fondamentali della metafisica del linguaggio — in parole più chiare, della ragione — penetriamo in un rozzo feticismo. Esso vede ovunque autore e atto: crede nella volontà come causa in generale; crede nell’«io», nell’io come essere, nell’io come sostanza, e proietta la fede nell’io-sostanza su ogni cosa — solo così crea il concetto di «cosa»… L’essere viene penetrato col pensiero, interpolato ovunque come causa; solo dalla concezione dell’«io» segue, come derivato, il concetto di «essere»… […] La «ragione» nel linguaggio: oh, che vecchia donnaccia ingannatrice! Temo che non ci libereremo di Dio perché crediamo ancora alla grammatica…
L’inganno del linguaggio, secondo Nietzsche, starebbe proprio nella separazione tra soggetto e oggetto, intesi come sostanze diverse, l’una dotata di volontà e ragione, l’altra inerte, ma non per questo non dotata di essere, e interpretabile causalmente. Il (nostro) linguaggio sarebbe il principale perpetuatore di questa prospettiva: dall’idea di io nasce quella di essere, che è a sua volta alla base dell’idea di Dio. Dio, essere e io non sono che conseguenze della (nostra) grammatica, ovvero della (nostra) ragione.
Prendiamo ora un frammento molto citato della prefazione di Alfredo Giuliani all’antologia I Novissimi (1961):
Ovviamente, l’inclinazione a far parlare i pensieri e gli oggetti dell’esperienza è un atto individuale, di me che scrivo e che non voglio affatto nascondere la mia soggettività. La “riduzione dell’io” è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente […]. Ora, però, dalla parte dell’oggetto, che è ancora penetrabile e pronunciabile senza falsità, si svolge una poesia che, secondo la “qualità dei tempi”, cerca l’unità di visione e quindi il recupero di quel medesimo io prima ridotto metodicamente. Dialettica, se vogliamo, dell’alienazione. (pp. 22-23 dell’edizione Einaudi 1965)
Se rileggiamo Giuliani alla luce dell’aforisma di Nietzsche, ci accorgiamo che la (comunque problematica – anzi, dialettica) riduzione dell’io continua a svolgersi in una prospettiva di rapporto tra soggetto e oggetto, solo che – a differenza che nella lirica tradizionale – è l’oggetto a trovarsi in primo piano. Del resto, poche righe prima, Giuliani aveva scritto anche che:
Troppo frequentemente, nelle poesie che vorrebbero essere le più aliene dall’intimismo, l’io si nasconde con orgoglio e pervicacia dietro una presunzione di oggettività. Le apparenze, come di solito, ingannano. In realtà – e ciò spiega perché diamo importanza a un certo orientamento metrico – il tono non solo fa la musica del discorso, ma ne determina l’operatività, il significato. Così la riduzione dell’io dipende più dalla fantasia linguistica che dalla scelta ideologica. (p 21)
È quindi l’oggettività ciò che andrebbe cercato in vista di una riduzione dell’io. Ma se seguiamo Nietzsche, l’oggettività non è che una conseguenza di un’organizzazione del linguaggio basata sull’io-ragione-grammatica: nella negazione apparente della soggettività, dunque, l’oggettività non farebbe che riproporla surrettiziamente, rimettendo in campo – proprio con il cercare di escluderlo – il soggetto attraverso l’oggetto che esso crea, e che insieme lo crea, perché soggetto e oggetto (e dunque soggettività e oggettività) escono dalla stessa matrice linguistica.
Di più, la teorizzazione stessa di Giuliani, che coinvolge nella stesura di riflessioni critiche anche gli altri autori dell’antologia, e che poi, come bisogno di teoria, caratterizzerà fortemente l’operare della futura neo-avanguardia, è un’operazione progettuale, e, in quanto tale, un’operazione che si basa su quella volontà che Nietzsche vede alla base del processo di organizzazione dell’essere in soggetti (che possono volere) e oggetti (che non hanno volontà). In altre parole, la preoccupazione critica medesima di Giuliani lo porta di per sé in direzione contraria a ogni possibile riduzione dell’io, come lo porterà (lui e i suoi compagni di viaggio dal ’63 in poi) ogni concezione progettuale dell’agire poetico.
Si noti che il problema di Giuliani (la riduzione dell’io) è importante, ed è importante anche l’apparato critico-esplicativo con cui la nuova avanguardia nasce. Il problema è che si tratta di due strade incompatibili, quasi opposte se seguiamo la prospettiva nietzscheana…
Prosegue qui, su Nazione Indiana.
 Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte. Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte.
La prima volta riprendevo uno spunto di Paolo Giovannetti che esprimeva (tra altre interessanti considerazioni) una qualche stanchezza per una poesia che abbia sempre bisogno del supporto della critica (che interpreti e spieghi) per arrivare al suo pubblico. Mi è venuto da dire che non è così dappertutto. Non, per esempio, nel mondo di lingua spagnola, specie in America Latina, dove ci sono addirittura paesi, come il Nicaragua, in cui la poesia ha più lettori del romanzo. Mi verrebbe semmai da dire che l’Italia, con altri paesi europei, rimane vittima dell’osservazione di Adorno, per cui non potrebbe più esistere un’arte innocente, e non tanto perché c’è stata Auschwitz (come in una sua prima affermazione) quanto perché è la stessa struttura della produzione estetica di massa a renderla impossibile. Proprio per questo l’arte (tra cui evidentemente la poesia) sarebbe condannata a riflettere su di sé (una volta persa l’innocenza) per non diventare inautentica, falsa coscienza, credendo vanamente di poter recuperare un’irrecuperabile innocenza.
Riprendendo poi Paolo Zublena, che aveva contrapposto soggetto e soggettività, dicevo che l’opposizione andrebbe secondo me formulata piuttosto nei termini lacaniani, secondo cui intanto il soggetto è semplicemente il soggetto dell’inconscio, e quindi qualcosa che vive già in una dimensione pubblica, sociale (trovando la sua differenza specifica non in una identità autocosciente, ma semplicemente nel diverso modo in cui in ciascuno si organizzano specificamente delle istanze collettive). In secondo luogo, sempre per Lacan, l’io (il moi) è invece una sovrastruttura alienata, della quale, comunque, non si può fare a meno – e al massimo si può riconoscere la sua natura alienata.
Ma se l’io, pur alienato e sovrastrutturale, c’è, perché inibire alla poesia la facoltà di esprimerlo (fatto salvo che esprime sempre e comunque il soggetto – ma questo in sé non produce lirica)?
D’altra parte io stesso non ne posso più di una poesia che necessiti della critica per essere compresa, e mi piacerebbe tanto poter essere innocentemente lirici. Ma poi, quando guardo i prodotti che cercano di essere davvero tali, in verità mi sento raggelare, tanta è la falsa coscienza (di solito involontaria) che si aggira in loro. Da questa ambivalenza, come si esce? Oppure, da questa ambivalenza è possibile uscire?
Nel secondo intervento citavo inizialmente Alfredo Giuliani (lo cito un po’ troppo spesso, anche in queste pagine) che, nell’Introduzione alla edizione 1965 de I Novissimi, definiva la riduzione dell’io come “l’ultima occasione storica di esprimermi soggettivamente” – un’espressioni in cui vanno notati sia l’io che il soggettivamente, i quali fanno evidentemente riferimento a due entità differenti.
A questo punto, visto che qualcuno aveva parlato di musica, mi è venuta alla mente l’estetica di Eduard Hanslick, ovvero quell’estetica musicale sviluppata a fine Ottocento che ha fatto piazza pulita dell’idea romantica della musica come espressione delle emozioni e dei sentimenti dell’io, sostenendo non tanto che la musica non possa esprimere emozioni e sentimenti, quanto che non ha nessuna necessità di farlo, e può essere interessante anche senza esprimere alcunché. Non è un formalismo, come pure molti l’hanno interpretato, perché, anche se l’espressione non è più il cuore del problema, alla musica viene riconosciuta la possibilità di provocare in chi l’ascolta emozioni e sentimenti (indipendentemente dal fatto che sia o meno espressione delle emozioni del suo autore). L’accento, insomma, si sposta sulla ricezione e sugli effetti di senso prodotti dal testo musicale.
L’estetica di Hanslick è stata importante al punto da generare la pittura astratta, poiché Wassily Kandinsky ne era un appassionato lettore, ed è dall’idea di un’arte non figurativa (come la musica) in grado di produrre reazioni estetiche nel suo fruitore che può nascere quella di una pittura non figurativa che funzioni al medesimo modo. Nel mondo della poesia italiana sembra che, almeno sino agli anni Sessanta, non venga in mente a nessuno che la poesia potrebbe non essere letta come espressione del proprio autore; e anche dopo quella data le contrapposizioni sono ambigue. Per esempio la stessa espressione di Giuliani riportata qualche riga sopra sembra tradire una necessità di – comunque – esprimersi soggettivamente, per quanto con forme nuove e meno fruste.
Con un bel cambio di prospettiva, potremmo assumere oggi radicalmente la posizione di Hanslick e sostenere che la relazione tra testo poetico e soggettività (che in gioco sia il soggetto – quasi collettivo – dell’inconscio, oppure l’io alienato) è del tutto irrilevante, perché l’io è in poesia comunque un effetto testuale, la cui presenza è giustificata o meno dalla coerenza con il resto del discorso. In altre parole, l’io potrà essere assente o viceversa dominante, purché questo sia coerente con il resto della costruzione, e il testo produca su di me lettore qualche effetto emotivo interessante (dove emotivo va inteso nel senso più ampio possibile, che non esclude affatto l’emotività di natura intellettuale; e però nemmeno, d’altra parte, quella più istintiva e animale).
Se assumiamo questa posizione che privilegia l’effetto sul lettore, tutta la problematica della riduzione dell’io, o dell’espressione della soggettività appare ridursi sin quasi a scomparire, e con essa scompare anche il dilemma (l’ambivalenza) di cui parlavo alla fine del mio primo intervento. Questo ad Albinea non sono arrivato a dirlo, come non sono arrivato a dire le conclusioni a cui giungerò di qui in poi. Insomma, in questa prospettiva, soggettività o oggettività, espansione lirica o riduzione dell’io appaiono semplicemente come strumenti retorici per produrre effetti di senso (o effetti emotivi, il che non è molto diverso), strumenti a disposizione del poeta per la propria operazione di costruzione.
Attenzione! Questo non comporta che il testo poetico non possa più essere un testo spontaneo, dovendo piuttosto essere sempre progettato a tavolino con grande consapevolezza degli effetti di senso. A parte che l’idea stessa di spontaneità è un’espressione del pregiudizio romantico secondo cui la poesia sarebbe espressione dell’io – e perdere spontaneità sarebbe ridurla a calcolo. La dimensione progettuale, calcolata, non è in verità né implicata né esclusa da una visione della poesia che privilegi l’effetto sul lettore. Il poeta potrebbe anche aver scritto di getto, cercando di affiatarsi con lo Zeitgeist, e limitando l’intervento ragionato a qualche limatura successiva: questo, a priori, non renderebbe la sua poesia più soggettiva (e nemmeno più oggettiva, peraltro). Oppure potrebbe aver progettato tutto, come dichiarò Edgar Allan Poe (il più romantico dei Romantici) a proposito del suo poemetto The Raven.
Questa conclusione non coincide con quella del post di lunedì scorso, ma è comunque coerente o compatibile con quella. Là si riconosceva che la sensazione di presenza del noi (o di riduzione dell’io) è un effetto della qualità poetica, e non una sua causa o ragion d’essere. Qui si sostiene che si tratta di un effetto di senso del testo, non la testimonianza di un atteggiamento emotivo dell’autore. Certo, di per sé, la sensazione, prodotta dal testo, di presenza del noi (o di riduzione dell’io) non basta a garantirne la qualità; mentre una buona qualità del testo poetico, anche quando basata sulla costruzione di un effetto di presenza dell’io, richiama comunque la presenza del noi – perché trascende la dimensione semplicemente individuale.
Mi viene da dire, insomma, che il dibattito sulla riduzione dell’io, e sulla lirica e il suo eventuale oltrepassamento o negazione, è in verità basato su un equivoco tardoromantico, quello che Giuliani perdura parlando di “esprimersi soggettivamente”. Se l’io che si esprime attraverso un componimento poetico viene considerato soltanto come un effetto di senso testuale (e non come rappresentazione o testimonianza del poeta), che bisogno c’è di discuterne la legittimità? Sarà legittimo se retoricamente funziona; e sarà legittima la sua assenza se funziona quella.
Mi domando come ho potuto non accorgermene prima. In altri campi sostengo questa tesi da anni. Sembra che in poesia il dibattito dominante mi abbia accecato, mi abbia condotto nel suo alveo senza lasciarmi alternative se non quelle previste dei termini stessi del dibattito: ma sono i presupposti di questi termini ad essere sbagliati, e il dibattito stesso di conseguenza non lascia uscite.
Tornando alla falsa coscienza che emergerebbe da tanta (non tutta) poesia “innocente” o “ingenua”, certo anche quella è un effetto di senso, non c’è dubbio, e pure un pessimo effetto di senso. È naturale perciò che mi faccia raggelare.
 Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io. Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io.
Non è solo il Romanticismo a esaltare l’io. Lo stesso imporsi del verso libero è dovuto alla richiesta di un’espressione meno vincolata da regole, e in grado di utilizzare più liberamente il ritmo come elemento espressivo, anziché come gabbia di riferimento, ovvero metrica, come era stato nella tradizione. Di nuovo, l’espressione riguarda la possibilità dell’io di manifestarsi, come fa notare Guido Mazzoni a pagina 212 del suo Sulla poesia moderna (Il Mulino, 2005) (più ampiamente, della posizione di Mazzoni in merito ho parlato qui):
L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi.
L’obiezione di Mazzoni investe assai più della “maggior parte delle poesie moderne”. Se assumiamo che “l’indecifrabilità” sia davvero “il primo segno della chiusura egocentrica”, anche buona parte della cosiddetta poesia di ricerca, compresa la Neoavanguardia e l’oggettivissimo Balestrini, finiranno a far la parte del narcisismo. Non vedo bene che cosa davvero ne possa restare fuori.
D’altra parte, uno degli aspetti che caratterizzano la modernità in generale, almeno in Occidente, è proprio la crescita del senso dell’io, narcisismo incluso. Una buona obiezione consisterebbe allora nel far notare che una poesia che esprima il proprio tempo non può esimersi dall’esprimere l’io, narcisismo alienato (alla Lacan) incluso. La (parziale) contro-obiezione sarebbe allora: d’accordo, la poesia dovrebbe sì esprimere l’io e il narcisismo, ma dal punto di vista di una consapevolezza del suo stato alienato. In alternativa, la poesia può anche esprimere altro dall’io, ma stando bene attenta a non reintrodurre attraverso le forme dell’espressione quello che tiene sotto controllo nelle forme del contenuto.
Non so. Ho l’impressione che da questa strettoia non si esca, e che il vicolo sia cieco. D’altra parte è lo stesso Lacan a definire sì l’io come un’alienazione, ma ammettendo insieme il fatto che si tratta di un’alienazione necessaria; ovvero che della sovrastruttura dell’io non possiamo in realtà fare a meno. E se non ne possiamo fare a meno nella vita, come potremmo farne a meno in poesia? Tanto più quando la poesia deve esprimere una realtà, la nostra, in cui l’io narcisistico è forte.
Proviamo allora a ribaltare i termini, e a pensare che quello che conta non sia tanto togliere di mezzo l’io, ma metterci dentro la comunità, rappresentare, o meglio esprimere la comunità. Uno dei ruoli della metrica nella poesia tradizionale era proprio quello di rappresentare la comunità, attraverso delle convenzioni diffuse di cantabilità, o attraverso l’implicita ritualità che la metrica tradizionale comporta. Peccato che la riproposizione della metrica tradizionale non funzionerebbe, oggi – se non dove la cantabilità è cruciale, ovvero ai confini della poesia, o appena fuori, cioè nella canzone musicale! Non funzionerebbe perché oggi quella metrica non ci rappresenta più, se non in casi molto particolari, o come parodia.
In questa prospettiva, non si tratterebbe più di ridurre l’io, tanto per citare il solito Giuliani, quanto di espandere il noi. La riduzione dell’io può essere una conseguenza di questa espansione del noi, ma può anche non esserlo, e l’io può benissimo far parte del noi. Insomma, non dobbiamo concentrarci sull’esclusione dell’io; perché non è quello il punto cruciale. Se l’attenzione è sul noi, l’io risulterà comunque inquadrato criticamente.
Ma che cosa vuol dire espandere il noi, o porre l’attenzione sul noi, in poesia? Una strategia a basso costo si chiama poesia civile: il noi ne è l’oggetto esplicito del discorso. Si tratta di una strategia a basso costo perché è anche, di per sé, a basso rendimento. Quello che rende affascinante i versi di Fortini, o quelli di Pasolini, non è il fatto che parlino di temi politici, ma il modo in cui lo fanno – e, per esempio, la particolare attenzione alla problematica metrica, alla ricerca di una strategia di identificazione con il collettivo. La maggior parte della poesia civile che si scrive oggi serve sostanzialmente a lavare la coscienza dei suoi autori: al di là del tema sociale, il narcisismo e i luoghi comuni la attraversano continuamente.
Rendere la poesia oscura, di difficile lettura, è un modo per nascondere il narcisismo e i luoghi comuni che a un occhio più attento non risultano affatto nascosti. Certo, così come non tutta la poesia civile è paccottiglia, nemmeno tutta la poesia oscura e difficile lo è; ma almeno la prima ha un noi come riferimento, ma la seconda? (giusto per dare qualche riferimento, nella poesia oscura e difficile non metterei nessuno del gruppo dei Novissimi, né ci metterei Adriano Spatola o Corrado Costa, ma ci starebbero benissimo vari epigoni della neo-avanguardia – come peraltro gran parte dell’ermetismo) In ogni caso, l’oscurità non è in sé un peccato mortale: solleva, però, dei legittimi sospetti. La poesia ha diritto di essere incomprensibile, anche se non è proprio opportuno che lo sia.
Forse abbiamo di nuovo bisogno di un ribaltamento di prospettiva. Vedendo le cose in un altro modo, forse quando la poesia funziona, quando è buona, quando possiamo definirla bella, è proprio quando è riuscita ad attingere alla dimensione del noi, comunque abbia trattato l’io. Se la poesia è buona, è perché ci possiamo identificare in lei; è perché esprime qualcosa che riguarda tutti, che siamo uno per uno (in quelli che ci paiono i nostri privati sentimenti) o che siamo tutti assieme.
In questo ribaltamento di prospettiva, allora non ha più senso cercare la ricetta per espandere il noi. Il noi si espande quando la poesia è buona, e non c’è una ricetta per questo. Ci sono corsi di scrittura, suggerimenti d’azione (tra cui l’aver letto tanta poesia di altri), dibattiti anche feroci: tutte cose utili, ma nessuna determinante.
Se questo è vero (e il se è d’obbligo), allora non serve la riduzione dell’io come programma, non serve la poesia civile come tema esplicito, non serve il sovvertimento della sintassi come tecnica. Sono possibilità che alla poesia restano (cioè non vanno escluse) ma è inutile utilizzarle programmaticamente, cioè come elementi della propria poetica di autore. La lezione di Peirce e Nietsche, Freud e Lacan, è recepita dalla poesia quando la sentiamo come collettivamente importante, non quando percepiamo l’espressione appassionata dell’io – la quale ci potrà anche essere, ma non è di per sé quello che conta. Non ha senso essere contro la lirica, ma nemmeno essere per la lirica; che una poesia sia lirica o meno è irrilevante per il giudizio se sia o meno una buona poesia. In questo senso siamo oltre la lirica.
Quanto ai confini del noi, io sto con Gregory Bateson (altro nome da aggiungere alla lista di cui sopra): non solo la comunità in cui viviamo è noi, non solo l’umanità, non solo la natura vivente.
 Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi. Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi.
Questa visione del soggetto e dell’io si oppone, evidentemente, a quella antica e a quella cartesiana, che, in vario modo, contrappongono una res extensa, il mondo, la natura, a una res cogitans, l’autocoscienza, la mente. Questa dicotomia non esiste: la boutade di Rimbaud, “Io è un altro”, è preoccupantemente vera. Essere alienati, per Lacan, è non rendersene conto, e pensare di possedere davvero un’arena interna di cui si è padroni.
Ora la domanda è: la poesia può, o magari deve, recepire questa posizione rispetto all’io? Che senso ha parlare di lirica, cioè di espressione dell’io, se l’io è un’illusione? E chi ancora scrive lirica sta davvero sbagliando tutto? Oppure in che senso ha ancora senso scrivere lirica? Quando Alfredo Giuliani parlava di riduzione dell’io (come “l’ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente”) stava parlando di questo?
Proseguendo con le perplessità. La posizione di Peirce e Lacan non è storica. Il soggetto è sempre stato una costruzione, anche al tempo di Saffo. Questo vuol dire che la lirica greca è uno sbaglio? Presumibilmente no. Saffo scriveva, ovviamente, basandosi sulle convinzioni del suo tempo. Ma per noi, oggi, che lo sappiamo, allora la lirica è uno sbaglio? E se un poeta non ha studiato filosofia, e non sospetta nulla di tutto questo, continuando a crogiolarsi nella dominante vulgata cartesiana, è già solo per questo un cattivo poeta? Presumibilmente no, ma forse sarà un poeta un po’ anacronistico, o forse ci lascerà la facoltà di interpretarlo come se scrivesse da dentro l’illusione, come se potessimo ancora crederci davvero.
E cosa vuol dire, oggi, scrivere poesia essendo consapevoli della relatività del soggetto, e della superficialità alienata dell’io? C’è una forma specifica di questa post-lirica?
Aggiungiamo che, se l’io è un’illusione, allora si tratta di un’illusione progressivamente sempre più dominante in Occidente, di cui tutti in misura maggiore o minore, siamo vittime, anche quando dell’illusione siamo consapevoli. Una poesia che agisca dentro l’illusione, rendendone conto, ma senza consapevolezza del suo essere tale, sarà accettabile? Oltre certi limiti è certamente anacronistica, come dicevamo sopra (il che non significa, di per sé, che sia cattiva poesia); ma parlare dell’io è comunque anacronistico? Forse se la poesia ci permette di essere letta come se (nei termini di cui sopra) allora l’anacronismo scompare, o almeno si riduce?
Certo, gran parte della lirica del passato appare, se vista con questi occhi, ingenua. Ma tale, se ci leviamo il paraocchi dell’adorazione feticistica del passato, ci appare anche la statuaria della Grecia antica. Ma questo non toglie nulla alla grandezza di Fidia, che va comunque valutato pensando al suo tempo, e non si può trasfondere così com’è nel nostro. Ne era ben consapevole persino Antonio Canova, le cui capacità tecniche sono paragonabili a quelle di Fidia, e che viveva in un’epoca in cui riproporre il classicismo aveva senso; ma Canova sapeva benissimo che una bella statua neoclassica andava comunque interpretata in un modo differente da una bella statua classica – e che parte della differenza stava proprio nella perdita irreparabile di un’ingenuità.
Sul soggetto, oggi, non siamo più ingenui. Possiamo perdonare i poeti che continuano ad esserlo? E se possiamo, in che misura li possiamo perdonare? Certamente non del tutto. L’ignoranza, almeno in qualche misura, va pagata.
(altre riflessioni, di tono un po’ diverso, ma sullo stesso tema, si trovano qui)
A vacanza avanzata resta poco da raccontare. Il riposo fa poca storia. Magari la fanno invece le riflessioni che il riposo suscita, insieme con le letture che si fanno. Per questo ho intitolato questo post “Sacro e poesia” perché è il tema su cui ha divagato la mia mente in questi giorni di relax.
I libri che ho letto qui (e di cui ho parlato nei post precedenti) hanno mostrato sostanzialmente due vie di accesso al sacro. Parlo di sacro senza ulteriori specificazioni; naturalmente chi vuole può vederci Dio, nel sacro, o gli dei, o Shiva, o il Brahman, o la coscienza cosmica; io mi fermo prima, magari parlando di sacro/sublime, vista la vicinanza strettissima delle due nozioni, come ho fatto nei giorni scorsi; mi interessa il numinoso, non so quanto mi interessi Dio.
Dicevo, dunque, di due vie di accesso al sacro, una esteriore (e uso questa parola senza connotazioni negative) e una interiore. La via esteriore è quella del rito, del gesto corale, del riconoscersi in un ordine rituale, che è, inevitabilmente, un ordine sacro, in quanto antico, virtualmente immutabile, collettivo non solo nel senso della collettività umana. La via interiore è quella dell’ascetismo mistico, del fondo dell’anima, del fare il vuoto dentro di sé perché possa entrarci dell’altro. Nella tradizione induista la via esteriore corrisponde alla bhakti dei seguaci di Vishnu, mentre quella interiore all’advaita degli shivaiti.
In modi diversi, per entrambe le vie si arriva a una diversa coscienza di sé, dove il sé non è più l’io, ma qualcosa di assai più vasto. L’io si rivela quell’illusione che è, certo mai del tutto abbandonabile, ma altrettanto certamente molto riducibile rispetto al ruolo strabordante che ha per noi occidentali.
Le vie esteriore e interiore sono diverse tra loro, ma molto meno di quello che sembra. La via rituale è la più antica: il rito è più antico del linguaggio, e il linguaggio è più antico della coscienza di sé. Ma proprio l’esistenza del rito e del linguaggio hanno fatto sì che il nostro inconscio, che già è un processo di per sé naturale, diventasse anche un processo sociale, ancora prima di sostentare un io. Questo è accaduto filogeneticamente e continua ad accadere ontogeneticamente nello sviluppo di qualsiasi bambino.
In questa prospettiva l’autocoscienza non è che un breve segmento nella linea che va dal mondo esteriore a quello interiore, entrambi naturalmente e socialmente costruiti. L’esistenza dell’inconscio (che è sì quello freudiano, ma non solo) rende incoerente la concezione cartesiana di una res cogitans interna contrapposta a una res extensa esterna. Interno ed esterno, piuttosto, sono solo aspetti diversi della stessa cosa, e da qualche parte lì in mezzo ci sta quell’illusione che chiamiamo io, o autocoscienza.
Attingere il sacro è riuscire a vedere, almeno per un attimo, al di là dell’illusione; sentirsi parte del tutto, essere il tutto. La via esteriore ha funzionato da sempre, quella interiore, più difficile e tortuosa, funziona pure lei da molto tempo.
Che cosa c’entra la poesia con tutto questo? Ho forti ragioni per pensare che sia la scrittura che la fruizione di una poesia (ma soprattutto la fruizione) siano atti di carattere rituale. Come ho scritto anche nel mio libro, per fruire un componimento poetico bisogna recitarlo, almeno interiormente, ovvero ricostruirne attivamente le sonorità, l’andamento. Non basta leggere con gli occhi, come si fa con la prosa: leggere una poesia solo con gli occhi è infatti ridurla a prosa, puro significato delle parole, escludendo dal gioco la gran parte dell’efficacia poetica.
Recitando almeno interiormente, ma meglio ancora esteriormente, l’esecuzione assume l’aspetto della recitazione di un mantra; diventa cioè un atto rituale, in cui il lettore si ritrova in sintonia, accordato, a quello che hanno fatto o faranno tutti gli altri lettori dei medesimi versi. Nel fare questo, le parole contenute in quei versi acquistano quello che si acquista attraverso il rito, ovvero una qualche sacralità.
Si noti che è presente, nel sacro, una forma di verità che non è quella epistemologica dell’aderenza al reale (“la neve è bianca” è un’asserzione vera se e solo se la neve è bianca, come recita l’assioma di Tarsky). È piuttosto una verità che si dà per assunta, pur essendo indimostrabile ed essendo indimostrabile la sua negazione. È quella verità per cui un credente ritiene vero che Dio esista, pur sapendo perfettamente che non c’è modo di verificarlo, ma è il rito stesso a renderla tale (cfr. Roy Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, il volume che sto leggendo ora). Non è certo la verità della scienza, e un filosofo analitico non ve la farebbe passare; ma tutte le religioni si fondano su questo senso di verità.
I Greci antichi ritenevano vera qualsiasi asserzione che fosse stata espressa attraverso i versi di un testo poetico; in altre parola, se era poesia che lo diceva allora era sicuramente vero (lo ricorda Paul Veyne, nel volume I Greci hanno creduto ai loro miti?). Si tratterà di verità nel secondo senso, indubbiamente, ma sempre di verità si tratta. Per i Greci, infatti, i testi poetici più antichi sono testi in cui si parla degli dei, e attraverso cui si fonda il loro sistema di credenze.
Ecco quindi dove voglio arrivare: la natura rituale della poesia la rende dell’ordine del sacro, e conferisce quindi alle sue parole uno statuto particolare di verità. È per questo che la poesia suscita il rispetto di chi la legge; ma è anche per questo che ha vita difficile in un mondo de-sacralizzato, in cui la nozione di verità imperante è quella epistemologica di corrispondenza al mondo.
Parlo di buona poesia, ovviamente. La cattiva poesia è come un rito eseguito male, senza criterio, senza serietà: qualcosa quasi di sacrilego, insomma. Se non fosse che ce n’è tanta, e che inevitabilmente siamo più spesso in contatto con la poesia cattiva, percepiremmo davvero questo senso sacrilego, questa impressione di voler avere a che fare con il sacro senza aver preso le dovute cautele, senza saperle prendere, in realtà. Perdoniamo ai cattivi poeti solo perché sappiamo bene che non c’è una scuola a cui si impari a costruire questo genere di riti, e che senza cattiva poesia non nasce nemmeno quella buona.
Ma questa sacralità, e quindi, in qualche modo, oracolarità della parola poetica le conferisce delle responsabilità terribili. Proprio in quanto depositaria di un senso particolare di verità, apparentato col sacro, la poesia non può dire qualsiasi cosa. Non che non possa parlare di qualsiasi cosa: ovviamente lo può fare. Ma dev’essere in grado di vedere la dimensione sacrale in quello di cui parla; altrimenti fallisce, altrimenti si rivela come un bluff, non è che banale cattiva poesia.
Può essere ironica, scherzosa; il sacro può stare anche lì. Ma non lo può essere in maniera banale.
Personalmente, sono poco interessato ai temi della poesia. Quello che interessa a me è come la poesia li mette in scena, li sviluppa, li rende fascinosi, li sacralizza. Per questo (ma questo vale solo per me, personalmente) quando inizio a scrivere non devo sapere di che cosa parlerò: se lo sapessi, starei sviluppando un tema, come si fa a scuola, o come si fa in prosa. Devo avere piuttosto la sensazione che il tema stesso scaturisca dal mio fondo dell’anima, il luogo del sacro dentro di me, e che si sviluppi secondo linee rituali/sacrali che dentro di me si sono depositate. Solo così, per me, chi leggerà poi quei versi potrà ritrovarvi davvero il sacro, attraverso il rito che essi costruiscono.
In questo modo la via interiore e quella esteriore al sacro convergono. Anzi, sono una e una sola.
Provo a riprendere le fila, o almeno qualche filo, del discorso aperto con Marco Giovenale nel post del 12 settembre. È un discorso complesso, complicato, dove i vari fili si intrecciano e ingarbugliano, e io stesso non sono sicuro di vederci chiaro. Cominciamo dalla fine, cioè dall’ultima parte del commento di Giovenale al mio post, dove dice:
Che un cambiamento, un mutamento di qualche genere, si sia dato, sia avvenuto, lo considero in ogni caso difficilmente contestabile; anche su questo mi sembra concordiamo.
Personalmente, l’impressione che ho, a prescindere dall’atteggiamento che la poesia e le poetiche assumono o dalle loro prassi, e a prescindere dallo studio che la critica letteraria fa di poesia e poetiche, è però che di quel mutamento si diano e si siano date inevitabili incarnazioni e evidenze nella vita quotidiana, nel dialogo banale, nei media, nel discorrere comune, nei videogiochi, nella scienza, nell’arte: in tutto tranne che nel 90% della poesia contemporanea.
Come se la gente vestisse in camicia o maglietta e pantaloni in tutte le stanze dell’edificio sociale, ma nella stanza dei poeti vigesse l’obbligo di indossare l’armatura e la cotta del crociato. La grammatica della complessità è cambiata nei nostri discorsi più banali e in quelli più articolati; ma in poesia la postura assertiva – erede di un’assertività religiosa? – non riesce a mettere in crisi se stessa.
Non vorrei che ci fosse qui un, come dire, abbaglio di prospettiva. La trasformazione sociale c’è stata, non c’è dubbio, e si rispecchia nei nostri discorsi, non c’è dubbio. Ma siamo davvero sicuri che i nostri discorsi non assomiglino al 90% a quelli dei nostri nonni, differenziandosi per un solo 10%? Non c’è dubbio che quel 10% sarebbe quello che sentiamo più rappresentativo, più identificante di noi stessi rispetto a chi ci ha preceduto – però resterebbe comunque un 10% (d’altra parte, per fare un’analogia, il 99,99% del DNA di tutti gli umani è identico, e la nostra cruciale differenza individuale si annida nel restante 0,01). Se così fosse, non ci sarebbe da stupirsi che il 90% della poesia contemporanea continui ad esprimersi come quella dei nostri nonni (o bisnonni): non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità. Quello che le chiediamo è di parlare a noi, e non si parla solo di quello che è nuovo o recente; e nemmeno si parla solo nelle modalità nuove o recenti. Quel 90% di zoccolo duro resta lì, a fianco del 10%. Che sopra abbiamo camicia e pantaloni, oppure l’armatura, sotto portiamo comunque le mutande, e la pelle, e i muscoli, e il desiderio sessuale e l’appetito e il bisogno di fare pipì. Non c’è da stupirsi che la poesia continui a parlarne.
In aggiunta, può ben darsi, come suggerisce Giovenale, che vi sia in poesia l’eredità di un’assertività religiosa, o comunque (non sono certo di capire bene del tutto l’uso che lui fa del termine assertivo/assertività) qualcosa di ereditato con forza. D’altra parte, la poesia (e proprio la poesia, non la prosa) viene sentita come qualcosa di particolarmente profondo, qualcosa che, anche se parla della banalità del quotidiano, in verità non si ferma mai alla banalità del quotidiano – quindi qualcosa che ha in comune con la religione un atteggiamento di fondo, io direi una sacralità (che è un concetto che non ha necessariamente a che fare con la divinità). Trovare questa sacralità nelle modalità di un presente frenetico ed estremamente secolarizzato è molto difficile; mentre esiste in maniera “naturale” nelle strutture che la poesia si è tramandata.
Questa risposta a due facce è comunque soddisfacente solo in parte. E infatti c’è inevitabilmente dell’altro, che viene già un po’ suggerito dalla seconda faccia. Può darsi che quello che Giovenale sente e che le sue parole esprimono sia proprio la necessità di una sacralità che possa essere trovata nelle forme del presente, quelle del suddetto 10%; poiché quelle del rimanente 90%, per quanto possano essere state a loro tempo autentiche, oggi non lo sono più (e Adorno sta occhieggiando dalla finestra).
Io temo però che ci troviamo di fronte a un altro abbaglio prospettico, che potrei descrivere come segue. La poesia riuscita, che ci piace, che definiremmo bella, è quella che mette in crisi il moi (con la sua assertività, suppongo) e che esprime dunque, in qualche modo, il presente. Questa è un’asserzione che sottoscriverei, a patto di non confonderla con il suo converso, che è questo: la poesia che mette in crisi il moi e che esprime dunque, in qualche modo, il presente, è quella riuscita, che ci piace, che definiremmo bella. Questa seconda, a differenza della prima, è un’asserzione prescrittiva, che ci dice che attraverso questi mezzi possiamo arrivare al fine della buona poesia; ma riduzione dell’io ed espressione del presente non sono mezzi, bensì fini. Comunque sia scritta una poesia, di qualunque cosa parli, siano anche coniglietti, se è una poesia interessante, complessa, ricca, bella, è una poesia che ci parla del presente e in cui l’io (il moi) del poeta non campeggia. Qualche volta potrà sembrare che lo faccia, ma sarà un effetto di superficie: pensiamo a – per fare un esempio di qualche anno fa – le poesie di Sandro Penna. Apparentemente centrate sull’io, sentimentali, banali come lessico e come sintassi; ma appena le si guarda più da vicino complessissime e strapiene di ragioni di interesse – in barba alla complicazione esibita delle poesie ermetiche loro coeve!
Questo mi rimanda all’altro punto cruciale su cui Giovenale insiste nel suo commento, cioè la questione dell’oscurità. Avevo affrontato una questione simile in un post di qualche mese fa (Del diritto della poesia a essere incomprensibile). In quel post distinguevo tra il diritto che la poesia ha all’oscurità (e dei suoi fondati motivi), e l’opportunità di non essere invece oscuri, e arrivavo a dire:
Entriamo più facilmente in un testo se abbiamo la sensazione di seguirne il discorso, e la poesia non fa eccezione. Per molti lettori, poi, specie se poco avvezzi alla poesia, se non c’è discorso non c’è nemmeno testo, e si abbandona presto la lettura di una siffatta assurdità. Se accettiamo che il discorso possa non essere coglibile, dobbiamo essere molto più disponibili alla sua ricerca, e persino al fallimento di questa ricerca.
Ma Giovenale sostiene che non sono oscuri testi (come quelli di Broggi o Zaffarano) che a me (e suppongo non solo a me) appaiono tali. Ha ragione solo in un senso banale. Se provo a leggere un testo come L’invenzione della scrittura, di Michele Zaffarano, tutto quello che leggo è immediatamente comprensibile, si parla di cose ed eventi storici. Quello che è oscuro è come si debba interpretare, in quanto poesia, un testo di questo tipo. Credo che la maggior parte dei lettori arriverebbero, al più, a considerarlo una sorta di provocazione neo-dadaista; però molto datata, se considerata così. Voglio sperare che ci sia un’altra interpretazione chiave, che mi permetta una lettura a più strati, ricca e complessa; tuttavia, sinché io non la trovo, questo mi appare come un testo vuoto, non interessante. Poiché è sufficientemente evidente che si tratta di un’operazione colta, non banale, le concederò il beneficio del dubbio, e riconoscerò che si tratta comunque di un tentativo. Ma nella misura in cui non colgo l’interesse del testo, esso non mi parla, non mi rappresenta; e non riduce affatto il moi dell’autore: semplicemente lo afferma in un altro modo, più indiretto e astuto, ma non meno forte. (Poi, certo, sarebbe compito della critica fornirmi spunti per cogliere l’interesse del testo. Ma se la critica non lo fa, con chi me la prendo? con l’incapacità dei critici o con l’oscurità dell’autore? Posso sempre sperare, certo, che sia uscito qualche intervento critico di cui non ho avuto notizia. Però, sinché non ne ho notizia, siamo da capo.)
Il primo pregio delle poesie di Amelia Rosselli è quello di essere (almeno per me) fortemente coinvolgenti. Esprimerebbero una riduzione dell’io anche se non la tematizzassero; in più la tematizzano, spesso.
Per quanto riguarda Le petit bidon di Tarkos, ho la sensazione che il fascino di questo testo orale stia in gran parte nella capacità espressiva orale di Tarkos stesso. Non ne ho trovato on line la versione scritta, il che mi fa pensare che sia un testo fatto per l’oralità e basta. E questo va benissimo. Ma se ne esistesse una versione scritta, dubito che sarebbe capace di trasmettermi un fascino comparabile a quello che la sua voce costruisce. Magari il testo di Zaffarano è oral poetry, un semplice canovaccio per l’esecuzione, ma allora il testo (come nel caso di Tarkos) dovrebbe essere l’esecuzione e non la partitura da leggere con gli occhi. Se però accettiamo questo, accettiamo anche che entrino in gioco elementi espressivi, del suono e della voce, molto diversi e già autonomamente significativi. Esagerando un po’, Tarkos avrebbe potuto ottenere lo stesso effetto affascinante anche con un testo verbale molto diverso, fatti salvi gli andamenti dell’esecuzione orale. Ma senza arrivare a questo, io credo che sia per l’effetto dell’andamento della voce che il piccolo bidone e gli spostamenti dell’aria al suo interno finiscono per diventare così interessanti, e fascinosa metafora di chissà cosa…
Dove voglio arrivare non lo so. Quello che mi è ben chiaro è che la poesia è una cosa e le poetiche ne sono un’altra, che sta già sul versante della critica. Per questo la poesia possiede un diritto ad essere oscura che la critica invece non ha. Certo l’oscurità di un testo poetico aumenta la sua probabilità di non poter essere inteso, e senza un’intesa (il gioco di parole è voluto) tra il testo e il lettore non parte il meccanismo che ci permette di entrare nel gioco, di essere coinvolti, di trovare interessante la casa, l’ambiente che ci circonda. Oltre un certo limite di oscurità l’intesa non viene trovata più da nessuno, e il testo poetico è come una casa (magari meravigliosa) di cui nessuno possiede la chiave. Un oggetto inutile, insomma.
(continua – molto molto a lungo, probabilmente)
Caro Marco Giovenale
voglio rispondere qui a una serie di questioni da te aperte nel tuo post del 25 agosto “scritture di ricerca: dopo il paradigma” (anche riproposto in versione più breve il 10 settembre su punto critico). Rispondo da qui perché i commenti da te sono chiusi, perché avrei comunque troppe cose da dire per rinchiuderle nello spazio di un commento, e perché – su sponde per certi versi opposte – mi ritrovo a guardarmi attorno su percorsi che mi paiono simili a quelli che lasci trasparire dal tuo intervento, cogliendo l’occasione per un chiarimento anche a me stesso su alcuni concetti.
In primo luogo, una precisazione doverosa su polemiche passate, rispetto al cambio di paradigma (per esempio, qui da me, e su Nazione Indiana). Se lo posizioni nei primi anni Sessanta, cioè agli inizi della Neoavanguardia italiana, non ho nulla da obiettare. D’altra parte, quello è il periodo in cui i cambi di paradigma di sprecano, nella cultura occidentale: solo per citarne alcuni a me cari, la musica colta ha attraversato Darmstadt da pochissimi anni, e quella di ascolto più diffuso sta incontrando la nascita del Rock e dei Beatles (una via senza ritorno); gli studenti si stanno politicizzando e di lì a poco ci sarà Berkeley e il maggio parigino; il fumetto inizia timidamente (specie in Francia e in Italia) a rivolgersi a un pubblico colto.
Tutti questi cambiamenti rispecchiano evidentemente l’assunzione diffusa di una trasformazione sociale, e potrebbe essere benissimo – come dici tu – “la sovrapposizione di due onde sonore contrapposte nella storia – distruzione e ricostruzione (guerra e “boom”)”; ma evidentemente anche – e credo che me lo concederai facilmente – le peculiari caratteristiche di questa ricostruzione, con l’apertura radicale (e quasi improvvisa) di una società mediatizzata e di massa.
In secondo luogo, ti ringrazio perché mi hai fornito l’occasione per rileggere il saggio di Eco che citi (“Del modo di formare come impegno sulla realtà”, uscito su Il Menabò nel 1962, poi in Opera aperta), che avevo letto troppi anni fa, e troppo presto; e perché mi hai costretto, per risponderti, ad andarmi a cercare il saggio di Lacan (Dei nomi del padre, che contiene anche il saggio del 1953 “Simbolico immaginario e reale”) che non conoscevo nello specifico, anche se giro da tempo attorno a quegli stessi temi lacaniani attraverso altri scritti.
Ed ora veniamo al punto, anzi ai punti – sempre considerando che le tue non sono tesi scolpite nel marmo (mi pare di capire), bensì proposte; e come tali le discuto, pregando chi mi legge di considerare allo stesso modo quello che scrivo qui.
Ecco, quindi, la premessa lacaniana del tuo intervento, che trovo, devo dire, un po’ pretestuosa. Capisco bene la posizione di Lacan, pur espressa con la sua solita indelicatezza, che lamenta il fatto che il paziente voglia, in qualche modo, sostituirsi all’analista, cercando di analizzare da sé le proprie esperienze. Tuttavia non capisco affatto come si possa in qualsiasi modo avvicinare la relazione (psico)analitica alla relazione autore-lettore, se non magari sul solo piano del narcisismo (dell’autore che vuole sostituirsi al lettore, così come del paziente che vuole sostituirsi all’analista). Tuttavia, la medesima accusa di narcisismo potrebbe essere rivolta anche all’autore che si esprima con strutture linguistiche e/o concettuali del tutto proprie, e pretenda (narcisisticamente) che il suo pubblico (che non è un terapeuta raffinato, non è pagato per farlo, e non è Lacan, con il suo acume e la sua cultura) lo segua, lo intenda, o perlomeno si sforzi di farlo. Narcisismo per narcisismo, non so quale sia peggio, visto che ambedue questi autori (il tuo e il mio narciso) ignorano evidentemente alcuni fatti di linguaggio piuttosto basilari.
Poi, in quello che segue nel tuo intervento mi ritrovo abbastanza, a parte alcuni accostamenti che mi paiono davvero forzosi, come quello tra il suicidio di Vittorio Reta nel 1977 e l’uscita della Parola innamorata nel ’78, o (idem) quello tra il suicidio della Rosselli e l’uscita nel ’96 dell’antologia dei “cannibali”. Ma le prendo come provocazioni evocative, e magari un po’ nostalgiche.
Piuttosto, è proprio là dove parli di Amelia Rosselli che la mia attenzione si è improvvisamente risvegliata, per esempio là dove dici “Rosselli era soggetto (oscuro) di scrittura (oscura), brutalmente sintetizzando: un je (quasi) senza moi.” Questo mi piace molto, mi ci ritrovo, lo pensavo anch’io, ma indubbiamente l’uso dell’antinomia lacaniana rende molto più chiara la cosa.
Credo che valga la pena di andare maggiormente in profondità, non tanto su Rosselli (già lo faccio parecchio in un saggio sulla metrica della poesia italiana recente, in uscita tra poco su L’Ulisse) quanto in generale sulla questione della lirica e dell’io. L’ipotesi (ed è davvero un’ipotesi, perché sto scrivendo senza avere troppo chiaro a che conclusioni arriverò) è che la distinzione lacaniana tra je (il “soggetto inconscio”, soggetto del desiderio e delle pulsioni) e moi (la sovrastruttura costruita socialmente in cui riconosciamo noi stessi, inevitabile ma inevitabilmente fittizia – una finzione di cui non si può fare a meno per esistere, insomma) possa gettar luce su cosa si intende con espressioni quali “riduzione dell’io”, “dopo la lirica” ecc.
Mi sembra abbastanza evidente che l‘io di cui si parla nei dibattiti attuali sulla poesia dovrebbe essere il moi, non certo il je, cioè la sovrastruttura apparentemente coerente con cui ci rivolgiamo al mondo: siccome questa sovrastruttura è costruita a partire da questo stesso mondo che ci circonda, un certo accordo tra moi e mondo circostante sarebbe dunque garantito. Una delle tesi del nuovo paradigma (dagli anni Sessanta a oggi) dovrebbe essere dunque che va smascherata la natura fittizia del moi, in quanto sodale a una natura fittizia e costruita del mondo circostante. Poiché (lacanamente, ma non solo) il linguaggio (nietzschianamente, ma non solo) è il principale garante di questa apparenza di coerenza, il linguaggio va decostruito, e tanto peggio se questo produce delle difficoltà di comunicazione: la facilità di comunicazione non è che un’altra delle illusioni che tengono insieme il moi e il mondo circostante! Si tratta (riferimenti lacaniani a parte) grosso modo di una delle tesi esposte da Eco nel 1962 nel saggio da te ricordato, e che ho citato sopra.
Le cose, però, come sempre, non sono così semplici. Intanto il moi c’è, e non se ne può fare a meno, anche se è un’illusione. L’idea che se ne possa sollevare la coperta per vedere la realtà che si trova sotto è a sua volta una illusione; per bene che vada vi si troverà infatti un altro moi, magari più complesso e (forse) meno narcisistico, auspicabilmente meno tormentato (se si tratta del moi di un paziente che si rivolge a un terapeuta). Si tratta del paradosso dello “schema concettuale alternativo” portato in luce da Donald Davidson e sottolineato da Richard Rorty (in Conseguenze del pragmatismo, mi pare): lo “schema concettuale alternativo” è solo una possibilità virtuale, visto che non possiamo concepirlo che nei termini del nostro proprio sistema concettuale. Però, certo, il nostro sistema concettuale può cambiare: ma allora siamo noi stessi che cambiamo, e il nuovo sistema concettuale non è più alternativo; è semplicemente, adesso, il nostro, e ci siamo dentro, e magari leggiamo nei suoi termini quello dentro cui vivevamo prima – ma non possiamo tornare indietro, o, peggio, saltare un po’ di qua e un po’ di là per comparare i due punti di vista.
Però, si dirà, la poesia non è filosofia, e non deve spiegare, ma solo esprimere, o meglio, direi io, far vivere al suo lettore una certa condizione. Allora vogliamo dire che se la poesia non fa vivere al suo lettore una certa condizione di problematicità del moi, si tratta di poesia inautentica, falsa? Mi sembra una conclusione eccessiva, che presume che la poesia debba avere sempre a che fare con i massimi sistemi (di questo ho parlato ampiamente in un post della scorsa settimana), e che sia comunque vincolata a dire sempre il vero al livello più profondo possibile, assumendo che il livello più profondo possibile sia quello del rapporto tra je e moi. Potrei aggiungere che quando mi trovo di fronte a una poesia riuscita, fosse anche il prototipo petrarchesco della lirica, un certo superamento del moi è comunque presente, se solo si va oltre, nell’interpretazione, al significato letterale delle parole; perché è la forma stessa della composizione a richiamare qualcosa che non riguarda strettamente l’io. Poi, certo, il tipo di strutture di riferimento che un sonetto di Petrarca richiama è abbastanza diverso da quello delle nostre – anche se non del tutto. Una certa parte di verità gli rimane anche per noi; altrimenti non avremmo alcun modo di apprezzarlo.
Ma restiamo sul punto, e assumiamo che, se pure la tematizzazione della finzionalità del moi non sia indispensabile, certo per la poesia del nuovo paradigma essa è importante, e va tenuta in posizione centrale. Anche a queste condizioni, resta comunque la questione del quasi, nel senso in cui la poesia di Rosselli è un je (quasi) senza moi. Dal quasi, evidentemente, non si scappa, per le ragioni dette sopra. Di conseguenza, qualsiasi destrutturazione è, implicitamente, una nuova strutturazione.
Io credo (sottolineo io; non so cosa ne pensasse Lacan in proposito) che nella cultura occidentale il moi individuale si sia molto rafforzato negli ultimi due secoli, contestualmente al trionfo della ragione positiva (e poco importa che Kant avesse già dimostrato nella sua prima Critica l’insostenibilità razionale dell’idea di Io – insieme a quelle di Mondo e di Dio), e all’indebolimento delle strutture sociali tradizionali, molto più collettive e comunitarie di quelle moderne. La messa in crisi del moi in poesia diventerebbe perciò un tema caldo solo nella modernità, nel momento in cui questa sovrastruttura diventa sovrabbondante – e al tempo stesso vanno in crisi tutte le Weltanschauung globalizzanti, a partire dalla ragione logica stessa (Gödel docet).
Ma credo anche che la prima conseguenza storica (nel nostro campo) di questo predominio del moi sia stato il predominio della lirica in poesia, a danno degli altri generi tradizionali. Sino al punto che qualsiasi epica pensabile oggi è comunque epica di individui, un’epica lirica, come ne “La ragazza Carla”. Paradossalmente, persino la centralità del tema della riduzione dell’io in poesia è espressione della centralità dell’io, del moi. Lo potremmo pensare come un tentativo, consapevole della propria impossibilità, di guardare sotto la superficie del moi, da apprezzare come tentativo eroico, e non per quello che (non) troverà. Una sorta di convivenza della letteratura con la modalità del labirinto, facendosi magari labirinto a sua volta (tanto per chiudere il cerchio con l’altro critico che tu stesso citi, cioè Calvino).
Comunque sia, Amelia Rosselli riesce in qualche modo a costruire l’impressione di una destrutturazione del moi. L’impressione conta: magari, lavorandoci sopra, troverò la coerenza nascosta nel suo sistema. Ma intanto l’impressione di scarsa strutturazione del moi c’è già stata, e ha già agito su di me, il suo lettore.
Amelia Rosselli, tuttavia, non scrive in maniera incomprensibile. Elimina o trasforma dei nessi, ma ne conserva altri. Scrive, insomma, in maniera da risvegliare continuamente la mia curiosità, e mi spinge ad andare avanti, e ad accorgermi, in qualche modo vivendola, della sua difformità.
Molti testi di scrittura di ricerca non sono capaci di fare questo: mi si pongono davanti, semmai, come rebus, e si aspettano che sia io a essere interessato a loro, senza fare nulla per venire verso di me. Sappiamo bene come quello dell’interpretazione sia un campo strano: la Qabbala stessa ci insegna come da qualsiasi sequenza di lettere e/o numeri si possano ricavare un’eternità di significati differenti. Se quello che mi piace è avere un testo che non mi sveli dove sta andando, affinché sia io (lettore) a trovarlo, basta seguire l’indicazione data a suo tempo da Tristan Tzara, costruendo una poesia con le parole estratte a caso da un sacchetto. Ne ricaveremo certamente un testo che sembra esprimere un je (quasi) senza un moi.
Quello che io trovo interessante nella poesia di Rosselli, viceversa, non è che sia stata capace di destrutturare (in parte, in apparenza…) il moi, ma che sia stata capace di farlo continuando ugualmente a richiamare il mio interesse di lettore. Per farlo, evidentemente, Rosselli deve giocare su delle strutture semiotiche (cioè linguistiche, ma non solo) condivise, e deve darmi continuamente la sensazione di stare comunicando qualcosa di rilevante. Insomma, deve presentarsi inevitabilmente come un moi che comunica a un altro moi. Certo, se si fermasse lì, probabilmente il nostro interesse non andrebbe molto più in là; ma se di lì non passasse, non vi sarebbe nemmeno motivo di interesse – come di solito non ce n’è per i prodotti del caso, se non, talvolta, come curiosità.
Detto questo, la destrutturazione del moi (o almeno la sua impressione) è più una questione di gradi che non di presenza/assenza assolute. E siccome l’interpretazione ha numerosi (tendenzialmente infiniti) livelli, non è difficile accorgersi che a uno di questi livelli persino il crepuscolare pascoliano Pasolini arriva a destrutturare il suo moi nel mito della collettività dei sottoproletari o dell’icona collettiva di Gramsci, benché si esprima con forme canoniche nel linguaggio e nel racconto. Ed è magari anche per questo che comunque noi apprezziamo la sua poesia. E, magari, ciò che è assertivo a un livello si rivela non assertivo a un altro; oppure addirittura viceversa. Mai fidarsi delle apparenze, nel campo della parola.
Forse il cambio di paradigma, da questo punto di vista, non ha fatto che spostare più in superficie il livello della destrutturazione dell’io richiesta. Certo non ha cambiato la centralità del moi, anche se magari l’ha ribaltata (apparentemente) in negativo.
O forse è proprio l’espressione paradigma a essere fuorviante. Kuhn la impone all’uso parlando delle rivoluzioni scientifiche; e il paradigma è un po’ il criterio soggiacente ai dibattiti scientifici di una certa epoca, quella cosa che, quando cambia, impone una riconsiderazione globale delle verità assodate sino a ora. Forzando un poco (non molto), può aver senso usare la parola paradigma per la critica, anche se lo statuto delle verità critiche è diverso da quello delle verità scientifiche – ma si tratta comunque di un campo caratterizzato da un pubblico dibattito tra i soggetti che ne fanno parte attivamente. Però la poesia, in sé, non è un campo di discussione; le opere d’arte non sono tesi, o asserzioni vere o false. Magari lo diventano attraverso l’occhio della critica; ma questo riguarda la critica, non la poesia. Pensare che ci possa essere un paradigma (e quindi dei cambi di paradigma) in poesia, a me sembra legato all’idea che ci possa essere uno schema di fondo che regoli tutta la poesia di un’epoca; e la poesia che non si adegua si trova fuori dal dibattito. Ma il campo della poesia non è fatto così: solo se lo confondiamo con quello della critica che se ne occupa possiamo pensare che lo sia. È nel campo della critica che il dibattito avviene.
Per concludere, due osservazioni su un paio di testi che mi arrivano contestualmente alle tue riflessioni. Uno è quello di Jean-Marie Gleize che citi tu stesso nel post del 26 agosto sulla mimesi (non condivido le riflessioni che fai sulla mimesi, ma ne parliamo un’altra volta); l’altro è una coppia di poesie di Andrea Inglese apparse su poetarumsilva il 24 agosto, attaccate con curiosa violenza da qualche lettore. Il testo di Gleize non è privo di attrattiva, ma sembra uscire dalla prescrizioni di Marinetti (e forse Soffici – entrambi comunque quanto a virulenza del moi non scherzavano) nel Manifesto della letteratura futurista: alla fin fine, “La passeggiata” di Aldo Palazzeschi mi diverte molto di più. Viceversa, trovo molto intrigante l’apparente pochezza delle poesie di Inglese, persino l’apparente ostensione dell’io: c’è qualcosa, in loro, che continua a trattenere l’attenzione, e lo straniamento dell’io ne esce progressivamente e nettamente. Certo, ne emerge, inevitabilmente, anche un’altro moi, più ricco e più critico, che osserva “dall’alto”; però, appunto, della finzione del moi non è possibile fare a meno.
A presto, e à suivre.
Le parole dell’articolo di Carlo Carabba “Meno Sanguineti più Szymborska: liberiamo la poesia”, uscito l’11 marzo sull’inserto domenicale del Corriere, “La lettura” (leggibile qui, segnalato e commentato da Massimiliano Manganelli qui), sembrano riprodurre un antico cliché: buono è ciò che piace ai più. E il libro della Szymborska, caso più unico che raro di raccolta di poesie assurto all’empireo dei libri più venduti, fornirebbe l’esempio di versi “che hanno un pregio che spiazza e sorprende il lettore: si capiscono e, spesso, commuovono”.
Divento inquieto quando leggo queste cose. Evidentemente io non appartengo alla categoria dei lettori a cui fa riferimento Carabba, visto che trovo talvolta commoventi i versi di Sanguineti, mentre non mi ritrovo capace né di capire né di apprezzare la Szymborska. Sto facendo un’affermazione eretica, evidentemente, ma io non leggo il polacco, e ritengo che la poesia sia non traducibile, bensì solo riscrivibile in un’altra lingua (ovvero in un altro sistema semantico, lessicale, prosodico, ritmico, metrico e fonetico – sempre assumendo che il sistema di valori culturali di riferimento sia sufficientemente simile da non produrre troppi equivoci). Di conseguenza non mi permetterei di dire che la Szymborska non è un grande poeta, o anche soltanto che non mi piace: io non ho mai letto la Szymborska, bensì solo i suoi traduttori.
Certo, al cliché (pseudodemocratico) che è buono ciò che piace ai più si contrappone quello non meno irritante (pseudoaristocratico) per cui è buono solo quello che pochi sanno apprezzare. Questo secondo è il chiché delle sette e delle conventicole, e non si può negare che le avanguardie storiche, indipendentemente dalla loro importanza e dal loro successo, abbiano mostrato una certa tendenza a organizzarsi in sette e conventicole. Inevitabile strategia di sopravvivenza, certamente. A cui si aggiunge la rassicurante sensazione di far parte di un gruppo di eletti, di aristocratici dello spirito – persino quando si perseguono ideali socialisti, persino quando si è bolscevichi.
Ma le avanguardie non si possono ridurre a questo. Se lo si fa si corre il rischio di prendere granchi grotteschi, quale il sostenere – come fa Carabba – che tra i bersagli polemici dei Novissimi, espressi nell’Introduzione di Giuliani, ci sarebbe anche “una lingua che abbia la pretesa (ingenua) di significare qualcosa”. Nemmeno Balestrini, il più estremista del gruppo da questo punto di vista, potrebbe davvero riconoscersi in una proposta così estrema. E così stupida, bisogna aggiungere: Carabba deve costruire la caricatura del proprio bersaglio, e caricarla in eccesso, per poterlo distruggere. Un segno che in verità il suo obiettivo polemico non è così facilmente attaccabile.
Ha un poco più ragione quando espone l’altro obiettivo polemico di Giuliani, quella che (pure qui caricando, perché i termini della polemica di Giuliani non sono esattamente questi) Carabba definisce “la malaugurata tendenza dei poeti a parlare di sé”.
È a questo punto che, come esempio (negativo) delle perduranti conseguenze dei mali introdotti nella poesia dall’avanguardia, Carabba cita il volume curato da Vincenzo Ostuni, Poeti degli anni Zero. Ho polemizzato anch’io con Ostuni, e non condivido diversi tra i criteri che hanno guidato le sue scelte. Tuttavia, interventi come quello di Carabba mi spingono, se non a concordare, perlomeno a prendere le difese di Ostuni.
Intanto, nel complesso l’antologia è riuscita. Il criterio di selezionare un numero ridotto di autori cui dedicare molte pagine è condivisibile e anche coraggioso, perché comporta la necessità di escludere tanti. Inevitabilmente, quindi, non si sarà (e non sono) d’accordo sulle esclusioni e inclusioni. Ma questo è secondario, perché non esiste (per fortuna) una scienza esatta della qualità dei poeti – e tutto sommato Ostuni me ne presenta parecchi che interessanti sono.
Detto questo, c’è davvero un errore nelle posizioni di Giuliani, Ostuni e Zublena (che Ostuni cita ampiamente nella sua introduzione), ed è quello di ritenere che la riduzione dell’io sia uno strumento in mano al poeta e/o un metro di giudizio in mano al lettore. Se dovessimo dar credito ciecamente a queste posizioni, dovremmo concludere, guardando indietro, che Gabriele D’Annunzio (che di se stesso parla direttamente assai poco nei propri versi) è un poeta molto più in linea con i Novissimi di Guido Gozzano (il quale invece non fa altro che parlare di sé e del proprio mondo); e non si capirebbe come mai il medesimo Sanguineti attribuisca tanta importanza al secondo anziché al primo.
In verità, io credo, la riduzione dell’io non è una causa bensì un effetto, collaterale, della qualità poetica. In altre parole, una poesia di valore è una poesia che viene apprezzata per il suo rappresentare qualcosa per chi legge, indipendentemente dal fatto essa che dica “io” oppure no, o che abbia “tratti di immobilità o compiutezza”, come ricorda Ostuni, oppure no. Si potrà forse sostenere che un componimento che escluda l’io e che abbia carattere di non propositività esprime meglio il nostro tempo (e questa è l’unica giustificazione sensata che riesco a trovare alle regole esposte da Zublena e citate da Ostuni); ma anche questo è a sua volta discutibile, e presuppone implicitamente che il nostro tempo sia suscettibile nel suo complesso di una rappresentazione sufficientemente unitaria – fosse pure quella della semplice incertezza: ma anche la certezza dell’incertezza è una certezza, e dal paradosso non si esce.
Quanto alla natura democratica o aristocratica delle scritture poetiche, temo che Carabba sia vittima comunque di un errore di prospettiva. Il prestigio culturale di cui la poesia gode da secoli e di cui continua comunque a godere, per quanto in Italia sia evidentemente in calo, non è legato alla sua natura democratica o popolare, se non ritornando sino alle origini orali, per noi perdute. Tra i poeti che leggiamo sulle nostre antologie scolastiche, gli ultimi sospettabili di un legame con il popolare sono assai più vecchi di Dante. Il prestigio culturale della poesia ha poco a che fare con la sua diffusione, e con i grandi numeri.
L’auspicio, del tutto condivisibile, di una sua maggiore diffusione, non è l’auspicio a una semplificazione della poesia, bensì quello a un maggior numero di lettori competenti. Non sarà una cosa facile, sinché l’accento, nella fruizione dei testi letterari, a partire dal romanzo, continuerà a essere messo dall’industria culturale sui contenuti, sulla trama avvincente, sulla storia – come comunque fa Carabba, e come continua a fare, implicitamente seppur in negativo, chi sostiene la necessità della riduzione dell’io, e ne vede lo strumento nella complessità sintattica e discorsiva. Che le proposte avanzate a suo tempo dai Novissimi siano diventate ormai da anni maniera, e abbiano contribuito – come ogni maniera – al formarsi di sette e conventicole, è certamente un fatto. Ma questo non squalifica a priori nessuno specifico poeta, come non lo qualificherebbe a priori la sua appartenenza a qualsiasi ambito stilistico. E né la complessità né la semplicità sono di per sé indici di qualità.
La realtà, quella sì, è davvero complicata. Ridurre la qualità poetica al successo di pubblico, al giudizio del lettore qualsiasi, è una semplice ingenuità – oppure è un programma politico, ma noi speriamo di no.
Serenata
Homenaje a Lope de Vega
.
Por las orillas del río
se está la noche mojando
y en los pechos de Lolita
se mueren de amor los ramos.
¡Se mueren de amor los ramos!
La noche canta desnuda
sobre los puentes de marzo.
Lolita lava su cuerpo
con agua salobre y nardos.
¡Se mueren de amor los ramos!
La noche de anís y plata
relumbra por los tejados.
Plata de arroyos y espejos.
Anís de tus muslos blancos.
¡Se mueren de amor los ramos!
.
da Federico García Lorca, Canciones (1921-24),
Ecco la traduzione di Carlo Bo (Guanda 1962):
Serenata
Omaggio a Lope de Vega
Lungo le rive del fiume
la notte si sta bagnando
e nei seni di Lolita
muoiono d’amore i rami.
Muoiono d’amore i rami.
La notte canta nuda
sopra i ponti di marzo.
Lolita si lava il corpo
con acqua salmastra e nardo.
Muoiono d’amore i rami.
La notte d’argento e anice
risplende sui tetti.
Argento di rivi e specchi,
anice delle tue cosce bianche.
Muoiono d’amore i rami.
.
Non è solo bella, questa Canción (Canzone) di García Lorca. È che pone un problema a cui non so dare una risposta certa. Alfredo Giuliani scrive, nel 1961, nella prefazione alla storicamente cruciale antologia I Novissimi: “La riduzione dell’io è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente”. Così facendo apre la stagione della poesia dopo la lirica, almeno in Italia.
Ma quando leggo le Canciones, o il Romancero gitano, o il Diván del Tamarit scritti da García Lorca negli anni Venti e Trenta, io l’io non ce lo so proprio vedere – almeno non più di quanto ce lo sappia vedere nelle poesie della Neo-avanguardia. Per esserci, ci sarà, non c’è dubbio, da qualche parte dietro; ma c’è persino, da qualche parte dietro, nelle poesie fatte a macchina di Balestrini. Quindi non è a questa presenza nascosta che si riferisce Giuliani, e gli araldi contemporeanei della riduzione dell’io.
D’altra parte, continuiamo a chiamare lirica la produzione di García Lorca delle raccolte che ho nominato? Non mi pare che García Lorca avesse in quel momento velleità avanguardiste (ha fatto poi anche quello, nello straordinario e surrealista Poeta en Nueva York, e anche sulla liricità di quello ci sarebbe da discutere), tant’è vero che la poesia riportata qui sopra si presenta persino come un omaggio a Félix Lope de Vega y Carpio, un grande della poesia ispanica a cavallo tra Cinquecento e Seicento. E quella di Lope de Vega era lirica?
Certo, potremmo sostenere che qui il poeta, pur non utilizzando mai la prima persona, sta esprimendo un sentimento personale. Ma questo potrebbe essere sostenuto per qualsiasi componimento contemporaneo – persino per Balestrini, se pur un po’ più contortamente. Oppure potremmo dire che il sentimento espresso in questi versi è un sentimento popolare, una voce di tutti, di cui semplicemente il poeta si fa portavoce: e allora l’io è ridotto, indubbiamente.
Insomma, in semplici termini di liricità o di riduzione dell’io, qual è la differenza tra questa poesia e quella che cavalca la bandiera del dopo la lirica? (Potremmo parlare – adornianamente – di perdita dell’innocenza, di espressioni dell’alienazione, dell’impossibilità o colpevolezza del parlare degli alberi dopo Auschwitz: ma tutto questo è trasversale alla questione della lirica. Queste differenze probabilmente ci sono, ma non riguardano affatto la questione dell’io e della sua espressività.)
P.S. Sulla questione della riduzione dell’io e della lirica ho già scritto, per esempio, qui e, in generale, nei post sotto il tag lirica.
I temi che ho affrontato due settimane fa in un post intitolato Delle questioni delle poetiche, della lirica, del soggetto e della leggibilità continuano a girarmi per la testa e a crearmi più perplessità che certezze. Il post era stato ispirato da un intervento di Andrea Inglese su Nazione indiana; e a farmi rimuginare questi temi hanno contribuito altri post, tenendo aperto un dibattito in cui questi stessi temi si inseriscono (anche se esso ne investe pure altri, che non affronterò qui): sono il post di Marco Giovenale ancora su Nazione Indiana, quello di Lorenzo Carlucci su Poesia 2.0, la prima e la seconda più articolata risposta del medesimo Giovenale su Slowforward, con tutte le relative abbondantissime discussioni, ora molto interessanti ora pura polemica personale.
Il punto (o almeno quello che mi ronza per la testa ora) è la questione della cosiddetta “riduzione dell’io”. Alfredo Giuliani scrive nel 1961, introducendo l’antologia de Novissimi, che “La ‘riduzione dell’io’ è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente“. Mi sembra del tutto ragionevole che Giorgio Manacorda (introducendo nel 2004 il suo La poesia italiana oggi. Un’antologia critica) faccia notare che c’è qualcosa di paradossale nel fatto che l’espressione, e per giunta l’espressione soggettiva, si debba realizzare mediante riduzione del soggetto medesimo, per cui “o il punto non è l’espressione, bensì il referto (appunto la riduzione dell’io a “cosa”) e allora va bene cancellare o anche solo ridurre l’io, o il problema è l’espressione, e allora perché ridurre l’io, magari fino a cancellarlo? Questa scelta ha avuto conseguenze per le generazioni successive.”
Non si può certo qui ripercorrere quello che è successo nella poesia italiana dagli anni Settanta in poi. Trovo però interessante che tutti e due i corni della scelta – che Giuliani cercava ancora, eliotianamente (montalianamente?) e pericolosamente di tenere insieme – abbiano trovato espressione, e prodotto, talvolta, anche opere di qualità.
Non riesco, proprio per questo dunque, a far a meno di vedere nelle dichiarazioni di Giuliani qualcosa di molto meno assertorio, universale e definitivo di quanto il suo tono di voce voglia far credere. Le frasi chiave del discorso di Giuliani mi paiono in verità queste, appena dopo l’apertura del saggio introduttivo: “Io credo si debba interpretare la ‘novità’ anzitutto come un risoluto allontanamento da quei modi alquanto frusti e spesso gravati di pedagogia i quali perpetuano il cosiddetto Novecento mentre ritengono di rovesciarlo con la meccanica dei ‘contenuti’. Ciò che molta poesia di questi anni ha finito col proporci non è altro che una forma di neo-crepuscolarismo, una ricaduta nella ‘realtà matrigna’ cui si tenta di sfuggire mediante schemi di un razionalismo parenetico e velleitario, con la sociologia, magari col carduccianesimo.” Se leggiamo tutto il resto alla luce di questo, ci appare evidente che Giuliani non sta dicendo come si debba fare poesia in generale, ma semplicemente proponendo un percorso di uscita da una situazione culturale di stallo; e che Pasolini ne fosse in quegli anni l’emblema lo dimostra abbastanza chiaramente la sua successiva parabola poetica involutiva.
In altre parole, Giuliani sta proponendo di rinnovare la poesia italiana guardando più a Eliot e Pound che a Pascoli e Corazzini. Ma cosa ne sarà del valore di un’affermazione di questo genere qualche anno dopo, una volta che la poesia sia stata davvero rinnovata? Se la scelta starà tra “riduzione dell’io” e “espressione soggettiva”, una volta che la “riduzione dell’io” abbia vinto, dovremo ritornare all'”espressione soggettiva” per rinnovare di nuovo? E poi ancora viceversa? Certo che oggi, cinquant’anni dopo, potremmo magari leggere proprio in questi termini quello che è accaduto in seguito, e valutare in termini di progressisti e conservatori ora gli uni ora gli altri, ora i riduttivisti ora gli espressivisti.
Le polemiche che si possono leggere in calce ai post che ho citato sopra appaiono spesso (non sempre) impostate davvero in questi termini. Assunta come opinione condivisa che sia positivo essere progressista e negativo essere conservatore, ci si scanna per decidere chi sia il vero progressista. Naturalmente scannarsi serve anche per proporsi pubblicamente, e quindi in questo dibattito c’è senz’altro una forte (e positiva) componente di promozione personale (insomma, di autopubblicità). E questo va benissimo, soprattutto con il poco interesse che gira nell’aria in Italia per la poesia: magari qualche dibattito acceso può richiamare l’attenzione di qualcuno, e far venir voglia persino di leggere le opere.
Ho tuttavia la sensazione che il dibattito manchi il punto, e che ci siano troppi elementi sia a favore che contro (tanto per i riduttivisti quanto per gli espressivisti) per poter prendere partito per una delle due posizioni. A me pare semplicemente che quando un lavoro poetico è davvero riuscito, se ne percepisca sia una componente di espressività che una di superamento della soggettività: se sentiamo che l’io straborda, non è poesia, ma diario, autobiografia; se dell’io non troviamo traccia non è poesia, ma tabella, elenco, calcolo. D’altro canto, ci sono poesie riuscite in cui apparentemente l’io straborda, ma sono riuscite perché è facile rendersi conto che questo strabordare è pura apparenza, presentazione di un caso umano – e la poesia è riuscita perché quel caso umano è sentito come universalmente rappresentativo. E ci sono anche poesie riuscite in forma apparente di elenco o calcolo, dove ci si accorge che da quelle relazioni apparentemente astratte emerge in verità un universo di significati, e di nuovo qualcosa di universalmente rappresentativo. Nell’uno e nell’altro caso questa universale rappresentatività non è necessariamente una verità: può essere una domanda, un dubbio, una ricerca; comunque sia è qualcosa in cui ci possiamo riconoscere – e possiamo riconoscerci, con questo, parte dell’umanità.
Poiché nella poesia che funziona, quella che è bella, profonda, riuscita, non trovano spazio vero né la riduzione dell’io né l’espressione soggettiva, e tuttavia entrambe possono farne parte come mattoni da costruzione, i simpatizzanti di ambedue i partiti possono con una certa plausibilità accusare gli avversari di cercare di mettere nella poesia qualcosa che non ci dovrebbe essere. Dovrebbe essere evidente, a questo punto, la natura pretestuale di entrambe le posizioni: sono due ricette, ciascuna delle quali pretende di produrre la vera poesia; due apparenti scorciatoie, o, se siamo più generosi, due proposte di percorso. Alla poesia buona, di qualità, si può di fatto arrivare sia per l’uno che per l’altro percorso, o anche (credo) per nessuno dei due. E la poesia buona soddisferà tutti e due i partiti, perché gli uni vi ritroveranno l’assenza della riduzione dell’io, e gli altri quella dell’espressione soggettiva.
Bisognerebbe relativizzare, a questo punto, anche il concetto di “poesia buona”. A che cosa si aspira quando si fa poesia? A influenzare il presente? Ma allora basterebbe una buona comunicazione funzionale. A poter essere storicizzati? E allora basta trovare il pubblico giusto, che siano i tanti (ma anche di scarsa competenza poetica) della Merini, o che siano i molto meno (ma di molto superiore competenza poetica) di De Angelis. Chi vale di più, dei due? Integrati e apocalittici hanno pane per i reciproci denti. E la storia si scrive anche attraverso queste discussioni.
Personalmente, preferisco di gran lunga De Angelis, ma ci sono anche per me, qua e là, alcune poesie illuminate della Merini. La critica è utile, spesso indispensabile, ma l’emozione della lettura alla fine riguarda me e solo me; e sono solo io a poter dire che cosa è buona poesia e cosa non lo è. Per questo, se non c’è un numero sufficiente di io ad apprezzare la poesia, buona o cattiva che sia è come se non esistesse.
Se il proprium delle avanguardie è la centralità della poetica e la sua prevalenza sull’opera (un commento nei dibattiti di cui sopra mi ha ricordato che lo ha pure sostenuto Eco nella sua prolusione ai quarant’anni del Gruppo 63 – ma ne ero convinto comunque), allora è proprio l’idea di progetto a essere al centro del lavoro dei loro autori. Ma pensare la poesia come operazione sul linguaggio, alla Giuliani, o operazione politica, alla Brecht, significa pensarla come comunicazione funzionale.
Ora, una buona comunicazione funzionale è certamente un valore positivo, ma la nostra concezione della poesia di fatto non si risolve in quello. Se si risolvesse in quello, i dibattiti tra poeti e tra poetiche non farebbero che esplicitare quale sia il proprio scopo comunicativo, e si discuterebbe, a parità di scopi, quale sia il modo migliore per raggiungerli. E invece l’ambiguità medesima in cui cade Giuliani cercando di tener salda sia la riduzione dell’io che l’espressione del soggetto deriva proprio dall’impossibilità di intendere funzionalmente la poesia – nonostante lui stesso in vari momenti cerchi di presentarla così.
Se riduciamo la poesia a comunicazione funzionale non c’è poi modo di tenerla fuori dalla logica alienante del mercato, dallo “sfruttamento commerciale cui la lingua è sottoposta” (sempre Giuliani, ibidem). Vista in questi termini, ci sarà sempre, prima o poi, una situazione in cui la logica del mercato la re-ingloba, anche, al limite, se si è Balestrini, o e.e.cummings.
D’altra parte, se riconosciamo alla poesia una dimensione differente dalla comunicazione funzionale, questa dimensione potrà manifestarsi a volte persino nelle poesie della Merini, o magari nei versi di un cantautore, persino di uno di successo. Ci troveremo costretti a constatare che la qualità di un’opera non ha a direttamente che fare con il suo successo commerciale, non in positivo (coincidenza o dipendenza) ma nemmeno in negativo (esclusione).
Adorno è morto, per fortuna. La sua grandezza di critico e filosofo ci ha impedito di vedere per molto tempo i danni che la sua estetica ha prodotto.
19 Ottobre 2010 | Tags: Ananda K. Coomaraswamy, avanguardie, estetica, fumetto, lirica, poesia, poetiche, progetto, riduzione dell'io, sacro | Category: estetica, fumetto, poesia | Nel post di Andrea Inglese “Che genere di discorso” pubblicato su Nazione Indiana del 12 ottobre, e soprattutto nel dibattito da esso generato, si incontrano una serie di temi che mi impongono una riflessione: c’è la questione delle poetiche, ovvero delle dichiarazioni di intenti degli autori; c’è la questione del soggetto e c’è quella della lirica; e c’è la questione della leggibilità. Sono temi interessanti anche perché non riguardano solo il mondo della poesia e della prosa, che è quello di cui specificamente si discute in quella sede; investono piuttosto qualsiasi produzione o comunicazione di carattere estetico, da quelle che definiamo tradizionalmente “artistiche” sino a quelle di carattere esplicitamente funzionale, come la pubblicità.
Sulle poetiche, mi fa sorridere che Inglese, dopo un’evidente dichiarazione di poetica, ammetta nei commenti, in risposta a una mia obiezione, di non credere davvero sino in fondo alle dichiarazioni di poetica: “sono scettico rispetto alla nozione di poetica. O meglio, ho raggiunto una certa idea di cosa sia la poetica: un campo di proiezioni immaginarie sul proprio fare.” Mi fa sorridere perché l’ambiguità in cui, con questo, Inglese cade è probabilmente inevitabile oggi, per chiunque si cimenti con una produzione artistica, poetica, prosastica, filmica, pittorica o fumettistica che sia (o quant’altro). E credo che lo sia perché rispecchia un’analoga ambiguità presente oggi nella nozione di Arte.
Quando frequentavo l’università, ho fatto in tempo a seguire le lezioni di Luciano Anceschi, che ci parlava dell’estetica e delle poetiche, sottolineando il valore e l’importanza di queste ultime assai più della prima – che nella sua visione finiva per essere quella che lui chiamava, se ben ricordo, una “sistematica”, contrapposta al “sistema”, per esempio, di Adorno (che era, nell’anno in cui lo seguii, l’argomento del corso). Fu così che per il suo esame preparai una tesina (ma lo spessore non giustificherebbe il diminutivo) sulle poetiche dei Novissimi.
Con questo accento forte sull’importanza delle poetiche, ho dato per scontato per molto tempo, io come tanti, che si trattasse di un problema costitutivo della produzione artistica. E non c’è dubbio che per il Novecento lo sia: ma prima? Ci sono delle dichiarazioni di poetica precedenti al Manifesto del Futurismo che siano davvero tali? Qualcosa del genere indubbiamente c’è, perché spesso gli artisti hanno riflettuto sul proprio lavoro; tuttavia la mia sensazione è che manchi a quelle dichiarazioni quella dimensione programmatica che invece da Marinetti in poi diventa cruciale, e che rende le poetiche del Novecento assolutamente peculiari.
La mia sensazione è che la nascita delle poetiche (in senso novecentesco, di qui in poi) sia una conseguenza dell’affermarsi dell’idea di progetto, in campo comunicativo e in campo politico. Il progetto è ciò che permette di finalizzare una comunicazione, di decidere a priori quali scopi si vogliano raggiungere, e con quali mezzi ci si proponga di agire: è il mito che attraversa l’universo del design (che significa non solo disegno, ma anche progetto) dal Bauhaus a Ulm e oltre, ma è anche quello che chiaramente si ritrova nel programma di Marinetti. In questo senso le avanguardie sono chiaramente le figlie di una mentalità razionalistica e progettuale, che si distingue da quella del design industriale solo per la diversità degli scopi e degli strumenti specifici.
Se dovessimo valutare le opere delle avanguardie sulla base delle poetiche espresse, ovvero dei progetti dichiarati dai loro autori, la nostra valutazione sarebbe non molto diversa da quella che uno studio di valutazioni qualitative compie su una campagna pubblicitaria: è riuscita se (e solo se) ha raggiunto lo scopo che si proponeva. E con tutto questo non intendo affatto sminuire l’ideologia del progetto, che è la vera sostanziale novità del Novecento, trasversale dal marxismo sino ad Heidegger e all’esistenzialismo, dalla giocosità dadaista alle teorie sulla progettazione del software.
Tuttavia, di fatto, non è in questi termini che ci poniamo di fronte a quegli oggetti che definiamo opere d’arte, o, almeno, non è solo in questi termini. Esiste un modo tradizionale, antico, di sentire il bello come espressione di valori positivi condivisi dalla comunità, che precede la nozione stessa di Arte, la quale è una nozione moderna (ne ho parlato più a fondo in un post su Coomaraswamy). Secondo questo modo, l’Arte ha a che fare non con l’estetico, bensì con il sacro. Il Romanticismo, in epoca di positivismo imperante, cerca di recuperarne l’essenza attraverso l’intromissione del sentimento e del soggetto, perché la soggettività e l’interiorità gli appaiono come le uniche risposte possibili alla desacralizzazione che sta compiendo la scienza. Così si costruisce un’idea dell’Arte che poi il novecento insieme combatte e perpetua: che ha ragione di combattere perché si tratta di una perversione contingente, e che ha ragione di perpetuare perché spesso appare come l’unico legame rimasto con quella sacralità così essenziale – una sacralità che non è necessariamente religiosa, ma è semplicemente un senso mistico della comunità.
Esporre la propria poetica e insieme dichiarare che non ci si può credere davvero è dunque l’espressione di questa oscillazione tra un’Arte come progetto, che ci permette di liberarci dalle pastoie romantiche dell’esaltazione dell’io, e della lirica intesa in questo senso; e un’arte come sacralità, in cui la dimensione irrisolvibile del simbolo si lega a un senso collettivo che trascende a priori il soggetto, senza negarlo ma senza nemmeno porlo come mediazione irrinunciabile (come fanno i Romantici). Rinunciare alla poetica significherebbe rinunciare al dialogo con le espressioni artistiche del novecento; ma rinunciare al sacro significherebbe rinunciare a quello che sentiamo come Arte – e fare, del tutto legittimamente, e magari anche ottimamente, della comunicazione funzionale. Tuttavia, in questo modo si rinuncerebbe al dialogo con tutto quel mondo che noi sentiamo come Arte e che precede il novecento – a meno di considerarlo, del tutto legittimamente ma un po’ riduttivamente, anch’esso come comunicazione funzionale.
Tuttavia, perché la riduzione (anche parziale) dell’io deve coincidere con un aumento della complessità dell’opera e delle difficoltà di fruizione da parte del lettore/spettatore? Certo che l’opera difficile, oscura, attinge più facilmente alla dimensione del simbolico, ed è più facilmente distinguibile da quella della comunicazione funzionale tout court, specie se si intende svalutare quest’ultima come troppo compromessa con i mali del presente. Così, la scarsa leggibilità è certamente una scorciatoia per dichiararsi dalla parte del sacro, nonostante si continui a progettare la propria comunicazione. Un testo facilmente leggibile è più facilmente sussumibile – non c’è dubbio – alle logiche del consumo, che sono antitetiche a quelle del sacro. E senza progettazione non c’è avanguardia, sia nel senso storico, che nel senso più banale di gruppo organizzato attorno a uno scopo politico (magari anche solo politico-culturale).
Mi sembra che siamo di fronte a un bel nodo di contraddizioni, ben difficili – forse impossibili – da sciogliere. Eppure l’io, la lirica, la leggibilità, mi sembrano tutti temi-ponte, parole d’ordine su cui aggregare il dibattito, su cui organizzare la comunicazione che permette poi all’opera di essere conosciuta, avendo incuriosito qualcuno, e di essere letta, fruita. Un’opera che non viene fruita è come se non esistesse.
Voglio concludere facendo osservare che le cose non procedono allo stesso modo su tutti i fronti. Se nel campo della poesia e dintorni la ricerca verte sul come mettere un po’ da parte questo io troppo strabordante e imbarazzante, nel mondo del fumetto sembra invece essere proprio la ricerca dell’io e del suo intimismo a definire un percorso di rinnovamento, e di differenziazione dal passato. Il punto è che le forme non sono universalmente distribuite allo stesso modo, e quello che vale come novità in un campo può non valere affatto in un altro.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|







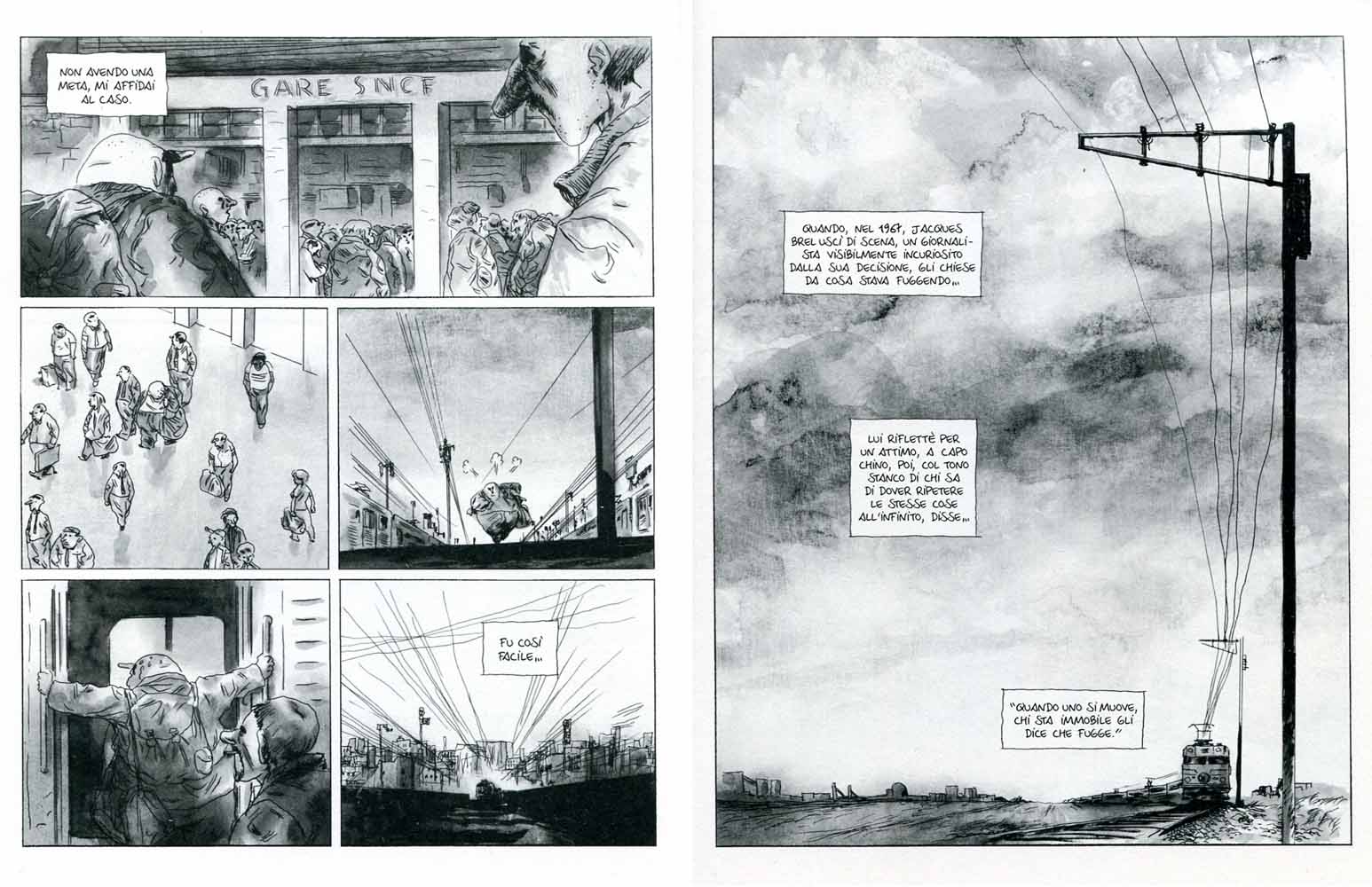



 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco





Commenti recenti