C’è una differenza di base tra la percezione visiva e quella sonora: quello che vediamo è là, di fronte a noi; quello che udiamo è qua, attorno se non addirittura dentro di noi (specie i bassi, che ci fanno vibrare la pancia). Fondamentalmente la percezione visiva è frontale, quella sonora è immersiva. Quando la percezione è frontale, ci troviamo di solito in una relazione cognitiva: il soggetto conosce l’oggetto davanti a lui. Quando è immersiva, soggetto e oggetto tendono a confondersi: non c’è tanto conoscenza, quanto compartecipazione (il filosofo francese François Jullien usa il termine connivenza, ma io credo che la connivenza sia già la consapevolezza – cioè la conoscenza – della compartecipazione, quindi un suo derivato). Ascoltando musica, sentiamo il ritmo, per esempio, e magari lo seguiamo e ci mettiamo a ballare; non è un’attività in sé cognitiva, è piuttosto il partecipare a un’attività cui partecipa chiunque ascolti quella musica. Qualcosa di simile succede ogni volta che fluiamo insieme con ciò che percepiamo attorno a noi.
Detto questo, si può ascoltare frontalmente la musica (come richiede la musica colta, pur mantenendo aspetti immersivi), o ci si può immergere in situazioni visive: il medesimo Jullien ha scritto un libro (Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison, Gallimard, 2014) dove si parla essenzialmente della percezione del paesaggio, e del senso di connivenza che essa procura. Inoltre, anche se la compartecipazione non è in sé conoscenza, può essere comunque occasione per conoscere; e, d’altra parte, si può essere compartecipi o conniventi anche su qualcosa che prima abbiamo dovuto conoscere (come succede con tante arti, compresa la letteratura, e compreso il fumetto). Insomma, anche se conoscenza e compartecipazione, frontale e immersivo, sono dimensioni diverse, e diverse relazioni nei confronti del mondo, le troviamo continuamente intrecciate e mutuamente causate. Io credo che sia così perché noi stessi siamo fatti così: sino a un certo punto siamo dei soggetti (come ci voleva Cartesio) che conosciamo il mondo organizzandolo in oggetti; al di là di quel punto siamo noi stessi mondo, e lo siamo assai prima e assai più in profondità di quanto non possa arrivare la nostra soggettività.
Cosa c’entra tutto questo con il fumetto? Il fumetto è interamente visivo, non ha suoni né percezioni di altro tipo. Dovrebbe essere perciò interamente frontale, e quindi cognitivo…
Il fatto è che il fumetto fluisce, scorre, e ha perciò, inevitabilmente, dei ritmi. Con questi ritmi il lettore si può trovare in sintonia. Non che ci si possa ballare: un ritmo narrativo, per esempio, non è fatto per questo. Ma conosciamo tutti la fluida magia di un racconto che scorre bene, e il nostro vissuto del momento con lui.
Non è tuttavia di questo che voglio parlare, perché di questi temi ho già parlato in molte occasioni. Il fatto è che qualche giorno fa, mentre discutevo una tesi in corso di stesura a proposito del fumetto nel Web, opera di una mia allieva ISIA, Claudia Conti, lei salta fuori con un’osservazione che mi fa sobbalzare, dicendomi qualcosa sul fatto che mentre la singola vignetta in sequenza sarebbe sostanzialmente narrativa, frontale, la pagina nel suo insieme sarebbe invece immersiva. Sul momento ero perplesso: sarà davvero così? A una prima veloce riflessione le ho detto che poteva aver ragione; ma poi di riflessioni, più tardi, ne ho fatto molte altre. E, sì, credo che non solo sia davvero così, ma che si tratti di una considerazione importante, che spiega varie cose.
Leggevo qualche giorno fa, non ricordo dove, qualcosa su Mark Rothko, il quale pare che sostenesse che i suoi dipinti andrebbero guardati da una distanza ottimale di 60cm…
Continua qui, su Fumettologica.

Ho passato un po’ di tempo a riguardarmi i frontespizi di The Spirit (ce n’è, per esempio, una vasta collezione online qui, ordinati dalla fine, 1952, verso l’inizio, 1940), lasciandomi andare alle libere associazioni di un antico lettore di fumetti. Il risultato è almeno in parte documentato dalle immagini a corredo di questo articolo.
Ce n’è un primo gruppetto in cui affianco un frontespizio del 1940 a una tavola di Sergio Toppi del 1980. Non c’è bisogno di sottolineare le differenze, che saltano all’occhio. È invece interessante osservare che Will Eisner (e siamo a pochi mesi dall’apertura della serie) introduce una tecnica che permette la composizione sequenziale della tavola secondo una logica che non è quella canonica delle vignette: nello specifico, la lettura della didascalia sotto la testata introduce al titolo The Spirit, il quale si collega, attraverso il braccio levato che afferra l’ultima lettera, alla ragazza bionda, il cui sguardo conduce allo scimmione vestito in primo piano, che si appoggia sul piano di una banchina che è lo stesso su cui agiscono i due personaggi con cui inizia davvero il racconto, all’interno di una quasi-vignetta, i cui limiti vengono suggeriti da quelli della situazione narrativa e da quelli del rettangolo della dida che la sovrasta.
Analogamente, nella pagina di Toppi la direzione alto-basso e varie linee che costituiscono altrettanti impliciti vettori conducono la lettura.

C’è un secondo gruppetto, in cui affianco due frontespizi del 1947 e ’48 a due tavole rispettivamente di Gianni De Luca e di Frank Miller. Qui la tecnica è leggermente diversa: c’è un quadro spaziale generale, sopra il quale le medesime figure ricorrono più volte, senza che possano sorgere dubbi sul fatto che non sono compresenze di personaggi diversi, bensì ripetizioni dei medesimi. Sappiamo l’uso straordinario che ha fatto De Luca di questa tecnica nella sua trilogia shakespeariana del 1976, ed è suggestivo riflettere sul fatto che la rivista Eureka inizia a pubblicare regolarmente The Spirit in Italia nel 1969.
Guarda caso gli esperimenti sia di Toppi che di De Luca iniziano qualche anno dopo. E questo lascia anche capire come non ci sia bisogno di scomodare davvero De Luca per individuare l’ispirazione dell’uso di questa tecnica da parte di Miller nel 1990…
Prosegue qui, su Lo Spazio Bianco
 Frank Miller, Holy Terror, p.80 L’idea del superuomo, in sé, è un’idea consolatoria e infantile. È del tutto naturale che a un bambino possa piacere l’idea che ci sia qualcuno, più grande e più potente, che venga a risolvere con facilità dei problemi più grandi di lui; ed è anche ragionevole che un bambino possa appassionarsi alle avventure di questo potente genitore. Meno ragionevole è che vi si possa appassionare un adulto; ma ugualmente succede, e molti aspetti di varie religioni esistono pure per questo – e magari, storicamente, l’Illuminismo è andato vincendo la sua battaglia contro la religione proprio mettendone in luce l’infantilismo di certi suoi aspetti.
Dei limiti del concetto di supereroe nel fumetto americano si accorgono in tanti, e sin dall’inizio. Ma la storia che mi interessa, qui oggi, è quella di coloro che non vogliono abbandonare il genere, pur rendendosi conto dei limiti dell’idea che gli sta al centro (non intendo perciò parlare qui delle parodie, magari semi-interne, alla Will Eisner o alla Jack Cole). Per contrastare la grande crisi del fumetto di supereroi degli anni Cinquanta, i primi a prendere interessanti provvedimenti in merito sono dunque, proprio cinquant’anni fa, Jack Kirby e Stan Lee; la formula “supereroi con superproblemi” serve proprio a questo: spostare la focalizzazione narrativa da fuori a dentro l’eroe, rendendolo in tal modo più umano. Se fino a quel momento i supereroi DC erano stati una sorta di semidei, narrati da fuori, visti dal punto di vista del mondo e di quello che mostruosamente e meravigliosamente essi fanno, rispetto alla normalità degli esseri umani normali, i nuovi supereroi della Marvel, grazie al nuovo punto di vista, alla nuova focalizzazione, si rivelano al lettore come uomini normali alle prese con l’ulteriore problema (e l’ulteriore grande responsabilità) di avere dei grandi poteri. Se prima il gioco era: guarda cosa può fare per te un essere con superpoteri; adesso è diventato: pensa a come potresti essere tu, se ti capitasse di acquisire di colpo dei superpoteri!
Il nuovo gioco della Marvel regge alla grande per una decina d’anni. Non c’è dubbio che la sua ricchezza potenziale è molto maggiore che nella versione precedente. Ma le conseguenze della contestazione giovanile degli anni Sessanta e Settanta, e l’aumentata consapevolezza politica che ne deriva, mietono vittime anche qui. Negli anni Settanta la figura del supereroe è complessivamente in crisi, e non basta nemmeno più, a salvarlo, il cambio di focalizzazione. Diventa evidente, cioè, che il cambio di focalizzazione non è affatto, in fin dei conti, una problematizzazione, una messa in discussione dell’idea di superuomo e delle sue conseguenze. Il supereroe Marvel, benché più umano, non è meno straordinario e ammirabile di quello tradizionale DC.
Per superare questa seconda crisi ci vuole altro. Se ne accorge, per esempio, Neil Adams, il cui Batman (con Dennis O’Neil) gotico, nero, tormentato, è tra i pochi sopravvissuti alla moria di personaggi del decennio. E (la storia la conosciamo) lo capisce benissimo, meglio di chiunque altro, Frank Miller, che, dopo altre prove interessanti, alla metà degli anni Ottanta fa proprio di Batman il proprio cavallo di battaglia per il rilancio del fumetto di supereroi in chiave adulta. Miller si rende conto benissimo che l’idea del supereroe come personaggio è potente ma in sé poverissima: è potente perché permette esiti estremamente spettacolari, ma è anche poverissima proprio perché troppo infantile, troppo ingenua – e l’espediente di Kirby e Lee (pur indicando la giusta via) è ormai ampiamente insufficiente a risvegliare l’interesse di un pubblico adulto.
Miller non è da solo, negli anni Ottanta, a intuire il problema e a suggerire vie di soluzione. Ma è certamente colui che riesce a perseguire con maggiore chiarezza ed efficacia una via interna al mito del supereroe, problematizzandolo sia eticamente che psicologicamente, mettendolo in crisi, anche profondamente, ma sempre con l’idea di rivitalizzare il genere, non di affossarlo. Ben diverso, per esempio, è lo spirito con cui agisce Alan Moore, il cui Watchmen è una critica spietata all’idea stessa di supereroe, e alla stessa possibilità di glorificarne le imprese. Anche Watchmen finisce per contribuire alla rinascita del genere, ma probabilmente è proprio perché il Dark Knight Returns di Miller ha già impostato e reso credibile l’idea di una critica costruttiva e adulta, e quindi la possibilità stessa di un genere supereroi rinnovato, accettabile anche a livello adulto. Certo, si tratta di una mossa che ha senso in un mondo in cui esistono lettori adulti che hanno amato quel genere da bambini e adolescenti, e ora si trovano nella condizione di poter rinnovare l’interesse – in qualche modo ricollegando la consapevolezza adulta con la passione infantile, potendo rileggere nella complessità quello che, anni prima, amavano in un contesto di semplicità che, passata l’infanzia, apparirebbe solo ridicola.
Dato questo contesto, la mossa di Miller è straordinaria. Il suo Batman è eticamente e psicologicamente sfaccettato; tutte le sue scelte si trovano discusse all’interno della storia stessa, e messe in discussione persino da lui stesso. Persino l’idea stessa di supereroe si trova messa in discussione attraverso la figura meschina che viene fatta fare al supereroe per antonomasia, proprio Superman, nella sua integrità (e stupidità): in Dark Knight, Superman perde contro Batman perché non è capace di mettersi in discussione, e accetta acriticamente le linee di comportamento che gli arrivano dal potere.
Date queste premesse, poco mi importava allora delle critiche di coloro che mi avvertivano che Miller era di destra. Probabilmente era già vero, ed essi avevano ragione, ma il suo Daredevil e il suo Batman mettevano in scena dei valori in cui mi potevo benissimo riconoscere anch’io, che di destra proprio non sono. Sinché il fulcro del discorso sul superuomo sta nel senso del suo esistere e del suo agire, e nella propriocezione disforica del suo essere tale, poco mi importa che poi la conclusione di Miller è che è un bene che il superuomo ci sia: su questo non sarò d’accordo, ma su come mi viene presentata la situazione (e questo come è quello che conta) sì. E potrò perciò appassionarmi in una problematica in cui riesco a riconoscermi, e quindi persino godere di una spettacolarità che, nel suo eccesso ostentato, mi può apparire a sua volta come implicita critica pur mantenendo l’impronta spettacolare.
In altre parole, se anche magari, alla fin fine, The Dark Knight Returns suggerisce un discorso di destra, il grosso della sua costruzione, a monte di tale fin fine, è godibile e appassionante anche da parte di un lettore di sinistra, perché al centro del discorso c’è un tema, un problema, un nodo problematico, e non una soluzione, una proposta di direzione da prendere. Quella, se c’è, è talmente marginale e sfumata da non creare problema: è molto facile persino accettarla, persino non condividendola. Basta confinarla nel dominio del mondo della storia raccontata, che non è il nostro. E se poi proprio non la vogliamo accettare nemmeno lì, pazienza: sarà solo questo che ci dividerà da Frank Miller: un dettaglio, neanche tanto significativo.
Credo che a nessuno sia mai venuto in mente di etichettare come propaganda né Dark Knight né nessuno dei lavori del Miller di quegli anni. Col tempo, e progressivamente, le cose sono cambiate. I fumetti di Frank Miller sono cambiati.
Non ho apprezzato 300, nonostante le qualità grafiche e di regia di Miller, perché il messaggio mi sembrava già troppo scoperto e troppo diretto: non era più il dubbio, la problematicità, a dominare la scena, ma un’inossidabile certezza. Miller era, al momento, ancora in qualche modo, velato nell’esprimersi. La versione cinematografica di Zack Snyder, nonostante tutte le sue qualità di regia e scenografie, toglieva comunque gli eventuali dubbi residui (vedi, su questo, un bellissimo testo del 2007 di Wu Ming 1, qui); ma qualche anno, intanto, era passato, e quindi magari i dubbi residui erano scomparsi pure nel medesimo Miller. Ho continuato ad apprezzare, con qualche riserva, Sin City, perché il mondo in cui si trova ambientato è talmente assurdo e di maniera che non è difficile considerare Sin City come un esercizio di stile. A lungo andare, tuttavia, gli esercizi di stile possono apparire un po’ troppo fini a se stessi, e annoiare. Ho resistito a lungo, temendo il peggio, ad andare a vedere The Spirit. Avrei fatto bene a continuare a resistere: Will Eisner non faceva esercizi di stile, e vedere ridotto il suo mondo a quello, e solo a quello (proprio cercando a tutti i costi di non vedere le implicazioni ideologiche del film), è qualcosa che mi ha fatto male.
In Holy Terror, del Miller che a suo tempo mi ha fatto sognare, è rimasta solo l’abilità registica. Il resto è propaganda ed esercizio di stile. Neppure il disegno è quello di un tempo, piegato com’è, oggi, a sostenere le esigenze di una spettacolarizzazione reboante e finalizzata a convincere. Che sia propaganda me l’ha suggerito Miller stesso, nel suo blog. Miller sostiene una tesi paranoica, ovvero che, fondamentalmente, tutto quello che viene pubblicato è propaganda, i giornali non fanno altro che propaganda, i fumetti di supereroi degli anni Quaranta facevano propaganda: dunque perché non dovrebbe farla lui?
Ma lui stesso non faceva propaganda quando il dubbio era il protagonista delle sue storie, e i giornali stessi non fanno propaganda quando discutono delle idee e accettano quelle degli altri; e, sì, Capitan America era davvero un fumetto di propaganda, ma in quegli anni gli USA erano in guerra. La tesi di Miller è, evidentemente, che gli USA sono in guerra anche oggi, e questo giustifica tutto: poiché non può essere lui a prendere in mano il fucile, quello che può fare è questo.
Al di là dell’inaccettabilità di una tesi del genere, potrebbe ancora capitare che un autore paranoico, convinto di tesi assurde, possa produrre un’opera interessante. Ma Holy Terror è indifendibile da molti punti di vista: non ci troverete niente che non sia stato già visto e rivisto in lavori precedenti, salvo che mentre in Sin City la retorica dell’eroismo personale si trova sempre in qualche modo messa a contrasto con la dubbia moralità dei personaggi (ladri, balordi e prostitute – in un’oscura prospettiva di redenzione), qui il cattivo è cattivo e basta, e non è solo l’Islam e Al Qaida, ma sotto sotto c’è persino l’interesse economico – poiché evidentemente, quando uno è davvero cattivo come lo sono i terroristi, se non è stupido deve averci un interesse personale.
Solo nella propaganda di guerra si può vedere il nemico dipinto a tinte così esclusivamente e drasticamente negative e disprezzabili. Solo nella propaganda di guerra è necessario dipingere l’eroe (cioè noi) a tinte così immacolate e infantili. Confesso che credevo che queste cose fossero scomparse da un pezzo, o relegate a produzioni davvero da poco, quelle che definirle “fumetto popolare” è offensivo persino per il fumetto popolare e chi lo produce con onore.
Frank Miller crede di essere in guerra. Il che spiega anche le sue boutade contro Occupy, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Se siete convinti di essere in guerra contro l’Islam, forse potete godervi questa roba. Non venitemi a raccontare che Miller fa differenza tra l’Islam e Al Qaida: in Holy Terror questa differenza non si vede. Quando si è in guerra, comunque, non si può davvero andare per il sottile. La guerra giustifica tutto, anche la stupidità.
Addio, Frank Miller. Sarebbe bello che la tua prossima mossa smentisse quello che ho detto. Sarei felice di aver torto, e di ritrovare l’autore che ho conosciuto anni fa. Sarei felice di poter apprezzare un autore di destra. Temo però davvero che non lo farai, confermando cupamente gli stereotipi che girano tra noi di sinistra su quelli di destra, lasciandoci pensare che i nostri luoghi comuni abbiano un fondamento. Dai Frank, dimostra che abbiamo torto! Te ne sarei davvero grato, e per più ragioni.
Quello che riporto qui sotto è un frammento di un articolo che ho scritto nel 2009 per il catalogo di una mostra su Frank Miller (a Moncalieri – TO). Ecco:
—————————————————–
… Faccio fatica, insomma, a tenere insieme l’autore di 300 con quello di Sin City. Si potrebbe malignare che il filo che li lega sta in quella capacità di creare spettacolo che davvero pochi possiedono nella misura in cui la possiede Miller. Benché si tratti di un’osservazione in sé superficiale (appunto, una malignità), questa osservazione ci invita comunque a indagare sulla natura dello spettacolo proposto da Miller.
Rileggiamo Dark Knight, allora. Soffermiamoci, come mi è già accaduto più volte lavorando su Miller, sulla coppia di pagine in cui si racconta l’incontro tra Bruce Wayne bambino e il suo futuro demone, il pipistrello che diventerà in seguito il suo simbolo. Nella pagina di sinistra si racconta, quasi senza parole, della caduta di Bruce, del suo rialzarsi e del volo di miriadi di pipistrelli sino a che soltanto un’ombra rimane. A questo punto la parola narrante riprende. È un flusso di coscienza del Bruce maturo, che sta ricordando, ma il suo andamento ha qualcosa di poetico, o meglio, di liturgico:
Then…
…something shuffles out of sight…
…something sucks the stale air…
… and hisses.
(Poi…/ … qualcosa si trascina nell’oscurità… / …qualcosa aspira l’aria stantia… / … e sibila.)
Dopo una vignetta muta e quasi completamente nera, mentre la figura del pipistrello si avvicina a quella del bambino e finalmente si rivela:
Gliding with ancient grace…
unwilling to retreat as his brothers did…
eyes gleaming, untouched by love or joy or sorrow…
breath hot with the taste of fallen foes… the stench of dead things, damned things…
surely the fiercest survivor… the purest warrior…
glaring, hating…
claiming me as his own
(Scivolando con grazia antica… / non disposto a ritirarsi come hanno fatto i suoi fratelli… / gli occhi luccicanti, mai toccati da amore o gioia o dolore… / il fiato caldo del sapore di nemici caduti, il lezzo di cose morte, cose dannate… / sicuramente il sopravvissuto più fiero… il guerriero più puro… / sfolgorando (ma anche: guardando con ira), odiando… / rivendicandomi come suo.)
 Fran Miller, The Dark Knight Returns, 1985, pp. 10-11 Non è rilevante se questi siano davvero versi oppure no, così come non è rilevante la qualità poetica delle parole di Miller. Queste valutazioni non hanno rilievo e non devono portarci su un percorso sbagliato d’indagine perché, a differenza che in poesia, qui le parole non devono essere fruite autonomamente, bensì come accompagnamento di una sequenza di immagini. Resta invece necessario notare la quantità di tecniche specificamente poetiche che vengono utilizzate in queste parole, tecniche riportabili in vario modo allo stesso principio di fondo che avvicina la scrittura poetica a quella liturgica e rituale: il principio del parallelismo.
Si può notare, per esempio, la ripetuta allitterazione sul suono “s” presente nella prima parte, rafforzata da una più debole insistenza sul suono (non lontano) “f”: something shuffles out of sight / something sucks the stale air / and hisses. L’allitterazione è un tipico principio costruttivo e unificante del verso germanico antico, ereditato in misura minore anche da quello inglese moderno. Si può notare la ripetizione in posizione parallela della parola something nelle due espressioni successive, e il ripetersi della medesima costruzione sintattica, rafforzata dalla quasi-rima tra sight e air. La medesima tecnica ritorna, enfatizzata, nei versetti (chiamiamoli così) della pagina successiva: osserviamo questo ossessivo ripetersi di gerundi, anche funzionale a un effetto di sospensione del tempo, in attesa del verbo non infinitivo che mi dica che cosa accade davvero – e che qui non arriva, mentre l’evento risolutivo viene descritto alla fine da un altro gerundio sospensivo.
Ci sarebbero ancora altre osservazioni da fare sul linguaggio, ma è più urgente ora mettere in relazione i versetti con le immagini che essi accompagnano. Ci accorgiamo, così facendo, che il progressivo allungarsi dei primi quattro (della pagina di destra) coincide con l’avvicinarsi dell’ombra del pipistrello al bambino spaventato, ed è funzionale a un progressivo rallentamento della visione, e perciò anche della percezione del tempo raccontato: a un crescendo di intensità dei contenuti corrisponde un crescendo di durate, e si produce così un crescendo di tensione alimentato in due differenti modi paralleli. Nel quinto versetto, il soggetto, cui prima si faceva riferimento solo indirettamente, diventa decisamente il pipistrello, proprio mentre l’immagine finalmente ce lo mostra di fronte. Nel sesto versetto c’è la ripresa dei gerundi, ma il crescendo è finito e il versetto è diventato brevissimo: l’immagine ci mostra un bambino non più terrorizzato, bensì abbandonato (conquistato o rassegnato); e la dichiarazione di appartenenza del settimo versetto, che coincide visivamente con la chiusura completa dell’immagine da parte dell’ombra, ci appare, in calando, come una semplice e inevitabile conseguenza dell’evento che si è già consumato appena prima.
L’effetto complessivo è quello di una celebrazione, poetica e liturgica, dell’evento fondante dell’identità del Batman, che il vecchio Wayne sta ora riportando alla memoria. Sicuramente il fatto di essere un evento presentato come leggendario, quasi mitologico, giustifica narrativamente questo uso così accentuato di un andamento di carattere epico e celebrativo – ed è anche per questo, è probabile, che questo momento ci si è proposto più immediatamente all’attenzione. Tuttavia non si tratta di un evento isolato nella produzione di Miller: anzi, la maniera assolutamente naturale in cui questo momento così fortemente liturgico si inserisce nel complesso di Dark Knight ci lascia pensare che si tratti solo di una punta, cioè di un passaggio fortemente epico e liturgico all’interno di un contesto complessivo che possiede costantemente elementi epici e liturgici, in misura ora più ora meno marcata.
La mia sensazione è che la qualità della dimensione epica che i racconti di Miller ci affrescano dipenda proprio dalla sua straordinaria capacità di tenere fortemente viva la dimensione liturgica, facendoci percepire le vicende come altrettante celebrazioni di un mito cruciale per la nostra cultura. Da Daredevil a Sin City, questa dimensione mitica e fondativa percorre stabilmente il lavoro di Miller.
—————————————————–
Immaginate ora che la stessa persona che è in grado di coinvolgerci così intimamente in una liturgia a base epica di questo tipo esprima opinioni che non potremmo mai e poi mai condividere, e che anzi riteniamo contrarie al vivere civile. C’è da stupirsi che noi reagiamo male? C’è da stupirsi che ci appaia come pericolosa una simile capacità tecnica, capace di coinvolgerci così profondamente, quando c’è il rischio (in verità, ormai, qualcosa di più del rischio) che venga applicata per propagandare idee che ci appaiono non solo sbagliate, ma nefande, nefaste? È lo stesso Miller ad ammettere di stare facendo propaganda, salvo difendere la propria propaganda in quanto buona da quella (secondo lui) cattiva.
Capisco ma non condivido la difesa che ne fa Mark Millar, il quale non condivide le idee espresse da Miller, ma ritiene che non si possa proporre di boicottare le opere di un grande autore se dice qualcosa su cui non siamo d’accordo. Avrebbe ragione se Miller si fosse espresso attraverso le sue stesse opere; ma, nel dire quello che sta dicendo, Miller non è più un autore: è un cittadino che esprime la propria opinione fondandosi sul prestigio che si è costruito con le proprie opere. In altre parole, le parole di Miller non agiscono più nell’arena del prodotto artistico, che ha le sue regole di interpretazione, e in cui mi posso sempre permettere di sospendere il giudizio, o di fare uso della mia libertà interpretativa. Agiscono invece in quella del dibattito politico, e sono molto chiare, nette, lasciando davvero poco spazio a interpretazioni concilianti o problematiche. Vanno perciò trattate in termini di lotta politica, contesto in cui anche un’azione di boicottaggio ha un senso: in altre parole, poiché per dare peso alle tue parole tu sfrutti la tua notorietà, io cercherò di colpire quella, che è basata sulle tue opere.
Insomma, è Miller stesso che ha cambiato arena; non i suoi (nonostante tutto) affezionati lettori.
Detto questo, tra questi affezionati lettori (come si capisce bene dal testo riportato sopra) ci sono senz’altro anch’io, o ci sono stato, o ci sono ancora, ma delle sue opere passate. Da DK2 in poi confesso che leggendo Miller ho continuato ad avere l’impressione che la retorica superasse l’abilità, producendo in me una dinamicissima e ripetitivissima sensazione di noia. Il top in questo senso è stato toccato dal suo film su The Spirit, che mi è parso quasi offensivo nei confronti dello spirito di Will Eisner. Continuo ad apprezzare qualche episodio di Sin City, ma forse perché il contesto è talmente assurdo e straniato che molte cose sembrano funzionare lo stesso.
Certo, probabilmente Miller era “di destra” anche allora, quando realizzava Dark Knight, ma tra le cose che la sua liturgia celebrava c’erano sempre anche il dubbio, la problematicità, la pluralità delle voci, il conflitto interiore, l’irrisolvibilità di molte decisioni su cosa sia bene e cosa sia male: tutti valori in cui mi riconosco, e che mi permettevano di accettare, almeno per il mondo di finzione in cui accadevano le storie, anche altri valori in cui mi riconosco meno. Poi, progressivamente, tutte queste dimensioni sono scomparse, e la celebrazione di Miller è diventata sempre più monotòna, e quindi anche più monòtona: se c’è una cosa che la propaganda non contiene, quella è proprio il dubbio (insieme con la problematicità, la pluralità delle voci, il conflitto interiore, l’irrisolvibilità di molte decisioni su cosa sia bene e cosa sia male…). Da quando il dubbio è scomparso, la produzione di Miller è diventata sempre più propaganda, e tanto più pericolosa quanto più sappiamo che lui è efficace.
Sotto un aspetto solo mi sentirei di difendere le parole scritte da Miller. Leggendole avevo l’impressione che non stesse parlando del nostro mondo, ma che parlasse piuttosto di un mondo delle sue storie, specie le ultime. Poi ho letto il primo commento in ordine di tempo (dovete selezionare, in cima ai commenti, “oldest first”, mentre il default è “popular now”), di un certo Dan Morelle, che dice “This sounds just like something Marv would say” (Suona proprio come qualcosa che direbbe Marv). Dan Morelle ha capito tutto: Miller vive nel mondo di Sin City, non nel nostro. Dovremmo perciò lasciare ai suoi personaggi, e solo a loro, il compito di sostenere nel loro mondo, e solo nel loro, la sua abusata notorietà.
Le tinte assolute di Miller fanno volare il goffo Marvin
Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 1994
Per chi conosce il fumetto americano, il nome di Frank Miller è associato al genere supereroi, e davvero non si tratta del nome di un autore qualsiasi. La rinascita del genere, attraverso un nuovo modo di raccontare e un nuovo rapporto con il pubblico, oggi molto più adulto che non in passato, nonché il rinnovato interesse della critica per gli eroi superumani dei comics gli devono moltissimo. Basterebbe ricordare il suo Batman: The Dark Knight Returns, del 1985-86, un’opera dal successo senza precedenti nel settore, dove si raccontava, con il ritmo serratissimo di una composizione polifonica, la storia di un Batman invecchiato e alle prese con un mondo diverso da quello in cui era stato protagonista.
Non era la prima opera di Miller, e non è stata nemmeno l’ultima. Ma negli anni seguenti è stato soprattutto come sceneggiatore che Miller si è espresso, con numerose e spesso notevoli storie, nelle quali era però la capacità grafica di altri autori a mostrarsi al lettore, lasciandoci rimpiangere il suo montaggio e l’irruenza delle sue idee visive. Purtroppo, l’unica opera da lui interamente realizzata di questi anni è stata anche quella in cui l’abilità di disegnatore non si è accompagnata con quella di narratore. Difficile è stato infatti non sentire Elektra Lives Again come un polpettone di temi rifritti, nonostante questi temi fossero esposti al lettore con un virtuosismo non inferiore a quello delle sue opere migliori. Insomma, l’immagine che Miller dava di sé sino a poco tempo fa era un po’ quella del genio rovinato dal proprio successo, troppo impegnato in troppo numerose iniziative per riuscire a dar vita di nuovo a opere notevoli come quelle che lo avevano reso famoso.
Sin City è uscita a puntate negli Stati Uniti, tra il 1991 e il 1992, su una rivista di un editore minore. La cadenza mensile degli episodi ha reso più lento, più difficile, il rendersi conto della sua novità e del suo valore. Certo, sin dall’inizio era affascinante la scelta grafica di un bianco-nero a tinte assolute, giocato sui contrasti senza sfumature, con un frequente gioco di silhouette e di inversione coloristica tra figura e sfondo. Ed era notevole anche la scelta grafica delle immagini grandi, a mezza o piena pagina, con l’effetto di rallentamento ritmico della narrazione che essa comporta. Ma niente di tutto questo basterebbe a ravvivare un racconto banale, e il rischio di una storia a puntate (in Italia Sin City è stata pubblicata sulla rivista “Hyperion” e ora è disponibile in volume) che inizia lentamente, e sembra proseguire come tante altre, è che l’eccessiva attesa del seguito disamori un lettore che non ha ancora trovato validi motivi di interesse.
Invece, lentamente e progressivamente Sin City prende il volo, sempre più intrigante e coinvolgente nello sviluppo della vicenda, sempre più incisiva nel disegno e nel montaggio grafico. Si tratta di un thriller, questo è evidente, con richiami non troppo nascosti alla tradizione hard boiled, ma più parente forse di storie come Il silenzio degli innocenti che non del Falcone maltese o del Grande sonno. Marvin, un omone grande e grosso, con un passato militare ma anche trascorsi poco puliti, non particolarmente intelligente ma cocciuto come un toro, e dall’aspetto così poco piacevole da faticare persino per trovare amori a pagamento, vive la notte della sua vita con Goldie, ma quando si sveglia accanto a lei la trova strangolata, e le sirene della polizia in arrivo gli fanno capire che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Sin City è la storia dell’indagine compiuta da questo improvvisato investigatore, consapevole della propria pochezza ma testardo e così innamorato del ricordo di lei da non fermarsi nemmeno davanti alla scoperta che Goldie non era stata con lui per amore ma soltanto per trovare protezione. L’indagine porterà progressivamente alla luce una storia sordida di misticismo e di cannibalismo, in cui i personaggi più innocenti finiscono per essere delinquenti e prostitute, schiacciati in una macchina del potere che è deragliata verso il delirio. Marvin è l’anti-Schwarzenegger, l’anti-Stallone: gigantesco e fortissimo e diabolicamente abile negli scontri quanto loro, ma orribile, goffo e sanguinario, stupido e cocciuto. È un Calibano riscattato solamente dal fatto di agire per amore, e dalla nequizia dei suoi antagonisti. Riscuote la simpatia del lettore solo perchè posseduto da una passione comprensibile e giusta, mentre la giustizia che gli si contrappone non capisce, e rispetta solo il potere dei potenti.
C’è una visione manichea molto americana, dietro a questa storia, ma il bene e il male vi sono così mescolati che si fatica a distinguerli. Eppure è sulla base di questa tensione etica che si regge la tensione narrativa – fortissima – di questa storia. Una volta entrati nel suo meccanismo ci si rende anche conto che sull’estremismo dei due poli è giocato anche lo stile grafico, basato sull’irrisolvibilità del contrasto tra bianco e nero. Ed è comunque il nero, l’oscurità , l’ombra, che vince. Sembra che con Sin City Frank Miller sia finalmente ritornato ai suoi livelli migliori, riunendo la sua capacità di inventare storie originali e coinvolgenti con quella di montarle e rappresentarle sulle pagine.
E l’Uomo-pipistrello risorge dalle ceneri
Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 1992
Non è trascorso molto tempo da quando era la norma che un film tratto o ispirato a un fumetto americano fosse un prodotto non solo di consumo, ma anche di scarse pretese estetiche e poche o nulle velleità artistiche. Forse qualcuno ricorderà alcuni film del dopoguerra o degli anni cinquanta ispirati a Batman o a Superman, a Dick Tracy o a Flash Gordon; e quasi tutti ricorderanno le infelici pellicole di Superman di qualche anno fa. Ma l’inversione di tendenza avvenuta quattro anni or sono con il primo Batman di Tim Burton, poi confermata dal Dick Tracy di Warren Beatty e ora nuovamente dal secondo Batman, è stata troppo netta e forte da rimanere inosservata: tre film decisamente interessanti, tre esempi ben riusciti di cinema antinaturalistico e surreale. Ma non so quante persone siano riuscite a darsi una risposta sul perché di questo cambiamento.
La spiegazione superficiale è che, dopo tanto tempo, solo oggi dei registi intelligenti e sensibili come Burton e Beatty hanno deciso di manifestare la propria passione per un universo di personaggi cui nessuno aveva mai prestato interesse nel cinema, se non per ragioni di semplice cassetta: osservazione vera ma insufficiente. Per capire qualche cosa di più è necessario sapere che nel mondo del comic book americano gli anni ottanta sono stati segnati da un’enorme trasformazione, e che il personaggio del Batman ne è stato al centro.
Il comic book, fascicoletto mensile a colori su carta povera, rappresenta da lungo tempo uno dei due principali modi di pubblicazione del fumetto americano; l’altro è la strip, la striscia che compare ogni giorno sui quotidiani. Tradizionalmente strip e comic book si sono rivolti a pubblici differenti, adulto la prima (i lettori dei quotidiani), bambino o adolescente il secondo. I cosiddetti supereroi, da Superman all’Uomo-Ragno al Batman, sono personaggi da comic book, mentre sui quotidiani troviamo sia strisce umoristiche come i Peanuts, Doonesbury, B.C. e Calvin & Hobbes, sia strisce di carattere più avventuroso, a puntate, come Dick Tracy.
Fino a una decina di anni fa la situazione del fumetto americano è rimasta descrivibile sostanzialmente in questi termini. Ma una serie di fattori, economici e culturali, hanno spinto, da quel momento in poi, verso il cambiamento: da un lato il comic book si è trovato con l’esigenza di una crescita del mercato, appena ripresosi dalla paurosa crisi degli anni settanta, e dall’altro gli autori più giovani hanno spesso agito sotto l’influsso delle novità occorse nel frattempo in Europa, dove, soprattutto in Francia e in Italia, si era intanto imposto un fumetto molto più colto, decisamente destinato a un pubblico adulto e consapevole. Si aggiunga che la crisi del comic book di supereroi degli anni settanta ha annoverato tra le sue ragioni anche il successo del fumetto underground, vicino alla contestazione studentesca – e quindi a sua volta innovativo, irriverente, slegato dai vecchi schemi. E c’è stato infine il fatto, tutt’altro che trascurabile, che i personaggi del comic book sono conosciuti ai lettori americani (e non americani) ormai da decenni, ed esiste di conseguenza un potenziale pubblico adulto che li conosce per averli frequentati in età più giovane.
Una serie di circostanze che sarebbero forse rimaste senza alcun collegamento, senza sortire conseguenze rilevanti, se non fosse stato per un giovane autore, Frank Miller. Fu lui che nel 1985, dopo una serie di prove personali di crescente successo, decise di creare una miniserie in quattro parti sul Batman, su basi completamente nuove rispetto al passato. Slegata dalla serie regolare dove si raccontano le avventure dell’uomo-pipistrello, Batman – The Dark Knight (pubblicato in Italia dalla Milano Libri) racconta il ritorno sulle scene di un Batman invecchiato, ultracinquantenne, in un contesto umano e sociale che fatica a riaccettarlo, in un contesto politico sull’orlo della guerra mondiale, e alle prese con i peggiori tra i nemici di sempre, ora più mortali che mai. Robin è morto sul campo anni prima, i supereroi insieme con cui egli combatteva sono banditi dalla legge, mentre il solo Superman agisce in incognito come braccio armato del Presidente, ligio al potere come sempre.
La storia raccontata da Miller ha la complessità, la profondità, l’impatto emotivo dei migliori esempi di letteratura americana, cinematografica e non. Si rivolge a un pubblico di adulti che sono stati ragazzi e che come ragazzi hanno letto, conosciuto e amato quei personaggi. Richiede al suo lettore l’accettazione di un mito, e glie ne presenta in cambio la versione adulta, problematica, complessa, articolata in mille facce dall’aspetto differente. L’eroe Batman è sì il simbolo della purezza morale, ma evoca ora le pericolose sembianze del cittadino che si pone al di sopra della legge, ora il fulgore oscuro del combattente misconosciuto, ora l’ansimo patetico di chi ha messo in moto un meccanismo destinato a schiacciarlo, ora la coinvolgente euforia di chi sa trovare la soluzione non convenzionale al problema impossibile, ora, infine, la malinconia di chi vive un tempo che non è più il suo.
Quando The Dark Knight viene pubblicato, nel 1986, il successo è clamoroso: le ristampe si succedono alle ristampe in tempi brevissimi – e, cosa più importante, la maggior parte dei nuovi lettori sono adulti, spesso adulti acculturati. E’ un nuovo mercato che si è aperto al comic book, un mercato più difficile e di umori alterni, ma sufficiente a risollevare le sorti del settore. A partire da questo episodio i comic book di supereroi per adulti, già nati da qualche anno, diventano una forte realtà editoriale: prodotti strani, soprattutto quando visti con gli occhi dell’Europa, per la loro acerba contaminazione tra temi che qui da noi possono sembrare eccessivi (come quello, reiterato, del superuomo) e modalità narrative e stilistiche decisamente raffinate.
Con il passare degli anni, il comic book per adulti è passato dal momento esplosivo a una più assestata fase di routine. Oggi è difficile dire dove finiscano i prodotti dedicati ai ragazzi e inizino quelli destinati ai grandi. Se allora il valore estetico delle storie per gli adulti era un fatto evidente, oggi la differenza sta forse più nel modo di scrivere che nella qualità. Inoltre, l’intero mondo del fumetto di supereroi ha subito il contraccolpo della storia di Miller e di alcune altre che nel medesimo periodo, con minore fortuna editoriale, ne hanno condiviso lo spirito.
Così, il mito del supereroe campione di virtù, perfetto e immortale, si è trasformato nella critica del mito (che non ne cancella la presenza, anzi, semmai, la rende ancora più accettabile), e l’immobilità temporale dei personaggi è divenuta un’apparente ma vorticosa trasformazione. Gli ultimi anni hanno visto una serie di avvenimenti nel mondo fatato degli eroi del comic book che non sarebbero stati nemmeno pensabili in passato: abbiamo assistito in diretta alla morte di Robin, aiutante e pupillo del Batman, abbiamo assistito al matrimonio dell’Uomo-Ragno e al frazionamento degli X-Men; una pletora di eroi minori, ma pur sempre eroi e protagonisti, sono caduti sul campo e usciti di scena. Qualche anno fa è stata pubblicata addirittura una serie i cui eroi erano destinati a morire dopo breve tempo a causa dello stesso procedimento che donava loro i super-poteri. In questo contesto l’annunciata morte di Superman non stupisce affatto, oggi; e come sa ogni buon lettore di supereroi, la morte del personaggio non è la morte del mito, poiché le sue avventure possono continuare in una miriade di modi, senza nemmeno ricorrere all’obsoleto (ma non del tutto abbandonato) trucco della resurrezione o della falsa morte: vi sono infinite avventure al passato dello scomparso Superman che devono ancora essere raccontate, e vi sono infiniti eredi nel presente che ne possono evocare la grandezza agendo nel suo nome…
Insomma, i bei film sul Batman che Tim Burton ci ha regalato hanno radici nello stesso retroscena che sta condannando Superman a gloriosa (e remunerativa) morte. Forse tutto questo visto dall’Europa fa sorridere un poco, e getta ombre di fanciullezza sull’intera cultura americana. Ma davanti allo schermo cinematografico ogni tanto anche la vecchia Europa può ben apprezzare quest’aura di giovanile mitologismo, per quanto alieno esso le possa sembrare.
 Jorge Luis Borges, da "Magie parziali del Don Chisciotte", Altre inquisizioni, Feltrinelli 1963, traduzione di Francesco Testori Montalto  Frank Miller "The Dark Knight Returns", DC Comics, 1985, pag. 26 Le parole di Borges hanno per oggetto testi classici, o speculazioni filosofiche. Le conclusioni a cui arriva restano comunque affascinanti. Questo è un saggio vero, non una delle sue Finzioni. Con Borges, si fatica a distinguere il reale dall’immaginato, e alla fine ci si rende conto che spesso non è una distinzione pertinente. Siamo anche noi il sogno di qualcuno, come Don Chisciotte era il sogno di Cervantes?
Che cosa c’entra Frank Miller con le fascinose ma astratte elucubrazioni del maestro argentino? Miller impara dai giapponesi, già nei primi anni Ottanta, a costruire la pagina in maniera diversa, a giocare con lo spazio della pagina nella sua interezza, considerando il margine delle vignette un elemento opzionale, da utilizzare o meno a seconda del caso. Il margine delle vignette ha, in generale, una funzione di cornice, e serve quindi, tra le altre cose, a distinguere lo spazio del mondo della finzione (il mondo raccontato) da quello del mondo reale (la pagina materiale, lo spazio bianco che allude allo scorrere della lettura e al passaggio dell’occhio del lettore a un altro quadro). Lasciare l’immagine al vivo, limitata solo dal taglio materiale della pagina, significa eliminare una cornice, cioè un elemento di distanza. Naturalmente rimane un’altra cornice ineliminabile, che è quella della pagina stessa – ma il taglio della pagina è un vincolo materiale, non un prodotto del disegno, proprio come il bordo della finestra che inquadra un pezzo di mondo. L’immagine al vivo rimane finzionale, ma il suo impatto è molto più forte, perché si avvicina di colpo al nostro mondo reale – lo sfiora, pur senza poterlo raggiungere. Se poi sai giocare bene anche sull’inquadratura, ecco che Batman sta davvero di colpo piombando su di noi.
Ma cosa sono dunque quei riquadri appoggiati sull’ìmmagine? Altre vignette, certo. Eppure se ci stanno sopra essi non appartengono al medesimo mondo: sono come cartoline appoggiate sopra a un manifesto. Nel mondo reale le immagini non si possono giustapporre in questo modo. Solo le immagini lo possono fare tra loro – e il fatto di trovarsi sopra indica che sono posteriori (non si infila un manifesto sotto a delle cartoline, di solito, ma viceversa).
Mentre l’immagine al vivo si accosta mostruosamente al mondo reale, la sovrapposizione di altre immagini la rigetta verso il finzionale, il rappresentato. Ma non dimentichiamo che la lettura di un fumetto va fatta in sequenza: prima dunque l’immagine grande è quasi-reale, poi diventa lo sfondo di altre immagini. La correttezza di questa modalità di lettura è confermata anche dalla posizione relativa delle vignette, e dall’andamento narrativo che ne consegue.
Si può leggere tutto questo però anche in un altro modo, cambiando un poco il punto di vista. Se l’immagine grande era quasi-reale, le vignette piccole si trovano ora ancora più vicine a noi – e poco importa che la realtà dell’immagine grande sia nel frattempo retrocessa, perché essa ormai si trova nel passato, e noi stiamo già leggendo le vignette piccole sovrastanti. È così che gioca Miller, illusione dopo illusione; e quando un’illusione si disvela, noi siamo già dentro la prossima, e poco ci importa della precedente.
E poi, soprattutto, poco ci importa perché quello che ci importa è soltanto l’impatto emotivo: questa insomma è fiction, questo è mito. Quello che Borges non arriva a dire (ma consegue dalle sue parole) è che l’ipotesi di essere a nostra volta personaggi della lettura di qualcuno ci rende parte di uno spettacolo, di un mito, di una fiction, in cui valiamo per quello che possiamo comunicare nella trama complessiva, non per quello che siamo. Se siamo i personaggi di un racconto, il senso della nostra vita, dell’intero nostro mondo, è quello di costruire un’esperienza significativa per chi ci legge, per chi lo legge.
Guarda caso, le vignette inserite sulla pagina di Miller sono schermi televisivi, con il relativo sonoro. Tutto The Dark Knight è intessuto di sequenze televisive. Le immagini più reali del quasi-reale che sta sotto di loro rappresentano dunque non una realtà bensì una rappresentazione – magari fedele, come può anche essere la TV, però una rappresentazione. Nel momento di massima vicinanza al mondo reale incontriamo quindi di nuovo una rappresentazione.
Non so se Miller abbia mai letto Borges, ma gran parte della sua notevolissima capacità narrativa sta proprio nell’aver capito che la fiction ci può apparire tanto più reale quanto più assomiglia a quella confusione di livelli tra il reale e il rappresentato che è il nostro mondo dominato dai media e dalle loro rappresentazioni. In un mondo in cui la rappresentazione (televisiva, cinematografica, raccontata dai giornali ecc.) può essere per noi più reale del reale, la realtà è per noi una dialettica complessa tra i tanti modi di viverla e rappresentarla.
Il Cervantes di Borges riduceva il mondo a spettacolo per la lettura di uno dei suoi personaggi, insinuando in noi il dubbio sulla nostra stessa realtà. Frank Miller non fa che riconoscere che il nostro mondo è ormai di quel medesimo tipo, e gli specchi della costruzione in abisso sono i diretti responsabili della costruzione del reale – non dei semplici riproduttori. Su questa dialettica senza scampo Silvio Berlusconi ha costruito il suo impero di finzione, e i suoi personaggi siamo noi. Per la lettura di chi?
9 Dicembre 2010 | Tags: comunicazione visiva, Dark Knight Returns, Filippo Scozzari, Frank Miller, fumetto, Guido Crepax, Guy Peellaert, sistemi di scrittura, Vaughn Bodé | Category: comunicazione visiva, fumetto, sistemi di scrittura | C’è un ambito, nel fumetto, che riguarda la scrittura ma non il lettering in senso stretto, ed è quello dei rumori. I rumori appaiono sotto forma di segni di scrittura dalla forte caratterizzazione grafica, con una grande varietà di forme.
Il rumore non è un oggetto del mondo rappresentato, e la natura semiotica della sua espressione nel fumetto è complessa. Un rumore viene tipicamente rappresentato attraverso una sequenza di lettere che, pur essendo di carattere onomatopeico, appare comunque come una parola – magari inventata. In quanto parola, implica la presenza di un senso (che magari può anche semplicemente essere: rumore forte) e soprattutto del suono che la sequenza di lettere evoca, un suono che (a parte quando si tratta di grida) non può davvero corrispondere a quello letteralmente espresso dalle lettere. Il suono espresso dalla parola brakabrakabraka, per esempio, che vediamo qui sotto in una tavola di Frank Miller, sarà dunque interpretato come il suono della mitragliatrice mostrata dall’immagine, un suono caratterizzato – proprio come la sequenza fonetica rinviata dalle nostre lettere – dalla ripetitività di suoni secchi, meccanici ed esplosivi.
 Frank Miller, The Dark Knight Returns, 1985
La parola brakabrakabraka rinvia perciò a una serie di suoni che sono un corrispondente analogico di quelli emessi dalla mitragliatrice. L’analogia messa in scena a livello del suono trova poi riscontro in un’altra costruzione analogica a livello della forma grafica, alla quale è demandato di dare energia alla figura del suono. Così, nei diversi esempi visivi che abbiamo raccolto qui si vede chiaramente come i rumori siano costruiti graficamente in modo da rendere, per analogia, la qualità dei loro corrispondenti sonori evocati.
Ma il rumore forte visivizzato nel fumetto gode di un’altra caratteristica. Il rumore è un elemento di per sé estraneo alla natura visiva del mondo rappresentato (e deve comunque avere, nel fumetto, una rappresentazione visiva), e si tratta di qualcosa che deve caratterizzare un eccesso, poiché il rumore stesso (quando vale la pena di rappresentarlo nel fumetto) è frutto di un eccesso. Per questa sua estraneità alla dimensione figurativa e per questa sua natura eccessiva, il rumore finisce per apparire come un elemento cruciale di caratterizzazione stilistica: ci sono infiniti modi possibili di essere eccessivi nell’inventare la forma visiva di qualcosa che in sé non ha nulla di visivo; e di conseguenza il modo scelto è cruciale per l’individuazione del contesto grafico di riferimento.
 Guy Peellaert, Pravda La Survireuse, 1967 Così, i rumori di Peellaert sono coloratissimi e bombati come nella visività psichedelica degli anni Sessanta, e quelli di Bodé sporchi e irregolari; mentre Crepax deve giocare sulla poca deformazione di un carattere lineare bold di ascendenza pubblicitaria, e Scozzari non si allontata dal modello underground di Bodé se non per una molto maggiore ricchezza di espressioni. Miller, infine, fa dei rumori visivi uno dei punti di forza della propria poetica della spettacolarità a tutti i costi, con una continua folgorante serie di invenzioni fonetiche e grafiche, dove non di rado il rumore investe la totalità del campo, ed è l’oggetto che si impone principalmente all’attenzione.
 Vaughn Bodé, War Lizards, circa 1970  Guido Crepax, L'uomo di Harlem, 1978  Filippo Scozzari, Nekator Superfly, 1974  Frank Miller, Ronin, 1983 Il racconto – da questi esempi è chiaro – si è mangiato l’immagine: là dove la rappresentazione di un rumore può diventare la totalità di ciò che si vede, è ovvio che si guarda (e si deve guardare, e anche con attenzione) per leggere la storia. Solo nel leggerli come rumori degli eventi della storia i rumori visivi del fumetto ricevono un senso dal proprio essere guardati. Tuttavia, al tempo stesso, essi restano anche delle pure caratterizzazioni grafiche astratte, con una figuratività, perciò, del tutto diversa da quella delle figure del mondo che li attorniano.
Se ignorassimo, o mettessimo sullo sfondo il racconto, certo, allora il rumore grafico si trasformerebbe in uno straordinario oggetto visivo, spesso da godere tramite un puro guardare. Ma non verrebbe più, in tal caso, inteso come un rumore. Eppure, anche se il racconto costituisce il fumetto, sappiamo bene che non lo esaurisce affatto. I rumori grafici sono certo prima di tutto rumori, ma un po’ sono anche favolosi oggetti grafici sospesi nello spazio.
 Frank Miller, The Dark Knight Returns, 1985
 Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley, The Dark Knight Returns pag. 3 (dettaglio) Ci dicono che farà ancora più caldo i prossimi giorni, e a me vengono in mente le prime pagine del capolavoro di Frank Miller. Gotham City è immersa in un’afa mortale, una tensione climatica che corrisponde alla tensione che agita lo spirito del vecchio Bruce Wayne. Non a caso, qualche pagina dopo, l’arrivo del temporale coinciderà con il primo rientro in scena del Batman.
Mi viene da domandarmi allora come faccia il fumetto a rendere l’effetto caldo. Le immagini che Miller ci propone sono efficaci, ma da sole non bastano: potrebbero benissimo rappresentare anche l’alba su una città invernale, il cui cielo è attraversato dai fumi dei camini o dell’inquinamento. Tuttavia, quando arriviamo a queste vignette, Miller ci ha già introdotto narrativamente il tema del caldo, ed è per questo motivo che in queste immagini riconosciamo non dei fumi ma delle volute di umidità, e il sole vi appare come una sorta di demone maligno e spietato.
Il fumetto, e in generale l’immagine, non può esprimere l’eccesso di calore se non attraverso i suoi effetti sulle persone e sulle cose. Però una volta che il tema è impostato, può anche riuscire a essere drammaticamente efficace. Guardate come nella sequenza riportata qui sotto, anche senza leggere le parole, il tema del calore salga nelle prime quattro vignette per poi esplodere nell’ultima, dove persino la grande dimensione diventa espressione del grande caldo!
Dobbiamo aspettare anche noi una qualche risoluzione emotiva di un qualche Batman per trovare un po’ di respiro? Magari, se vivessimo in una storia, in una bella storia…
 Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley, The Dark Knight Returns pag. 6 (dettaglio)
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|

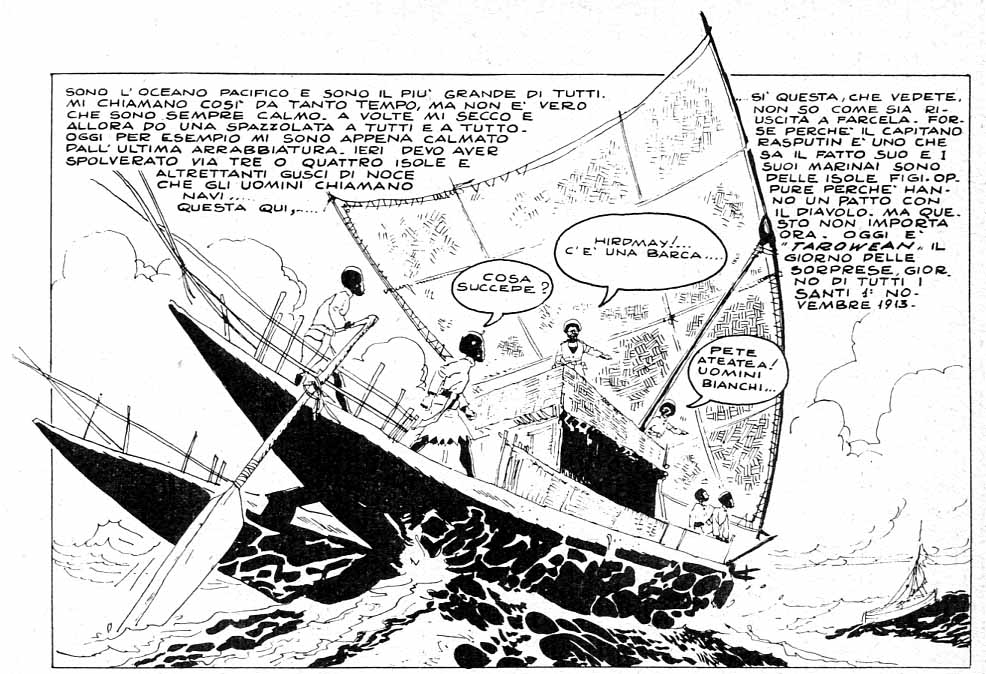
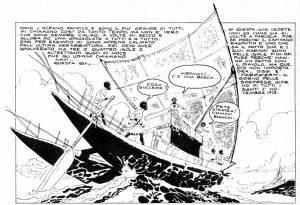











 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






Commenti recenti