Mi sto domandando qual è il mio modo di ascoltare la musica. Scorrendo un mio curriculum vitae, mi sono accorto infatti che la maggioranza delle mie pubblicazioni accademiche degli ultimi due anni ha come argomento proprio la musica, ed è stata prodotta per incontri di carattere musicologico – in almeno un caso co-organizzati da me. Eppure io non sono un musicologo, anche se, evidentemente, qualche competenza in materia ce l’ho. Dunque: perché e come ascolto la musica, io?
Sono un frequentatore (non assiduo, ma costante) di concerti, di musica di vario tipo, durante i quali l’ascolto è ovviamente attento e concentrato. Se non sono impegnato in attività intellettuali, ho spesso la musica come sottofondo. Ascolto sempre musica se viaggio in macchina. A volte ascolto musica per sentire un determinato pezzo, e in questo caso la fruizione è attenta; ma anche quando la musica mi fa da sfondo, può accadere che lo sfondo passi sul primo piano, e che la mia attenzione sia concentrata su di lei piuttosto che su quello che sto facendo. In macchina questo è una condizione normale (e per fortuna gli automatismi dell’automobilista mi hanno tenuto in vita sino ad oggi).
Ascoltare la musica con attenzione e concentrazione piena significa considerarla come una sorta di discorso – ovviamente differente da quello della parola, però comunque un discorso, ovvero una comunicazione che va da chi la produce a chi la riceve, trasmettendo un qualche contenuto (emotivo, informativo, narrativo…). Ma la musica non è nata per essere ascoltata. Questa affermazione potrà sembrare paradossale finché non riflettiamo sul fatto che prima della musica come cosa che si ascolta c’è stata la musica come occasione per ballare, come occasione per cantare insieme, come commento (accompagnamento) a una situazione (tipicamente cerimoniale, ma non solo). In tutti questi casi la musica non è una cosa che sta di fronte a noi per l’ascolto, ma qualcosa che viene vissuto da dentro, qualcosa che ci avvolge e di cui facciamo parte, ballandola, cantandola o vivendo il rito di cui essa è parte. Sino a qualche secolo fa questi tipi di fruizione costituivano la totalità dei modi di fruire la musica.
L’ascolto frontale, distaccato, è un’invenzione moderna. Possiamo, a essere generosi, risalire al Rinascimento, ma prima del Seicento in verità la pratica teatrale del concerto, in cui si va semplicemente ad ascoltare qualcuno che suona, non è affatto diffusa. E, naturalmente, anche quando si diffonde, non soppianta affatto le altre pratiche.
Inoltre, anche se il diffondersi dell’ascolto frontale permette il formarsi di uno specifico discorso musicale (ovvero la musica impara a trasmettere al suo ascoltatore un discorso, emotivo, informativo, narrativo ecc.), la musica non perde mai la sua natura coinvolgente, di esperienza immersiva. Di questo facciamo esperienza tutti facilmente quando, nell’ascoltare (frontalmente) un concerto, sentiamo il nostro piede che batte il tempo (ovvero balla), la nostra voce che interiormente riproduce l’andamento musicale (ovvero canta), e vediamo che il contesto in cui ci troviamo è trasformato dalla semplice presenza della musica.
Insomma, quello che credo è che anche la musica da concerto oggi (a qualsiasi genere appartenga) debba possedere sia la natura frontale che le permette di esprimere un discorso (e quindi di essere interessante anche per un ascolto concentrato) sia la natura immersiva che ci permette di partecipare al suo evento (e quindi di riconoscerci nella comunità – danzante, cantante, vivente – dei presenti). In questo senso, certamente la musica è parente stretta della poesia, che vive delle medesime componenti, anche se magari in diversa misura.
Qualche tempo fa, in una tra tante discussioni conviviali con Luca Francesconi, il discorso era andato sul rock, sul jazz e sulla musica colta contemporanea. Ricordo che a un certo punto Luca disse che se il rock ha uno spessore così (facendo il segno con due dita di uno spessore di qualche centimetro), allora il jazz ce l’ha così (e il segno rappresentava ora uno spessore del doppio o del triplo) e la musica contemporanea ce l’ha così (e ora le sue mani si allargavano ad abbracciare il massimo spessore possibile). Lo spessore in questione era quello che Francesconi definirebbe (credo) lo spessore semantico, ovvero la possibilità di trasmettere un discorso articolato e complesso.
Assumiamo che Francesconi avesse ragione, e che la musica colta contemporanea sia davvero in grado di trasmettere un discorso tanto più articolato e complesso di altri generi musicali (è un’assunzione facile da condividere, in sé). Questo comporta dunque una qualche superiorità della musica colta? Dal punto di vista della complessità senz’altro: è proprio questo il suo specifico! Ma davvero dovremmo essere tutti tifosi di Luciano Berio, e, per questo, disprezzare Miles Davis e i Beatles?
In altre parole: il fatto che esista della musica fatta per essere principalmente un discorso, lasciando decisamente in secondo piano gli elementi immersivi, dionisiaci, corali, ci deve indurre a disprezzare la musica in cui questi elementi rimangono forti? Rispondere positivamente a questa domanda vuol dire ritenere che il destino della musica debba essere quello di costituire discorsi (e in questo senso sembrano andare sia le famose conferenze di Anton Webern sull’esaurimento delle possibilità della musica tonale, sia gli scritti di Theodor Adorno sull’invecchiamento della musica contemporanea): in questa prospettiva saremo portati a vedere, come mi sembra che faccia lo stesso Francesconi, tutta la musica principalmente come discorso. E, certo, se accettiamo questo punto di vista, Francesconi ha ragione, non è possibile dagli torto.
Ma le mie consuetudini di ascolto (e io sono uno che ama sia Luciano Berio che Miles Davis che i Beatles, e anche la musica stessa di Francesconi) mi dicono che le cose non stanno così. Se la musica deve ridursi a discorso, allora esiste già uno strumento molto più potente di lei per trasmettere discorsi: ed è la parola, tanto più se scritta. Il potere della poesia non sta nei discorsi che fa (tanto spesso riconducibili a un piccolo gruppo di stereotipi), ma nel fatto che attraverso i propri strumenti di carattere immersivo e dionisiaco, la poesia riesce a farci vivere quei discorsi e insieme a farci sentire parte di una sensibilità comune, collettiva, umana.
Chi difende la musica contemporanea mi dirà che essa fa proprio questo, però deve prendere le distanze da tutto quello che è mercificato, banalizzato dal consumo. Il problema è che in un mondo in cui tutto è mercificato e banalizzato dal consumo, dovremmo prendere le distanze da tutto: e questo è proprio quello che almeno certa musica contemporanea ha l’aria di fare. Tuttavia così facendo ha anche tagliato i ponti con la partecipazione immersiva e, paradossalmente, persino con la possibilità di trasmettere il proprio discorso: se l’ascoltatore non ha motivo per sentirsi partecipe, non ha neanche motivo di ascoltare la musica – e un discorso che non si può trasmettere è come se non ci fosse.
Ritrovo nelle mie stesse consuetudini di ascolto le conseguenze di tutto questo. Di fatto, quasi non riesco più ad ascoltare la musica colta contemporanea; a volte mi annoia, a volte mi irrita. Mi irrita quel tono da appartenenti a una casta di eletti che essa frequentemente esprime.
D’altra parte, non posso nemmeno ascoltare quegli autori contemporanei di tradizione classica che non seguono la linea marcata da Darmstadt. Meglio sicuramente Boulez, o Berio o lo stesso Francesconi piuttosto che John Adams o Michael Nyman: non ho dubbi su questo. Il sospetto che questi altri autori abbiano mancato o volutamente ignorato un momento cruciale della storia è troppo forte.
E allora? Allora forse c’è un problema a monte. Magari è la musica colta contemporanea che non ci rappresenta più, e rimane un vestigio della grande tradizione classico-romantico-novecentesca, che viene perpetuato per poter sostenere che le orchestre e le strumentazioni tradizionali (con tutto l’apparato teatrale che le accompagna) non sono solo un retaggio che ci viene dal passato. In altre parole, la musica colta contemporanea servirebbe a farci sentire la continuità con un passato che noi sentiamo (e del tutto a ragione) come grande.
Ma questo è sufficiente a farla esistere?
Nel mio piccolo ho dei problemi ormai ad ascoltare questa musica. Mi sento più rappresentato da Miles Davis, oppure, magari, da Mozart o da Stravinsky. Lo so che c’è qualcosa che non quadra: ma l’epoca dell’ideologia è finita (purtroppo e per fortuna), e non credo più che le avanguardie abbiano ragione perché sono avanguardie.
Non essendo un musicologo, e non essendo tenuto a teorizzare sulla musica, mi sfogo esplorando musiche di altre tradizioni, come quella (straordinaria) dell’India. Posso però teorizzare sull’ascolto, o almeno sul mio.








 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



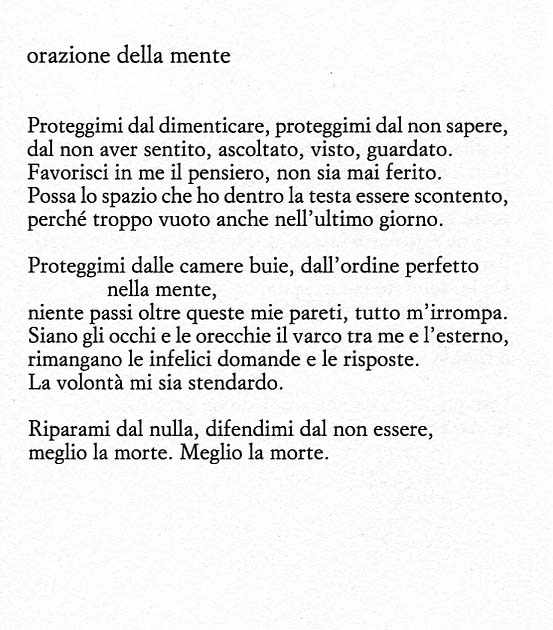


Il problema della committenza c’è sempre stato, nessun compositore vive di vento. Questo vale per ogni genere di musica, la più “facile” come la più impegnativa. Forse il difetto è piuttosto nella critica musicale, pronta ad acclamare il genio dove ce n’è poco – penso a Nyman e al minimalismo in genere.
Sì, certo. L’idea del genio che esprime se stesso senza limiti che non siano quelli della propria capacità di esprimersi è un’idea Romantica, legata a quel mito del sublime di cui ho parlato anche in un altro post. L’ammirazione per i maestri e per il passato in genere (che ne nasconde gli aspetti più pratici) fa il resto, facilmente aiutata da una critica che vive all’interno dell’ideale romantico.
Però il minimalismo io non lo butterei via tutto: Steve Reich è irritante ma di grande originalità. Louis Andriessen e persino Wim Mertens si lasciano ascoltare: chissà perché mi fanno venire in mente (soprattutto Mertens) la musica francese dei tempi del re Sole, tipo Charpentier o (soprattutto) Delalande. Corsi e ricorsi storici, sensibilità mia deviata, oppure una strategia deliberata?
Magari dovremmo riformulare la domanda in questi termini: che relazione c’è tra quello che mi (ti, ci) piace ascoltare, e quello che è degno di essere dichiarato importante per una Storia della Musica? Domanda facile, vero?
“ciò che è importante in un’opera d’arte non è quello che l’artista ci mette dentro, ma quello che lascia fuori”
barnett newman
non sono d’accordo su quello che dice francesconi: mi sembra ingenuo attribuire un certo spessore fisso a un genere musicale, a un linguaggio. se un compositore scrive su pentagramma un pezzo per orchestra di venticinque minuti sedimentandovi l’esito di un lavoro a tavolino durato mesi produce forse, ipso facto, qualcosa di maggior spessore rispetto a quello che può produrre un cantautore capace di comporre una meravigliosa canzone in dieci minuti o un jazzista che lasci al vento un memorabile assolo sul suo strumento? perché?! perché il primo ha ‘studiato’ la musica e i secondi no? perché nel pezzo per orchestra si riflette un sistema complesso di relazioni reciproche tra i suoni, rigorosamente controllato dal compositore, laddove nella canzone o nell’assolo tutto è lasciato all’intuito? ma forse francesconi non è così ingenuo – almeno, lo spero! – da pensare una cosa del genere: forse vuol dire che tra i migliori prodotti della musica colta e quelli del jazz e del pop resta comunque uno scarto di ‘spessore’, e quindi uno scarto qualitativo. ma non è anche questa un’idiozia? che senso avrebbe paragonare, che ne so, ‘lux aeterna’ di ligeti a ‘shine on you crazy diamond’ dei pink floyd o ad ‘a love supreme’ di coltrane per dire che ligeti fa un’arte ‘di serie a’ e gli altri no? che ligeti comunica, trasmette PIU’ cose (e migliori) degli altri? questo è un pregiudizio bell’e buono, purtroppo ancora duro a morire presso la stragrande maggioranza dei compositori cosiddetti ‘colti’, un pregiudizio che li rende personaggi perlopiù tristi (anche quando, come nel caso di francesconi, hanno molto ‘successo’), arroganti e autoreferenziali. la verità è che questa smunta maggioranza vive da decenni all’ombra degli ultimi veri, grandi compositori (quelli nati negli anni venti, con qualche incursione nei tranta e qualche lumicino nei quaranta, poi stop) portando con sé un retaggio di strumenti e di tecniche che non sono più capaci di leggere il mondo, di capire il presente, e ancor meno di radicarsi in un vissuto personale autentico (sono tutti ragionieri, ingegneri e commercialisti dell’arte, privi, al di là del talento, di un qualsiasi temperamento artistico). ho sempre trovato molta più musicalità nei musicisti pop che in quelli colti, che infatti spesso non sanno o si rifiutano di improvvisare, cantare e soprattutto GODERE dell’esperienza musicale. insomma, per dirla tutta, credo fermamente che aphex twin, autechre, bjoerk, tricky, beck e daft punk siano di gran lunga superiori al novanta per cento dei nipotini di berio o di boulez. con buona pace di francesconi e di tanti suoi colleghi.
Capisco la posizione (e ringrazio per i complimenti) ma non riesco a essere altrettanto deciso.
Forse il problema sta proprio nell’espressione “godere l’esperienza musicale”. Il godimento si dà a livelli molto differenti: in qualche caso persino la ripetizione di un battito piuttosto elementare mi può dare godimento. Poi magari non lo reggerei a lungo.
Forse ci sono musiche adatte a contesti (sociali, emotivi) diversi e non ha senso stilare classifiche. Oppure le classifiche si stilano da punti di vista specifici e chiaramente dichiarati; e valgono per quello.
In musica sono sempre presenti una dimensione discorsiva e una immersiva (o, se vogliamo dirla con Nietzsche, una apollinea e una dionisiaca) e anche se semplicemente stiliamo classifiche per l’una, per l’altra, o per la commistione ottimale tra le due, abbiamo risultati radicalmente diversi.
Personalmente, e approfittando del fatto che non sono davvero un musicologo e posso non schierarmi, le mie classifiche valgono lo spazio del momento e dell’occasione in cui sto ascoltando musica. Certo: ci sono musiche che non mi verrebbe mai voglia di ascoltare – eppure talvolta le circostanze mi portano persino a “godere” di quelle.
Mi capita quindi di “godere” di Francesconi e di Boulez (che io trovo abbiano momenti di grande godibilità) ma anche dei Pink Floyd, di John Coltrane o di Bhimsen Joshi. Musicalmente resto un “damned intellectual”, questo si capisce. A priori, però, sono pronto ad apprezzare qualsiasi musica, purché nel momento giusto.
sì, anch’io credo che l’espressione ‘godere l’esperienza musicale’, sia problematica, ma lo è anche – e forse di più – l’espressione ‘spessore SEMANTICO’. non capisco bene infatti cosa voglia dire ‘semantico’ se applicato alla musica. in estrema sintesi, direi che per ‘capire’ la musica non sia necessario ‘conoscerla’. non so se mi spiego. ma certo è un discorso troppo complesso questo, che esula un po’ dai limiti imposti da un blog. la ringrazio comunque per la gentile risposta e le faccio tanti auguri per la sua attività.
PS dimenticavo: steve reich è un grande compositore.
PS2 e soprattutto dimenticavo (e mi scuso): complimenti a daniele barbieri, è davvero un blog molto bello, questo. grazie
@ marcolenzi
Sì, l’espressione “spessore semantico” è problematica almeno quanto lo è la questione del significato della musica.
Però magari presto o tardi mi verrà voglia di scrivere un post sul tema, o almeno su qualche suo aspetto.
Mi ero dimenticato di esprimere apprezzamento per la citazione da Barnett Newman. Perché si capisca che cosa rimane fuori bisogna che quello che c’è dentro lo lasci intuire. Ma probabilmente il fascino sta davvero proprio lì, in quella sensazione di cogliere qualcosa che continuamente ci sfugge, perché è il nostro rincorrerla a spingerla sempre più in là. Ma non è per niente facile costruire oggetti di questo genere. Quando funzionano mi pare giusto fregiarli di quell’appellativo onorifico che è l’espressione “opera d’arte”.
sono pienamente d’accordo. e spero di leggere prima o poi il suo post sul tema. grazie ancora, un caro saluto da livorno.
Mi viene in mente ora (meglio tardi che mai) che ci sono almeno due articoli miei on line dove si parla del problema del discorso musicale – e quindi, implicitamente del significato della musica.
Uno è più generale, si chiama Appunti per un’estetica del senso, e il tema è affrontato a partire dal capitolo “Testo e discorso” in poi.
L’altro è più specifico (e più breve), ma contiene alcuni termini tecnici del discorso semiotico (essendo stato prodotto per un convegno specialistico). Il titolo è Quando Mozart faceva piano-bar. Appunti per una sociosemiotica dello sfondo.
grazie per la segnalazione, li leggerò con interesse.