22 Settembre 2014 | Tags: estetica, metrica, poesia | Category: estetica, poesia |  Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza. Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza.
Una cosa su cui vari antropologi insistono è il fatto che le strutture regolari che si trovano, per esempio, nelle forme dei villaggi delle culture tradizionali (quelle che la lingua italiana tradizionale chiamerebbe selvagge, ma mi sembra un termine molto crudo e un po’ discriminante), oppure nelle cicatrici rituali del volto di certi popoli africani, hanno come scopo quello di distinguere l’appartenenza a una cultura e società umana dalla naturalità di fondo dell’ambiente. In altre parole, la cultura si distinguerebbe dalla natura imponendo artificiosamente ai propri costrutti un ordine ritmico che la natura normalmente non ha (o almeno non in quei termini).
La nostra cultura e società non ha bisogno di enfatizzare allo stesso modo quelle stesse cose o altre analoghe. Siamo già sufficientemente separati dalla natura per sentire il bisogno, semmai, di enfatizzare i punti di contatto, alla ricerca di una naturalità di fondo che percepiamo come perduta. La hybris della modernità è (anche) questo senso di perdita della natura, di incolmabile distanza, di scarsa appartenenza all’ecosistema.
Potremmo ipotizzare che anche le strutture metriche della poesia tradizionale siano strutture regolari che servono (anche) a marcare la culturalità, l’artificialità della parola poetica rispetto alla spontaneità e naturalità di quella quotidiana. Non dimentichiamo che anticamente, e tutt’ora nelle culture orali, i narratori narravano in versi; e la forma ritmica del racconto in versi caratterizzava dei veri e propri riti di ascolto, quelli da cui nasce poi il teatro. La parola poetica era dunque la parola massimamente sociale, culturale – contrapposta a una parola quotidiana non del tutto separata dal sottofondo naturale, in quanto ne condivideva i ritmi troppo complessi e l’origine non progettata, spontanea.
Se una visione del genere fosse accettabile (ed è questa l’ipotesi che sto facendo) il destino della metrica tradizionale sarebbe segnato in una modernità che ha più bisogno di riconoscersi nella natura che di distinguersi da lei. La nascita del verso libero, come abbandono di strutture ritmiche troppo regolari e canoniche, sarebbe allora l’abbandono di una modalità tradizionale di contrapposizione al dominio naturale sopravvissuta al proprio bisogno (come spesso accade con le istituzioni). Da artificiali che erano, certe strutture ritmiche canoniche (in poesia come nei villaggi) vengono sentite come artificiose. Bisogna piuttosto cercare una nuova naturalezza.
Ma le cose non sono così semplici. Il bisogno di strutture rituali – che una volta si accompagnava positivamente a queste regolarità, qualificando le regolarità rituali come a loro volta artificiali e culturali, dunque umane – non è in realtà diminuito, perché i riti sono comunque costitutivi del legame sociale. Ci si trova dunque nella situazione paradossale per cui si ha comunque bisogno di riti (caratterizzati da ritmi regolari) mentre le regolarità vengono sentite come artificiose, meccaniche, antinaturali e quindi tendenzialmente da evitare.
In questa contraddizione costitutiva del nostro modo di vivere socialmente, la poesia patisce, fatica a trovare un posto, perché rappresenta implicitamente il retaggio di un mondo in cui la contraddizione non esisteva. Il verso libero è la sua ultima linea di resistenza, ovvero la condizione contraddittoria di una regola (metrica) che nega la propria regolarità (metrica), permettendo in qualche modo la fruizione rituale che la poesia richiede, e insieme parzialmente negandola in nome dell’espressività personale, qualcosa che per noi è certamente più naturale dell’artificioso meccanismo iterativo.
Da qui, tutta la debolezza e tutto il fascino della poesia del Novecento (e oltre), schiacciata dalla (quasi) scomparsa delle sue condizioni normali di esistenza, e costretta a cercare gli stigmi della naturalità dopo aver portato per millenni il vessillo della culturalità!
 Qualche giorno fa, ritornando su una delle mie ossessioni poetiche (qui a sinistra) in occasione di un seminario universitario, facevo un ripasso di metrica inglese sul libro di G.S.Fraser Metre, Rhyme and Free Verse (Methuen London 1970). Dopo una lunga parte dedicata ai ritmi giambici, di gran lunga i più utilizzati nella metrica inglese, Frazer passa a quelli trocaici, anapestici ecc., insomma, tutti gli altri. E a un certo punto dice: “I trochei si prestano meglio dei giambi a un certo tipo di effetto cantante in poesia (mentre il piede giambico è fondamentalmente il piede parlante)”. Qualche giorno fa, ritornando su una delle mie ossessioni poetiche (qui a sinistra) in occasione di un seminario universitario, facevo un ripasso di metrica inglese sul libro di G.S.Fraser Metre, Rhyme and Free Verse (Methuen London 1970). Dopo una lunga parte dedicata ai ritmi giambici, di gran lunga i più utilizzati nella metrica inglese, Frazer passa a quelli trocaici, anapestici ecc., insomma, tutti gli altri. E a un certo punto dice: “I trochei si prestano meglio dei giambi a un certo tipo di effetto cantante in poesia (mentre il piede giambico è fondamentalmente il piede parlante)”.
Il piede giambico è il piede parlante perché il ritmo normale del parlato inglese è molto vicino a un ritmo giambico. Quando Shakesperare scrive “I còme to bùry Càesar nòt to pràise him” (ho aggiunto gli accenti per rendere evidente il ritmo), sta giocando su una leggera formalizzazione di un andamento tutto sommato normale, prosastico.
Il blank verse di Shakespeare è un pentametro giambico, la cui origine è legata storicamente all’endecasillabo italiano, modificato per adattarlo alla lingua inglese, ma estremamente simile nello spirito. Il ritmo dominante nel parlato dell’italiano non può essere giambico, perché la lunghezza media delle parole dell’italiano è maggiore di quella dell’inglese, e ogni parola possiede un solo accento. Per questo in italiano l’accento cade di solito ora ogni due ora ogni tre sillabe. L’endecasillabo italiano è dunque il verso in cui questa varietà accentale si trova più naturalmente espressa; basta leggere un po’ di Dante per rendersene conto. Come il pentametro giambico per l’inglese, l’endecasillabo italiano rappresenta un modo per formalizzare, regolarizzare, armonizzare l’andamento della prosa, senza forzarne troppo i ritmi; senza farli sentire troppo artificiosi.
Per questo l’endecasillabo è il nostro verso epico, ed è il verso dominante in tutta la nostra tradizione. Come vedremo meglio tra poco, l’endecasillabo incarna al meglio l’ambivalenza della poesia tra musica e prosa, portando in direzione della regolarità del cantato la naturale irregolarità del parlato.
È però naturalmente possibile giocare di più sul lato del cantato (come anche, naturalmente, su quello del parlato).
Torniamo a Fraser. Il ritmo trocaico si presta meglio all’effetto del cantato proprio perché è decisamente più distante dai ritmi naturali del parlato. Questo mi permette di aggiungere una riflessione in più a quelle che ho già esposto qui su The Tyger, di Blake. Blake inizia il suo componimento con un ritmo trocaico fortemente battuto, la cui cantabilità è ulteriormente ribadita della presenza della rima baciata a fine verso (bright/night). Ma poi questa ossessione ritmica fa naufragio sul quarto verso, che è giambico e in cui alla parola eye fa riscontro una semplice rima per l’occhio (eye rhyme) con symmetry.
Ho già fatto osservare le conseguenze di questo naufragio sul significato complessivo del testo, e non ci torno qui. Quello che mi preme far notare, qui, è che il passaggio improvviso dal ritmo trocaico a quello giambico e dalla rima baciata a quella non rima che è di fatto la eye rhyme, è di fatto un passaggio dal cantato al parlato, dalla musica alla prosa.
Intendiamoci, non c’è veramente né musica né prosa nel testo di Blake. Quello che c’è è un andamento poetico che ora si fa maggiormente musicale e ora si fa maggiormente prosastico; in altre parole, la poesia evoca nel suo flusso ora la presenza della musica ora quella della prosa.
Poi, non è certamente un caso che Blake ponga proprio nei versi giambici (quelli cioè prosastici) i punti chiave del suo discorso (come il verso 4/24 “Could/Dare frame thy fearful symmetry” oppure il 20 “Did he who made the Lamb make thee?”, che contiene la domanda chiave e conclusiva della sequenza). Non è un caso per due motivi: in primo luogo (e più importante) i versi giambici sono pochi in questo componimento, e rappresentano quindi dei punti di rottura, il cui contenuto viene messo in evidenza proprio dal loro trovarsi in questa posizione; e in secondo luogo (ma tutt’altro che irrilevante) la prosa è, rispetto alla musica, proprio il contesto dell’espressione concettuale, del discorso, contrapposto a quello della pulsazione condivisa, del ritmo, della Stimmung.
Tutta la poesia vive di questa ambivalenza tra parlato e cantato, tra prosa e musica, ma Blake gioca sulla polarizzazione, spingendo parte dei suoi versi in direzione del lato musicale e l’altra parte in direzione di quello prosastico. Siccome è uno straordinario fabbro (il miglior fabbro in giro in quegli anni), è capace di giostrare magistralmente una possibilità che la poesia comunque ha sempre posseduto, e continua a possedere.
Ora sarebbe interessante andare a vedere la poesia di Eliot e di Pound (il miglior fabbro in giro un secolo e qualcosa dopo) analizzandola in questi termini. Credo che scopriremmo la medesima dialettica, anche se maggiormente spostata nella direzione del prosastico. Il verso libero stesso è, in generale, una manifestazione di questo spostamento verso il prosastico, verso il parlato. Lo è in generale, ma non in assoluto: vi sono infatti autori, come Campana, il cui verso libero finisce per creare quasi l’effetto opposto, in direzione cioè del musicale.
Potremmo azzardare persino una regola generale, definendo l’ambito del poetico come quel vasto incertissimo campo che sta tra il musicale e il prosastico. C’è ancora poesia nelle parole delle canzoni, anche se ci troviamo sul confine – e il confine viene superato definitivamente quando queste parole sono discorsivamente irrilevanti, puro supporto della voce per diventare musica. E c’è ancora poesia nel poema in prosa o prosa poetica, anche se ci troviamo sul confine – e il confine viene superato definitivamente quando il discorso e il contenuto concettuale sono centrali, e la parola è puro supporto del concetto per esprimersi.
Per finire, vorrei fare un esempio del tutto diverso. Ho appena tradotto per Le voci della luna alcune poesie di un autore spagnolo, Lawrence Schimel, dalla sua raccolta Desayuno en la cama, ovvero Colazione a letto. Usciranno sul prossimo numero, il 56. Sono poesie d’amore, omosessuale, caratterizzate da un verso libero dall’apparenza molto colloquiale, molto prosastica. Eccone una, prima l’originale, poi la mia versione.
Ya no quiero callarme cuando follo
por miedo a lo que piensen los vecinos.
Ya estoy harto de contenerme.
Quiero gritar, quiero celebrar,
quiero cantar… pero me temo que he perdido
la voz de tanto inhibirme.
Afónico, me desnudo delante del poema.
Non voglio stare zitto quando scopo
temendo la condanna dei vicini.
Sono stanco di contenermi.
Voglio gridare, voglio celebrare,
voglio cantare… ma ho il timore di aver perso
la voce a forza di inibirmi.
Afono, mi denudo di fronte a questi versi.
Anche nei versi dal 3 al 6 è presente una forte attenzione al ritmo prosodico (e questi versi danno un’idea dell’andamento della gran parte dei versi della raccolta), ma i versi 1 e 2 sono perfetti endecasillabi, e anche l’ultimo lo è, a partire dalla virgola.
Per lo spagnolo ancora più che per l’italiano, l’endecasillabo è il verso della tradizione petrarchesca. Se viene contrapposto al verso libero, appare certamente come più vicino al polo musicale che a quello prosastico. Ma qui lo spostamento improvviso verso il polo musicale (che ho cercato di rendere con lo stesso ritmo endecasillabico anche in italiano) corrisponde all’esposizione di un contenuto piuttosto crudo e carnale, decisamente antipetrarchesco. L’effetto è quello di un addolcimento della crudezza, da un lato, ma, dall’altro, è anche quello di una virata verso il grottesco, per cui “voi ch’ascoltate in rime sparse il suono/ di quei sospiri ond’io nudriva ‘l core” non potete non sorridere dell’arditezza di inserire in questo quadro idilliaco i suoni di una scopata. Arditezza che rientra pienamente, peraltro, nell’ultimo verso, molto più petrarchesco nello spirito – salvo non poter non notare, anche qui, l’ammiccamento di quel “denudarsi”, che rimette in gioco il discorso di prima.
Insomma, Schimel gestisce con molta arguzia il rapporto tra espressione e tradizione, ma soprattutto tra musica e prosa nella sua poesia, nascondendo un sacco di musica nell’apparente bassa prosa del suo discorso amoroso.
 Qualche giorno fa, sull’altro mio blog, quello in cui metto le poesie mie, ho postato l’esito di un esperimento; ovvero il rifacimento, a distanza di 5 anni, di una mia poesia, conservando il tema e le linee del discorso, ma esponendoli per come farei oggi. Potete leggere cliccando qui i due lavori, magari partendo da quello del 2008, che, sulla pagina, è il secondo. Di fatto, l’idea dell’esperimento mi è venuta dopo aver pubblicato sul blog la versione 2008, in parte per i commenti che ho ricevuto. Qualche giorno fa, sull’altro mio blog, quello in cui metto le poesie mie, ho postato l’esito di un esperimento; ovvero il rifacimento, a distanza di 5 anni, di una mia poesia, conservando il tema e le linee del discorso, ma esponendoli per come farei oggi. Potete leggere cliccando qui i due lavori, magari partendo da quello del 2008, che, sulla pagina, è il secondo. Di fatto, l’idea dell’esperimento mi è venuta dopo aver pubblicato sul blog la versione 2008, in parte per i commenti che ho ricevuto.
Entrando nei dettagli dei termini dell’esperimento. Si trattava di riproporre un discorso che io continuo a trovare interessante sottraendolo a una condizione metrica in cui non mi riconosco più, oggi – con tutte le trasformazioni che ne conseguono, anche nel senso. Intendiamoci: non sto dicendo che considero la versione del 2008 sbagliata o brutta; se la pensassi così nemmeno l’avrei pubblicata. Piuttosto, è semplicemente un lavoro che io trovo (per i miei parametri) riuscito, ma che oggi non potrei scrivere così; non mi interesserebbe scrivere così; troverei noioso scrivere così…
I termini della riformulazione sono, di base, termini metrici, ovvero alcuni vincoli metrici che hanno conseguenze profonde sull’andamento del discorso. I versi sono isosillabici, e in particolare esadecasillabi, con accento obbligato (oltre che sulla quindicesima) sulla settima sillaba; li si potrebbe definire doppi ottosillabi senza cesura (ottosillabi e non ottonari, perché l’ottonario italiano ha gli accenti fissi, mentre nei miei versi gli accenti sono mobili). A questo si aggiunge il requisito di una tendenziale continuità del discorso, in modo da ottenere, il più possibile, un effetto di fluidità continua, con eventuali (e graditi) enjambement.
L’effetto che, con questo espediente metrico, si vuole ottenere è quello di evitare l’andamento da verso libero, cioè esattamente quello che domina nella versione del 2008, con i suoi legami con la sintassi e l’inevitabile focalizzazione creata dalle modalità del ritaglio (secondo i principi che ho provato recentemente a spiegare qui). L’altro effetto che si cerca di evitare è la caduta (pressoché inevitabile, prima o poi, col verso libero) in qualcuno dei ritmi canonici della poesia italiana, come quelli dell’endecasillabo e del settenario. Nella versione 2008, due versi cruciali, l’1 e l’11 sono endecasillabi, e gli ultimi due (12 e 13) sono settenari. Questa ricomparsa occasionale di metri canonici non passa inosservata, in un componimento in versi liberi; il recupero momentaneo di un andamento ritmico familiare è inevitabilmente una sottolineatura retorica. Però è anche, al tempo stesso, un recupero classico – con l’effetto complessivo che nei luoghi cruciali di una poesia in versi liberi troviamo facilmente dei recuperi classici; quasi a dire che la tradizione è inabbandonabile, in fin dei conti.
La disciplina metrica che mi sono dato (e non in questo solo componimento) ha tra i suoi fini proprio quello di evitare la ricaduta del verso nei ritmi canonici. L’accento obbligato sulla settima sillaba rende difficile (non impossibile) ricadere in un ritmo che ha accenti pressoché obbligati sulla quarta o sulla sesta. In questo modo posso giocare sul ritmo prosodico senza troppo preoccuparmi di richiamare andamenti noti ed esausti della poesia italiana. L’ottosillabo ad accenti liberi è familiare alla poesia spagnola, ma praticamente sconosciuto a quella nostrana. Se si aggiunge il suo raddoppiamento senza cesura (e quindi la misura obbligata sarà solo quella complessiva di sedici sillabe, mentre gli emistichi possono tranquillamente essere anche tronchi di 7 o sdruccioli di 9), tagliamo fuori pure le orecchie spagnole.
Il discorso, poi, deve fluire il più possibile senza interruzioni, un po’ come a volte succede in Amelia Rosselli, o in alcune cose di Montale, quasi come se fosse un brano musicale, in cui gli stessi andamenti melodici (qui, le stesse parole) possono ritornare in posizioni ritmiche diverse, o su tonalità diverse (qui, in contesti diversi di senso), creando collegamenti trasversali di identità e diversità, e mettendo in secondo piano quell’organizzazione su base sintattica che invece il verso libero, quasi inevitabilmente, enfatizza – ma creando, al tempo stesso un tessuto sonoro (qui sonoro e semantico) d’insieme.
Insomma, questo è quello che il mio esperimento provava a fare. Poiché sono sempre stato sensibile al problema, tra i primissimi post pubblicati in questo blog ce n’è uno del marzo 2010 intitolato proprio “Dell’andare a capo in poesia“. Quando l’ho scritto, mi muovevo ancora nelle modalità di scrittura della versione 2008 di “Un gioco di finestre”, ma già si capisce, dalle citazioni che faccio, dove cercavo di andare a parare.
È ovvio che a me, oggi, piaccia di più – tra le due – la versione 2013. Mi piacerebbe molto avere un’opinione dei miei lettori (ben meno dei Suoi 25, ahimé).
 Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà. Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.
A dispetto delle apparenze, il verso libero non è una forma informe. In apparenza, è una forma di verso che, del verso tradizionale, mantiene solo il principio dell’a capo, senza regole interne, fornendo tuttavia ugualmente al componimento una scansione, per quanto irregolare. Nella sostanza, il verso libero non solo ha il più delle volte una matrice sintattica (come si capisce bene dal fatto che l’eventuale enjambement emerge benissimo pure nel verso libero), ma flirta anche inevitabilmente con varie forme metriche tradizionali, in primis l’endecasillabo (almeno nella poesia italiana).
Se si vanno a studiare le origini del verso libero, nella poesia di lingua inglese, da Blake a Whitman, ci si accorge che il verso libero non nasce dal niente. Blake e Whitman, per fare il loro gran passo, hanno inevitabilmente bisogno di una stampella, ovvero di qualcosa che possa ancora essere sentito come verso dai loro lettori pur facendo a meno della metrica tradizionale. Essi trovano così questa stampella nella Bibbia, e nell’andamento non dei suoi versi, ma dei suoi versetti, ritualmente consacrati da secoli di recitazione. Si tratta di un ideale ritorno alle origini, al testo mitico per eccellenza – del tutto coerente con il tono oracolare che contraddistingue la poesia di entrambi.
La poesia in versi liberi che li segue eredita precisamente questa tensione oracolare, pur temperandola a volte, modulandola, modificandola, però senza perderla mai del tutto. Non la può perdere del tutto, perché la tensione oracolare è implicita nell’uso di una formula che permette di isolare una proposizione o una sua parte, sino una parola, rendendola assoluta nel suo isolamento, senza nemmeno la giustificazione tradizionale del metro, senza la scusa della cantabilità. È la musica che è scomparsa, insomma, lasciando il posto al verso libero come scultura di parole, monumento alla clausola verbale. Il verso non è più una struttura del canto, come almeno formalmente continua a essere nella metrica tradizionale, anche quando la poesia nemmeno viene più letta a voce alta; il verso è una sorta di cornice, che rende icastico, oracolare, assoluto, ciò che contiene.
Questo è ciò che succede in linea di principio. Nella pratica poetica del Novecento sappiamo tuttavia come la metrica tradizionale rimanga ben viva, e come l’endecasillabo, per esempio, rappresenti il calco su cui molti versi liberi si trovano di fatto formati. Molti versi liberi, in altre parole, non sono veri e propri versi liberi: sono piuttosto una versione “liberata” dei metri tradizionali (endecasillabi ipermetri o ipometri, per esempio) che cerca di conciliare una certa cantabilità con una certa oracolarità, giocando a spostarsi ora più sull’uno ora più sull’altro dei due poli.
Alla fin dei conti, dunque, il verso libero non è propriamente un verso liberato, bensì un verso che a un tipo di gabbia ne sostituisce un’altra: non più la gabbia metrica, ma la gabbia dell’icasticità, dell’incorniciamento espressivo.
Si noti che prima dell’entrata in scena e della vittoria del verso libero, la poesia – anche quella italiana – stava già sperimentando strade diverse. E non è solo lo sperimentalismo sui versi latini o sui versi popolari di Carducci e di Pascoli (che è comunque un tentativo di mantenere la cantabilità modificandone le basi metriche – pur mantenendo, nella coincidenza tendenziale tra clausola metrica e clausola sintattica, una certa icasticità e oracolarità). È piuttosto il ricorrente ricorso all’enjambement di Foscolo e Leopardi, che della cantabilità conserva un’apparenza ancora più debole, ma che indebolisce pure la cornice del verso, proprio per il suo trapassare del discorso da un verso all’altro – il che rende impossibile isolarli davvero.
Probabilmente, questo uso insistito dell’enjambement esprimeva in quegli anni una tensione verso l’espressività che il metro tradizionale faticava a contenere; ma nel momento in cui il metro tradizionale viene poi sostituito dal verso libero, scompare anche questa tensione, che non ha più ragione di esistere là dove l’espressività può essere garantita, verso per verso, dal verso stesso. Questo è il prezzo che la poesia paga al verso libero: la coincidenza del verso con la clausola espressiva, senza l’attenuante musicale; l’asservimento del verso al discorso, all’espressione dell’io; la riduzione della poesia stessa a espressione dell’io, a lirica.
Chi comprende molto lucidamente la questione, nel mondo del verso libero, è Amelia Rosselli, mostrandolo nella pratica della sua poesia, ma anche in quel breve ma cruciale saggio del ’63, intitolato “Spazi metrici”, là dove dice: “In effetti nell’interrompere il verso anche lungo ad una qualsiasi terminazione di frase o ad una qualsiasi sconnessa parola, io isolavo la frase, rendendola significativa e forte, e isolavo la parola, rendendole la sua idealità, ma scindevo il mio corso di pensiero in strati ineguali e in significati sconnessi. L’idea non era più nel poema intero, a guisa di un momento di realtà nella mia mente, o partecipazione della mia mente ad una realtà, ma si straziava in scalinate lente, e rintracciabile era soltanto in fine, o da nessuna parte. L’aspetto grafico del poema influenzava l’impressione logica più che non il mezzo o veicolo del mio pensiero cioè la parola o la frase o il periodo”.
Proprio per evitare l’icasticità prodotta dal verso libero, e l’effetto oracolare che ne consegue, Amelia Rosselli inizia quindi a suddividere i versi in maniera apparentemente arbitraria (in realtà con una regola rigorosa, ma che impedisce che l’unità del discorso possa coincidere con quella del verso), facendo dell’enjambement un principio talmente pervasivo da vanificare l’idea stessa del verso come unità conclusa (pur provvisoriamente). In realtà, anche nell’artificio della Rosselli continua a giocare un principio musicale: non è più la cantabilità, nemmeno formalmente, ma è comunque un principio di costanza ritmica, di quantità prosodica ricorrente.
Se veramente il verso libero implica la lirica e l’espressione dell’io, e la metrica tradizionale implica la cantabilità tradizionale (almeno formalmente) con le sue belle forme che non ci rappresentano più (e i poeti neometricismi giocano proprio su questa ostentata e invalicabile distanza), allora la strada indicata da Amelia Rosselli potrebbe essere davvero l’unica praticabile per portare la poesia fuori dalla lirica, senza ricadere nella tradizione. Questo non vuol dire né che si debba per forza fare poesia come faceva lei, e nemmeno che si debba tagliare il verso come faceva lei; ma restano fondamentali, nel mio modo di vedere le cose, la sua messa in crisi del verso libero e il recupero di una qualche musicalità che non coincida con la cantabilità. La Bibbia, con tutto il suo innegabile fascino, ha fatto un’altra volta il suo tempo.
27 Marzo 2013 | Tags: Aldo Nove, Amelia Rosselli, Andrea Inglese, Elio Pagliarani, Gabriele Frasca, Gian Mario Villalta, Giovanna Frene, Giuliano Mesa, Ivan Fedeli, Lello Voce, Marco Giovenale, Mario Luzi, metrica, Patrizia Valduga, poesia, Sergio Rotino, Umberto Piersanti | Category: poesia | A che cosa serve l’artificiosità del vincolo che caratterizza la poesia nei confronti della prosa? Per quale ragione si coltiva così pervicacemente una forma di scrittura che si rifiuta di scorrere liberamente secondo l’andamento naturale del discorso?
Credo che la risposta debba essere cercata in un sospetto verso quella che potremmo chiamare la trasparenza della parola, ovvero l’idea che il discorso verbale debba essere considerato uno strumento di espressione del pensiero, tendenzialmente senza residui. A questa visione ideale della prosa – ideale perché in verità nemmeno la prosa più tecnica la raggiunge sino in fondo – la poesia contrappone una concezione della parola piuttosto come ambiente. In poesia la sequenza delle parole costruisce un piccolo mondo, i cui oggetti, come nel mondo reale, valgono sia per le loro proprietà fisiche che per quelle simboliche: un tavolo è un oggetto materiale, fatto di legno, metallo e plastica e in relazione spaziale con gli oggetti circostanti, non meno e non più di quanto esso sia il supporto per il rito del pranzo, il simbolo dell’unità famigliare, il ricordo della nonna a cui era appartenuto. Gli oggetti della poesia sono ovviamente le parole e le loro costruzioni, nella propria natura sonora e visiva (con tutte le loro complessità) non meno e non più di ciò per cui stanno (con tutta la complessità dell’universo del significato).
Nella misura in cui siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a un uso strumentale e trasparente della parola, la poesia cerca di restituirci una dimensione globale del linguaggio, in cui la parola riappaia come cosa simbolica e insieme materiale proprio come le altre cose del mondo. Il vincolo posto sulla dimensione del significante serve proprio a imporne la pertinenza, a togliergli ogni possibilità di trasparenza. L’artificiosità è necessaria proprio perché si fa notare. Quando non c’è nulla che si faccia notare non c’è infatti ragione di uscire dall’uso standard, quello assestato, banale: nel nostro caso, appunto, l’uso strumentale del linguaggio.
Riportare il linguaggio alla sua natura di cosa, di oggetto, non significa rivendicarne la naturalità. È per forza evidente che un costrutto linguistico è un manufatto, così come lo è un tavolo e come non lo è un albero. Che cosa resta al linguaggio se si prescinde dalla sua natura di strumento per comunicare idee? Credo che quello che resta sia proprio la sua natura di manufatto, e in particolare di manufatto collettivo: il linguaggio è…
 Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea. Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.
La rivista è comunque, come sempre, di grande interesse anche a prescindere dal mio personale intervento. Segnalo con piacere che mi ritrovo citato, al suo interno, anche negli interventi di Rodolfo Zucco (“Lettera su Bonifazio e Cella”) e di Vincenzo Bagnoli (“Endecasillabi in quattro quarti. Fra Dante e il Rock”).
BATTUTA DI CACCIA
Sono una battuta
di caccia queste ombre staccate
agli oggetti che le consolano, la loro sola
struttura possibile. Lo so
questo spiarmi mentre dormo, guardarmi
sotto le coperte: le vedo
tutte quelle mani senza impronte
infilarsi nella carne per scoprirmi
la bile fino al cuore. E dopo
il setaccio: ecco
si tirano tutte indietro
innocenti e tornano a contornare
le cose.
Il volume di Azzurra De Paola da cui sono tratti questi versi (e anche quelli riportati sotto) ha per titolo Benedizione per la bassa moltitudine (Le voci della luna, 2011) ed è dedicato ad Amelia Rosselli. Le è dedicato non per un debito stilistico (non in maniera evidente, almeno), ma perché si tratta di una lunga ripetuta meditazione sulla morte della Rosselli. Dai versi della Rosselli è tratto il titolo.
Amelia Rosselli parla in prima persona in questi versi, come se fosse un eroe tragico, uscito dal mito. Ed è così che ci appare, distillata nell’umanità della sua tragedia come un’Antigone, o un’Elettra; ogni componimento una diversa riflessione sulla difficoltà di vivere, sull’attrazione del salto nel vuoto. Non è tanto la poetessa Amelia Rosselli ad apparire qui, quanto la donna, l’essere umano, attraversata nella propria permanente condizione di tragedia.
Che tipo di verso si deve scegliere per raccontare liricamente una tragedia? Scegliere un verso tradizionale regolare, come l’endecasillabo, vorrebbe dire compiere un’operazione di distacco, vorrebbe dire mostrare le cose attraverso il velo della tradizione. Non si tratta necessariamente di una scelta sbagliata; ma sarebbe un’altra scelta, e certamente non è mai stata la scelta della Rosselli.
Il verso, qui, vuole restare il più aderente possibile all’espressione dell’angoscia; anzi, se possibile, deve amplificare quello che la sequenza sintattica esprimerebbe se fosse stesa in prosa. L’a capo deve mettere in evidenza le parole più forti, oppure spezzare le espressioni a rischio di frasi fatte, per ridare loro vita; oppure enfatizzare parallelismi; oppure isolare dal contesto intere espressioni…
Non si possono utilizzare, per i medesimi motivi, vere rime a fine verso. Assonanze, consonanze, e soprattutto allitterazioni, meglio se lontane dalla sede forte di fine verso, e quindi più irregolarmente dislocate, possono ugualmente costruire un tessuto musicale, una rete di ricorrenze. Sono un segnale di poeticità, di appartenenza al linguaggio; ma si impongono con sufficiente discrezione. Anzi, sono spesso l’occasione per richiamare o suggerire foneticamente dei legami narrativi.
La ripetuta allitterazione sulle liquide (l ed r) e sulla s al verso 3 di “Battuta di caccia” (che le consolano, la loro sola) viene raccolta dalla paronomasia con cui si chiude il verso 4 (Lo so), che a sua volta apre, sintatticamente, la spiegazione dell’incubo – rallentata a sua volta dallo spazio bianco dell’interlinea del cambio di strofa. (Si chiamano ancora strofe, queste, perché non abbiamo un altro modo per chiamarle; ma quello che conta davvero qui non è l’unità dei versi che le compone, bensì la spezzatura che le separa dalla precedente e dalla successiva).
E poi i versi 5 e 6 sono ritmicamente irregolari, segnati dagli enjambement, volutamente quasi-prosastici, così che l’isolamento in cui si trova posto il verso 7 (anticipato dal le vedo che riprende il lo so della strofa precedente) ne metta in evidenza l’ossessiva struttura giambica (tùtte quélle màni sènz’imprónte, accenti sulle sillabe 1, 3, 5, 7 e 9), che corrisponde al momento della contemplazione ossessiva e protratta delle figure del male. Queste figure del male si rimettono poi in moto nel verso successivo, ugualmente giambico ma dinamizzato dalla divisione in tre gruppi di quattro sillabe (ìnfilàrsi | nélla càrne | pér scoprìrmi – in neretto gli accenti forti, in corsivo quelli deboli) e sfociano di nuovo, proseguendo, in una struttura meno definita (molto debolmente trocaica), di nuovo tendente alla prosa.
Regolarità e irregolarità metrica sono perciò qui altrettanti espedienti narrativi, volti a enfatizzare in vario modo, o ad abbassare il tono, o a modificarlo di colpo. Il verso è ciò che rende possibili questi effetti, rimanendo comunque, anche nella sua variabilità, una misura del respiro. Anzi essendolo tanto di più in questa sede, dove il respiro della voce narrante (la stessa Rosselli, nella finzione narrativa) vuole essere rotto dall’angoscia, vuole essere tragico.
È singolare come nella poesia dell’ultimo secolo e mezzo una figura come il verso, che è tradizionalmente stata una figura di mediazione, di presa di distanza, nei confronti della cruda espressività delle emozioni forti, sia finita per diventare spesso una figura a sua volta espressiva. La natura scritta della nostra poesia garantisce l’immediata riconoscibilità del verso (così non era per gli antichi); e quindi il verso può rimanere un’unità formale anche là dove questo non sia evidente all’orecchio. Sarà poi compito del rapsodo moderno quello di riuscire a far sentire ugualmente questa unità – ma non è detto che ci possa riuscire davvero: la cesura di fine verso va certamente fatta sentire in qualche modo; ma come fa l’ascoltatore che non vede il testo scritto a distinguerla dalle cesure sintattiche o espressive di altro tipo?
Il verso libero permette alla modulazione della lunghezza del verso di farsi elemento fortemente espressivo, giocando pure, se si vuole, sulla maggiore o minore regolarità prosodica al suo interno. In questo modo, la scansione dei versi si trasforma in un sistema sintattico ulteriore, che si affianca a quello vero e proprio, ora assecondandolo, ora contrapponendovisi. Abbiamo così due modalità diverse di gestione del respiro: il verso, che dovrebbe esprimere un respiro, e la punteggiatura che dovrebbe suggerire a sua volta le possibili modulazioni della presa di fiato.
Questa complessità di respirazione si presta bene a esprimere quella dell’angoscia, che anche è complessa e difficile. Eppure è proprio la scansione dei versi, che di questa complessità fa parte, a permettere che si conservi comunque un senso ritmico, una dimensione ancora sotterraneamente rituale. Raccontare in versi l’agonia della Rosselli vuol dire comunque celebrare il rito che la ricorda, che la rende presente – come si poteva fare, a suo tempo, a Epidauro celebrando l’agonia di Cassandra, o quella di Ifigenia.
DISSENSO PRIVATO
Si deve
dissossare il pensiero – comprendere
per sottrazione e togliere
tutte le parti iniziando
dalla pelle.
Pianificare un olocausto
del senso del pudore e poi l’angoscia
e togliere anche questi
al computo finale.
Sottrarre all’amore il tarlo del proibito.
E resta
un’impalcatura vuota, un mucchio
di costole a scaffali
e da una parte all’altra il vuoto
purissimo del corpo.
Nonostante le apparenze, questo non è un post (solo) sulla poesia. Ecco dunque queste apparenze.
Ci sono due eventi all’origine delle riflessioni che sto per esporre. Intanto, mi sono arrivate le bozze del mio libro sulla poesia (Il linguaggio della poesia, Bompiani – ne ho anticipato qualcosa qui), e nel correggerle mi si sono inevitabilmente scatenate varie riflessioni. L’altro è la segnalazione di un sonetto di Gongora (grande poeta spagnolo del Seicento), da parte di un’amica ispanista che mi ha promesso un riferimento più preciso di quello che ricordava a memoria e che, a quando ho capito, per parlare di una bellezza imperfetta, concluderebbe la sua sequenza con un endecasillabo eccedente e sgraziato, un po’ a modello di ciò di cui sta parlando.
Mentre sono in attesa del riferimento preciso, per leggermi davvero il sonetto, non posso fare a meno di pensare che l’uso di un verso a-metrico non fa certo di Gongora un precursore del verso libero. Anzi, se le cose stanno come ho capito, il verso “sbagliato” di Gongora deve la sua efficacia locale proprio al contesto in cui si trova, all’allusione che produce, e alla sostanziale validità del principio metrico: insomma, è la classica eccezione che conferma la regola, mettendola in evidenza proprio con il suo occasionale scarto.
Dunque, sinché lo scarto è occasionale, esso contribuisce a rafforzare la regola – ma quando comincia a diventare a sua volta regola, la nuova regola scaccia quella vecchia. E il verso libero vero e proprio non è in nessun senso una conferma della metrica tradizionale.
Nel mio libro sostengo, tra le altre cose, che la metrica tradizionale rappresenta un quadro regolare, sicuro e confortante, attraverso cui possono essere trasmessi anche i significati più inquietanti o spaventosi, rendendoli accettabili. Sono accettabili, in questi casi, perché la regolarità metrica funziona come metafora (o persino come locale implementazione) dell’ordine imposto dall’uomo alla natura selvaggia (ivi compresa quella, interiore, dei sentimenti). Il quadro regolare e assestato del sonetto, per esempio, fa da cornice, e rende più facilmente accettabili sin la disperazione e la tragedia, quando emergono. Proprio come gli elementi di antropizzazione del paesaggio, o il riconoscimento di una struttura narrativa in una situazione di angoscia incontrollata (e il mestiere degli psicoanalisti è fatto anche del saperla fare emergere dal caos mentale del paziente).
Così, possiamo pensare la metrica tradizionale come il corrispondente in poesia delle strutture sociali tradizionali – quelle al cui interno abbiamo vissuto per secoli, al riparo dagli eccessi della natura, esterna o interna a noi. Da questo punto di vista il sonetto di Gongora (così come me lo sto immaginando) non viola nulla: quello che fa è semplicemente giocare sul principio, suggerendo che l’imperfezione del suo oggetto possa riflettersi persino in un’imperfezione dell’ordine umano delle cose.
Ma il verso libero è un’altra cosa. Nel mio libro suggerisco che l’uscita dalle strette del metro permetta alla disperazione e alla tragedia (o a quant’altro) di esprimersi in maniera più diretta ed efficace, perché la cornice in cui vengono inserite è più leggera e meno distanziante. In altre parole, una poesia in versi liberi rimanderebbe molto meno (ma in qualche modo deve continuare a farlo) all’ordine umano e sociale imposto alla natura; e in questo modo ridurrebbe la distanza nei confronti del proprio oggetto emotivo, rendendolo più vivido ed efficace.
Continuo a pensarla così (nel libro tutto questo viene spiegato molto più ampiamente), ma ho la sensazione che ci sia dell’altro.
Il punto è che la poesia in versi libero non esclude il metro. Semmai, quello che è accaduto è che a una serie di strutture metriche (all’incirca) stabili da secoli si cerca di sostituire delle strutture nuove, adatte alla situazione espressiva particolare. Ma se la metafora (o locale implementazione) di cui parlavamo sopra resta valida, questo tentativo dovrebbe corrispondere anche a un tentativo di costruire strutture sociali nuove. È certamente un tentativo presuntuoso, ma è proprio quello che la modernità ha cercato di portare avanti, timidamente nel corso dell’Ottocento e poi molto più spavaldamente nel Novecento, sino alle utopie razionaliste del comunismo sovietico, che ha sognato di ricostruire l’ordine sociale da zero, coi risultati che sappiamo.
Senza arrivare a questi estremi, mi sembra comunque che il verso libero sia figlio della stessa presunzione che ci fa pensare di poter essere davvero i capitani della nostra stessa società e delle nostre vite, capaci di sottomettere tutto a un nuovo ordine, razionalmente fondato. Non è un’idea campata in aria, e soprattutto è l’idea dentro cui viviamo, ma ancora non sappiamo se sia destinata ad avere successo sul lungo termine, e in che misura andrà eventualmente emendata per poter funzionare a lungo. Rispetto alle società tradizionali, che funzionavano così perché si basavano su un ordine che, giusto o ingiusto che fosse, era validato da secoli o millenni di sopravvivenza, la nostra società pretende di sapersi progettare in termini nuovi, e magari anche più giusti. Allo stesso modo lo pretende la poesia moderna, che ha abbandonato le certezze dell’organizzazione assestata da secoli a favore delle incertezze del progetto.
Il punto non è, a questo punto, se il passato sia meglio del presente, o viceversa. Questo sarebbe oggi un problema unicamente virtuale, perché al punto in cui siamo non c’è possibilità di ritorno (se non attraverso una certo non auspicabile catastrofe). Nell’ambito ristretto del metro, non basta affatto recuperare la metrica tradizionale per ripristinare la situazione precedente. Oggi come oggi, dopo un secolo di intensivo verso libero (e a due secoli e passa dalla sua nascita), l’endecasillabo, per esempio, appare una possibilità come un’altra, e non come un obbligo. I poeti cosiddetti neo-metricisti non stanno riproponendo il passato, ma soltanto avanzando un progetto tra i tanti, magari profumato di classicismo, ma niente di più. Se anche una volta l’endecasillabo si contrapponeva (statisticamente vincente) ad altri metri ugualmente canonici, inevitabilmente in numero limitato, tra i quali era giocoforza scegliere, oggi l’endecasillabo non è che una scelta tra innumerevoli potenzialità progettuali per il quadro di riferimento.
La poesia, alla fin fine, socialmente ne patisce – ma non perché i poeti di oggi siano meno capaci di quelli di ieri (e certamente, oltretutto, ci rappresentano di più). È semmai perché quella funzione di conforto, di sostegno all’ordine umano e riconosciuto delle cose, non è più possibile – ed è passata, sostanzialmente, ad altre modalità di espressione. Nel leggere una poesia dell’ultimo secolo non posso contare su un quadro di sfondo condiviso: persino la presenza di un simile quadro (o la possibilità di condividerlo) va verificata caso per caso. È naturale che la situazione venga sentita come enormemente più complicata di prima: non solo sono scomparse le certezze, ma ciascuno ha il diritto di suggerire le proprie. Meraviglioso! e insieme devastante. Non ne possiamo fare a meno, perché ciò che non è così non ci rappresenta; ma questo non è necessariamente positivo.
Ancora un’osservazione: non sto parlando delle avanguardie, degli esperimenti estremi. Quello che ho detto vale per Sandro Penna come per Nanni Balestrini. E siccome, nonostante le apparenze, non sto parlando solo di poesia, vale per Frank Miller come per Lorenzo Mattotti o Chris Ware; con il vantaggio (o lo svantaggio) per il mondo del fumetto, di non avere secoli di tradizione regolatrice alle spalle, essendo nato già in un mondo orientato più al progetto che alla tradizione. Ma, di questo, in qualche prossimo post.
14 Settembre 2011 | Tags: Dante Alighieri, metrica, poesia, verso | Category: poesia | Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte.
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Permettetemi qualche riflessione vissuta da autore, senza pretesa di confrontarmi con uno con cui qualsiasi confronto è perdente, ma nell’ipotesi di poter sentire, almeno un minimo, alcune cose come lui. Però mi sembra di aver visto qualcosa, in questi versi di avvio della Commedia, che non ho letto da nessuna parte. D’altra parte, non essendo un dantista, può benissimo trattarsi di ignoranza mia. Nel qual caso, se vi è noto qualche approccio simile a questo mio, vi prego di segnalarmelo.
Dico riflessione da autore perché le osservazioni che vado a fare su questi versi derivano da mie specifiche considerazioni sulla scrittura dei versi – e riguardano quasi esclusivamente metrica e prosodia.
Ho bisogno di fare una piccola premessa sull’endecasillabo, il verso della Commedia e il verso principe della poesia italiana. Ci insegnano i manuali di metrica che l’endecasillabo, pur non essendo davvero un verso composto, è tuttavia costituito di due parti: un settenario seguito da un quinario nella versione cosiddetta a majore (accento forte sulla sesta sillaba), oppure un quinario seguito da un settenario nella versione a minore (accento forte sulla quarta). L’endecasillabo non è veramente un verso composto perché 7+5 (come 5+7) fa 12 e non 11, e le condizioni per cui siano davvero leggibili sia il settenerio che il quinario sono particolari e non sempre presenti.
Non sono presenti certamente quando l’endecasillabo non è canonico, ovvero non presenta accento né sulla quarta né sulla sesta sillaba. L’endecasillabo non canonico è raro in Dante come pure in generale nella poesia italiana, perché con facilità suona poco musicale al nostro orecchio.
Al contrario, le condizioni sono effettivamente presenti quando il primo emiverso (settenario o quinario che sia) è tronco, e ha di conseguenza una sillaba in meno, lasciando la sillaba libera a completare il secondo. I primi tre versi della Commedia sono di questo tipo. Per intenderci, chiamerò qui questo tipo di endecasillabo fortemente composto, o anche solo composto (nelle versioni, rispettivamente, a majore e a minore).
C’è un altro modo per far sì che 7+5 (o 5+7) possa fare 11, ed è la sinalefe sulla settima (o sulla quinta) sillaba. Per esempio, nel verso 5 del nostro esempio, la “e” dopo “selvaggia” fa sinalefe con la vocale che la precede, e quindi viene inglobata nella medesima (settima) sillaba. Questo è un modo molto debole per ottenere il verso composto, perché per far sentire l’andamento dell’endecasillabo dovremo far sentire anche la sinalefe, e ridurre di fatto il conto del secondo emiverso a quattro (o sei, se a minore) sillabe. Ma la lettura separata (come se la sinalefe non ci fosse) non è completamente esclusa, e può ritornare ad aver senso in qualche caso. Chiamerò perciò qui questo tipo di endecasillabo debolmente composto.
Chiamerò infine non composto ogni endecasillabo canonico in cui non sia possibile percepire entrambi gli emiversi come settenario e quinario, come succede, per esempio, nei versi 7 e 9 riportati qui sopra (tra “poco” ed “è” c’è dialefe, e “cose” e “ch’i'” sono chiaramente separati).
Il particolare andamento dei versi di Dante riportati sopra non dipende, mi pare, solo dalla distribuzione degli accenti, ma anche dalla loro natura composta o non composta. Per verificarlo, ecco un piccolo esperimento: modificherò i versi 1-3 con alcune piccole sostituzioni, che ne rispettino grosso modo il senso (che comunque non è in gioco in questo discorso), e ne mantengano lo schema di accenti (per il verso 2 dovrò introdurre una voce verbale che non esiste, facendo finta che esista, perché non trovo in italiano un’alternativa sensata che regga alle mie condizioni). Ecco dunque:
Nel mezzo del cammino della vita
mi ritrovetti in una selva oscura,
ché la diritta strada era smarrita.
Anche senza prendere in considerazione il senso leggermente mutato, e nonostante il sistema degli accenti di questi versi sia esattamente lo stesso di quelli originali, essi suonano al mio orecchio molto meno melodiosi di quelli veri. Credo che il punto stia nella perdita della sospensione che gli endecasillabi fortemente composti manifestano in concomitanza della cesura dopo la sesta o la quarta sillaba, nelle versioni rispettivamente a majore e a minore. Nella mia versione alterata i versi sono diventati non composti (1) o debolmente composti (2 e 3), e la cesura è scomparsa.
Con la scomparsa della cesura si viene ad affievolire anche la differenza tra l’endecasillabo a majore e quello a minore:tutti e tre i versi portano infatti accenti sia sulla quarta che sulla sesta sillaba, e possono essere perciò letti in ambedue i modi. Tuttavia, nell’originale dantesco, la natura fortemente composta dei versi permette di sentire chiaramente la cesura, che si trova dopo la sesta sillaba nei versi 1 e 3, e dopo la quarta nel verso 2. Da questo punto di vista, dunque, la terzina propone la medesima struttura ABA che si trova anche nella rima, secondo la successione: proposta-variante-ripresa. Aggiungiamo che le sillabe accentate messe in evidenza dal troncamento contengono nei versi 1 e 3 la stessa vocale “i” della rima finale, mentre è diversa quella del verso centrale – e anche questo contribuisce a rafforzare la struttura della ripresa.
Considerando le cose in questo modo, ecco come sono organizzati questi primi dodici versi:
A majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore fortemente composto)
a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a majore non composto)
a majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore non composto)
A majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore debolmente composto
a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
A majore non composto (ma anche leggibile come a minore non composto)
a minore fortemente composto (ma anche leggibile come a majore fortemente composto)
a majore non composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
A majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
Eccetto il verso 5, tutti gli altri portano accenti sia su quarta che su sesta sillaba, con generalizzato ritmo dunque giambico, e seconda diversa lettura possibile. Tra l’altro, è interessante osservare come la rottura del ritmo giambico cada sulla forte paronomasia di “esta selva selvaggia”, e si situi in un verso interno della terzina, sempre a conferma della struttura ABA riconosciuta sopra.
La struttura ABA è dunque presente in tutte e quattro le terzine in esame, ma cambiano gli elementi di diversificazione: nella prima terzina è il rapporto a majore/a minore; nella seconda è la presenza/assenza del ritmo giambico (o l’assenza/presenza della paronomasia); nella terza è la natura non composta/composta, insieme al rapporto a majore/a minore; nella quarta la natura fortemente/debolmente composta.
La varietà di ritmi si trova dunque organizzata in schemi di ricorrenze, che non riguardano solo le singole terzine al proprio interno: la prima e la terza terzina, per esempio, sono entrambe caratterizzate da una comune alternanza di endecasillabi a majore e a minore, anche se la terza introduce un’ulteriore differenziazione. Ma la prima e la terza terzina sono avvicinate anche dalla comune opposizione alla seconda, che gioca sulla presenza di un cambiamento assai più forte degli accenti al suo centro.
Se ora mettiamo in ordine i versi in cui è presente il momento di sospensione determinato dalla cesura (endecasillabi composti), otteniamo questo schema (che include anche alcune terzine successive, sino al verso 36):
+++ –+ -+- +-+ +– -++ -++ ++- +-+ -+- — +-+.
Versi non giambici oltre al 5 sono il 15, 20, 22, 25, 29, 32, 33, ottenendo lo schema:
+++ +-+ +++ +++ ++- +++ +-+ -++ -++ +-+ +– +++. I versi con ritmo non giambico si fanno più frequenti dopo le prime terzine, e perdono in parte la forza accentuativa dovuta alla loro particolarità.
A partire dalla quinta terzina la struttura ABA non si presenta più così stabilmente, e il gioco (come si vede anche dagli schemi qui sopra) diventa più irregolare. Ma con la quinta terzina incomincia anche la narrazione vera e propria e si è già concluso questa sorta di piccolo prologo, che ha avuto anche la funzione di impostare gli andamenti ritmici. A questo punto il lettore è già entrato nel gioco delle sospensioni e dei rilassamenti, del ritmo accentuativo standard (giambico) e delle sue rotture, delle varie alternanze tra a majore e a minore. L’endecasillabo si è mostrato nelle sue tre facce (endecasillabo indivisibile, settenario e quinario) e nelle loro possibili combinazioni. La varietà metrica è stata esibita, ma anche il quadro in cui può essere comunque organizzata.
 Amelia Rosselli, frammento da "La libellula (Panegirico della libertà)", 1958 Ho iniziato ad amare la poesia di Amelia Rosselli quando ho scoperto questi versi. Li trovavo insieme irritanti e impossibili da abbandonare con gli occhi, impossibili da abbandonare con la mia voce interiore che li recitava mentre li leggevo con gli occhi. Trovavo insieme eccessivo a avvolgente il riferimento ossessivo ai versi de “La chimera” di Dino Campana. Io che faccio fatica a leggere componimenti poetici che superino le due pagine, qui mi ritrovavo come inglobato in questa struttura vischiosa, forse complessivamente insensata, ma così continuamente piena di echi, di riferimenti, di richiami anche a strutture poetiche e narrative ben note (ma qui destinati a essere trattati allo stesso modo dei versi di Campana).
I versi di Campana sono quelli che iniziano così:
Non so se tra rocce il tuo pallido
Viso m’apparve, o sorriso
Di lontananze ignote
Fosti, la china eburnea
Fronte fulgente o giovine
Suora de la Gioconda:
O delle primavere
Spente, per i tuoi mitici pallori
O Regina o Regina adolescente…
Da Campana, la Rosselli non mutua solo alcune parole, ma anche una tecnica basata sulla ripetizione ossessiva, sul ritorno insistente di parole, di suoni, di formule sintattiche. Tuttavia, mentre in Campana questa insistenza assume la consistenza del favoloso, del fantastico, del meraviglioso (Montevideo, la Pampa, La Verna, Genova, la notte…), l’ossessione della Rosselli sembra quella di un’anima prigioniera di un pensiero fisso, dove tutto ciò che si può pensare non fa che tornare lì, sempre lì, senza uscita. Campana, se vogliamo, era prigioniero della sua libertà, incapace di non fuggire, di non immergersi nel suo epos – che per noi, suoi lettori, non è, in fin dei conti, che un epos letterario. E in questo modo sembra viverlo e recuperarlo anche la Rosselli stessa, perché di quell’epos sono rimaste soltanto le parole e il loro andamento a spirale, il loro sviluppo in realtà lentissimo o impossibile: non sai mai dove questo eterno quasi-ritorno ti stia in verità portando, proprio come se, girando in quasi-cerchio, con minime variazioni a ogni giro, dovessimo dire in che direzione ci stiamo complessivamente muovendo.
Si scoprono cose interessanti sulla poesia della Rosselli se si va un po’ più a fondo sul metro di questi versi. Non c’è qui una misura regolare né quanto a sillabe né quanto ad accenti. Non c’è nemmeno un’accentazione regolare come succede per esempio nelle ossessioni in versi liberi di Campana. A differenza della gran parte dei versi liberi del Novecento, non c’è nemmeno un verso su base sintattica, di matrice biblica, come quello che Campana aveva assunto da Whitman. L’enjambement è talmente frequente da essere la norma nei versi della Rosselli di quegli anni, e in queste condizioni di verso così debolmente definito la divisione di clausole sintattiche unitarie tra versi differenti non suona nemmeno come un enjambement. Tutto, insomma, sembra contribuire a configurare questi come dei non-versi.
Perché allora la Rosselli non scrive in prosa? A che cosa servono dei versi che non conservano nulla del verso? Proprio questa operazione straniante ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra il verso e la sintassi. Nella poesia tradizionale, in metrica, quella dove l’enjambement è un fatto raro e notevole, c’è sempre una certa coincidenza tra l’organizzazione metrica e quella sintattica. Poiché l’organizzazione metrica rappresenta l’elemento più musicale della poesia, mentre quella sintattica è legata al senso linguistico, questa coincidenza ha il senso della messa in musica di parole che esprimono un pensiero, una sorta di legame tracciato tra la dimensione rituale del ritmo e quella individuale/interpersonale del discorso. Legandosi al metro, la sintassi ci permette di sentire il senso come un fatto musicale, e l’agire interpersonale del discorso come un fatto collettivo e compartecipativo. Finché le parole della poesia erano fatte per essere messe in musica, la fine del verso era anche una (provvisoria) fine della clausola del senso, il luogo ideale dove respirare; e il verso diventava la figura verbo-orale del respiro.
L’enjambement rompe questa unità logico-ritmica, mettendo in evidenza l’arbitrarietà della loro giunzione. L’effetto di sottolineatura, che le clausole sintattiche interrotte dal cambio di verso ottengono, è funzionale al discorso; e rappresenta un modo, di dare rilievo a certe espressioni, che solo la poesia possiede, perché ha origine dall’infrazione di una regolarità che la prosa, per sua natura, non ha.
Se l’enjambement si diffonde troppo, però, il gioco smette di funzionare. Funziona ancora, e splendidamente, nei sonetti di Foscolo, perché il verso è così nitidamente definito come endecasillabo, e la struttura tradizionale del componimento così familiare alle orecchie dei lettori, che le sue infrazioni emergono come tali, e ottengono una grande forza. Già nella canzone leopardiana l’effetto è più debole, perché la struttura è in sé più libera, e quindi meno definita e meno familiare. Quando si impone il verso libero, la clausola sintattica prende nuovamente il sopravvento, in qualità di nuova misura del verso, sostituendosi alla regolarità delle quantità delle sillabe (o quant’altro sia la regola nella tradizione di riferimento): ma questa nuova misura è più debole della vecchia. Per questo l’enjambement va usato nel verso libero con ancora maggiore parsimonia, pena il rischio di distruggere l’effetto metrico pericolosamente ricostruito.
La Rosselli non ci sta, però, nemmeno a questo gioco. I suoi sono non-versi perché rifiutano persino la sintassi come base neo-metrica del verso. Lei si è accorta, io credo, che il verso, comunque sia costruito, costituisce una sorta di cornice, e le cornici sono quegli apparati che servono per distanziare le figure incorniciate, dichiarandole figure non del mondo, ma della sua rappresentazione – e quindi il prodotto di un discorso sul mondo. L’operazione della Rosselli, in altre parole, ha qualcosa di simile a quella che un grafico compie quando fa stampare un’immagine al vivo, ovvero facendola tagliare dal bordo stesso della pagina, senza margine bianco attorno. Un’immagine al vivo appare più vivida al fruitore perché sembra in qualche modo uscire dalla pagina stessa. Non è che si sia davvero eliminata la cornice, perché è inevitabile che un’immagine abbia un bordo; però si è eliminata quella cosa che convenzionalmente consideriamo la cornice; e il taglio del bordo-pagina assomiglia a quello del margine di una finestra attraverso cui vediamo il mondo. Insomma, si suggerisce che l’immagine al vivo non possieda che quella stessa cornice che può avere una scena reale vista attraverso una finestra; una cornice ben diversa da quella distanziante del quadro. Insomma, ciò che sta dentro il quadro di una finestra appartiene allo stesso mondo a cui appartiene la finestra stessa e noi; è solo un po’ più in là – ma non è rappresentazione.
Se la Rosselli scrivesse in prosa non otterrebbe dunque questo effetto al vivo, perché non potrebbe giocare sull’ostentazione dell’assenza della struttura tradizionale del verso. Solo costruendo dei versi che sono non-versi lo si può fare.
Ecco di conseguenza questo effetto di presa diretta, di estrema non mediatezza che viene prodotta in questo modo dalle parole della Rosselli. Ma non è un flusso di coscienza banale quello che si presenta qui. La presenza del non-verso non è sufficiente di per sé a far percepire questa al lettore come poesia. Anzi, avendo annullato il verso, è necessario rafforzare la sensazione di poesia attraverso altri strumenti. Ecco, quindi, a cosa servono la ripetizione e il riferimento a Campana (e non solo a lui, in altre sezioni del poemetto). La ripetizione ossessiva, il ritorno delle formule e dei suoni e dei ritmi prosodici, sono tutti elementi immediatamente riconoscibili come poetici, attraverso cui il lettore può riconoscere il contesto, sentire questo flusso di parole come autentica poesia.
A questo punto, tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso. L’occultamento della cornice ha portato il flusso di coscienza dell’autore in primo piano, come se non fosse una rappresentazione, ma il suo stesso diretto grido di ansia; eppure questo stesso occultamento viene con evidenza prodotto attraverso l’enfatizzazione di una serie di procedimenti di carattere chiaramente letterario, e quindi dichiaratamente artificiosi. Lo stesso grido di ansia a cui ci viene dato l’accesso diretto, senza la mediazione della cornice, è un oggetto letterario, pieno di figure retoriche utilizzate con ostentazione.
Insomma, è come se la Rosselli volesse comunque ostentare il fatto di essere una poetessa, e dunque una letterata, e quindi qualcuno che non può che esprimersi attraverso quella lingua lì, la lingua della letteratura e della poesia – e tuttavia quella lingua lì può essere, insieme, anche una lingua estremamente spontanea e diretta, non mediata. Se quella che vediamo in questi versi è la voce ossessiva della sua stessa anima, senza la cornice del verso tradizionale, quella voce si è costruita essa stessa all’interno della parola poetica, e la parola poetica medesima è la sua epressione vera, spontanea, non mediata, costruita intimamente dalla musica del verso perché la musica del verso non è qualcosa che si aggiunga alla parola, ma la parola stessa è già nata in noi (in lei) originariamente intrisa di quella musica, nella sua sintassi, nei suoi accenti e nei suoi significati.
La Rosselli riesce insomma, qui come in tante altre poesie, a restituire un senso profondo all’esperienza dell’espressione letteraria, interiorizzandone in qualche modo la cornice, con questa forma di iper-lirica, dichiarandosi lei stessa in qualche modo letteratura, o almeno costruita dalla letteratura, costruita dai racconti letterari, e specialmente da quelli poetici, e dalle loro parole e dalla loro sintassi e dal loro suono. La Rosselli paga questo successo lirico ponendo se stessa come un altro caso della sovrapposizione tra letteratura e vita; una sovrapposizione da cui la letteratura ha, indubbiamente, ancora oggi, molto da guadagnare. Ma la vita?
Dopo ancora, se tutto va bene, ce ne sarà un’altro sul fumetto; ma il mio prossimo libro, in uscita da Bompiani intorno a novembre, avrà probabilmente come titolo Il linguaggio della poesia.
Questa è un’anticipazione. Il libro è già in fase di editing presso l’editore. Nei prossimi mesi ne dirò qualcosa di più. Per adesso, ecco il comunicato stampa:
Il linguaggio della poesia si rivolge, in maniera divulgativa, a un pubblico ampio. Ma propone un modo diverso di guardare al fenomeno poetico, attraverso lo sviluppo di una nozione di ritmo che non riguarda soltanto i fenomeni dell’universo sonoro (metro, accenti, rime…) ma anche l’ambito del significato. La poesia costruisce infatti un percorso, che è insieme di suono e di senso (e in qualche caso anche di visione), lungo il quale il lettore viene condotto; ed è inevitabilmente, per questo, un percorso emotivo, che ha qualche aspetto in comune con i percorsi dell’ascolto musicale. Le nozioni di base indispensabili per la comprensione del linguaggio poetico vengono dunque spiegate con maggiore chiarezza in questa prospettiva, dal metro alle figure retoriche, al rapporto tra verso e sintassi, alle simmetrie e agli sviluppi del suono e del discorso, al fascino dell’iterazione e della variazione.
Per gli insegnanti, il volume riprende e sviluppa con maggiore ampiezza una serie di temi presenti nelle due antologie scolastiche a cui l’autore ha contribuito per la sezione poesia: Segnalibro e Dietro le parole (Bompiani Scuola).
Penso che chi segue questo blog se lo aspettasse, prima o poi.
Sarà per le radici musicali comuni, che rendevano una volta poesia e canzone solo due facce diverse di uno stesso linguaggio (e vedi come se ne discute su Absoluteville anche – e non solo – nelle rubriche di Stefano La Via e di Rosaria Lo Russo) ma sarà anche per la separazione netta che la storia ha poi sancito tra loro. Sarà per questo e probabilmente pure per altro, ma se mi venisse chiesto a bruciapelo che cos’è il verso in poesia, mi verrebbe da rispondere che si tratta della versione stilizzata (ritualizzata) del respiro.
Nelle canzoni – è facile – il verso è direttamente l’estensione del respiro, anche quando chi canta non tira davvero il fiato tra un verso e l’altro; ed è così per ragioni fisiologico-musicali di cantabilità. Ma in poesia la componente di stilizzazione non è meno importante del richiamo al respiro stesso. Da diversi secoli a questa parte, la poesia esiste anche senza che nessuno la declami, quando la percorriamo con gli occhi ed è solo una voce interiore stilizzata a renderne per noi i suoni. (Se manca pure la voce interiore, e leggiamo unicamente con gli occhi, allora o quello che leggiamo non è poesia, oppure non sappiamo davvero leggere la poesia, e il verso non è che un disturbo visivo alla continuità della lettura.)
Il principio del respiro stilizzato (che l’eventuale declamazione dovrebbe in qualche modo rendere acusticamente, riavvicinando – almeno rispetto a questo – la poesia alla canzone) è ciò che dà senso al verso libero. Nella poesia che fa uso del verso libero, secondo la proposta già di William Blake, quando scriveva Jerusalem intorno al 1804, ogni verso ha un respiro differente, adatto alle sue specifiche necessità espressive (qualche idea sul come si va a capo in poesia l’avevo già presentata qualche mese fa in questo post).
Ma allora quello che dovremmo chiarire ora è: che differenza c’è tra usare versi lunghi e usare versi brevi? Oppure, in altre parole: in che cosa è diverso il respiro lungo da quello breve? E come si collega la problematica della lunghezza del verso con quella della lunghezza della proposizione o del periodo? E poi: che differenza si produce tra il fare uso del verso libero, e il sottoporre i versi a un qualche tipo di regolarità (che sia sillabico-accentuativa come nella tradizione italiana, o magari solo accentuativa come in quella germanica, o solo sillabica come in quella francese, o qualsiasi altra purché percepibile)? E infine: perché si usano (o si evitano) i versi canonici?
È un po’ di tempo che sto provando, nei miei esperimenti poetici, a fare uso di un verso non canonico relativamente breve, un ottosillabo alla spagnola, senza gli accenti fissi di quello italiano (qualche esempio si può leggere qui, qui o qui). Ultimamente ho invece cercato di sperimentare un modello diverso, basato su un verso molto lungo, con un andamento cantilenante caratterizzato da quattro o cinque accenti e un numero variabile di sillabe – che non è però un vero verso libero, perché la percezione alla lettura è comunque di una certa uniformità ritmica da un verso all’altro (un esempio qui, e un altro qui).
L’ottosillabo è stato per me una scoperta importante (ne ho già parlato qui) perché mi ha permesso di costruire delle strutture poetiche con respiro fisso ma senza il richiamo ad andamenti prosodici già troppo presenti nelle orecchie del lettore italiano – come sarebbe, per esempio, quello del settenario, appena differente in apparenza, ma in realtà sancito da secoli di tradizione. La (relativa) brevità dell’ottosillabo, aggiunta alla sua regolarità sillabica, permette di costruire delle strutture sufficientemente ossessive; mentre l’irregolarità degli accenti ne permette un uso narrativo, evitando l’effetto filastrocca tanto caro a Pascoli. Questa combinazione tra formalità (e ripetitività) rituale (e ritmica) da un lato, e varietà sintattica e narrativa dall’altro, è – per me – quello che fa l’essenza della poesia, mettendo in comunicazione il nuovo con il già noto e viceversa, ovvero la comunicazione riguardo al mondo (esteriore ed interiore) con le nostre strutture assestate personali, sociali e naturali.
Certo, non è che la ripetitività stia solo dalla parte del metro e la novità solo da quella del racconto. La poesia è qualcosa di molto più complicato di così – ma in qualche caso può trovarsi anche ridotta a questo. D’altra parte, l’adozione di un ottosillabo ad accenti variabili comporta un innesto di variabilità (e quindi di novità) anche nel metro stesso – e si può bene, d’altro canto, giocare di ricorrenze sintattiche o anche narrative…
Passare, nella scrittura, da un verso breve a un verso molto lungo significa per me prima di tutto abbassare il livello di ansietà, di tensione ritmica di base. È come abbandonare il respiro affannoso della corsa o della marcia per quello lungo del riposo o del sonno. Tuttavia questa maggiore lunghezza rende anche più probabile la coincidenza tra le cesure metriche di fine verso e quelle sintattico-narrative di fine proposizione o periodo. Questo vuol dire che, nonostante che il respiro sia più calmo, la componente rituale, iterativa, coinvolge in qualche modo anche il racconto. Gli enjambement, che con il verso breve sono probabili e attesi, con quello lungo diventano più rari, e producono perciò, quando si presentano, effetti molto più radicali.
A grandi linee (perché esistono anche casi particolari in cui accade il contrario), il verso libero privilegia la componente espressiva, comunicativa; mentre la ricorrenza di una clausola regolare (comunque sia ottenuta questa regolarità) sottolinea la componente rituale (ritmica). Se le cose stanno così, il verso libero avvicina la poesia alla prosa, costringendola – per mantenere la distanza – a enfatizzare altre differenze (per esempio di carattere tematico, o moltiplicando le iterazioni sintattiche o narrative).
Giusto per chiudere, è giusto osservare che il rapporto tra espressività e ritualità non caratterizza solo la poesia, bensì – in diversa misura – ogni specifica forma di comunicazione. Quello che potremmo dire della poesia è che si tratta di una forma molto ritualizzata, pur se ancora molto meno della musica.
Cosa succede, in questi termini, nel fumetto? Un po’ ne ho già parlato in qualche post precedente, un po’ ci tornerò sopra, spero presto.
1 Aprile 2010 | Tags: A Zacinto, Ardengo Soffici, avanguardie, Canti Orfici, Dino Campana, Filippo Tommaso Marinetti, fumetto, lirica, metrica, poesia, poesia in prosa, ritmo, Ugo Foscolo, verso | Category: estetica, fumetto, poesia, semiotica | Raccolgo la sfida di Andrea Inglese a parlare di poesia in prosa, di lirica e di lirismo, proseguendo qui la conversazione avviata con i commenti al suo articolo “Poesia in prosa e arti poetiche. Una ricognizione in terra di Francia” uscito su Nazione Indiana.
Prima di tutto voglio raccogliere un termine che appare nel controcommento di Inglese, dove dice che la lirica novecentesca è zeppa di periferie antiliriche estremamente interessanti. Il termine è periferie. La parola periferie mi piace perché, usata in questo contesto, occupa un’area semantica opposta a quella di avanguardie. Parlare di avanguardie, nell’arte (e non solo) del Novecento, significa parlare di gruppi che hanno al loro centro un’idea forte (e fin qui niente di male) che resta produttiva sino a quando non prendono il potere – ma a questo punto si trasforma in una sorta di dittatura (culturale, o magari del proletariato). Non è successo solo con i Bolscevichi nel ’17, ma anche con la neoavanguardia italiana e con la musica colta del dopo-Darmstadt: l’idea diventa talmente forte che a un certo punto sembra davvero rappresentare lo spirito del tempo (o è facilmente spacciabile come tale), e chi vi si contrappone è facilmente bollabile come reazionario.
Se si ragiona in termini di periferie, si capisce invece come qualsiasi pretesa di rappresentare lo spirito del tempo è velleitaria, perché ogni autore di valore, ogni gruppo di successo, anche ogni avanguardia non fa che rappresentare uno spirito del tempo – perché la realtà è complessa, e gli spiriti che convivono sono tanti. Avendo molto amato diversi autori della neo-avanguardia italiana, ho fatto fatica io stesso a suo tempo ad accorgermi che quella linea rappresentava certo qualcosa, ma che lasciava ugualmente fuori molto altro. Quel tipo di intellettualismo ha i suoi pregi e il suo fascino, ma risponde solo ad alcuni dei miei bisogni di lettore di poesia. Mi ha sempre molto colpito come vi si inserisca e ne esca un autore come Antonio Porta, che io reputo fortemente e originalmente lirico – a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’oggettività e l’oggetto che gli stanno attorno. (E d’altra parte, la nozione eliotiana e montaliana stessa di correlativo oggettivo non è affatto antilirica in sé, mi pare)
Forse il problema è decidere quali siano davvero i confini della lirica. Io Marinetti ce l’ho sempre visto dentro, e ugualmente Soffici, per prendere un poeta futurista magari un po’ meno profetico, ma probabilmente anche più capace. Il loro essere contro è tutto basato sull’esaltazione dell’emotività. Magari una lirica superomistica, se mi si permette il quasi-ossimoro – ma non ancora un’epica come quella del D’Annunzio di Maia, che sta loro certamente dietro.
Quello che temo è che i termini di ciò che è lirica e di ciò che è antilirica siano così incerti da permettere di discutere vanamente per giorni. Credo che lo si veda bene, per esempio, nelle scelte fatte da Enrico Testa nella sua antologia Dopo la lirica. Confesso che nel leggerla, io non mi sono affatto sentito “dopo la lirica”.
Il lirismo, semmai, mi appare come la caricatura della lirica. Caricatura nel senso letterale, non necessariamente negativo, di espressione caricata, in cui certi tratti vengono esasperati e diventano per questo più immediatamente riconoscibili. Per cui, senza dubbio, anche certa grande lirica è liricistica, mentre Marinetti non lo è.
Il lirismo si trova indubbiamente dappertutto, ed è quella caratteristica di un’opera non di poesia che la rende (nel modo più diffuso di esprimersi) poetica. Nel fumetto il lirismo è tanto più presente quanto più si afferma la tendenza autobiografica che caratterizza il fumetto d’autore degli ultimi vent’anni: non che tutte le narrazioni autobiografistiche (spesso il tono è quello dell’autobiografia, ma i contenuti non è detto che siano veramente autobiografici) abbiano caratteri di lirismo, ma ce ne sono anche di questo tipo. Autori lirici (in questo senso) e di grande valore sono certamente Lorenzo Mattotti, Gabriella Giandelli, ma anche Chris Ware e David B. Anche qui, comunque, non è chiaro sino a che punto si possa stirare la nozione. Proprio per questo, di solito, tendo a non farne uso.
E veniamo alla poesia in prosa. Approfitto dell’argomento per riportare qui un paragrafo di un articolo che sto pubblicando sulla Rivista Italiana di Filosofia del linguaggio, dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura”.
1. La parola poetica e la sua natura collettiva
È interessante osservare che cosa succede quando si toglie alla parola poetica la dimensione ritmica del verso, riducendola a semplice prosa. Ecco un esempio:
Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.
La ricchezza di enjambement del sonetto di Ugo Foscolo cancella più facilmente l’andamento metrico dell’endecasillabo una volta che l’organizzazione in versi sia stata soppressa. Il risultato è una prosa di difficile lettura, perché, nonostante l’identità della sequenza verbale, la versione in prosa manca delle messe in rilievo procurate dagli inizi e fine dei versi, e in particolare dagli enjambement medesimi.
La struttura ritmica del componimento, che si rispecchia graficamente nella versificazione, non è infatti soltanto un andamento musicale che ne accompagna il flusso, bensì un preciso sistema di enfatizzazioni, di costruzione di luoghi di rilievo nel testo, che indirizzano e probabilmente determinano la corretta interpretazione delle proposizioni e del periodo. In questo senso, l’organizzazione dei versi diventa un (parziale) sostituto visivo del sistema delle intonazioni della parola parlata. Per mezzo del verso la parola poetica mantiene con l’oralità un legame più stretto della parola in prosa.
L’occultamento della struttura metrica ha però un’ulteriore conseguenza. Anche se la frequenza degli enjambement sembra mettere in crisi la divisione dei versi, nella versione originale essa è ben lontana dall’annullarla; e anzi il gioco testuale di Foscolo è possibile proprio perché la struttura formale del sonetto, con il suo sistema di strofe, versi e rime, non viene assolutamente intaccata, costituendo comunque uno sfondo rilevante alla (relativa) indipendenza dell’andamento sintattico, e fornendogli per questo un ulteriore senso. Il sonetto si caratterizza infatti proprio per la sua struttura ritmico-metrica: una sequenza di quattordici versi endecasillabi con rime (in questo caso, del tutto canoniche) ABAB ABAB CDE CED.
La struttura ritmica è una struttura di carattere musicale, ovvero un andamento con il quale è possibile sincronizzare degli andamenti corporei, come in una sorta di danza. Questa danza è potenzialmente collettiva – anche se di fatto tipicamente vissuta dal lettore nella personale intimità – poiché il medesimo ritmo si presenta a qualsiasi rilettura eseguita da chiunque. Fruire una struttura ritmica significa dunque riprodurre anche in solitudine i gesti di un atto con carattere comunitario e rituale, e di conseguenza accordarsi a un agire corporeo collettivo, proprio come nella danza.
Ridurre A Zacinto a prosa non ne diminuisce soltanto la leggibilità, dunque, ma ne compromette in larga misura la dimensione corporea e rituale, recidendo il legame con la dimensione orale della parola ed enfatizzando i suoi aspetti di scrittura.
Naturalmente A Zacinto non nasce come poesia in prosa, e quello riportato qui è solo un esperimento concettuale. Credo che però l’esperimento mostri chiaramente che cosa la poesia tolga a se stessa abbandonando il verso. Quello che segue è invece evidentemente il classico dei classici della poesia in prosa:
Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata ne l’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.
Eppure ho il sospetto che aprire un libro di poesie con una prosa fosse davvero una provocazione nel 1911, e che Dino Campana ne fosse al momento perfettamente consapevole. Proprio per questo si rivolgeva ai futuristi di Lacerba per pubblicarlo. C’era stato Rimbaud e Corazzini e altri, ma in un’epoca in cui in Italia il verso tradizionale e magistrale di D’Annunzio era l’inevitabile canone, fare poesia senza versi era dichiaratamente contro.
D’altra parte, questo testo rimane di sicuro dentro ai confini della lirica, comunque li si vogliano tracciare, e pure del lirismo (quello buono). Basterebbe quell’attacco sul “ricordo” per confermarlo.
Io lo trovo particolarmente interessante perché nei suoi componimenti in versi Campana è sempre particolarmente attento all’uso ritmico degli accenti – sino a certi effetti ossessivi. Studiare, per esempio, “Viaggio a Montevideo” dal punto di vista ritmico è una continua fonte di sorprese.
Ora, non è che qui i ritmi prosodici non ci siano. Ma la stesura in prosa ne nega la rilevanza: non ci sono infatti i versi a sostenerli, attraverso il gioco di conferma/contrasto con la struttura metrica. Quello che si sta abbandonando è dunque proprio il rapporto stretto con l’oralità musicale della parola poetica. Naturalmente la descrizione di Campana è bellissima, ma si pone per tanti versi dalla parte della prosa, cioè di un modo di usare il linguaggio che sottolinea la dimensione del significato in maniera maggiore di quanto non faccia la poesia – un linguaggio, insomma, più dichiaratemente scritto.
Io credo che la poesia viva di un rapporto ambiguo tra oralità e scrittura, e che il verso sia il principale portatore di questa ambiguità (o ambivalenza). Se eliminiamo il verso ci avviciniamo inevitabilmente alla prosa. Poi, come fa Campana, possiamo mantenere fissi una serie di altri elementi caratteristicamente poetici (la brevità, un certo modo di fraseggiare, la particolarità delle scelte lessicali e sintattiche ecc.), e continuare a chiamare poesia quello che facciamo. Questo forzerà un’interpretazione in termini poetici, e ci indurrà magari a cercare un ritmo degli accenti anche dove non sia sostenuto dal verso, e a mantenere una visione del testo che ne accentui il legame con l’oralità.
Ma come leggeremmo le parole di Campana se si trovassero all’inizio di un romanzo, invece che dei Canti Orfici? Finché il grosso della poesia mantiene il verso, resta possibile leggere la poesia in prosa come poesia. Ma se il genere dovesse affermarsi e diventare maggioritario, la trasformazione delle modalità di fruizione sarebbe tale da rendere impossibile questa lettura per contrasto. Perderemmo la dimensione della poesia, semplicemente.
17 Marzo 2010 | Tags: Amelia Rosselli, Dante Alighieri, endecasillabo, enjambement, Francesco Petrarca, Giovanni Della Casa, metrica, petrarchismo, poesia, risoluzione, tensione, Ugo Foscolo, verso | Category: poesia | Un’amica che leggeva delle mie poesie mi ha domandato una volta con che criterio si va a capo nei versi. In altre parole, quando scrivi una poesia, come fai a decidere quando è ora di concludere un verso e iniziarne un altro?
La risposta banale è “Quando lo senti”. È vero (perché mentre scrivi è in gioco la sensibilità assai più di qualsiasi tipo di calcolo) ma non basta (perché anche questa stessa sensibilità segue delle regole, che ci siano in quel momento presenti o no).
La risposta non banale è molto complicata. Riflettendo sulla stessa sensibilità che ci porta ad andare a capo in un certo modo, posso però enunciare una serie (tutt’altro che esaustiva) di principi, che hanno come conseguenza l’andata (o meno) a capo:
- l’inizio e (soprattutto) la fine di un verso sono luoghi di rilievo: quello che capita in queste posizioni viene enfatizzato rispetto a quello che si trova nella parte centrale del verso;
- di conseguenza, un verso molto breve enfatizza molto il suo contenuto (che si trova al contempo all’inizio e alla fine del verso);
- la coincidenza tra la clausola metrica (data dal verso) e quella sintattica (data dal periodo, dalla proposizione o dal sintagma compiuto) ha impostazione conclusiva: ne farò uso se voglio enfatizzare la cesura tra un verso e l’altro (e tra una clausola sintattica e l’altra), ottenendo un ritmo diviso; la eviterò se invece voglio minimizzare le cesure, ottenendo un ritmo più fluido;
- le forme regolari sono come la tonica nella musica tonale: un luogo di risoluzione della tensione; finché voglio mantenere la tensione devo mantenere irregolare la forma, e spezzare il verso in modo che lo sia; la regolarità, viceversa, è conclusiva. Posso fare uso dei versi più anomali in una poesia, ma un bell’endecasillabo con accenti sulle sillabe 4 e 6 darà l’impressione di un punto di arrivo, parziale se la sintassi non lo conferma, totale se anche sintatticamente si arriva in fondo;
- quest’ultima regola è particolarmente importante quando si fa uso di versi della stessa lunghezza (cioè non versi liberi): il gioco tra le versioni non canoniche e quelle canoniche del verso che stiamo usando crea tutta la tensione metrico-sintattica della poesia. In questo senso la presenza dell’enjambement permette di rendere forme irregolari anche i versi più canonici, inserendo nel gioco un’ulteriore variabile.
Quest’ultima osservazione riguarda qualcosa che mi è particolarmente presente. Probabilmente la natura sillabico-accentuativa (più sillabica che accentuativa) del verso tradizionale italiano ha a che fare con l’antico legame tra poesia e musica, reciso nel XIII secolo dagli aristocratici siciliani. Dante aveva capito bene, pur nei termini della propria epoca, che il gioco tra versioni più o meno canoniche dell’endecasillabo era uno strumento potente in mano al poeta, visto che non c’era più bisogno di rispettare il requisito della cantabilità (in senso musicale). Poi però Petrarca ha imposto alla poesia italiana un canone di regolarità che ha tagliato fuori questo gioco: purtroppo lui era talmente bravo che riusciva a ottenere gli stessi effetti giocando di variazioni minimali degli accenti; ma per chi l’ha seguito, affascinato dalla sua abilità, il risultato è stato mediamente assai noioso.
Sarà gusto personale, ma nell’universo del sonetto (cioè la forma che Petrarca ha maggiormente segnato) i miei amori sono sempre andati verso gli autori meno petrarcheschi, come Giovanni Della Casa e Ugo Foscolo, specie in A Zacinto. Ecco un bell’esempio da Della Casa (dalle Rime, pubblicate postume nel 1558):
Questa vita mortal, che ‘n una o ‘n due
brevi e notturne ore trapassa, oscura
e fredda; involto avea fin qui la pura
parte di me ne l’atre nubi sue.
Or a mirar le grazie tante tue
prendo: ché frutti e fior, gelo ed arsura,
e sí dolce del ciel legge e misura,
eterno Dio, tuo magisterio fue.
Anzi ‘l dolce aer puro, e questa luce
chiara, che ‘l mondo a gli occhi nostri scopre,
traesti tu d’abissi oscuri e misti.
E tutto quel che ‘n terra o ‘n ciel riluce,
di tenebre era chiuso, e tu ‘apristi;
e ‘l giorno e ‘l Sol de le tue man son opre.
Qui il gioco tra irregolarità (tensiva) e regolarità (risolutiva) è basato sull’enjambement, mentre per quanto riguarda gli accenti il canone petrarchesco viene rispettato.
Ma il principio si trova applicato sino in Amelia Rosselli (da Documento, 1966-73):
Ossigeno nelle mie tende, sei tu, a
graffiare la mia porta d’entrata, a
guarire il mio misterioso non andare
non potere andare in alcun modo con
gli altri. Come fai? Mi sorvegli e
nel passo che ci congiunge v’è soprattutto
quintessenza di Dio; il suo farneticare
se non proprio amore qualcosa di più
grande: il tuo corpo la tua mente e
i tuoi muscoli tutti affaticati: da
un messaggio che restò lì nel vuoto
come se ad ombra non portasse messaggio
augurale l’inquilino che sono io: tua
figlia, in una foresta pietrificata.
In questa corsa affannosa, l’unico punto risolutivo è quello finale, e questa “foresta pietrificata” ne riceve un rilievo straordinario.
(come questo principio sia applicato da me – si parva licet componere magnis – si può ovviamente verificare qui)
I manuali italiani di metrica, che spiegano il sistema dei versi italiani così come si è costruito nella tradizione, ci insegnano che i versi con un numero dispari di sillabe (cinque, sette, nove, undici) hanno gli accenti variabili, mentre quelli con un numero pari di sillabe (quattro, sei, otto, dieci) hanno gli accenti fissi. Se si aggiunge che il novenario ha comunque una forma canonica con accenti sulle sillabe 2, 5 e 8, e che il quinario è troppo breve per avere un uso significativo, i versi a disposizione per evitare l’effetto cantilena sono solo due, non a caso i versi classici della poesia italiana: il settenario e l’endecasillabo.
Tra i versi parisillabi, quello che produce al massimo l’effetto cantilena (o filastrocca) è l’ottonario:
La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte.
Col mantello tutto blu
noci e fichi butta giù.
o anche, come abbiamo visto con Rubino:
Ha la zia dimenticata
la credenza spalancata:
Quadratino di soppiatto
v’entra lesto come un gatto.
Gli accenti sono obbligati sulle sillabe 1 e 5 (deboli), 3 e 7 (forti).
Naturalmente, esistono anche esempi nobili nella poesia italiana, in cui questo clima ossessivo è stato positivamente sfruttato:
Quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia!
Chi vuol essere lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
E naturalmente Giovanni Pascoli ha saputo giocare da maestro sul clima popolaresco che questo andamento da filastrocca suggerisce:
Viene viene la Befana
vien dai monti a notte fonda.
Come è stanca! La circonda
neve, gelo e tramontana.
Al di fuori di questo ristretto sistema di possibilità, comunque, sembra non ci sia spazio per i versi che non siano (quinario) settenario ed endecasillabo, nella poesia italiana. Gli altri versi sono stati usati magari per occasioni diverse, ma sempre dove se ne potesse sfruttare, a qualche titolo, la natura ossessiva.
Questo sistema è così forte per noi che siamo portati ad applicarlo intuitivamente anche alla poesia in altre lingue, specie se non troppo lontane dall’italiano. Eppure, leggendo la poesia spagnola, nonostante la fonetica e la prosodia dello spagnolo siano così simili a quelle dell’italiano, ci accorgiamo che le cose sono parecchio diverse, e il verso di otto sillabe, per esempio, non è affatto una cenerentola dal passo ossessivo: è anzi per gli spagnoli il verso epico per eccellenza, quello in cui è scritto El cantar del mio Cid, il grande poema epico spagnolo; ed è anche il verso in cui Federico García Lorca ha scritto la parte più struggente del suo Llanto para Ignacio Sanchez Mejias.
…
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
…
Nella versione spagnola dell’ottosillabo (e chiamiamo d’ora in poi così il genere di cui l’ottonario italiano è una specie) non c’è traccia dell’accentazione ossessiva. Gli accenti sono liberi come nei nostri settenario ed endecasillabo.
Leggendo poi un bel manuale di metrica spagnola (Varela Moíño Jauralde – Manual de métrica espanola, Madrid, Editorial Castalia 2005), mi sono reso conto che, nella poesia spagnola, per tutti i versi, pari- o imparisillabi che siano, il sistema degli accenti è mobile.
Ma se García Lorca è in grado di ottenere dal suo ottosillabo una varietà così straordinaria di sfumature emotive, facendo uso di una lingua, come lo spagnolo, tanto simile foneticamente e prosodicamente all’italiano, perché un poeta italiano deve sentirsi legato al modo povero in cui la nostra tradizione ha fatto uso di questo verso?
La cosa mi è balzata di colpo davanti agli occhi in un periodo in cui sia il verso libero, sia l’unica alternativa al verso libero praticata dai poeti italiani del novecento, cioè l’endecasillabo, mi iniziavano a pesare. L’endecasillabo pesa perché ha troppa tradizione sulle spalle, e perché se scrivo versi di getto, senza curarmi del conto delle sillabe, è facile che mi escano sul modello sonoro dell’endecasillabo, sensuale, musicale e suadente – ma troppo segnato, ormai: così che è troppo frequente che, per ogni endecasillabo che mi esce dalla penna, mi balzino dopo poco agli occhi innumerevoli precedenti letterari.
Qualcosa di simile succede con il verso libero, che è il verso del novecento italiano, e che è il verso più difficile da usare; perché non libera affatto chi scrive, ma gli propone nuovi vincoli mentre lo libera dai vecchi, e aggiunge possibilità da un lato mentre le toglie dall’altro.
Dunque per un poeta va bene avere nell’ambito delle possibilità di scrittura il verso libero e l’endecasillabo, ma a patto che vi siano davvero altre possibilità liberamente percorribili.
E così ho incominciato a provare il verso di otto sillabe, e quelli di nove e dieci e dodici e più, sforzandomi di farne uso come versi ad accenti mobili. La regolarità del verso mi garantisce un certo ritmo di fondo su cui giocare, ma la sua novità mi protegge dal sentirlo come abusato. La presenza di un ritmo metrico di fondo mi permette poi di contrastarlo o assecondarlo con il ritmo sintattico.
Alla lunga, questo uso mi fa capire come anche dell’endecasillabo si possa fare (con molta più difficoltà, certamente) anche un uso non canonico.
Sparsi tra altri, ma non difficili da individuare, potete leggere qui gli effetti di queste mie scoperte.
7 Marzo 2010 | Tags: Ally Sloper, Antonio Rubino, comunicazione visiva, Corriere dei Piccoli, Fabio Gadducci, fumetto, Igort, metrica, nascita del fumetto, ottonario, poesia, verso | Category: comunicazione visiva, fumetto, poesia | A Bilbolbul mi sono abbuffato di mostre e incontri (compreso quello sul mio libro). Tutto interessante e di alto livello; talvolta ancora meglio. Gli effetti di quello che ho visto e udito prima o poi salteranno fuori, magari anche in questo blog. Per adesso voglio concentrarmi su un tema solo, perché credo di aver fatto una piccola scoperta.
Ieri (6 marzo) pomeriggio, Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli presentavano, insieme con Igort, il loro volume Antonio Rubino. Gli anni del “Corriere dei Piccoli”. Bello il libro, interessante la spiegazione e la discussione. A un certo punto è uscito il tema dell’ossessione di Rubino per la geometria, per le simmetrie e per le ripetizioni, e Igort è intervenuto con un’osservazione sulla natura un po’ ossessiva di tutta la produzione di Rubino.
A questo punto sono intervenuto anch’io, con un’osservazione che mi era divenuta sempre più evidente man mano che il loro discorso procedeva, e che ora esporrò ed espanderò qui.
Si tratta delle rimette. Le rimette sono un’invenzione tutta italiana, anzi, del medesimo Rubino (che inoltre, a quanto mi hanno poi assicurato Stefanelli e Gadducci, per lungo tempo la ha scritte per tutte le serie a fumetti del Corrierino). Negli altri paesi europei, lo standard era la sequenza di immagini accompagnata da una narrazione in prosa (come nell’esempio di Ally Sloper che  abbiamo postato qualche giorno fa). abbiamo postato qualche giorno fa).
Ora, perché Rubino spinge così fortemente verso l’uso del verso anziché del più assestato racconto in prosa? La spiegazione più naturale è quella di far riferimento alla tradizione dei cantastorie, che raccontavano in versi accompagnandosi con delle figure. Ma la spiegazione vale solo in parte, perché i cantastorie facevano presumibilmente uso di un altro tipo di verso, cioè l’endecasillabo, che è il verso epico della tradizione italiana, e magari addirittura l’ottava rima, che è quella dell’Orlando Furioso e dei poemi cavallereschi. L’ottonario è piuttosto un verso da canzonetta o da burla, proprio per la sua natura ossessiva, che mal si presta a raccontare.
Credo che la scelta di Rubino sia dovuta invece proprio alla natura non solo popolare, ma soprattutto ossessiva e “quadrata” dell’ottonario. È una scelta, in realtà, tutt’altro che popolare e ingenua (se non magari in seconda istanza): il versus quadratus, o dimetro trocaico, era il metro che i latini usavano, in età classica, per indovinelli, cantilene infantili, scherzi popolari. È caratterizzato dall’espansione di un modulo binario, con accento sulla prima sillaba: Tàta. Se raddoppiate questo modulo e poi lo raddoppiate ancora (Tàta tàta Tàta tàta) avete l’ottonario; se prendete l’ottonario e lo raddoppiate e poi lo raddoppiate ancora, avete le quartine di Rubino: “Ha la zia dimenticata / la credenza spalancata: / Quadratino di soppiatto / v’entra lesto come un gatto.” Più quadrato e ossessivo di così è impossibile.
Nel contesto di questa struttura iper-regolare Rubino inserisce le sue  narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento. narrazioni, spesso strampalate e deliranti, e crea il proprio universo assolutamente antinaturalistico, dove l’uso stesso di un verso così eccessivo fa parte della strategia di straniamento.
Ora, se osserviamo le sue figure vi ritroviamo la stessa strategia: un universo di invenzioni strampalate, trasmesse attraverso uno studio, decisamente geometrico, sulla ripetizione, sulla regolarità e sulla rima visiva! Una strategia dell’anti-reale costruita assemblando elementi di carattere opposto: assurdi e irregolari narrativamente, geometrici e iper-regolari strutturalmente.
Il fascino di Rubino sta probabilmente proprio in questa fantasmagorica gestione di opposti. La si vede persino nel suo stile grafico, insieme floreale e liberty da un lato, e geometrico-futurista dall’altro. Credo che Rubino non si sia mai riconosciuto in nessuna di queste correnti. Era abbastanza complesso da sé, evidentemente!
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|
 Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza.
Sto studiando e riflettendo per un convegno di metricisti a cui sono stato invitato per fine novembre (La metrica dopo la metrica, Padova 27-28 novembre). Nel corso delle mie letture mi è venuta a mente un’ipotesi, di cui scrivo qui anche per farmi chiarezza.

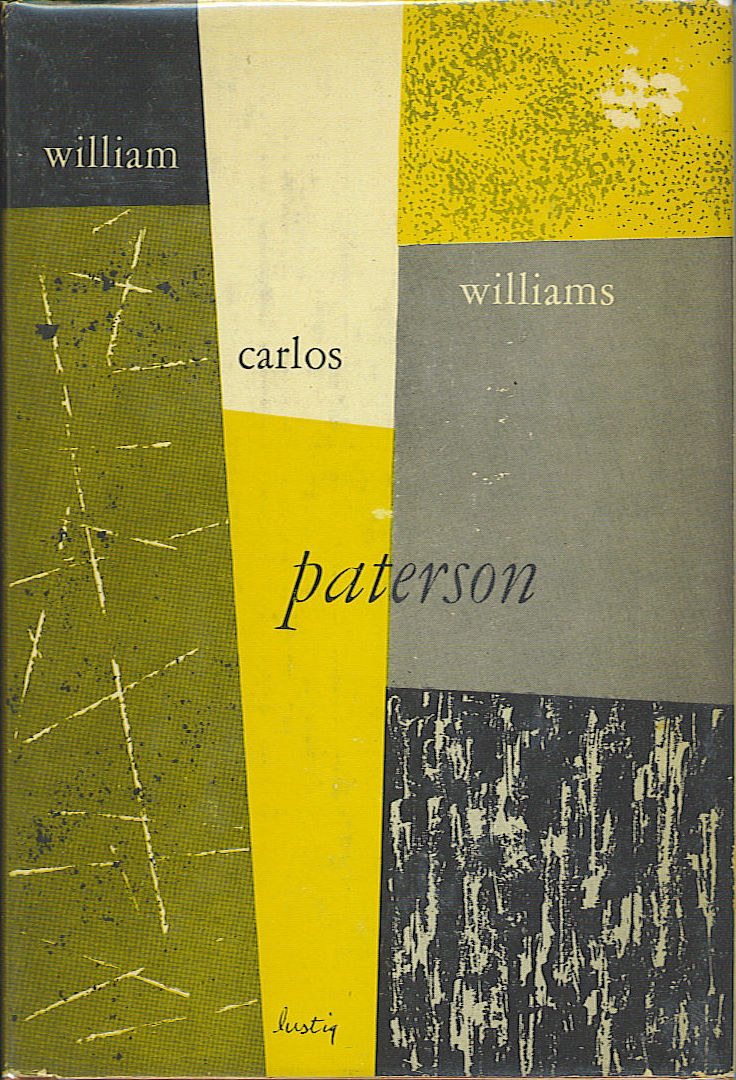

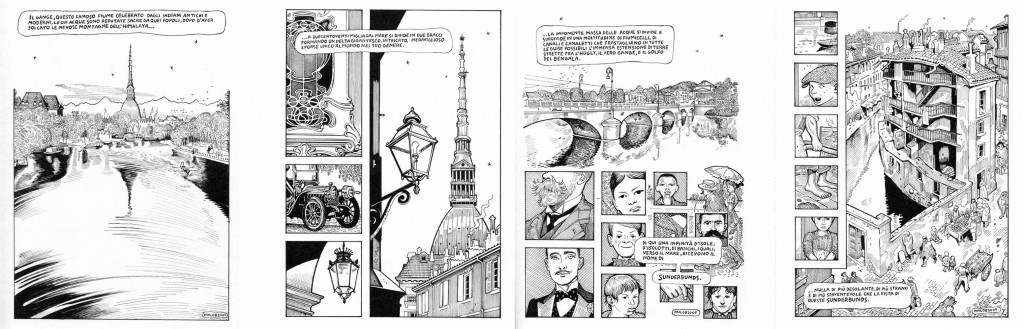






 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email
 Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.
Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






Commenti recenti