Per quello che voglio dire in questo post questa poesia potrebbe essere sostituita da molte altre, ma è una bella poesia, e prenderla come esempio è anche un’occasione per farla leggere. Il tema di questo post è l’allitterazione, e a cosa serve.
L’allitterazione è un parente della rima, ma può ricorrere con molta più frequenza, dimostrando che il principio del parallelismo con cui Roman Jakobson pretenderebbe di spiegarne la ragione può essere certamente valido in casi particolari, ma è lontano dall’avere valore generale. Secondo Jakobson, infatti, il parallelismo sul piano dell’espressione (creato, per esempio, dalla presenza della rima) dovrebbe implicitamente suggerire un analogo parallelismo su quello del contenuto, portandoci a ipotizzare relazioni semantiche nascoste tra parole avvicinate da elementi comuni di suono. Ma in un caso come quello esemplare del dantesco “e caddi come corpo morto cade” – in cui tutte le parole sono legate da allitterazione o quasi-rima con quelle circostanti – se il principio del parallelismo dovesse avere valore universale, il verso si ritroverebbe coperto da un’alluvione di sospetti di legami di senso tra tutte le sue parole. Non mi sembra che sia così.
Trovo più proficuo semmai un approccio che va nella direzione delle proposte di Henri Meschonnic, che porta a considerare la presenza dell’allitterazione e di altre figure fonetiche come strumenti di accentuazione, capaci di focalizzare l’attenzione e produrre rilievo, grazie all’improvvisa e innaturale presenza di una ricorrenza regolare dei medesimi suoni in un contesto – quello della normale sequenza linguistica – in cui solitamente i suoni sono distribuiti senza uno schema fonetico preciso, essendo utilizzati come semplici mattoni da costruzione delle parole, e queste a loro volta come veicoli del senso, a prescindere dal loro suono.
La presenza stessa del verso, che inquadra e permette di focalizzare gruppi ristretti di parole, favorisce l’osservazione dei fenomeni fonetici (che esistono anche in prosa, ovviamente, ma si trovano a essere molto meno sottolineati). La presenza di schemi di suono regolari attira la nostra attenzione per lo stesso motivo per cui questo accade anche al di fuori del linguaggio, nell’interazione col mondo: là dove ci sono strutture regolari c’è potenzialmente vita, e quindi ragione di interesse per noi in quanto viventi, vuoi che si tratti di una preda, di un pericolo, di un amico o di un manufatto (Gregory Bateson insegna). Le strutture dotate di qualche regolarità sono i principali candidati ad essere forme non solo salienti ma anche pregnanti: come minimo la nostra attenzione viene risvegliata e ci spinge ad almeno una prima analisi. Intanto, però, l’allitterazione (come pure assonanze, consonanze, rime…) ha creato rilievo, motivo di attenzione sulle parole che la contengono, e il senso che esse trasmettono ne risulta sottolineato, a sua volta messo in rilievo.
Anche questo approccio ispirato alle posizioni di Meschonnic non esaurisce però il valore dell’allitterazione. Se infatti da una parte, in un ambiente tendenzialmente irregolare la presenza di locali regolarità si fa notare come eccezione, d’altra parte si può trattare di un’eccezione di carattere tranquillizzante, non appena si arrivi a riconoscere la sua natura di manufatto, ovvero di oggetto realizzato secondo le regole dell’uomo, a noi comunque più familiari di quelle della natura extraumana. Questa percezione di regolarità tranquillizzante sarà tanto più forte quanto più ampiamente diffusa nel testo (come accade alle rime nella metrica italiana tradizionale; o come accadeva all’allitterazione stessa nei metri germanici antichi, il cui verso prevedeva obbligatoriamente la presenza di più parole allitterate). Ma l’allitterazione si presta molto più della rima a creare aree particolarmente dense di queste iterazioni, organizzando il testo (da questo specifico punto di vista) in aree strutturate e non strutturate (zone allitterate e rimanente del testo), o di confortante senso sonoro e di neutro rumore bianco. Teniamo sempre presente che la poesia non è, a differenza della prosa, un semplice dominio del senso, discorsivo o narrativo, dove le parole sono puri tramiti trasparenti. Un componimento poetico assomiglia piuttosto a un luogo, del quale sappiamo che molte – magari tutte – le cose che lo popolano hanno un significato nascosto; tuttavia per scoprire questi significati nascosti non abbiamo altra strada che iniziare a valutare gli oggetti per il loro aspetto esteriore. Gli oggetti della poesia sono le parole di cui essa è fatta, e il loro aspetto esteriore è dato dal suono non meno che dal loro significato più immediato ed evidente.
Il componimento di Giudici è scritto in una lingua mediamente piuttosto piana e colloquiale, con una normale distribuzione dei fonemi della lingua italiana. Solo in alcuni punti si aggregano alcuni fenomeni di ricorrenza fonetica, creando aree di rilievo. Altri rilievi, che non approfondiremo qui, vengono suggeriti da sorprese di carattere discorsivo o narrativo, come il “puzzo di cavoli” del decimo verso, nonché naturalmente dal procedere stesso dell’argomentazione sino all’effetto liberatorio della fine.
L’inizio del componimento è già allitterato, con l’insistenza sulle liquide (il luogo era lo), seguito da alcune parole in assonanza e rima (stesso, ma preso di peso), che si incrociano con una seconda, più forte, allitterazione (preso di peso e portato). Segue un verso senza particolari ricorrenze che però annuncia, già nella sua parte finale (non nel) l’allitterazione lunga e forte che segue (vicolo / fitto di facce da festa di streghe), dove la dominanza del suono f rende pertinenti i vicini suoni simili v e s.
Questo terzo verso è particolare anche per altre ragioni: è infatti un endecasillabo, il primo che incontriamo in un componimento in versi liberi, e possiede un sistema di accenti estremamente regolare, di carattere dattilico (1, 4, 7, 10). Un verso che si fa notare, insomma, sotto diversi aspetti, un verso costruito con forme tradizionali innestato in un contesto di linguaggio apparentemente più prosastico e colloquiale, un verso talmente concluso in sé che la scoperta dell’esistenza di un enjambement viene fatta solo a posteriori, quando già si sta percorrendo il verso successivo, e ci accorgiamo che in verità quell’andamento così ritmicamente definito dovrebbe sciogliersi nella continuità del discorso – mentre è impossibile che possa farlo del tutto.
Ce ne sono ancora altre, nei versi successivi, di queste ricorrenze allitterative: “L’ognigiorno del sogno”, “femmina e maschio che tremano ai minimi rumori”, “via vai a voce”, “succedeva / Volevo semplicemente un po’ scherzare”, “nessuno ci conosce”.
Escludo che il principio del parallelismo di Jakobson possa essere di qualche utilità per spiegare questa presenza diffusa: le parole allitterate sono troppo vicine tra loro perché abbia senso postulare un richiamo semantico basato sulla somiglianza fonetica, visto che ce n’è già un altro, molto più forte ed evidente, che si basa sulla vicinanza, o addirittura sull’appartenere alla medesima proposizione, se non anche al medesimo sintagma.
La funzione di creazione di rilievo è invece plausibile, però si trova in concorrenza con creazioni di rilievo di altro tipo. E poi, quando i rilievi sono troppi, o troppo frequenti, finiscono per neutralizzarsi a vicenda.
C’è piuttosto, io credo, in questa frequenza dell’allitterazione, un indice di poeticità, che ha il particolare vantaggio di non pagare alcun debito nei confronti della nostra tradizione (come fa invece l’endecasillabo al terzo verso). In altre parole, un po’ come il verso germanico antico aveva bisogno dell’allitterazione per dimostrarsi verso, perché la sua natura unicamente accentuativa (senza nessuna quantità definita di sillabe o di piedi) era di per sé troppo debole per permettere di riconoscere a orecchio il verso, in maniera simile una poesia come quella di Giudici (e di molti altri poeti del Novecento), basata sul verso libero e su una lingua “non poetica”, può utilizzare l’allitterazione (e altre ricorrenze fonetiche poco canonizzate dalla tradizione italiana) per rendere evidente la propria natura di ambiente verbale costruito, ovvero di poesia. L’allitterazione è cioè uno stratagemma artificiale, un manufatto esplicito, una deformazione della normalità della lingua che si mostra come tale, e perciò un indice di poeticità – ma col vantaggio di non richiamare la tradizione (come invece farebbero le rime, i versi regolari o canonici, la scelta di termini più aulici, e così via). A differenza delle ricorrenze della tradizione, infatti, l’allitterazione è locale, e può quindi essere di carattere tranquillizzante (in quanto evidente manufatto, secondo il principio che enunciavamo sopra) senza che il testo nel suo complesso appaia tranquillizzante – come invece accade inevitabilmente con l’assunzione tradizionale globale di un metro rigido o di un sistema di rime. La poesia del Novecento rifiuta l’inquadramento tranquillizzante della tradizione, in nome di una più efficace espressività – e perché quella maniera di tranquillizzare verrebbe ormai sentita come falsa. La località dell’allitterazione ne fa uno strumento espressivo anche in questo senso, permettendo persino di mettere a contrasto aree più esplicitamente manufatte (e quindi più tranquillizzanti in questo senso) con aree più “prosastiche” e selvagge.
Naturalmente non è l’unico stratagemma possibile a questo scopo; parlando di Amelia Rosselli ne avevamo già identificati altri – e anche lì, nella Rosselli, il rapporto con la prosa e con l’ostentazione del manufatto è indubbiamente forte.



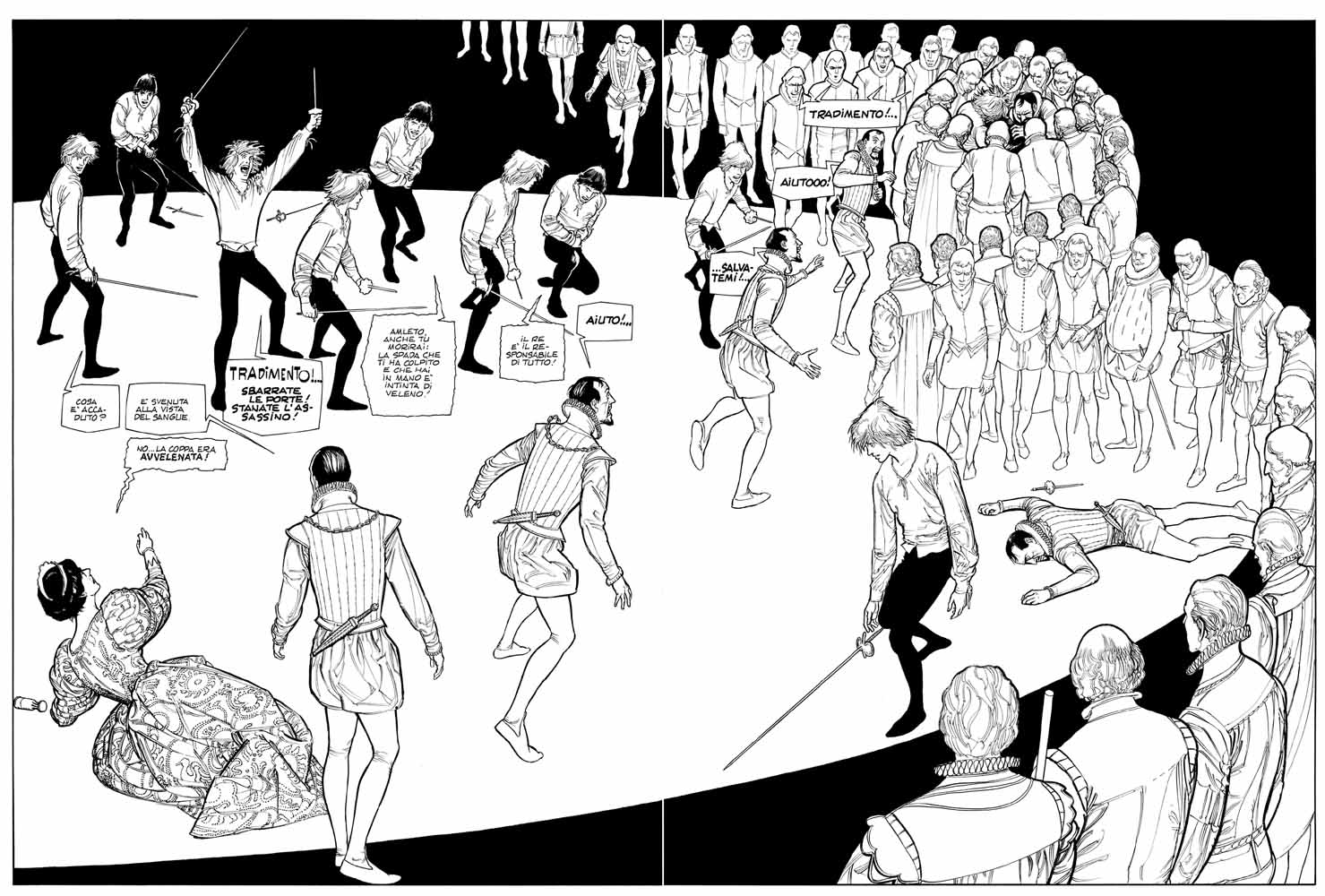




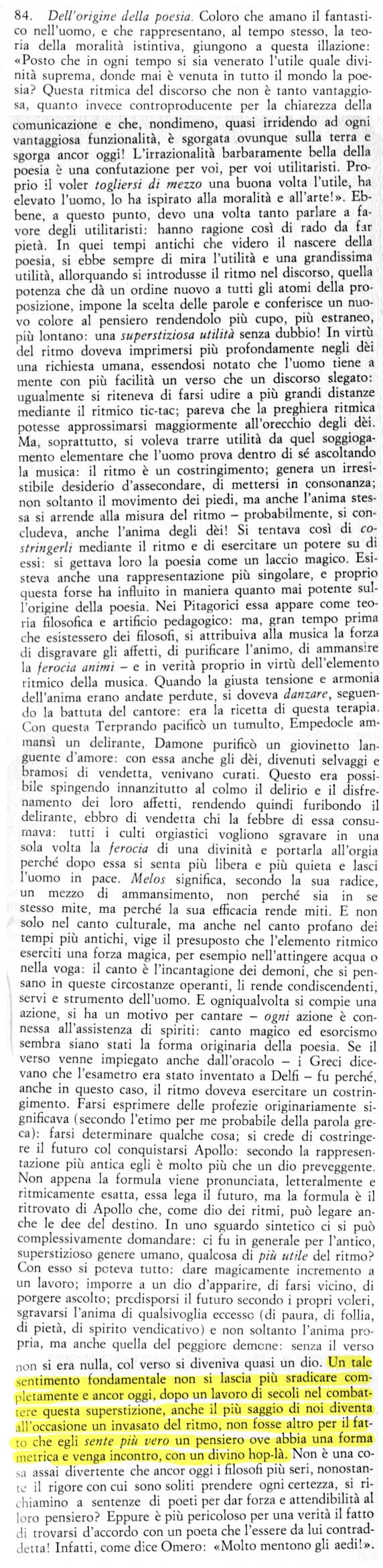
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email




















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco









Commenti recenti