Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.


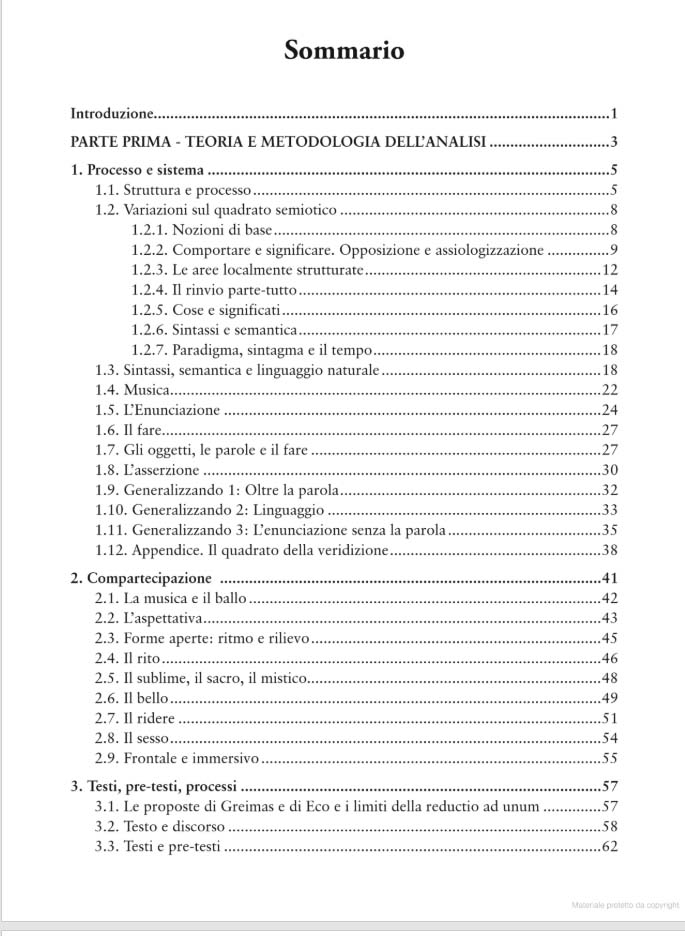
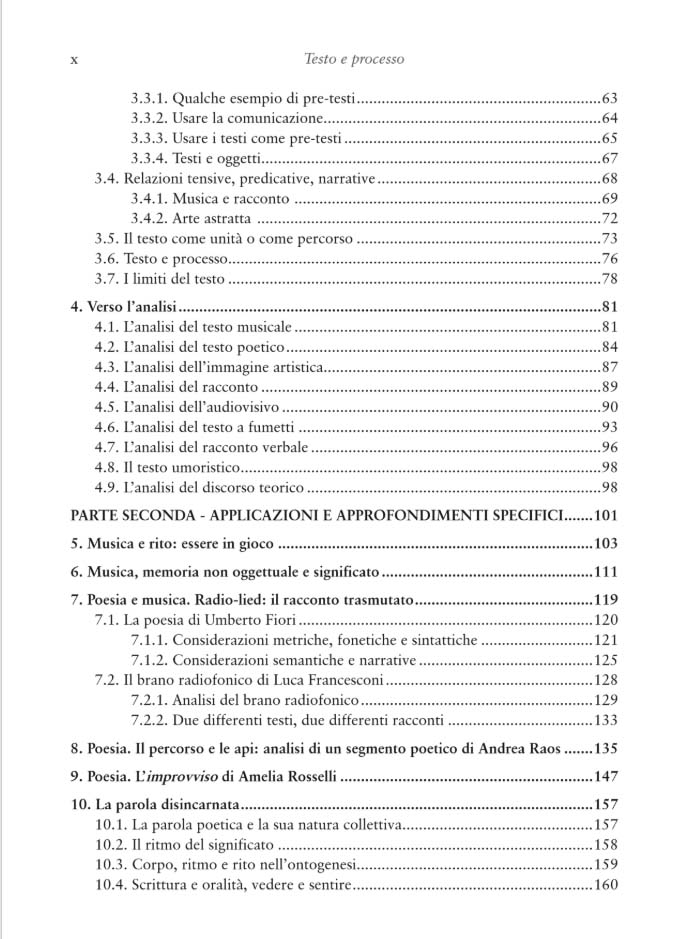
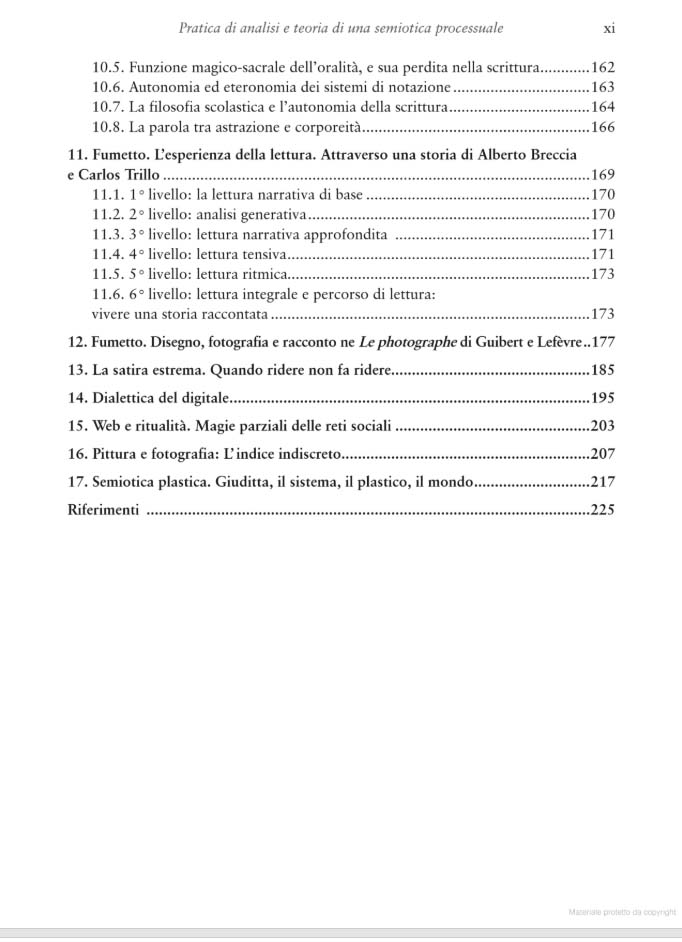

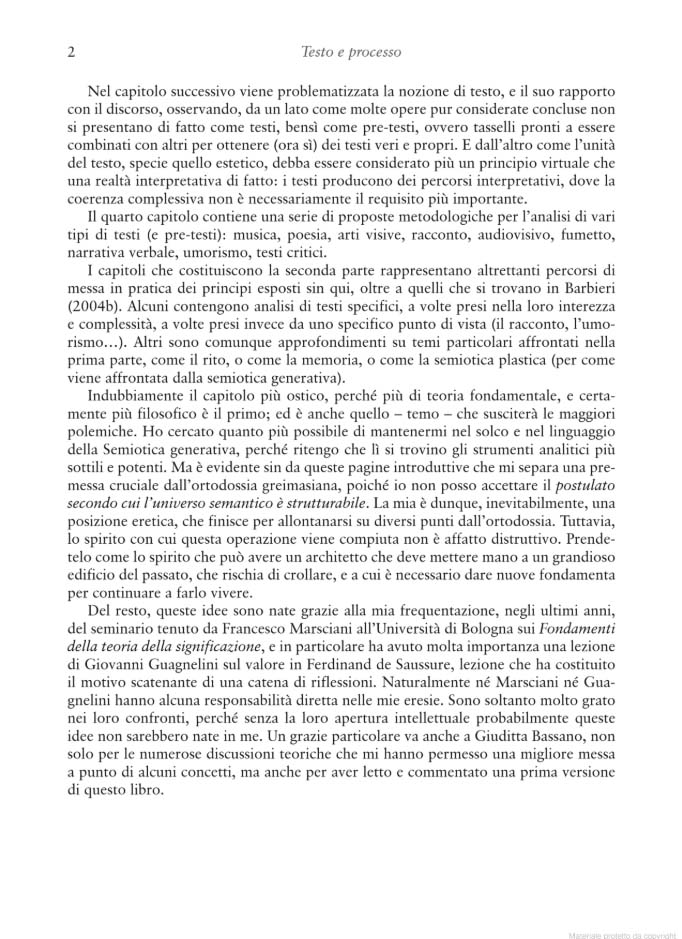
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
Comunque sia, tra vedere il libro sullo scaffale della libreria mentre si cerca un regalo per altri e decidere di farne un regalo per se stessi, date queste premesse, è questione di un attimo. Le vacanza e un po’ di influenza l’occasione per leggerlo praticamente al volo (e poi è un libro breve, leggibile e ben scritto, che vi farà ben tollerare un po’ di tecnicismi musicali negli ultimi capitoli, e sarà l’occasione – come è stato per me – di riascoltare un po’ di Zappa, che non fa mai male). Come già mi è capitato di scrivere qui, Zappa è un caso particolarmente significativo per chi sia interessato al tema del rapporto tra la musica cosiddetta colta e tutta l’altra musica. I più lo conoscono per il suo contributo al rock, per i suoi bellissimi dischi e i suoi straordinari concerti, per il suo spirito dissacrante (pensate solo a titoli come Hot Rats, We’re Only In It For The Money o Zoot Allures) e le sue capacità di solista improvvisatore alla chitarra. Una quantità molto minore di ascoltatori conosce il suo contributo alla musica tradizionalmente chiamata colta, con dischi come The Perfect Stranger (1984) con Pierre Boulez che dirige l’Ensemble InterContemporain oppure The Yellow Shark (1993) con Ensemble Modern. Zappa è affascinante, a guardar bene, perché è sempre da un’altra parte: poteva benissimo limitarsi a fare il grande compositore e ne aveva tutte le doti. Del resto era cresciuto ascoltando Edgar Varèse e Igor Stravinskij, e nella interminabile lista di ringraziamenti che appare all’interno della copertina di Freak Out, il suo primo disco rock, la parte del leone spetta a compositori di area colta, come Arnold Schönberg, Luigi Nono, Pierre Boulez, Anton Webern, Karlheinz Stockhausen, Charles Ives, Mauricio Kagel (pag. 29 del libro di Montecchi). Eppure non era quella la sua strada. Zappa non ha problemi a dichiarare che si è dedicato alla musica perché gli piaceva (pag. 36 segg.) e perché riteneva dovesse piacere ai suoi ascoltatori. Si tratta di una dichiarazione singolare per un musicista che cresce all’ombra di un’avanguardia su cui pesa come un macigno l’opposizione adorniana di arte autentica e inautentica.
Sin qui, le parole dello stesso Zappa. Adesso cito invece Montecchi (pag. 39):
La visione adorniana dell’arte ha inevitabilmente una vittima illustre, e cioè il corpo. Si poteva forse permettere a un’arte innocente di coinvolgere il corpo nel proprio gioco (come la musica può fare con la pulsione ritmica), ma nel mondo del capitalismo e della cultura di massa non è più possibile un’arte innocente, e il coinvolgimento del corpo va evitato come tutte le falsificazioni. Per questo motivo la musica delle avanguardie è una musica tutta cerebrale, dove viene sistematicamente evitata qualsiasi possibilità di coinvolgimento del corpo. Ed è esattamente questo rifiuto che Zappa non può accettare. Io credo che Zappa capisca bene che l’estetica adorniana si basa su un fraintendimento, e cioè su una visione fondamentalmente cognitiva dell’arte e del bello. È arte quello che ci disvela il male del mondo, ovvero che ce lo fa conoscere. Ora, che l’arte sia uno strumento di conoscenza è difficile dubitarlo; ma questo non significa che sia necessario ridurla a questo, e nemmeno che sia necessario ritenere che sia questa la sua funzione principale. Zappa ha scelto il rock perché gli piaceva, e gli piaceva perché nel rock poteva evitare di pensare all’arte, alla musica, in termini essenzialmente cognitivi, come voleva Adorno e come facevano tutti i suoi colleghi colti di quegli anni. Persino il jazz, probabilmente, dal suo punto di vista pencolava pericolosamente verso quella direzione, in epoca di free jazz e avanguardia jazzistica. Bisognava piuttosto stare in un mondo “basso”, vile come quello del rock, non solo perché lì le sue provocazioni trovavano un senso, ma anche perché lì c’era la materia per costruire qualcosa di differente. Eppure, d’altra parte, i musicisti a cui parlava erano indubbiamente quelli colti, e per attrarre la loro attenzione sul suo discorso, sulla sua visione della musica, era necessario farsi dirigere da Pierre Boulez, da Kent Nagano, o da Zubin Mehta, con la London Symphony Orchestra. Non ci vuole molto, ascoltando Frank Zappa, a capire che la sua è sempre musica colta, molto colta, talvolta esageratamente colta. I riferimenti possibili non finiscono mai, e Montecchi ha buon gioco, nel suo libro, a illustrare la sua originalissima concezione ritmica e armonica, e le differenze che la contrappongono sia all’evoluzione della tradizione colta (nella direzione Schönberg-Webern-scuola di Darmstadt) sia a quella della tradizione jazz (il jazz modale, per esempio). Zappa resta nel rock perché lì si diverte, perché la musica può prendere il corpo e ci si può muovere con lei, perché l’ascolto non si fa solo con le orecchie e la testa, ma è una condivisione convissuta, compartecipata, dove chi la fa e chi l’ascolta non solo conoscono, ma vivono insieme, vibrano insieme. La tradizione colta occidentale ha percorso una strada finalizzata a una sempre maggiore astrazione dell’ascolto, a una sempre maggiore concettualizzazione della musica, di cui la teoria dell’ascolto strutturale di Adorno rappresenta l’esito estremo. Essere un musicista colto e basta vuol dire rinchiudersi e rinchiudere la propria musica in questi limiti. Per uscire dai limiti bisogna ripartire da capo da un’altra parte, in un campo sufficientemente vergine – senza dimenticare, però, tutto quello che dalla musica colta si può imparare. È anche molto bella la descrizione che Montecchi fa del metodo compositivo di Zappa, il quale raramente scrive i suoi pezzi rock, limitandosi ai temi e a qualche indicazione esecutiva, e giocando molto sull’improvvisazione propria e dei propri selezionatissimi collaboratori (leggendaria è sempre stata la sua durezza e pignoleria nelle esecuzioni). Ma una volta che le registrazioni sono state fatte, e più e più volte, il lavoro di montaggio di un disco richiede mesi di scelta degli a-solo meglio riusciti e meglio combinabili tra loro, per costruire qualcosa che all’ascolto apparirà come l’apoteosi dell’estemporaneo, e invece non lo è per nulla. Invece di lavorare con le note scritte sulla partitura, Zappa monta dei materiali già realizzati (a loro volta, magari, con una fortissima componente di improvvisazione) secondo una logica non così lontana da quella con cui lavora un regista cinematografico nel montare un film, adoperando le varie versioni di scene girate più volte per poter avere poi quelle che meglio funzionano e si combinano tra loro. Sino ad arrivare all’estremo di pezzi costruiti del tutto in sala di montaggio, come succede in “Rubber Shirt” (nel disco Sheik Yerbouti, 1979) in cui Zappa fa dialogare un basso e una batteria che di fatto non hanno suonato insieme (non si sono nemmeno sentiti), ma l’effetto è affascinante lo stesso. *** Mi domando se il mondo della poesia italiana possa imparare qualcosa da Zappa e dalla descrizione che ne dà Montecchi. Come accade alla musica colta, anche la poesia non è del tutto uscita dalle secche dell’adornismo. A guardare i dibattiti che ne muovono l’ambiente, a volte si ha la sensazione di uno scontro tra chi nell’adornismo ancora ci vive o non sa come uscirne e altri che di lì non ci sono nemmeno passati, e spesso non hanno neppure un’idea del problema. Per quanto io consideri l’adornismo un problema, credo che l’elusione dei problemi che esso pone costituisca un problema ancora peggiore. Nel mondo della poesia italiana di oggi questa opposizione ha come termini la cosiddetta poesia di ricerca da un lato e la poesia lirica dall’altro. Non è facile schiacciare su questa opposizione i termini della polemica di Zappa contro Adorno e l’avanguardia. Di sicuro Zappa, se fosse un poeta, non sarebbe un lirico; eppure troveremmo nella sua poesia ugualmente un rifiuto verso il cerebralismo delle avanguardie. Magari la differenza sta che nel limitato universo della poesia non c’è stato il rock né il jazz né nulla di tutto quello che rappresenta la ripresa (dopo una secolare esclusione) di improvvisazione e recupero del contatto diretto tra esecutore e pubblico. Magari quindi la differenza sta nel fatto che Zappa si è potuto appoggiare su una dimensione che alla musica è comunque connaturata (può essere messa in disparte, ma mai esclusa del tutto), mentre alla poesia non è possibile. E non voglio mettere in gioco la facile soluzione della poesia per musica, che è sì più diretta e coinvolgente, ma lo è perché si tratta di musica, non perché è poesia. E nemmeno credo che la poesia performativa, essenzialmente orale, da palcoscenico, da recitazione, possa fare la parte del rock, in questo senso: c’è troppa differenza tra le modalità di fruizione di un componimento scritto su una pagina e quelle di uno performato! Saranno magari le stesse parole, ma esse arrivano a noi attraverso canali diversi, con caratteristiche percettive diversissime! A dispetto della convenzione diffusa, che sostiene l’esperienza dei reading, sino all’apoteosi teatrale dei contest poetici, io credo che poesia scritta e poesia orale siano forme comunicative radicalmente diverse, in cui l’efficacia si misura in maniera del tutto diversa. Saranno magari le stesse parole a stagliarsi sulla carta bianca o a risuonare nell’aria, ma questo è tutto ciò che c’è in comune, e non è molto. Se non ci rendiamo conto di questo problema è perché siamo vittime della stessa concezione cognitiva dell’arte che è alla base dell’adornismo, e ragioneremo sempre in quei termini, affermandoli o negandoli, ma senza aggiungere nulla di nuovo. Se vogliamo capire l’utilità della proposta di Zappa per la poesia, credo che dobbiamo porci a un livello di astrazione più alto. Potremmo, per esempio, riconoscere che nel linguaggio tradizionale della lirica ci sono elementi comunque coinvolgenti, che permettono un piacere che, certo, arriva anche ad avere a che fare con l’intrattenimento. Che questi elementi lirici funzionino in questo modo su di noi è impossibile negarlo, perché sono proprio quelli su cui si basa eventualmente la persuasione, la propaganda, persino la pubblicità. La reazione, sdegnata, dell’estremista sarà quindi quella di escludere con decisione qualsiasi elemento che possa essere utilizzato in questo modo: ripulita dal lirismo, la poesia potrà avviarsi a svelare davvero l’angosciosa realtà del mondo; e potrà perseguire la sua vocazione oracolare senza pericolo di contaminarsi con il piacere. La reazione dell’estremista, in realtà, sta buttando via, con l’acqua sporca, anche il bambino. È esattamente questo che Zappa rimproverava alle avanguardie. Come si costruisce, nella tradizione italiana, una poesia che sappia usare il piacere della lirica senza cadere nelle secche del poetese, del banale, dello scontato, del pacificato, ovvero di tutto quello che Adorno molto giustamente (qui sì) criticava?
Un pensierino sulla musica per rompere il silenzio. Mi è balzato come un’evidenza alla mente mentre ero in macchina e scorreva una musica su RAI3, della quale non sapevo cosa fosse, ma poteva essere un brano americano del 900, non Gershwin ma qualcuno che si sia ispirato a lui. Non è la qualità del brano che importa, ma il fatto che fosse chiaramente un discorso colto sulla musica che è più frequentemente nell’aria, jazz o altro che sia (non che il jazz non sia colto; semplicemente qui era un oggetto del discorso). Ciò che ha reso la musica un’arte, in Occidente e in poche altre parti del mondo, è stata la sua capacità di porsi come riflessione e discorso su qualcosa, e in questo senso destinarsi al semplice ascolto, attento e consapevole. Ma poteva benissimo non andare così. Non è andata così, per esempio, in tante parti del mondo, la cui musica è rimasta un evento da partecipare, ballando o cantando o suonando o vivendo la situazione pubblica cui la musica fornisce il sottofondo. Anche in Occidente, sino a qualche secolo fa, la musica era questo – e, mi preme sottolinearlo, non era più bella o più brutta di quella che è seguita: non è questo il punto. La trasformazione, quando e dove c’è stata, è stata da evento compartecipato a discorso da seguire e comprendere (comprendere magari sentimentalmente, non necessariamente per via intellettuale; ma in certi casi anche intellettualmente, come per tante cose di Bach). Poteva non andare così. Oggi ci appare ovvio che la musica sia questo, ma le cose ci appaiono così proprio perché è andata in questo modo. Poteva forse accadere nell’universo del tattile? Avremmo, in questo caso, un’arte degli oggetti da toccare, capace di trasmettere discorsi complessi come fa la musica. Magari l’universo tattile non è in grado di articolare lo stesso livello di complessità che possono articolare i suoni: e certamente questa potenzialità dell’universo sonoro giustifica la possibilità dell’evoluzione della musica in Occidente. Ovvero mi mostra che esistono i presupposti, ma non mi spiega perché questi presupposti si sono sviluppati – e soprattutto perché si sono sviluppati soprattutto in Occidente, in misura minore in India e Iran (sempre universo indoeuropeo), e ancora meno altrove. Pensare che perché esistevano le possibilità, queste dovevano necessariamente svilupparsi, mi pare un errore. Il campo della matematica astratta possiede un’articolazione concettuale che è forse ancora maggiore, ma questo non ne ha fatto un’arte, nel senso di una forma di discorso in grado di muovere le nostre emozioni. Forse è necessaria una radice compartecipativa, da cui la complessità possa emergere? Ma allora la pittura, che è certamente un’arte, come lo è diventata, visto che – per sua stessa natura – non ha mai potuto essere compartecipativa? Pensiamo alla cucina, alla gastronomia. A certi livelli di alta cucina, possiamo forse davvero parlare di arte. Tuttavia, mentre riconosciamo alla musica la capacità di parlare, eventualmente, dei mali del mondo, o dell’angoscia, riconosceremmo mai la qualità della creazione di uno chef che fa riferimento alla tristezza, o allo struggimento, o alla morte? Woody Allen scrisse su questo tema un racconto molto divertente, immaginando delle recensioni alle creazioni di grandi chef come se si trattasse di dipinti; e l’effetto paradossale ed esilarante stava proprio nell’impossibilità di utilizzare quel tipo di discorso critico per delle opere d’arte culinaria. Per cui, forse l’alta cucina, a certi livelli, è davvero un’arte; ma ci appare così difficile e limitata la sua possibilità di discorso che facciamo fatica ad attribuirle questa qualifica. Poteva andare così, magari, anche alla musica. Poteva accadere che certi suoni, o combinazioni di suoni, dovessero essere rifiutati alla base, a prescindere dal loro ruolo testuale, proprio come faremmo se la pietanza che ci viene messa nel piatto sapesse di cacca: poco ci importerebbe il discorso; la rifiuteremmo con sdegno e basta. Del resto, l’atteggiamento di molti ascoltatori di fronte a certe sonorità difficili della musica colta del Novecento è esattamente dello stesso tipo. E forse non aveva tutti i torti Adorno a definire gastronomica la loro modalità di fruizione – anche se volessimo (e vorremmo!) eliminare dal termine tutta l’acrimonia dispregiativa che Adorno sembra intenderci mettere. Quello che Adorno sembra dimenticare, infatti, è che la musica, pure quella delle avanguardie, per quanto sia discorso non è mai soltanto discorso, e una qualche componente compartecipativa rimane in gioco persino nelle musiche più astruse. Comunque davvero poteva non andare come è andata. E poteva magari svilupparsi qualche altra arte. Non sarà che la nostra prospettiva europocentrica ci sta impedendo di accorgerci che qualcosa del genere altrove esiste?
Ma se ne producono tanti! o almeno, vengono prodotti tanti testi che aspirano a essere artistici, cioè a ricoprire questo ruolo mitologizzante, che trasforma la quotidianità in leggenda, fornendo un senso alla banalità del mondo. Ne vengono prodotti tanti, ma sono pochi quelli che riescono davvero ad assolvere il proprio ruolo. La critica non serve principalmente a fornire delle chiavi di lettura dei testi artistici, anche se qualche volta per fortuna lo fa. Il suo scopo principale, mi sembra, è sacralizzare, mitologizzare i testi (gli autori) di cui sceglie di occuparsi. Insomma, se gli artisti, quelli veri, sono i sacerdoti del mondo, poiché producono opere che danno senso al mondo, i critici sono i sacerdoti degli artisti, poiché fanno sì che un artista (un creatore di miti) possa essere riconosciuto come tale. Così, artisti e critici sono tutti creatori di miti, pur secondo ambiti diversi e con strumenti diversi. I critici rendono mitici gli artisti che sanno rendere mitico il mondo. E chi rende mitici i critici? Be’, di nuovo i critici stessi, citandosi e riferendosi a. (In questo senso, in forma più debole, anche il pubblico è formato di critici, almeno nella misura in cui si scambia opinioni su quello che ha letto/visto/ascoltato) Si può fare a meno dei critici? Evidentemente no. Se non si rendono mitici i testi, questi non possono rendere mitico il mondo. Quando i testi sono già mitici, come quelli di Omero, è proprio perché generazioni di critici (lettori compresi, evidentemente) li hanno resi tali. Senza Omero (o chi per lui) saremmo tutti più poveri; ma lo saremmo anche senza coloro che lo hanno reso un mito. L’universo del senso è, a quanto pare, un universo di valorizzazioni intrecciate, un castello di carte in cui la parte tiene su il tutto, e il tutto tiene su la parte. Quando crolla una carta, che cosa succede?
E, certo, tutto questo porta acqua al mulino dell’appello iniziale di Lello Voce, che reclama uno spazio anche critico per l’oralità in poesia – istigandomi alcune riflessioni. Sul fatto che la poesia metta in gioco un accordo collettivo, e quindi un collettivo fare (non soltanto di carattere intellettuale/interpretativo) non ho molti dubbi. Gran parte del mio libro Il linguaggio della poesia si basa proprio su considerazioni di questo tipo, e sul fatto che la poesia scritta viva comunque di una dimensione sonora virtuale ed evocata di cui non può in ogni caso fare a meno. Tuttavia, nella ricostruzione virtuale della voce che il lettore privato, individuale, di poesia è tenuto a compiere, proprio perché virtuale, interiore, non si realizzano certi aspetti di spettacolarità che mi pongono qualche problema nella poesia veramente vocalizzata. Mi spiego, perché la cosa non è affatto ovvia. Non sto condannando la spettacolarità in quanto tale, ma la sto contrapponendo alla partecipazione rituale. In altre parole, il bravo lettore privato di poesia scritta è costretto a vocalizzare il testo che legge, almeno intimamente, per comprenderlo; e, nel fare questo, egli lo sta in qualche modo vivendo, e interpretando nel senso in cui un pianista interpreta uno spartito (oltre a interpretare nel senso in cui si interpreta – ovvero si fornisce una comprensione a – un testo). Il bravo lettore privato, nel fare questo, sta cioè partecipando al rito del ricreare la magia orale nascosta nelle parole scritte. Quando il performer fa la stessa cosa di fronte a un pubblico è tuttavia lui solo quello che vive e interpreta (nel senso musicale), mentre al pubblico non resta che recepire e interpretare (nel senso semantico). La partecipazione non c’è più nello stesso modo: c’è invece lo spettacolo, un’azione a cui non partecipiamo ma assistiamo, non un fare ma un percepire/conoscere. È paradossale che la poesia nasca, storicamente, come oralità ponendosi come momento culminante di una situazione rituale compartecipata e agita da tutti, per ritrovarsi oggi a rinascere come oralità ponendosi fondamentalmente come spettacolo, ovvero negazione dell’azione collettiva, mentre quest’ultima si ritrova – certo in forme più pallide – semmai nella fruizione individuale mediata dalla scrittura. Evidentemente quell’azione che potrebbe apparire la stessa (declamare versi, o comunque parole ritmate) viene resa differente dalla trasformazione del contesto che la contiene. Certo c’è l’analogia con la musica, e il fatto che, a determinate condizioni e entro certi limiti, quest’ultima è ancora in grado oggi di costruire una situazione rituale e collettiva (anche se molta musica, specie quella colta, è prima di tutto spettacolo, cioè discorso rivolto al pubblico). Ma la partecipazione collettiva, nella fruizione musicale, si basa sostanzialmente sul moto corporeo, cioè sul fatto che con qualche parte del corpo (o magari tutte, se si arriva alla danza vera e propria) chi ascolta partecipa, fa. Questa componente partecipativa non svanisce mai del tutto in musica, e ne restano elementi persino nella musica più intellettuale e “discorsiva”. In questo senso, la musica colta rappresenta sempre un percorso tra dimensione partecipativa (collettiva) e dimensione discorsiva (da chi fa a chi ascolta, cioè spettacolare); e, tutto sommato, anche la musica più popolare costituisce un percorso di questo genere, solo molto più spostato dal lato della partecipazione. Io credo che anche la poesia viva di un analogo percorso tra partecipazione e discorso. E nel momento in cui noi leggiamo privatamente un testo poetico dobbiamo ri-farlo vocalmente (almeno con la voce interiore) mentre al tempo stesso ne comprendiamo il discorso. Se saltiamo una delle due fasi non stiamo fruendo poesia, bensì prosa, oppure musica. Il problema della poesia vocalizzata è che non necessariamente essa gode del medesimo privilegio compartecipativo di cui gode la musica. Non è detto che essa infatti spinga i nostri corpi a muoversi, a seguire il ritmo, a danzare. Paolo Giovannetti fa notare nel suo articolo che i tipi di oral poetry che il pubblico sembra apprezzare di più sono quelli fortemente ritmici, o per una ritmica del suono (posizione degli accenti, delle rime, in generale del battito, come nel rap), o per una ritmica del senso (parallelismi, antitesi, figure retoriche chiare del livello del senso). Credo che il punto sia proprio questo: le performance poetiche di questo tipo permettono al fruitore di partecipare attraverso il ritmo, di essere a propria volta attivo, di fare con il proprio corpo, di accordarsi a un sentire collettivo. Ma una poesia che funzioni bene in questo senso non è necessariamente una poesia che funziona bene anche per una fruizione personale e privata. La fruizione visiva, ottica, pur se accompagnata dalla voce interiore, si trova attratta da aspetti diversi da quelli da cui si trova attratta la fruizione acustica. In altre parole, per quanto io ami la poesia di Montale (tanto per fare un esempio tra mille ugualmente legittimi), troverei mortifera una pubblica lettura di testi suoi della durata di un’ora – a meno che già io non li conosca un poco a memoria, quei testi, o a meno che contemporaneamente non li possa avere sotto gli occhi. Montale (come quasi nessun poeta italiano da qualche secolo a questa parte) non ha scritto per essere ascoltato, bensì per essere letto (e magari poi, e insieme, anche ascoltato); nello scrivere, aveva la sua poesia sotto gli occhi, non nell’aria attorno a lui sotto forma di vibrazioni sonore. La poesia sonora/orale non può dunque essere semplice poesia scritta ben recitata. È piuttosto un linguaggio diverso, qualcosa che si deve basare su pertinenze diverse, perché richiede un’attenzione differente. Paradossalmente, la sua scrittura dovrebbe essere chiaramente marcata come una semplice partitura per l’esecuzione orale, per non confondersi con la poesia scritta, la cui scrittura non è semplicemente una partitura, bensì il suo modo principale (seppur non esclusivo) di essere. Il problema, dal punto di vista della fruizione, è che la poesia sonora/orale, almeno da noi, non ha tradizione; cioè non ha tradizione recente: quella antica e nobilissima è di fatto dimenticata, se non da pochi, e magari ricordata solo virtualmente e accademicamente. Il fatto di non avere tradizione si paga in vari modi: prima di tutto, il pubblico non sa bene come ascoltare questa roba (è poesia? è musica? cos’è?) e si attacca a ciò che riconosce (come spiega bene Giovannetti); in secondo luogo, quella parte privilegiata di pubblico che è la critica si trova nella medesima situazione, ma fatica ad ammetterlo, e continua a giudicare con gli strumenti che possiede, sempre a cavallo tra musica e poesia di tradizione scritta – strumenti che spesso si rivelano del tutto insufficienti (proprio come coloro – perdonatemi il paragone – che condannano il fumetto perché il suo disegno con è comparabile alla pittura e la sua scrittura non è comparabile al romanzo; peccato che il fumetto, benché apparentato con entrambi, sia una terza cosa). Sia per il pubblico che per la critica la costruzione di strumenti atti a recepire e/o a valutare non può essere il prodotto di un atto volonteroso. Le tradizioni si creano per stratificazione, non per costruzione volontaria. Quello che volontariamente si può fare è contribuire al formarsi di una tradizione, sospendendo o attenuando il giudizio sino a quando non ci si ritrova finalmente dentro – ma ci possono volere decenni, secoli… In assenza di una tradizione di riferimento, è persino difficile distinguere i livelli di qualità, separare il grano dal loglio. Forse in questa fase dovremmo ascoltare tutto, tollerare tutto, anche quello che non capiamo. Questo probabilmente non è davvero possibile, ma si tratta di una prospettiva da tenere presente comunque, nell’ascoltare oral poetry, specie quando riteniamo che non ci piaccia. Io non so se la poesia sonora/orale avrà futuro, però da quando l’epoca dell’oralità primaria è finita, questa è la prima epoca in cui le condizioni sociali e tecniche ne potrebbero permettere una rinascita. Ma non è il passato che ritorna: è una cosa nuova, per noi del tutto nuova, e come tale, io credo, siamo tenuti a considerarla. Per molto tempo Ravi Shankar è stato il mio principale, se non unico, accesso alla musica dell’India. Da quando ho iniziato ad ascoltarlo, l’ho sempre trovato appassionante, ed è tuttora così. In seguito, però, ho scoperto un intero universo musicale, anzi due, che provengono dal suo paese, e ho imparato che Shankar non era solo nemmeno a qualità. Non mancano davvero i musicisti straordinari, in India. A lui resta certamente il merito di aver appassionato l’Occidente a una musica così diversa dalla nostra (dalle nostre, tutti i generi compresi), diversa non solo nei timbri e nell’armonia, ma anche nelle modalità dell’ascolto – ed è questo l’aspetto più interessante. La musica colta occidentale, in linea di massima, chiede un ascolto consapevole e attivo; chiede che si segua con la massima attenzione possibile il discorso che passa attraverso le note. La danza, la canzone, la cerimonia e la celebrazione che caratterizzano la musica popolare, e tutta la musica occidentale sino a qualche secolo fa, nelle musica colta degli ultimi secoli continuano a essere presenti come base del discorso, come riferimento implicito o esplicito; una sorta di mattoni da costruzione (ancora carichi del loro valore orfico, o rituale, e comunque collettivo) per un discorso emotivo/sensuale/intellettuale (l’accento su quale di questi elementi dipenderà dall’autore e dal periodo). Anche se le sue basi sono orfiche, e continuano ad agire, la musica colta occidentale è in generale fatta per essere contemplata intellettualmente, come un discorso da persona a persona, come se Beethoven, Stockhausen, Coltrane o Hendrix, nel fare musica, stessero parlando a me (così come a ciascuno dei loro ascoltatori). Anche se il cosiddetto ascolto strutturale (di adorniana memoria) è più un mito che una realtà, si tratta però di un mito costitutivo: è raro che ascoltiamo davvero un brano di musica comprendendo pienamente l’evoluzione dei motivi, ma sappiamo benissimo che, idealmente, dovremmo fare così. Danzare mentalmente insieme con la musica non è affatto un’azione riprovevole, e va benissimo farlo, secondo me; però, limitarsi a questo vuol dire aver rinunciato a comprendere tutto il resto. Nella musica semplicemente da ballare, il resto non c’è (o quasi), e il discorso finisce più o meno lì; ma nella musica colta, di qualunque genere sia, è proprio il resto che fa la differenza. La musica di Ravi Shankar, e in generale la musica indiana colta (nelle due tradizioni, indostana, del nord, e carnatica, del sud) chiede di essere ascoltata in un altro modo, io credo. Ho provato più volte ad ascoltare strutturalmente qualche esecuzione di raga. Qualcosa, indubbiamente, ne ho ricavato; però molto poco che giustificasse il piacere che quella musica mi stava donando. In questo, la differenza con l’ascolto, diciamo, di una sonata di Beethoven o anche di un pezzo di Miles Davis (che però credo che da Shankar alcune cose le abbia imparate), c’è: capire il senso di un passaggio beethoveniano mi dice sempre qualcosa anche sul piacere che mi dà. A forza di provare, e cercare il modo giusto per ascoltare, mi sono fatto l’idea che la musica colta indiana richieda un approccio diverso, un ascolto diverso. L’accento non è, direi, sul discorso, bensì ugualmente sulla condivisione di qualcosa. Quando si balla, la musica costituisce il fattore condiviso, all’interno del quale chi si trova al momento dentro il flusso musicale si deve accordare. Ma l’accordo collettivo si risolve nell’atto del ballare, che è un atto pratico (con tutti i suoi rivolti simbolici, certo – ma essi dipendono più dal ballare che dalla musica). Quando Shankar suona, io mi sento indotto a cercare un accordo con lui (e con chiunque altro ascolti) proprio come nella danza, solo che la musica è molto più complessa di quella necessaria a danzare. L’ascolto ideale dell’esecuzione di un raga – questa è l’idea che mi sono fatto – è una sorta di ascolto ipnotico, in cui io, insieme al musicista e a tutti gli altri ascoltatori (anche passati e futuri, se il brano è registrato) mi accordo non solo su un ritmo ma su un percorso di carattere emozionale di cui le note sono il tramite. Non sto dicendo che le note esprimono l’emozione del musicista; di questo mi interessa poco, in verità. Sto dicendo che il flusso di note è il medium attorno a cui io posso vivere un’esperienza emotiva complessa insieme con tutti coloro che stanno attorno a questa musica con me; una specie di danza intellettuale, che si sviluppa attraverso il tempo. Non che questo aspetto sia del tutto sconosciuto alla musica occidentale (né la musica indiana è del tutto priva della componente di discorso di cui sopra), ma in generale è piuttosto secondario – o relegato ai margini dell’ascolto. Dovrei dire che, mentre la musica occidentale privilegia la componente di discorso, quella indiana privilegia la componente rituale – a parità di complessità potenziale. Magari sono io che proietto anche sulla musica le categorie con cui già interpreto l’India rispetto all’Occidente: meno io e più collettività, meno affermazione della distanza tra sé e sé, e più interpenetrazione tra gli individui. Magari l’India funge da schermo (come spesso è successo) per proiettare l’Occidente che non è e che si vorrebbe che fosse. Ravi Shankar, primo tra tutti, è stato per me queste cose. Onore a Ravi Shankar.
Eppure esiste, e io lo so. Persino in questa stanza in cui sto scrivendo, che mi è estremamente familiare, vi sono innumerevoli aspetti e dettagli non percepiti, mai percepiti – non solo particolari che non c’è motivo di osservare, ma anche relazioni inosservate tra dettagli osservati e quindi noti. Insomma, io so di non sapere tutto della stanza in cui passo tante ore, e questo fatto non mi preoccupa minimamente: è normale che si viva in una realtà che sfugge in gran parte al senso, e non perché sia insensata, ma perché in gran parte non chiede di essere osservata – almeno sino a quando non arriva il suo momento. Tutto sommato, è una sensazione confortante quella di vivere in un mondo che mi permette di vivere (e magari pure con una certa comodità) anche se non lo comprendo del tutto. Non lo comprendo ma lo vivo, cioè lo attraverso trovando senso, volta per volta, in qualche sua parte. Naturalmente qualcosa devo capire, del mondo che ho attorno, e più ne capisco e meglio è. Ma vivere in un ambiente è accettare la dose di rischio che deriva dal fatto che qualche sua parte è ancora priva di senso per me; e che qualche sua parte priva di senso ci sarà sempre, per quanto io lo esplori e analizzi. Quando si ascolta un brano musicale, si legge una poesia, un racconto, una storia a fumetti, si guarda un film, un’immagine, e così via, ci si trova nella medesima situazione, con una differenza. L’ambiente in cui ci stiamo muovendo non è naturale, ma artificiale, cioè prodotto dall’uomo. Questo comporta che oltre al senso di base che hanno le cose in quanto percepite e interpretate, è presumibilmente presente anche un senso secondo, di carattere simbolico, attraverso cui passa la comunicazione umana. Anche qui, però, non tutto è percepito e non tutto, di conseguenza, arriva ad avere un senso: il testo viene vissuto, proprio come accade con un ambiente, e nel viverlo si sa di non sapere tutto, si sa che ci sono mille aspetti e dettagli che restano in attesa di arrivare a percezione. Questi aspetti e dettagli possono però agire su di noi anche se non ci accorgiamo esplicitamente di loro, anche se non siamo arrivati a dare loro un senso. L’andamento delle cose attorno a noi ci coinvolge anche se non ce ne rendiamo conto. Seguiamo un ritmo, per esempio. I testi artistici, o in generale estetici, vengono vissuti né più né meno degli ambienti del mondo. In questo senso non sono propriamente testi, nel senso in cui lo sono i testi informativi o persuasivi, cioè oggetti costruiti per trasmettere un discorso (che talvolta ha le forme del racconto). Poi, magari un testo artistico sarà anche informativo o persuasivo, perché comunque, sempre, il senso lo attraversa, in quanto prodotto da un autore umano. Tuttavia, ciò che lo rende tale è proprio la sua natura di ambiente, di luogo che va vissuto, attraversato, abitato. Per questo, anche se il lavoro sul significato è importantissimo per l’opera d’arte, l’opera d’arte non si esaurisce nel suo significato, proprio come il mondo stesso non si esaurisce nel senso che gli attribuiamo, perché le scoperte possibili che potrebbero rivoluzionare il senso già assestato sono sempre infinite e potenzialmente imminenti. E se l’opera non si esaurisce nel suo significato, vuol dire che c’è, nel rapporto che intratteniamo con lei, una dimensione di vissuto che rimane cruciale, un sapere che c’è qualcosa che non si sa, e ciononostante la realtà non ci rifiuta, anzi ci accetta, e ci permette di vivere con lei e in lei. L’opera d’arte è una realtà artificiale, fatta dall’uomo per l’uomo. Anche per questo, quando funziona, ci stiamo così bene dentro. Poesia e musica, e molto altro, sono discorsi fatti di mondo, e mondi costruiti di discorso. Una poesia non viene scritta per trasmettere un significato, ma per essere vissuta anche nel significato dei segni che la compongono. Ma siccome, in quel momento, la abitiamo, pure il suono, e l’aspetto visivo dei suoi segni sarà rilevante, proprio come nel mondo – a dispetto del fatto che non sappiamo che senso dare loro, o che non abbiamo la sensazione di accorgercene. Il fraintendimento corrente sta nel fatto che, siccome è fatta di parole, la poesia debba essere interpretata come un normale atto di parola, cioè per comunicare un discorso. Ma chi l’ha detto che un normale atto di parola serve solo a questo? In poesia è evidente che c’è dell’altro. La musica, non possedendo parole, ha evitato questo fraintendimento, ma il problema del suo significato ha ossessionato (e continua a ossessionare) generazioni di studiosi. Io credo che, per il bene del significato, dovremmo accorgerci che non sempre il significato è cruciale. Anche la musica vive una relazione dialettica tra significato e ambiente, dove spesso, sino a qualche secolo fa, il ruolo di trasmettere il significato era di nuovo demandato alla parola (e musica e poesia vivevano a stretto contatto). Poi la musica ha imparato a costruirsi i propri discorsi da sé, ed è diventata un poco più simile alla poesia anche senza fare uso di parole. Nonostante questo, anche nella più concettuosa e intellettuale musica di oggi, è del tutto evidente che per poter cogliere un qualsiasi senso bisogna già esservisi immersi, bisogna già attraversarla e abitarla. Sono andato a sentire, qualche giorno fa, Laura Pigozzi parlare di Billie Holiday. Laura Pigozzi è psicoanalista ma anche cantante jazz. Il ciclo era quello di Polifonia del femminile (info qui) a cui avevo partecipato anch’io l’anno scorso parlando di Diane Arbus. L’idea del ciclo di incontri è quella che il relatore parla di una donna che, per qualche motivo, l’ha colpito molto – e cerca di comunicarne al pubblico le ragioni. Sono sempre presentazioni molto sentite, dunque; e quella dell’altro giorno lo è stata particolarmente. Quando poi ci è stato mostrato un video del ’59 (l’anno in cui Billie è morta) in cui canta Strange Fruit, il pubblico era visibilmente commosso, me compreso. Io però non potevo fare a meno di pensare a un’altro resoconto emozionante su Billie Holiday, quello di José Muñoz e Carlos Sampayo, e una volta tornato a casa sono andato a rileggermelo. L’edizione italiana (Milano Libri – Rizzoli) è del 1993. In copertina c’è lei che canta, accompagnata da una coppia di pianisti dai capelli impomatati e con un’aria più latino- che afro-americana, in cui è difficile (ma non impossibile) riconoscere i volti dei due autori giovanissimi, all’età che potevano avere quando lei era ancora viva. Il disegno di Muñoz colpisce come sempre, cioè violentemente. Però, una volta tanto, vorrei parlare piuttosto della sceneggiatura di Sampayo – anche se bisogna sempre avvertire, parlando di loro, che l’interscambio tra i due autori è sempre molto forte, per cui non esiste una sceneggiatura precedente che viene poi messa su pagina con i disegni, bensì un lavoro comune di progetto e realizzazione nel quale Sampayo è soprattutto sceneggiatore (ma interviene anche nelle scelte grafiche) e Muñoz è soprattutto disegnatore (ma interviene anche nelle scelte narrative). Il racconto di questo libro è – diciamo così – polifonico: siamo al trentennale della morte della cantante, cioè il 17 luglio 1989, anzi, la notte prima; un giornalista che non sa nulla di lei viene incaricato di scrivere il pezzo per la commemorazione; non è molto contento di dover passare la notte in redazione, invece di raggiungere l’amante, che lo tempesta di telefonate; ma poi, inizia a scoprire la vita di lei, e ad appassionarsi alla cosa. Contemporaneamente, dall’altra parte della città, un uomo (nel quale chi conosce i lavori precedenti di Muñoz e Sampayo può riconoscere Alack Sinner) ascolta la voce della Holiday, e ricorda alcuni episodi che hanno intrecciato (marginalmente) la sua vita con quella di lei – e alla fine del libro andrà a posare un mazzo di fiori sulla sua tomba. Queste due diverse modalità di rievocazione (fredda e oggettiva – ma progressivamente sempre più partecipata – l’una, memore e appassionata l’altra) si intrecciano con i momenti della vita di lei, raccontati a questo punto senza un ordine preciso, ma seguendo ora l’una ora l’altra delle due rievocazioni: i difficili rapporti con i suoi uomini, che l’hanno sistematicamente sfruttata; la dipendenza dall’eroina e dall’alcol; i numerosi arresti; ma anche il rapporto singolare con Lester Young, il suo successo e la sua bellezza. Come pure la sistematica ignoranza della sua esistenza da parte dei bianchi, e l’adorazione, quasi venerazione, da parte dei neri. Certo, la vita di Billie Holiday si presta bene a un racconto dai toni forti; non c’è bisogno di pigiare sull’acceleratore dei sentimenti, perché tutto sembra già al massimo da sé: il genio e la capacità creativa, insieme all’assoluta incapacità di stare davvero al mondo, facendo le scelte – non dico giuste – ma almeno non troppo sbagliate. Insomma una tragedia (nel senso teatrale) bell’e pronta, sfornata dalla storia della sua vita, e tanto più forte perché tutta vera. Per questo Sampayo complica il gioco, e lo rende il racconto di un racconto, anzi di due; e Billie viene narrata attraverso il mito che la circonda, un mito fatto di luci spendenti e oscurità terribili, attraverso cui i sentimenti più dolci – come quelli che sembrano emergere dalla conversazione con Pres (Lester Young) si trovano presto sistematicamente annegati dalle durezze che li circondano – basate fondamentalmente sul pregiudizio, sull’incomprensione e sui luoghi comuni. Tutto questo viene raccontato per spezzoni, passando di colpo da un momento della vita di lei a un momento del presente, in cui il giornalista è incalzato dall’amante che lo aspetta, o Alack è sommerso dai ricordi, e poi di nuovo alla storia di lei. Ogni evento è un breve flash, un po’ più lungo o un po’ più corto, ma comunque sempre un frammento che emerge nel frastuono collettivo degli eventi, quelli del presente come quelli della storia, quelli individuali come quelli collettivi. Billie Holiday, il racconto a fumetti di Muñoz e Sampayo, è come una jam session in cui le voci soliste si alternano a scatti, emergendo sulla voce collettiva – la quale però rimane comunque ben presente, scandita dalla differenza e dai pregiudizi razziali. E la diversità di comportamento tra la comunità bianca e quella nera si riverbera anche nel presente, come quando il giornalista si accorge proprio studiando la vita di una donna nera che c’è lì, vicino a lui, un uomo delle pulizie nero, che lui non ha mai notato prima, ma che lavora in quel posto da ben 17 anni… La violenza della vita di ieri non è molto diversa da quella della vita di oggi, proprio come la difficile emersione dei sentimenti. Esemplare è la parabola di Rufus, uno degli uomini di lei che se ne approfitta e la maltratta (mentre lei lo difende sino all’ultimo), che la vita conduce all’umiltà, e si incontra con Alan sulla tomba di lei, a portare i fiori. Sampayo sa benissimo di maneggiare una materia pericolosa, che facilmente degenera nella retorica scandalistica dei quotidiani. Per questo gioca attraverso questi cambi fulminei di punto di vista, per cui siamo in un momento del tutto dentro alla storia di lei, vivamente compartecipi di quello che sente, e un momento dopo del tutto fuori, distaccati, quasi tecnici; e non c’è comunque tempo per la commozione, non c’è tempo per soffermarsi sui dettagli morbosi. Eppure, persino nella seconda modalità, quella cronachistica e distaccata, finiamo per coinvolgerci. Proprio come sulla copertina del libro, Muñoz e Sampayo si sentono evidentemente del tutto coinvolti. E pure noi, i lettori, lo siamo sin dalla prima pagina, quella in cui la voce di Billie parla dal mito che la accompagna: “Sfiorerò tutte le tonalità e vi farò sentire che la mia voce non è solo la voce di Billie, ma viene da una voce che è quella di tutti. Anche se solo io mi chiamavo Billie Holiday. Lady Day.” (traduzione: Fiorella Di Carlantonio) Qui mi metto nei pasticci da solo. Ci sono queste tre nozioni, dionisiaco, immersivo, improvvisazione, che sono imparentate ma non coincidono: stanno grosso modo dalla stessa parte, contrapponendosi ad apollineo, frontale, progetto. Tuttavia non coincidono perché posso immaginare un testo dionisiaco e immersivo ma progettato, qual è tutta la musica scritta; un testo dionisiaco e improvvisato ma frontale, come i dipinti di Pollock e i Kuang Cao di Zhang Xu, a meno che non fossero più studiati a tavolino di quanto sembrano, nel qual caso sarebbero ancora dionisiaci, ma frontali e progettati – quale può essere la musica stessa di fronte a un ascolto strutturale. Più difficile è immaginare un testo apollineo che non sia anche perlomeno progettato, ma potrebbe poi essere immersivo, come certamente era il teatro greco sognato da Nietzsche. L’apollineo semprerebbe incompatibile con l’improvvisazione, ma resta compatibile, seppur con qualche difficoltà, con l’immersione. Non c’è bisogno di spiegare le due coppie più note: apollineo vs dionisiaco, e progetto vs improvvisazione. Qualche parole va invece spesa sull’opposizione frontale vs immersivo, di cui faccio uso nel mio libro Il linguaggio della poesia. Cito dall’Introduzione, che si può leggere interamente su questo blog:
Un’esperienza immersiva è quindi una condizione favorevole, ma non esclusiva, al presentarsi del dionisiaco: posso comunque immaginare una musica (tendenzialmente) apollinea, o un dipinto (tendenzialmente) dionisiaco. Immersivo e frontale sono perfettamente compatibili entrambi con il progettato e con l’improvvisato: eppure, quando si parla di musica scritta, non si può trascurare la componente dell’interpretazione musicale, e la sua parte inevitabile di improvvisazione – per cui può benissimo capitare che lo stesso brano interpretato dal medesimo interprete in due occasioni diverse possa entusiasmarci in un caso e deluderci in un altro. E, d’altra parte, i pittori non sono tutti iperprogettuali come Mondrian, e sappiamo bene quanta parte del gusto della fruizione stia nel vedere la pennellata, che rimanda al gesto della mano dell’artista, che possiamo quasi sentire nella nostra carne – anche senza arrivare agli estremi di Pollock e Zhang Xu. Da che parte sta la poesia? Finché la poesia sta scritta, sembra un’arte frontale; ma la poesia chiede di essere recitata, almeno interiormente; e, chiedendo la voce, diventa suono, e si manifesta come un’arte immersiva quasi quanto la musica. Ci chiede di andare col suo ritmo, di intonarci col suo senso: può assumere certo anche aspetti apollinei, specie se se ne enfatizza la dimensione scritta, visiva (come, per esempio, nella poesia concreta), ma la sua natura è dionisiaca, specie da un secolo (o poco più) a questa parte. Non è improvvisata ma progettata, lungamente e con attenzione; anche se, certo, qualche elemento di improvvisazione rimane nella lettura ad alta voce, proprio come nell’esecuzione musicale. Tuttavia, mentre in musica si può improvvisare anche tutto, questo in poesia è quasi impossibile – e anche i poeti da braccio, per quel che ne rimane, lavorano su canovacci ben assestati; e gli aedi dell’antichità o dei Balcani o dei LoDagaa facevano variazioni su sequenze tradizionali ben note. L’opposizione progetto vs improvvisazione riguarda l’esperienza del produttore; quella frontale vs immersivo riguarda il canale e l’esperienza percettiva del fruitore; quella apollineo vs dionisiaco riguarda l’esperienza emotiva del fruitore. La musica ci fornisce i casi canonici in cui l’improvvisazione del produttore si trasmette come trasporto emotivo al fruitore per comune immersione nel suono; la scultura (tanto per essere nietzschiani sino in fondo) ci fornisce i casi canonici in cui il progetto del produttore produce un’esperienza apollinea attraverso il distacco frontale del vedere. Ma i casi intrecciati sono innumerevoli. La tragedia che incantava il giovane Nietzsche si vedeva e si ascoltava insieme, era progettata in quanto scritta e improvvisata in quanto recitata in pubblico: per questo poteva apparire ai suoi occhi un perfetto equilibrio di apollineo e dionisiaco. Socrate e Platone, agli occhi di Nietzsche, hanno decretato il trionfo dell’apollineo. Ma, con un certo numero di eccezioni, la modernità sembra votata piuttosto al dionisiaco. Che rapporto c’è tra il dionisiaco nietzschiano e il sublime di Boileau, di Burke e di Kant? Guardando le cose in questo modo, ci appare dionisiaca persino l’arte di Mondrian, che certamente non era né improvvisata né immersiva.
Avrei letto di corsa una graphic novel su Alan Lomax anche se l’avesse realizzata il peggiore fumettista del mondo. E, certo, nel timore di restare deluso, l’avrei letta tenendola con le pinze, attento a tutto. E invece mi è andata bene, molto bene, con questo Lomax. Ricercatori di folk songs, realizzata da Frantz Duchazeau. Alan Lomax (1915-2002) è quasi un personaggio mitologico, al pari dei vari Woody Guthrie, Jelly Roll Morton, Lead Belly, che lui scoprì o con cui collaborò. È colui che ha dato voce modiale a tutta quella musica che non era mai stata scritta, e quasi mai registrata, perché realizzata da chi non la sapeva scrivere e non aveva legami con l’industria musicale. È colui che, insieme, al principio, con suo padre John – che fu il vero iniziatore della ricerca – raccolse una mole impressionante di documenti musicali popolari da tutte le parti degli Stati Uniti e del mondo, scoprendo non solo una quantità di talenti, ma facendo soprattutto conoscere al mondo un universo sonoro sommerso e di solito remoto. Se volete sapere che musica facessero gli indiani (dell’India) trapiantati nelle Indie Occidentali, e in particolare nei Caraibi, Lomax l’ha registrata. La voce degli schiavi negri, dei reclusi nelle prigioni americane, dei cowboy texani (quelli veri però, non il country), ma anche quella delle Antille, dei cantanti popolari scozzesi, dell’Estremadura, della Yugoslavia, della Sicilia, dei trallalleri di Genova, lui le ha registrate tutte, per strada, nelle case, andando a cercare le persone. Era in contatto, attraverso Diego Carpitella, con Ernesto De Martino, e registrava le musica nel Salento nei primi anni Cinquanta, otto anni prima che il medesimo De Martino pubblicasse La terra del rimorso. Lomax ha raccolto e ci ha lasciato un patrimonio etnomusicale straordinario, e senza il suo lavoro non ci sarebbe stato nemmeno un Bob Dylan, a raccoglierne una delle tracce. Mi basta sentire il suo nome per pensare a un’esperienza favolosa, eccezionale, di quelle che in altre epoche davano vita alle leggende, e un po’ lo fanno anche oggi. Frantz Duchazeau se la cava molto bene, bisogna dire. Mette in scena un momento in cui i due Lomax, padre e figlio, stanno iniziando la propria campagna di registrazioni, negli Stati del Sud, tra sceriffi ostili, possidenti increduli e contadini diffidenti. John, il padre, è mosso da un entusiasmo fervido. Alan, che non ha ancora vent’anni, è naturalmente più timido, ma si capisce che è ugualmente appassionato. Ci sono mille problemi, a partire dal far capire il senso del voler registrare quella roba, ma ci sono anche un sacco di soddisfazioni – persino nei luoghi più assurdi, persino nelle prigioni, dove i Lomax scoprono un vero talento, Lead Belly (qui potete sentire la canzone di cui stanno parlando nelle pagine riportate sopra, e qui un’altra, ancora più bella). Il racconto di Duchazeau scorre come il suo tratto grafico fluido, fatto di linee lunghe e molto modulate, ma anche di forme essenziali, concise, quasi senza sfondi. È un poco caricaturale, appena appena grottesco, vagamente scherzoso mentre si capisce quanto sia serio quello che sta succedendo. I due Lomax stanno letteralmente dando voce a un popolo, quello dei neri di America, mostrando che al di là delle emergenze già riconosciute del jazz e del blues, esiste anche uno straordinario universo popolare sommerso. Insomma: cerco di parlare di Duchazeau, e finisco sempre per parlare dei Lomax. La mia passione per la musica, almeno qui, è più forte di quella per il fumetto. Ma è anche un segno che Duchazeau ha lavorato bene, e ha saputo tener viva la magia (il mondo magico, direbbe De Martino), restando leggero, con un’ironia affettuosa. Gli sono grado per avermi ricondotto per qualche attimo a Lomax, per averlo fatto con gentilezza e con una passione che evidentemente è molto simile alla mia. Negli ultimi decenni del Cinquecento, a Firenze, un gruppo di intellettuali innamorati di un mito prese un gigantesco granchio storico, e sulla base di quello inventò una delle forme artistiche di maggior successo dei secoli a venire: il Melodramma, detto anche Opera Lirica, o Teatro musicale. Bardi, Galilei (Vincenzo, padre di Galileo), Rinuccini, Peri, Caccini, de’ Cavalieri e Mei credevano di stare facendo rivivere la recitazione musicata dell’antica Grecia. Ancora oggi non abbiamo un’idea chiara di cosa accadesse in verità nei teatri dell’antica Atene, ma di sicuro non è quello che loro credevano. Tuttavia, sulla base di un principio errato, gli amici della Camerata fiorentina avevano fatto l’invenzione giusta, e gettato le basi per quattro secoli e più di ininterrotto successo. C’è un principio che potremmo definire multimediale all’origine del Melodramma: parola, musica e scena agiscono insieme per determinare uno spettacolo totale, insieme sonoro, verbale e visivo, di grande capacità di coinvolgimento. Certo, per loro si trattava principalmente di un’amplificazione della parola poetica, un recitar cantando in cui la musica doveva sostenere l’espressività, e la scena visiva fornire le coordinate narrative. Solo l’opera francese (pur creata da un italiano) cercherà il più a lungo possibile di mantenere questo modello. In Italia (e l’Italia in musica dettava legge) ci volle poco perché il bel canto trionfasse, facendo del libretto poco più che una scusa – e quindi pazienza se non era gran che. In seguito, certo, tra i librettisti c’è stato pure Da Ponte; ma la grande rivoluzione del Wort-Ton-Drama wagneriano, che a sua volta tornava a inseguire pervicacemente il mito di una musica che esprimesse l’emozione che il testo diceva, non si fonda certo sulle qualità di poeta di Wagner… Comunque andasse, nella storia del Melodramma, la componente musicale ha finito regolarmente per trionfare su quella poetica. Presumibilmente, quando parola e musica vengono emesse insieme, il portato emotivo della seconda finisce per mangiarsi quello della prima. Se poi c’è anche la componente visiva, cioè la scena (coi fondali, gli attori, l’azione drammatica), la parola conta ancora meno. Non potrebbe scomparire, certo, perché la presenza di certe parole o espressioni chiave è quello che permette di capire lo sviluppo drammatico; ma tutte quelle sottigliezze poetiche che potrebbe avere, o che magari che la parola davvero ha, finiscono poco o per nulla percepite. E allora, perché sforzarsi per mettercele? poco ascoltato per poco ascoltato, un testo banale varrà praticamente come uno interessante! Questo resta vero anche per le canzoni di oggi. Quanti sono i cantautori che scrivono testi che reggerebbero anche senza la musica? Quanto davvero ci importa dei testi di tante canzoni, anche belle, se non come il supporto su cui articolarne le note? Quanto ci importa delle qualità dei librettisti dell’opera? Sorridiamo con ironia nel leggere certi testi, ma poi La Traviata resta La Traviata! Poesia e musica sono state a lungo molto vicine. Così vicine che, se si generalizza quello che abbiamo appena detto, viene il sospetto che la poesia si sia separata dalla musica, sostanzialmente diventando poesia scritta, per acquisire visibilità. E la parola magica, visibilità, mi è uscita quasi accidentalmente: la poesia sarebbe quindi stata scritta per poter essere finalmente vista (e non solo udita), ma anche per acquisire un’autonomia che la sottraesse al dominio della musica, rendendola anche culturalmente visibile. Poi, certo, la poesia ha continuato a prestarsi alla musica: l’essenziale è il possedere anche una dimensione che sia interamente propria, non il sottrarsi a quelle condivise. Piccola cucina cannibale è un’opera a tre mani: il poeta (e performer) Lello Voce, il musicista Frank Nemola, il disegnatore Claudio Calia. Ritrovo, nel loro lavoro, lo spirito mitologico e utopistico della Camerata fiorentina, e la stessa propensione a realizzare un’opera che coinvolga la parola come il suono come l’immagine. Il mito non è forse quello della grecità, ma quello della voce come essenza profonda della poesia, nella sua arcaica radice orale – ma certo è anche, in fin dei conti, quello della grecità, se pensiamo all’aedo Omero, quando la scrittura non era ancora stata adottata. E la multimedialità non è quella del Melodramma, ma comunque qualcosa di più adatto all’epoca della riproducibilità tecnica: un libro scritto, con immagini disegnate, e un cd con le esecuzioni dei brani poetici, accompagnati da musiche. Il tutto è di ottima qualità. I testi poetici, che sono il centro del lavoro, si leggono e si ascoltano con piacere, accompagnati da belle musiche, con immagini evocative. Il risultato, qualunque cosa esso sia, è interessante, spesso coinvolgente… Alcuni pezzi, come la riscrittura della Canzone del maggio, o il componimento Il verbo essere, con cui si chiudono libro e disco, sono davvero memorabili. I testi di Voce, non c’è dubbio, reggono anche senza la musica. Eppure, nel loro essere stati concepiti evidentemente per la performance, guadagnano qualcosa mentre perdono qualcos’altro. E tanto più, questo, nell’esecuzione orale, accompagnata dalla musica, nella quale certamente il fatto di essere recitati (e non cantati) li mantiene comunque fortemente presenti, in netto primo piano. Guadagnano, direi, il portato della voce e dei suoi specifici andamenti e ritmi intonativi, e guadagnano l’intorno emotivo della musica, e quello visivo della scena che in verità non vediamo ma che ci viene in parte restituito dai disegni di Calia. Guadagnano quindi in complessità, in ricchezza. Perdono però, mi sembra, in essenzialità, in nitidezza, in precisione. Perdono, presumibilmente, qualcosa che non sono particolarmente interessati ad avere. Come facevo osservare la scorsa settimana, è spesso l’andamento liturgico a essere l’elemento dominante in poesia, e tanto più nella sua versione orale. Quello che la poesia effettivamente dice non è necessariamente dominante rispetto a quello con cui essa ci chiede di metterci in sintonia. L’elemento rituale è indubbiamente più forte in una poesia fatta per l’ascolto, piuttosto che in una nata per la lettura concentrata. L’operazione di Lello Voce è indubbiamente legittima e interessante, ma corre il rischio di fare la fine del Melodramma: il successo storico, a dispetto del non essere ciò che avrebbe preteso di essere. E solleva un dubbio: tornare alle origini orali della poesia non ci mette a rischio di perdere quello che si è acquisito con la sua dimensione scritta? O, in altre parole: dopo tanti secoli di poesia scritta, quella orale e sonora è ancora poesia per noi? Siamo capaci di sentirla come tale, oppure la nostra sensibilità è ormai diversa, e chiediamo a ciò che chiamiamo poesia qualcosa di differente da quello che le veniva chiesto quando la poesia era davvero orale? E ancora. Se si rafforza l’elemento rituale, si indebolisce quello dell’io, quello dell’espressione emotiva. E questo appare in linea con le tendenze antiliriche che si agitano in questi giorni. Ma si tratta di una coincidenza apparente. O forse è davvero questa l’unica vera possibile riduzione dell’io, in poesia. Nelle altre, il soggetto tende sempre surrettiziamente a rientrare. Insomma, Lello, vai avanti, che la strada è interessante. Però permetterci di vedere le differenze, e di salvare non solo la tradizione orale, ma anche quella scritta, più vicina a noi e a quello che immaginiamo, quotidianamente, quando diciamo poesia.
Mi domanda uno studente se non ci sia qualche relazione tra l’action painting di Jackson Pollock (cui ho già dedicato in questi giorni due post, qui e qui) e la calligrafia cinese. Gli rispondo che non ho notizie precise in merito, ma la cosa mi sembra ugualmente piuttosto probabile, soprattutto pensando a Zhang Xu, un calligrafo dell’VIII secolo, perché queste cose girano da tempo in Occidente – e senza arrivare a questo estremo di precisione, basta considerare l’importanza del giapponismo e la presenza costante dell’immaginario visivo giapponese, calligrafia artistica compresa (il Giappone non è la Cina, certo, ma le loro tradizioni calligrafiche sono molto vicine). Poi faccio una ricerca rapida sul Web e trovo qua e là dei riferimenti non documentati, secondo i quali Pollock si sarebbe ispirato a Huai Su (il discepolo di Zhang Xu) e avrebbe dichiarato pubblicamente i propri debiti nei confronti della calligrafia cinese. Da nessuna parte mi viene fornito un riferimento preciso, per cui le propongo per come le ho trovate, mettendoci davanti un bel “è possibile che…”, “è plausibile che…”. Non mi interessa in verità approfondire di più, dal punto di vista storico. Che Pollock sia arrivato alla propria procedura su ispirazione dalla calligrafia cinese (o giapponese) oppure che ci sia arrivato per altre vie, comunque la somiglianza formale tra le due procedure e i loro risultati esiste. Quello che mi colpisce è che mentre in Occidente questo modo di procedere appare come una novità del XX secolo, in Cina è invece una procedura antica e tradizionale, oggetto di innumerevoli aneddoti (come la storiella del pittore, dell’imperatore e del granchio riportata da Calvino nella sezione “Rapidità” delle sue Lezioni Americane). E in ogni caso, anche se davvero Pollock si è ispirato alla procedura cinese, bisognava che lui stesso e l’ambiente che lo riceveva fossero pronti ad accogliere un approccio davvero diverso da quello normale per noi. La novità di Pollock in Occidente non sta tanto nella priorità data alla fluidità e continuità del gesto, quanto nel fatto che l’opera, il dipinto, propone di essere visto più come un indizio della danza creativa che l’autore ha effettuato nel comporlo, che non come una composizione plastica. Naturalmente non è che la composizione nei suoi dipinti sia irrilevante, così come non era irrilevante, per la pittura occidentale prima di Pollock, la natura indiziale dei tratti di colore per ricostruire la manualità del pittore. Quello che cambia, con Pollock, è il maggiore o minore rilievo da attribuirsi all’una o all’altra: quando guardiamo un dipinto, poniamo, di Kandinsky, è certamente molto più importante comprenderne la composizione, che non analizzare le pennellate per vedere come l’autore si sia mosso nel realizzarla. In Pollock succede invece il contrario, e nel corsivo selvaggio dei calligrafi cinesi pure. Questa differenza evidente ne sottende una più profonda, che riguarda il senso stesso della comunicazione espressiva: la potremmo descrivere come una differenza tra progettazione e improvvisazione. Questa opposizione, in Occidente, ci è tradizionalmente familiare in un contesto piuttosto piccolo, che contiene sostanzialmente la musica e il teatro, ed è dunque soltanto lì che possiamo facilmente analizzarla nel dettaglio. Tutte le altre arti, infatti, si basano su un supporto statico (o realizzano opere statiche, come la scultura o l’architettura); mentre la musica si manifesta soltanto nel divenire dell’esecuzione e dell’ascolto, e il teatro nel divenire della performance. Ma il teatro ha praticamente da sempre una sua versione scritta, e da oltre mille anni pure la musica può essere registrata su un supporto statico. È per questo che la dialettica tra progetto e improvvisazione caratterizza in maniera sostanziale queste due arti, per le quali il supporto statico è soltanto un espediente mnemonico (e progettuale), ma che vivono sostanzialmente della propria natura dinamica nell’atto stesso del proprio realizzarsi di fronte al pubblico. Prendiamo la musica, nella sua versione colta. L’a solo improvvisato (o cadenza) è una costante dei concerti per strumento e orchestra dal Settecento in poi, almeno sino a quando il fossilizzarsi della tradizione non lo trasforma a sua volta in un pezzo scritto, spesso da parte dell’autore medesimo del concerto; così che la libertà dell’esecutore si riduce alla scelta di una cadenza piuttosto che di un’altra. La musica colta occidentale è dunque nel corso della storia sempre più scritta, più progettata a monte. È solo nel momento in cui il jazz assume i caratteri della musica colta che il momento dell’improvvisazione torna in gioco, e ritorna legittimo nell’ascolto la comprensione della musica come tramite di uno stato del momento. Per quanto la scrittura permetta alla musica di raggiungere livelli di complessità impensabili in sua assenza, configurando la partitura come progetto preciso di un’esecuzione, c’è qualcosa di cruciale che viene perduto in questo. L’idea della musica come progetto si basa su, e insieme sostiene, una concezione formalistica, plastica, del flusso musicale, mettendo in secondo piano gli elementi di compresenza, compartecipazione, consonanza tra i partecipanti – quegli stessi elementi che vengono invece enfatizzati dalle performance improvvisative. Ma poiché la musica comunque non si risolve nella sua dimensione scritta, e comunque richiede di essere eseguita, essa non è mai del tutto riducibile alla propria costruzione formale, e le componenti gestuali, dirette, del momento, che caratterizzano l’esecuzione, non smettono mai di avere importanza. In questa prospettiva di carattere optocentrico, è chiaro come invece la comunicazione visiva possa davvero interamente risolversi nella costruzione formale – poiché non c’è necessità di alcuna trasformazione successiva, che possa metterla in discussione. Ciò che Pollock e i calligrafi cinesi hanno in comune è dunque proprio una certa riduzione dell’optocentrismo, a vantaggio di una valutazione del segno grafico che ha aspetti di tipo musicale, poiché mette (tendenzialmente) in sintonia il gesto del fruitore (che segue l’andamento) col gesto dell’autore (che lo ha creato). Dovremmo assumere, in questa prospettiva, che la cultura cinese sia tradizionalmente meno optocentrica della nostra, visto che mentre da noi si tende a una concezione visiva anche del sonoro, in essa vi sono tracce di una concezione di carattere musicale anche del visivo. Da noi, la valorizzazione dell’improvvisazione al di fuori del campo musicale (e teatrale) si fonda sulle conseguenze di una concezione romantica dell’arte come espressione dell’io, o della sua variante surrealista dove al posto dell’io viene messo l’inconscio. Ma è difficile postulare qualcosa di simile per la Cina dell’ottavo secolo – tanto più che questa concezione non è affatto necessaria per valorizzare l’improvvisazione. Magari è solo perché i Cinesi non hanno avuto Platone, e la scrittura è rimasta manifestazione della parola senza che la parola dovesse identificarsi col pensiero razionale, o logos. In principio c’era altro, evidentemente, là. Due settimane fa, rispondendo a un commento di Guglielmo Nigro su Miles Davis, mi è capitato di avvicinare l’ascolto di Free Jazz di Ornette Coleman alla visione di un dipinto di Jackson Pollock. Il paragone mi è uscito del tutto spontaneo, sul momento, ma vale la pena di rifletterci sopra in maniera più approfondita. Come ho scritto nel mio libro Guardare e leggere, credo che Pollock abbia introdotto in pittura la preminenza di una modalità di significazione che, pur essendo sempre esistita, è anche sempre stata però secondaria o addirittura marginale. Quando guardiamo un dipinto del Seicento, certamente quello che ci colpisce prima di tutto è la scena rappresentata, e poi, se siamo sufficientemente competenti, valutiamo la composizione plastica. Ma esiste anche il gusto e il senso dell’avvicinare lo sguardo a riconoscere il segno delle pennellate, a cercare di capire il gesto del pittore nello stendere quel colore sulla tela. Questo specifico gusto, attraverso il quale il segno pittorico non è più solo di tipo iconico (nella rappresentazione) o comunque genericamente visivo (nella composizione plastica), ma anche di tipo indicale (in quanto traccia di un evento reale – quello del gesto pittorico), non è veramente esercitabile su dipinti precedenti il XVII secolo. Non che non si potesse capire il gesto del pittore anche prima, dai tratti del colore, ma l’idea dell’ostentazione di una capacità virtuosistica del pennello, non dissimile da quella dello strumentista che fa musica, è un’idea tutta barocca. Ed è quindi in epoca barocca che l’idea del virtuosismo della pennellata diventa una componente possibile, collaterale ma non ininfluente, del senso complessivo di un dipinto. Nel dripping di Pollock, la rappresentazione non c’è più, e anche il valore della composizione plastica è minore rispetto a, poniamo, Kandinsky. Ha invece un grandissimo peso il sistema, indicale, dei percorsi: le tracce lasciate dal pennello sgocciolante che danno un’idea della danza del pittore, del ritmo del suo movimento – ed è la qualità di questa danza e di questo ritmo che finisce per fare la differenza tra i dripping di Pollock e quelli di chiunque altro. In questo senso, dunque, l’action painting di Pollock costruisce una sorta di pittura musicale. Ma attenzione a non portare la metafora troppo in là: un dipinto di Pollock, come questo Autumn Rhythm, non è fatto di un solo ritmo, o di una sola danza, ma di un complesso intreccio di mosse, che ritornano e si sovrappongono, spesso rendendo impossibile seguire davvero le singole linee. Nonostante questa confusione – o forse proprio grazie a questa “confusione” – il dipinto funziona; è forte, di grande impatto, produce una sensazione vitale di movimento e di danza. A ben guardare, poi, l’intreccio è tutt’altro che omogeneo, e appaiono zone più dense di segni e zone più vuote. La sensazione di ritmo e di danza è prodotta dallo spostamento dell’occhio e dell’attenzione su questi segni, e anche dal tornare e ritornare sulle stesse forme: di fatto, nel dipinto, il movimento non c’è, e siamo noi spettatori a produrlo attraverso un’interazione ricorrente con dei segni statici. Ora pensiamo a Free Jazz, di Ornette Coleman. Se lo pensiamo nel suo insieme, lo possiamo descrivere in maniera non così dissimile da come abbiamo descritto il dipinto di Pollock: ci sono una serie di danze o di ritmi (quelli dei vari solisti dei due quartetti) che si sovrappongono generando una sorta di “confusione”, dalla quale emergono con fatica (e spesso non emergono) le singole linee; ma poi ci sono zone più dense e anche zone più libere, nelle quali può emergere la voce e il percorso (la danza, il ritmo) volta per volta di uno o due dei solisti. Ma a questo punto le somiglianze finiscono, e salta agli occhi una differenza fondamentale, e cioè che mentre per vedere la struttura complessiva del dipinto e le sue macro-forme non ho che da allontanarmi un poco in modo da rendere meno evidenti i dettagli, per percepire la struttura complessiva del brano musicale non ho altra scelta che ricostruirlo mentalmente in maniera quasi-visiva, come uno schema complessivo. In altre parole, mentre la struttura complessiva di un dipinto è un fatto visivo né più né meno dei suoi dettagli, quella di un brano musicale non è più un fatto sonoro, a differenza dei suoi dettagli. Mentre il dipinto continua a essere presente all’osservazione e disponibile a essere ripercorso, la musica scorre ed è in ogni momento quella che è in quel momento, contro lo sfondo di quello che è stato prima e nella prospettiva di quello che sarà, ma, in ciascun momento specifico dell’ascolto, sfondo e prospettiva sono fatti virtuali, presenze soltanto mentali, fatti di memoria e di immaginazione. Free Jazz gioca programmaticamente sul fatto di non avere né futuro né passato, se non di breve durata: c’è sviluppo forse nelle singole improvvisazioni, ma non nel brano nel suo complesso. La libertà di cui godono i singoli esecutori impedisce al brano di avere un’evoluzione complessiva, e al massimo distinguiamo le fasi di improvvisazione collettiva da quelle delle improvvisazioni individuali. Nel dipinto di Pollock, la struttura complessiva c’è, ed è chiaramente dominante, ed è anzi ciò che evoca in noi il quadro ritmico complessivo, poi riproposto all’infinito dalle singole linee e dagli intrecci. Nel brano di Coleman le singole danze non hanno modo di creare una macro-danza che dia un senso all’insieme, e questo è, per me, il peccato di Free Jazz: l’utopia della libertà espressiva del singolo esecutore che rende impossibile all’ascoltatore una sintonizzazione complessiva con la musica, un possibile “andare a tempo” o “sentire il ritmo” con l’insieme. Al mio orecchio Free Jazz è pieno di bei momenti, che non riescono a costruire complessivamente una bella musica – e a lungo andare mi annoio. A quanto pare, dunque, la musica è fatta di elementi extra-sonori molto più di quanto la pittura sia fatta di elementi extra-visivi. E anche questo è certamente un effetto dell’optocentrismo di cui la musica patisce nella nostra cultura. L’idea di una musica fortemente improvvisata, come il jazz ha cercato di essere, va certamente nella direzione di un allontanamento dall’optocentrismo – ma la mia sensazione è che Coleman abbia sbagliato strada, perché – come scrivevo nella mia risposta a Nigro – se l’ascoltatore di Free Jazz vuole cercare una coerenza e un’evoluzione più generale di quella delle singole improvvisazioni è costretto a un forte lavoro concettuale, a una forte astrazione, che non è di carattere sonoro – e non è nemmeno più la percezione di una danza, o di un ritmo. Sembra quasi che dietro alla libertà illimitata dei solisti di Free Jazz ci sia un disegno fortemente razionalista, un progetto, termini (“disegno”, “progetto”, “immagine complessiva”) tutti relativi al campo del visivo. In altre parole, Coleman non avrebbe fatto un’operazione molto diversa da quella di un musicista della tradizione cosiddetta “colta” della musica occidentale – e in effetti lo vediamo facilmente in linea con un John Cage, e con la sua – intellettualissima – esaltazione del caso. Tutto questo discorso, ovviamente, non comporta che Free Jazz sia un “brutto disco”. Con il peso culturale che ha avuto non ha nemmeno senso parlarne in termini di brutto o di bello. Però ci permette di riconoscere che nella sostanza il progetto di Coleman finisce per andare nella direzione opposta a quella che dichiara, approdando a un intellettualismo jazzistico che caratterizzerà pesantemente i decenni successivi – anche in molti casi con risultati, peraltro, che alle mie orecchie suonano decisamente meno “noiosi”. L’optocentrismo non si sconfigge così facilmente. Forse non si sconfigge affatto. Forse non va nemmeno sconfitto. Ma ci sono altre strade, nel jazz e altrove, lungo le quali si vivono più suoni e si ricostruiscono meno (peraltro comunque indispensabili) astratte strutture. . È stato ascoltando e riascoltando in questi giorni brani di Miles Davis di diversi periodi che la cosa mi è saltata all’occhio, pardon, all’orecchio. Tra gli ultimi brani registrati dal vivo da Miles ce n’è uno del 1991, a Montreux, intitolato Solea. È la riproposizione di un vecchio brano del 1960, contenuto nell’album Sketches of Spain, con Gil Evans. L’originale potete ascoltarlo qui (se non lo tolgono prima, come è già successo – nel qual caso cercate “Miles Davis Solea”), ma è molto diverso dalla versione del ’91, con Quincy Jones, della quale non sono riuscito a trovare tracce nel Web – per cui conto sul fatto che lo possediate o che possiate procurarvelo. Bene, ascoltando la Solea del ’91 ho avuto un flash, e non ho potuto fare a meno di pensare a un brano di Conlon Nancarrow, lo Studio for Player Piano (cioè per pianola meccanica) n. 12, nella versione strumentale realizzata da Ensemble Modern. Ovviamente i due brani (quello di Davis e quello di Nancarrow-Ensemble Modern) sono molto diversi, e il collegamento è occasionale e momentaneo, anche se, quando c’è, molto forte. È anche interessante osservare che la Solea originale del 1960, pur essendo un bellissimo pezzo, non produce su di me il medesimo effetto – segno che non è il comune tema spagnolo a marcare la somiglianza tra Davis e Nancarrow. È semmai un certo modo di usare la voce della tromba, e di intonare certe cadenze sì spagnoleggianti, ma comunque non standard, e particolari tanto nel brano di Davis del 1991 quanto in quello di Nancarrow. È ancora interessante notare che la mia evocazione istintiva ascoltando la Solea del 1991 va direttamente alla versione orchestrale di Ensemble Modern, mentre è solo indiretta e più debole nei confronti dell’originale per pianola meccanica, segno che c’è qualcosa nella timbrica e nell’intonazione, più che nella struttura dei brani, a creare per me il collegamento. Mi diverte pensare che ci sia stato un qualche tipo di influsso in qualche direzione, e ho indagato sulle date e sui luoghi, trovando varie coincidenze, ma niente di probante. Nancarrow compone lo Studio n. 12 in qualche momento tra il 1950 e il ’60, più probabilmente verso la fine che verso l’inizio del decennio. Lo compone quindi prima dell’uscita di Sketches of Spain, che è del 1960. Che Davis o Evans potessero conoscere Nancarrow è tranquillamente da escludersi, poiché Nancarrow, pur essendo americano, viveva in isolamento a Città del Messico dal 1940, dove si era rifugiato in quanto comunista. La sua musica non era conosciuta da nessuno, e tale rimane sino a quando, verso la fine dei Settanta, una piccola etichetta californiana gli pubblica qualche disco con gli Studi, e uno di questi capita, a Parigi, tra le mani di György Ligeti, che se ne innamora, e fa conoscere Nancarrow all’ambiente della musica colta contemporanea, che in pochi anni lo riconosce come uno dei maestri del Novecento. La performance di Solea che mi colpisce è invece del 1991. Ho ipotizzato che Ensemble Modern o qualcuno del gruppo potesse trovarsi a Montreux nel luglio di quell’anno; ma ho scoperto invece che in quei giorni erano negli Stati Uniti, a casa di Frank Zappa (grande ammiratore a sua volta di Nancarrow), per studiare la sua musica con lui. Dal lavoro con Zappa uscirà nel 1993 il disco The Yellow Shark. Il disco su Nancarrow è del ’92. A riprova dell’interesse di Ensemble Modern nei confronti del jazz c’è anche il disco, ancora del ’92, con le Two Compositions di Anthony Braxton (registrate nel 1989 e 1991). Se non erano presenti a Montreux, dunque, nonostante il possibile interesse, gli esecutori di Ensemble Modern non possono avere sentito l’esecuzione di Miles Davis, a meno che non ci fossero in giro dei bootleg – il che non è da escludersi. Ma su disco il pezzo uscirà solo qualche anno dopo; troppo tardi per rendere plausibile un collegamento. La coincidenza resta comunque interessante anche se non può essere giustificata storicamente. È ben possible che nel modo di usare la tromba per il pezzo di Nancarrow da parte del solista di Ensemble Modern un influsso di Miles ci sia, e che lo faccia emergere la casuale contiguità dei motivi musicali. E non si può escludere del tutto che Davis o Quincy Jones non avessero nel frattempo ascoltato quello studio di Nancarrow, nella versione originale – vista la pubblicità che gli andava facendo Zappa. Ma può anche benissimo darsi che sia davvero una convergenza del tutto fortuita. E la coincidenza continua a colpirmi lo stesso. Mi colpisce perché da un lato c’è un musicista accusato di essere pop e commerciale, e dall’altro un musicista che possiede invece tutti, ma davvero tutti, i crismi della non commerciabilità: Nancarrow ha vissuto nell’ombra, elaborando tra sé la sua musica straordinaria – ed è salito poi alla ribalta praticamente per una scoperta casuale. Insomma, possiede tutto quello che serve per diventare un divo dei duri e puri dell’anti-commercialità. A cavallo tra loro c’è Ensemble Modern, un gruppo che esegue musica da duri e puri, ma che ha l’intelligenza di guardarsi attorno – e guarda caso incrocia Frank Zappa, un personaggio che incarna l’ambivalenza dell’essere insieme pop e avanguardista; e incrocia Anthony Braxton, che è senz’altro un avanguardista, ma che esce dalla stessa tradizione di Miles Davis. Perché mi piacciono tanto questi inciuci? Credo che sia perché mostrano che le barriere tra i diversi generi musicali e tra ciò che è commerciale e ciò che non lo è sono davvero fatte di carta velina, e non reggono a un’osservazione più attenta. E poi ho avuto l’occasione, attraverso Miles, di riascoltare Nancarrow, che è davvero, io credo, uno dei grandi musicisti del Novecento, e che andrebbe studiato da tutti, a partire dai suoi terrificanti studi per pianola meccanica (ineseguibili al pianoforte – ed è per questo che Ensemble Modern li trasforma in pezzi per più strumenti, in modo che li si possa suonare), altrettanti esperimenti sulle possibilità di combinazioni di tempi e di ritmi, con un rigore e insieme un lirismo straordinari. Una musica indubbiamente cerebrale, però al tempo stesso – almeno per me – commovente, e talvolta entusiasmante; così diversa da quella di Davis che trovarmele per un attimo associate è comunque una sorpresa non da poco. Un po’ di cose di Nancarrow su Youtube ci sono. Se non le conoscete già, sarà una bella scoperta. Il bello di non essere un critico musicale è quello di poter dire quello che si pensa senza sentirsi impegnati a una verità universale, senza sentirsi troppo a rischio di dire castronerie, perché comunque quello che si mette in gioco è il proprio personale sentire, le proprie impressioni da dilettante – e non la Storia della Musica. È così che due settimane fa mi sono lanciato in alcune considerazione su Miles Davis, che mi davano l’occasione per arrivare invece a un discorso sull’avanguardia e sul difendere a oltranza le posizioni artistiche – argomento rispetto al quale mi riconosco più direttamente impegnato. Ma poi i commenti a quel post hanno riguardato nello specifico anche lo stesso Miles Davis, e mi sono ritrovato a promettere di cercare di capire (e di spiegare) perché il Miles elettrico e pop mi faccia l’effetto che mi fa – cioè mi piace moltissimo, mentre resto quasi indifferente alle sue performances più tradizionali sino al 1968. Per questo, dunque, nei giorni scorsi mi sono riascoltato un sacco di Davis, compresi brani del primo e del secondo quintetto, che hanno continuato a farmi lo stesso effetto di apprezzamento distaccato – mentre dalle prime note di Pharaoh’s Dance la mia attenzione ha avuto un balzo; e lo stesso succede con tanti dei brani dell’infinita serie di esecuzioni a Montreux (1973-91). Di qui a capire il perché di questo balzo il passo non è stato semplice. Stavo incominciando a pensare di smontare Pharaoh’s Dance o Bitches Brew (il brano che dà il titolo all’albo), un’operazione che spesso mi è stata decisamente utile per riuscire a capire qualcosa del mio oggetto di interesse, quando nella mia testa qualcosa è scattato. Di colpo ho visto un collegamento tra il Davis della svolta e tutto un altro genere di musica: la musica indiana dei raga. Ora, Miles Davis non usa né il sitar né altri strumenti indiani; armonie, melodie e ritmi non hanno nessuna parentela con quelli dei raga; non ho neanche idea (e non molto mi importa) se avesse avuto occasione di ascoltare Ravi Shankar, che già girava per l’Occidente a dar concerti dai tardi anni Cinquanta. Magari l’ha sentito e questo gli ha fatto scattare qualcosa; oppure non gli ha fatto scattare niente, e il suo percorso è stato un altro: non è questo che mi interessa. Mi interessa invece il fatto che i pezzi di Bitches Brew e tanti brani successivi di Davis hanno una struttura complessiva e prevedono una modalità di ascolto che è singolarmente simile a quella dei raga indiani: una modularità ossessiva-ricorsiva di fondo (spesso uniforme solo in apparenza, perché in realtà organizzata nella forma di un lento crescendo/accelerando attraverso una serie minimale di alterazioni) su cui si stagliano episodi improvvisativi che nascono l’uno dall’altro, e che sembrano a un certo punto morire nell’uniformità del fondo – salvo che il fondo in qualche modo ne ingloba gli effetti, e insensibilmente cresce. E tutto questo va ascoltato non con la razionale attenzione frontale dell’ascoltatore critico occidentale, che concepisce la musica come discorso e come sviluppo, e come tale la riconosce e segue; bensì con un atteggiamento ondeggiante tra quello frontale appena detto e una partecipazione rituale che va nella direzione del ballare, o del seguire corporalmente il ritmo, sino a una condizione di semi-trance. È questo che mi affascina delle esecuzioni dei raga indiani: non è che la sensazione di trovarsi di fronte a uno sviluppo e a un discorso (due capisaldi della musica colta occidentale e del suo ascolto – jazz compreso) scompaia, ma il discorso è talmente fatto di ripetizioni e riprese, in cui le variazioni si inseriscono fluidamente, che finisci facilmente per perderne il filo, rimanendo appeso solo alla componente di immersione nel flusso ritmico-melodico. Eppure l’esecuzione di un raga non è fatta della semplice ripetizione ossessiva di un ritmo o di un riff, ripetizione che soddisfa solo la dimensione dell'”andare a tempo”, e a lungo andare annoia. Al contrario, l’effetto immersivo, di semi-trance avvolta dal flusso musicale, viene costruita attraverso la presenza effettiva di un discorso musicale – che però fa parte del gioco senza poter diventare dominante. E questo è sufficiente a rendere impossibile per un raga quell’ascolto strutturale che tanta musica occidentale colta invece richiederebbe. Per godere di un raga devi cercare di seguirne il discorso, ma anche rassegnarti a vivere molto di più il suo flusso di quanto non capirai davvero il suo sviluppo – così che alla fine l’ascolto finisce per essere un’esperienza attiva piuttosto che cognitiva; o meglio, finisce per essere l’esperienza dell’immergersi in un flusso di cui tu cerchi di controllare cognitivamente la forma, mentre è lui che conduce te, a dispetto di tutti i tuoi sforzi. Bene. Senza nessuna parentela ritmica, melodica o armonica con la musica indiana, la musica di Miles Davis produce su di me lo stesso effetto: cioè quello di una musica che chiede sì di essere seguita cognitivamente come discorso e come sviluppo, ma solo per potersi immergere più intensamente e viverne attivamente il flusso, in uno stato di quasi-trance rituale, in uno stato di comunione partecipativa. Una volta che capisco questo, posso forse anche capire che Davis non ha bisogno di Ravi Shankar né della musica indiana per arrivare a un risultato pur così simile. Gli basta risalire alla propria origine africana, e alla natura rituale-compartecipativa delle poliritmie tribali, nelle quali il discorso e lo sviluppo musicali sono comunque presenti, ma non centrali, e comunque subordinati alla convocazione degli ascoltatori a una partecipazione attraverso il ballo, o l’accompagnamento vocale e in ogni caso attraverso l’immersione – ancora una volta – in uno stato di quasi-trance, in cui persino il cercare di seguire lo sviluppo e il discorso musicale è a sua volta parte dell’immersione e della partecipazione. Ora, se vediamo le cose in questo modo, l’operazione di Miles Davis appare di colpo come un altro capitolo della storia del free jazz, ma non quello cerebrale di Coleman (come mi suggerisce Guglielmo Nigro in uno dei commenti), quanto piuttosto quello politico-appassionato di Max Roach. E il disco che, con le mie scarse conoscenze, io ritrovo più vicino, nella storia precedente del jazz, a quello che Davis va a fare dal 1969 in poi, è la Freedom Now Suite – We Insist!, del 1960, proprio di Max Roach – specialmente (ma non solo) in quel brano, intitolato All Africa, in cui Abbey Lincoln canta sopra una base semi-immobile che finisce, dopo un po’, per essere fatta di sole percussioni poliritmiche. Ora, saranno queste le mie personali ossessioni e il mio modo di considerare la musica (e non per questo disprezzo affatto le modalità d’ascolto più intellettuali). Ma la mia sensazione è che Miles Davis abbia finalmente trovato, e solo da quel momento in poi, la sua vera sintonia con la musica e con la sua gente – che sono principalmente gli afroamericani, certo, ma siamo anche noi, nella misura in cui siamo capaci di capire che la musica non è né un freddo discorso intellettuale né un totale abbandono corporeo al ripetersi omogeneo dei suoni e dei gesti, ma un complesso in cui ciascuna delle due dimensioni investe l’altra, e capiamo mentre sentiamo e partecipiamo. E se non capiamo proprio tutto, pazienza, perché è anche il cercare di capire (senza necessariamente riuscirci) che ci fa entrare nel gioco complesso dell’essere a tempo. Visto che sono in tema di jazz, restiamo in tema di jazz. Nel 1979 sapevo pochissimo di jazz, e lo avevo scoperto, di fatto, da pochi mesi. C’ero entrato da un ingresso strano, non dallo swing né dal bebop. Tutto era iniziato l’autunno prima, quando un amico, che suonava il sax, mi aveva fatto ascoltare un disco di Anthony Braxton, “Five Pieces”. Io ci avevo riconosciuto gli stilemi delle avanguardie, e avevo drizzato le orecchie. Poi avevo trovato un complice, anzi un maestro, che di jazz era un patito, e mi spiegava un sacco di cose, e mi faceva ascoltare i dischi giusti. Tanto per restare in zona Chicago, oltre ad altri dischi di Braxton, ascoltavo e riascoltavo The Art Ensemble of Chicago, e Muhal Richard Abrams; e poi di lì verso Cecil Taylor e Ornette Coleman, e ancora verso forme di jazz più tradizionali. Avevo molta puzza sotto il naso all’epoca, e benché facessi fatica a negare il piacere che mi procurava comunque Louis Armstrong, faticavo a giustificarne il valore a fronte degli anatemi di Theodor Wiesegrund Adorno. Iniziai a frequentare i concerti, uno dopo l’altro. Ne ricordo uno molto bello (ma con un’acustica terribile) di Braxton alla sala della Gran Guardia di Verona. Quando il mio amico/maestro mi propose 5 giorni all’International Jazz Festival di Pisa, tutto dedicato alle avanguardie – e avremmo persino potuto dormire da un suo amico! – mi sembrò un’occasione straordinaria. E lo fu davvero. Era fine maggio o primi di giugno, mi pare. Arrivammo a Pisa in autostop. Le giornate erano pienissime: mattina, pomeriggio e sera fitte di occasioni musicali. Di giorno concerti con caratteri didattici, quasi seminari a volte. Di sera, fino a molto tardi, gli spettacoli. Ne ho ancora, di alcuni, un ricordo vivissimo. Han Bennink (con Misha Mengelberg e connessa sigaretta penzolante dal lato della bocca) che nel corso di un interminabile assolo si alza e, correndo, suona l’intera cancellata del palasport dove si svolgeva il concerto. Steve Lacy che esegue la sua preghiera tibetana camminando per il giardino Scotto (in seguito lo avrei sentito ripetere questo pezzo in molte, forse troppe occasioni, ma era la prima volta, quella). George Lewis che improvvisa al trombone da solo per un’ora (e forse dopo un po’ non ne potevamo più, ma non si poteva ammettere). Dave Holland pure da solo al contrabbasso, ma il tempo, alla fine, era volato via. Derek Bailey che improvvisava alla chitarra cose incomprensibili. Di molti concerti non ho più ricordo. Mi sembra che ci fosse Roscoe Mitchell, ma potrei confondermi con qualche concerto di qualche mese dopo altrove. Di sicuro il festival si concludeva con un evento differente, un’orchestra del gamelan di Bali, sul palcoscenico all’aperto del giardino Scotto. E sulle loro scenografie già pronte, oscillanti al vento della sera, Anthony Braxton aveva subito prima suonato da solo, in maniera memorabile. Avevamo fatto gruppo con altri appassionati, amici di amici. La sera, tornando verso casa (e c’era un sacco di strada da fare), si improvvisavano jam session vocali. Ma quando qualcuno aveva buttato lì che però forse Charlie Mingus era anche meglio di quello che ascoltavamo lì (con tutta la passione che ci mettevamo), si era levato immediatamente un coro di approvazioni. Mingus era morto, piuttosto giovane, pochi mesi prima. Io un po’ ignorante e un po’ supponente, non dissi nulla. Pensai che però Mingus rappresentava la tradizione, e comunque l’avanguardia doveva essere meglio; ma mi appuntai di ascoltarlo, questo autore di cui tutti i presenti parlavano con aria sognante. Racconto tutto questo un po’ perché mi va di condividere questo ricordo, e un po’ per via di un episodio significativo, un piccolo ma enorme passaggio di crinale, quei pochi metri di differenza che fanno sì che poi si scenda verso un mare piuttosto che verso un altro. Voglio dire che cinque giorni passati ad ascoltare, dodici ore al giorno, musica di avanguardia, lasciano per forza il segno. Quando inizi ti sembra tutto straordinario (anche perché è da tempo che corri dietro a questo mito) e dove non capisci dai comunque la colpa a te stesso. Ma poi, col succedersi dei concerti, ti rendi conto che anche nel contesto dell’avanguardia le forme finiscono per ripetersi, la quantità delle combinazioni è limitata, e talvolta quella che all’inizio ti era sembrato un problema di difficoltà per l’asprezza del linguaggio, a un certo punto si rivela come semplice noia: dopo tre, quattro giorni, quella roba lì l’avevamo già sentita, e un sacco di volte. Tra gli altri, emergevano comunque dei concerti di un livello differente, e Braxton e Holland si rivelavano certamente più bravi di molti altri, ma era difficile dire perché, visto che, tutto sommato, ritrovavamo anche nella loro musica quelle stesse forme, quello stesso modo di fare, quelle stesse strutture. Ci appariva quindi a un certo punto impossibile sostenere che Braxton (poniamo) ci piaceva perché faceva quel tipo di musica, il jazz di avanguardia. Lì, al festival di Pisa, tutti facevano quel tipo di musica, ma non tutti erano ugualmente apprezzabili. Ricordo benissimo che l’ultima sera ebbi una discussione feroce con un amico di amico che sosteneva quello che io stesso avrei sostenuto sino a tre giorni prima, ovvero che il valore di quella musica stava nella sua componente di rottura, di contrapposizione, di non rispetto delle regole, di antagonismo al sistema commerciale. Ma come potevano le cose stare a questo modo quando, dopo tanti concerti, ci appariva evidente che esisteva una norma dell’avanguardia, un sistema di regole condivise anche lì, una – chiamiamola così – banalità del nuovo non meno noiosa della banalità del commerciale? Tanto più che quella stessa musica aveva la sua stessa – per quanto minore, di nicchia, marginale, ma non inesistente – dimensione commerciale. Non ci era più possibile generalizzare, e salvare il genere per ragioni ideologiche, ora che dopo quattro giorni interi di ascolto, ci stava davanti agli occhi (o dentro alle orecchie) che quello era davvero un genere – contro tutto ciò che pensavamo sino a poco prima. Ma se l’avanguardia era un genere, con i suoi maestri e le sue mezzecalzette, le sue maniere e le sue regole, allora la denominazione “avanguardia” non le si poteva più attribuire in senso proprio; perché, in senso proprio, l’avanguardia è la punta estrema di un processo progressivo. Se la si riconosce come genere, allora le si toglie quel privilegio che la denominazione le vorrebbe attribuire. È solo un genere tra gli altri – magari quello che ci piace, ma non di più. Per bene che vada, può essere qualificato come un genere frequentato da molti artisti di valore: ma anche questo va appurato nei fatti, e si può persino scoprire che i musicisti di valore abbondano pure in altri generi, magari persino meno ideologicamente puri, magari persino più mefistofelicamente commerciali. E allora tanto valeva davvero provare ad ascoltare Charlie Mingus, per scoprire che sarebbe stato bello sentire dal vivo pure lui, e che la sua intelligenza musicale era comunque straordinaria, anche se con l’“avanguardia” (adesso le virgolette sono diventate d’obbligo) non aveva contatti diretti. E magari poi, la scoperta che andavo facendo rispetto al jazz valeva anche per altri tipi di musica, e pure per altre arti; e chissà mai che persino la neoavanguardia letteraria italiana (quella del Gruppo 63 e dintorni) non fosse altro che l’espressione di un genere, uno tra gli altri, difeso, come tale, solo dalla protervia ideologica dei suoi teorici? Non ho mai smesso di apprezzare Sanguineti e Porta, e di considerarli tra i più importanti poeti italiani del Novecento, ma l’ho fatto per le loro poesie, non per le loro teorizzazioni. In verità non ho nemmeno mai smesso di leggere Adorno, che continua ad apparirmi un critico musicale (e in generale, estetico) di grande qualità; ma lo è, paradossalmente, più a dispetto che a causa della sua concezione dell’arte come contrapposizione all’industria culturale. Lo trovo un concetto banale, quest’ultimo, alla fin fine: non mi spiega affatto perché in quel giugno del 1979 io abbia potuto trovare tanto più entusiasmanti Braxton e Holland di molti loro colleghi, né perché in seguito mi sia accaduto lo stesso nei confronti di Mingus, o perché in qualsiasi ambito io possa trovare delle differenze di qualità del tutto indipendenti dal genere, ma anche dal rapporto di adesione o contrapposizione al Moloch dell’industria culturale – benché non ne ami le regole, di questa, benché la rifugga ogni volta che posso, benché sia rimasto anche in me un po’ di quello spirito da vecchio aristocratico che certamente muoveva anche Adorno. Ma non posso chiudere gli occhi (o le orecchie) in nome di un’idea, qualunque essa sia. . Qualche giorno fa, leggendo questo post di Sergio Pasquandrea, mi è venuto voglia di riascoltare Miles Davis. Con la musica di Miles ho uno strano rapporto. E non posso farci niente: ci ho già provato un sacco di volte. Insomma, finché suona il jazz tradizionale lo trovo noioso; non saprei neanche dire perché; so solo che la sua musica non mi prende, scorre su di me senza trovare appigli. Certo che come trombettista è bravo, ma è come se lui e io stessimo parlando lingue diverse: io sento che è fluente, e che può piacere, ma non capisco niente. Nei pezzi per il quartetto degli anni Cinquanta poi, quando ha al suo fianco il giovane Coltrane, la cosa mi diventa ancora più evidente, perché mi rendo conto che appena Coltrane attacca a suonare, di colpo sono tutto orecchi. Poi c’è la svolta della fine dei Sessanta, e il mezzo milione di copie vendute di Bitches Brew, l’invenzione della fusion e le grida al tradimento, alla deriva commerciale. Bah. Sta di fatto che per me, Miles nasce con questo disco, che trovo straordinario – e gran parte di quello che ha fatto dopo mi piace da morire – al punto che non capisco bene come possa lo stesso musicista produrmi sensazioni così diverse. Ora, io non sono un esperto di jazz e non ho nessuna pretesa di dire in merito qualcosa di interessante. Probabilmente c’è solo qualcosa che non capisco nel Miles classico, e sarei ben contento se qualcuno mi fornisse gli elementi per capire. A capire e a saper apprezzare c’è sempre solo da guadagnarci. Quello, piuttosto, che sempre mi ha colpito, è l’anatema lanciato a suo tempo contro il Miles elettrico, e l’accusa di essere commerciale, di essersi venduto al successo. Mi colpisce, questa accusa, perché tradisce un certo atteggiamento purista che attraversa un po’ tutta la critica, di tutti i contesti, linguaggi e generi – con il correlato frequente di un atteggiamente contrario a quello che ho appena espresso, cioè il non voler apprezzare. Sembra quasi che il Miles del dopo la svolta non possa certamente fare della buona musica, perché siccome ha avuto successo commerciale quello che fa è necessariamente cattivo. Posso capire che il successo commerciale possa ingenerare dei sospetti sulla qualità, e che quello che ha avuto successo commerciale possa essere, abbia qualche probabilità in più, di essere cattivo. Ma poi le orecchie le abbiamo. I sospetti sono giustificati, ma solo finché non si tocca con mano come stanno le cose. Eppure, stranamente, l’atteggiamento purista non solo esiste, ma è incredibilmente diffuso in tutti i contesti, e l’incapacità di apprezzare quello che esce dagli schemi è dilagante. Credo che contribuisca alla diffusione di questo atteggiamento anche un fraintendimento, sempre di origine aristocratica e adorniana come l’atteggiamento in sé: quando si parla di schemi (e dell’uscirne) sembra infatti che si parli necessariamente di industria culturale (e delle produzioni alternative, di nicchia, d’avanguardia, controcorrente). L’industria culturale ha i suoi schemi, certo, a cui di solito si deve adeguare un prodotto per essere commerciale; ma anche ciascuna delle sue alternative ce li ha (ce li hanno le produzioni alternative, quelle di nicchia, le avanguardie, l’essere controcorrente…). In una situazione di nicchia come quella del jazz degli anni Sessanta (una nicchia non troppo piccola, certo, ma sicuramente con le sue regole e il suo pubblico – e quindi i suoi schemi), andare verso il rock è certamente fare quello che non si deve fare, e quindi rompere lo schema. Ora, essere puristi in una situazione di questo tipo vuol dire ritenere più importante lo schema dei risultati che si possono avere rompendolo. E questo non è un atteggiamento incomprensibile. Il rischio dell’operazione di Miles è quello – e tanto più se ha successo – di distruggere la nicchia; cioè, nello specifico, di distruggere il jazz, o almeno il jazz così come l’abbiamo amato sino a questo momento. La difesa dello schema è una difesa della casa in cui stiamo bene, che in qualche modo abitiamo, dove abbiamo amici con cui scambiamo opinioni, dove siamo riconosciuti e dove riconosciamo gli altri. Se la casa svanisce, come faremo? È per questo che la nuova musica di Miles, ancora prima che brutta, deve essere sbagliata, scorretta, intollerabile. In fin dei conti non abbiamo nemmeno bisogno di ascoltarla: questo è il senso dell’anatema. Questo atteggiamento purista, di difesa degli schemi, non è una prerogativa di chi ama la tradizione. All’interno delle avanguardie, per esempio, è dominante. E tanto più piccolo è l’orto da salvaguardare, tanto più si sarà duri nel condannare ciò che ne fuoriesce; perché certo, se l’orto è piccolo, il pericolo che possa ridursi fino a scomparire è più grande, e sempre più grande. Per la mia formazione e i miei interessi, io mi occupo di vari tipi di coltivazioni, tutti ambiti piuttosto piccoli, dove gli orti non hanno comunque modo di espandersi troppo. La varietà dei temi dei post di questo blog dà un’idea piuttosto chiara di quali siano queste coltivazioni. Tra loro, al giorno d’oggi, sicuramente la più piccola è quella del mondo poetico. È la più piccola in termini quantitativi, di giro di affari e di visibilità pubblica, ma è anche quella che ha – e di gran lunga – la tradizione più antica. Questo produce un effetto paradossale: il prestigio dell’essere un poeta apprezzato non consiste tanto nel guadagno o nell’esposizione mediatica (quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Milo De Angelis, per esempio?), ma nel potersi presentare, prima di tutto a se stessi, come qualcuno che è riconosciuto come appartenente alla stessa tradizione di Omero, Dante, Leopardi e Montale. Si tratta di un prestigio virtuale, in termini commerciali, ma estremamente reale e vincente in termini psicologici. Il poeta di oggi riconosciuto grande nel suo ambito non sposta una virgola a livello di cultura dominante, ma per chi lo conosce (e per se stesso, di conseguenza) il suo prestigio è enorme, superiore a quello di un famoso regista, o di una rockstar. Questo enorme prestigio è però legato alla dimensione minuscola della coltivazione, e a quella microscopica dell’orto di riferimento. C’è da stupirsi se nel mondo della poesia l’orticello venga difeso con le unghie e con i denti? C’è da stupirsi se ci siano critici che forniscono il decalogo di quella che è la poesia buona? Purtroppo non tutti coloro che rompono gli schemi consolidati lo fanno con qualcosa paragonabile a Bitches Brew, perché il talento è raro; ed è quindi facile ai puristi trovare dei controesempi di scarsa qualità, portandoli come prove della miseria in cui vive e produce chi è uscito dall’orto, o non ci è mai entrato. Il campo del fumetto, che mi è altrettanto caro, mostra, da questo punto di vista, dialettiche molto meno irritanti, spesso fin troppo poco irritanti. Il campo è un po’ più grande (non molto più grande), vi gira più denaro (non granché, certo, ma decisamente di più) e più esposizione mediatica (almeno un poco), ma molto molto molto meno prestigio (quello virtuale di cui sopra). In poco più di un secolo di vita è dura avere degli antenati paragonabili a quelli dei poeti. Per questo le certezze e le difese che contraddistinguono i purismi hanno meno ragione di esistere – e non ci si scanna per decidere che tipo di fumetto sia più autentico, così come succede nel campo della poesia, e in altri. Ci si scanna magari per altro – ma è anche un altro discorso. Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche cercare di spiegarmi perché il secondo Miles debba essere disprezzato, ma non credo che mi convincerà. Do invece qualche chance in più a chi mi volesse convincere della qualità del primo Miles – anche se ormai la vedo dura pure lì, ma non c’è nulla di ideologico in questo. Ci ho provato invano anche con Schumann a farmelo piacere, e lì non c’era né un Coltrane di riserva né una svolta elettrica a cambiare le carte in tavola. Quello che certamente non voglio è che le mie opinioni su ciò che è bene e ciò che è male determino i miei gusti. Se facessi così mi precluderei qualsiasi possibilità di cambiarle, le mie opinioni, qualsiasi possibilità di capire le cose meglio di quanto non le capisca adesso.
Non so se il tema che voglio affrontare qui sia davvero adatto per il post di un blog. Forse avrebbe piuttosto bisogno dello spazio e dello stile di lettura più concentrato di un saggio su una rivista scientifica. Ma ormai mi sono abituato a utilizzare questo blog per mettere giù le riflessioni che mi girano per la testa, e penso che i miei lettori si siano rassegnati a loro volta a questi post dai temi magari un po’ coriacei. In fin dei conti, per male che vada, il lettore ha sempre la possibilità di smettere di leggere e di guardare altrove: il Web è comunque strapieno di cose interessanti. Il tema è quello, profondamente semiotico ma non solo, della narratività. Una delle idee che stanno alla base della semiotica generativa di Greimas è che la struttura narrativa sia fondamentalmente alla base di qualsiasi discorso. Questo sarebbe dovuto al fatto che la struttura narrativa articola un percorso fondato sul quadrato semiotico, il quale a sua volta articola un’opposizione semantica; e le opposizioni semantiche sono alla base di qualsiasi discorso. Io ho qualche dubbio anche su questo, ma non è questo il punto in questione qui. Si può discutere sui dettagli, ma la posizione di Greimas individua nel suo complesso una questione reale, e una centralità del racconto che ne fa inevitabilmente un tema di indagine per chi voglia lavorare a fondo sui testi. Tuttavia, la posizione di Greimas ha un corollario che di solito non viene preso particolarmente in considerazione dai semiologi generativi, troppo intenti a rintracciare le strutture narrative nascoste, e poco interessati a capire come vi siano state nascoste. In altre parole, se il racconto è così pervasivo nei testi, è perché il racconto è evidentemente (come peraltro suggerisce Ricoeur) la forma con cui noi diamo senso al divenire temporale: il tempo, cioè, non è un semplice succedersi insensato di battiti dell’orologio; prende piuttosto senso per noi attraverso l’articolazione delle cause e degli effetti, che è già un’articolazione narrativa. Se volessimo essere kantiani, potremmo dire che la forma-racconto è un trascendentale, ovvero una struttura implicita nella nostra comprensione del mondo. Se invece che kantiani, volessimo essere evoluzionisti alla Bateson, potremmo dire che la forma-racconto è il modo migliore che la nostra evoluzione ha escogitato per metterci in rapporto memoriale con gli eventi del mondo, permettendoci di dar loro un senso – o di trascurarli o dimenticarli quando non entrano in nessuna successione narrativa. Qualunque sia il perché, il come non cambia, il racconto è il modello, lo schema che noi applichiamo alla nostra comprensione del mondo, ogni volta che viene messo in gioco il tempo, cioè un divenire. Ora, se portassimo questa assunzione alle estreme conseguenze, dovremmo dire che non ci sono racconti al di fuori di noi, ma solo sequenze di eventi che noi comprendiamo in modo narrativo. Se il mondo al di fuori di noi fosse fatto solo di natura, potrei anche sottoscrivere queste estreme conseguenze, e farla finita qui, neo-kantianamente. Ma il mondo al di fuori di noi è fatto anche di prodotti di altri esseri umani, i quali esprimono la propria comprensione del mondo; e siccome la loro comprensione del mondo è avvenuta in termini narrativi, allora anche la loro espressione potrebbe essere strutturata narrativamente. Cercare le strutture narrative di un testo significa allora cercare le tracce di questa narrativizzazione. E se mettiamo le cose in questi termini, sembra che i semiologi generativi facciano la cosa giusta quando cercano la forma-racconto alla base di qualsiasi manifestazione testuale, dal romanzo alla pittura alla musica. Il mio sospetto che sia il lettore colui che “nasconde” la forma-racconto nel testo sembra rivelarsi privo di fondamento; l’autore del testo, infatti, prima che autore, è stato a sua volta “lettore” del mondo, e l’ha “letto” in forma di racconto, passandolo poi a noi in questo modo. Continuo a non essere però del tutto convinto. Continuo a sentire della differenza tra il trattamento narrativo di un romanzo (che è sicuramente il prodotto di una lettura già narrativa del mondo), e quello di un dipinto o di un brano musicale. Proviamo a riflettere sulla natura delle nostre percezioni, in particolare sonore e visive. I suoni e le forme visive che arrivano ai nostri sensi vengono prima di tutto interpretati come segnali del mondo circostante; anzi, per la nostra ontologia ingenua, come il mondo circostante stesso. Solo in seconda istanza valutiamo se non siano stati prodotti da qualcuno a scopo comunicativo, e cerchiamo di interpretarli in questo senso. Ma c’è una grande eccezione a questo principio, perché quando i suoni e le figure sono riconosciute come linguaggio (oralità o scrittura, insomma), noi tendiamo a, per così dire, vedere attraverso di loro, per arrivare il più rapidamente possibile al loro significato. La dimensione materiale, quella del significante, non scompare, ma la nostra attenzione è rivolta da subito (e non in seconda istanza) al significato. È solo quando il significato è per noi incomprensibile (per esempio di fronte alle espressioni in una lingua sconosciuta) che ci arrestiamo al significante, con la forte (e ben giustificata) sensazione che ci stiamo perdendo il meglio. Quando sono in gioco le parole (e altri segni dichiaratamente convenzionali), insomma, assumiamo immediatamente che ci sia alle loro spalle qualcuno che le ha pronunciate o scritte. Questa medesima assunzione è molto più problematica, invece, quando le parole non sono in gioco, e siamo di fronte a immagini e/o suoni non verbali. Per portare la cosa al limite, è vero che un dipinto è sicuramente un’immagine prodotta dall’intenzione comunicativa di qualcuno; ma la cosa è molto meno certa (e rilevante) per un’immaigne fotografica o per un audiovisivo. I fotogrammi o le riprese di una telecamera di sorveglianza, per esempio, pur essendo immagini, non sono di solito interpretati come discorsi, bensì come testimonianze, documenti ottenuti attraverso un’estensione della nostra capacità di vedere e udire, che ci permette di vedere e udire anche quello che è accaduto in un luogo e un tempo in cui non eravamo presenti. Senza arrivare a questi estremi, l’assenza di una voce narrativa (orale o scritta) ci mette sempre nella condizione di valutare le percezioni non verbali come segnali del mondo (o direttamente come mondo); poi, subito dopo, nell’eventuale misura in cui sappiamo che sono state prodotte, iniziamo a considerarle anche come discorsi. Una delle conseguenze di questo è che mentre un racconto verbale (orale o scritto che sia) non può non avere un narratore (cioè una voce narrante, che si manifesta – come minimo – attraverso i pronomi e i tempi verbali), un’immagine, una sequenza di immagini o una sequenza di suoni, o una sequenza audiovisiva, possono benissimo non avere un narratore. Avranno un autore, certamente – ma non è la stessa cosa: è la voce narrante, cioè il narratore, che mi garantisce che quello che sto percependo è già una narrazione, ovvero il prodotto di un’interpretazione narrativa del mondo. Se il narratore non c’è, la situazione è molto più incerta. Supponiamo di stare facendo una passeggiata con un amico, in montagna. A un certo punto lui mi dice “Guarda”, indicando qualcosa. Io guardo e vedo una sequenza di eventi (un gruppo di camosci spaventati che fuggono, un falco in picchiata, una valanga): di fronte a quello che ho visto, io sto già interpretando narrativamente – e lo avrei fatto anche se avessi visto autonomamente quella scena. Certo anche il mio amico ha operato un’interpretazione narrativa del mondo, e sulla scorta di quella ha ritenuto opportuno avvertirmi. Ma la sua operazione si è esaurita di fatto con l’avvertimento, e la mia narrativizzazione è tutta mia. Ben diverso sarebbe stato se fosse stato lui a raccontarmi uno di questi eventi. In molti casi, quello che succede con i testi non verbali ha qualcosa in comune con l’esempio appena fatto, e non solo nell’ambito, ovvio, della fotografia. Un disegnatore o pittore traccia delle forme affinché, prima di tutto, io le veda e riconosca narrativamente. Proprio per questo le preparerà (potendolo fare, a differenza del mio compagno di passeggiata) in maniera da favorire una mia certa interpretazione narrativa, piuttosto che qualche altra. Ma, a differenza del narratore del romanzo, non potrà dichiarare implicitamente di stare raccontando – perché questo implicito è una prerogativa dalla parola. Il disegnatore (il pittore, il regista…) crea piuttosto delle situazioni prenarrativizzate (o delle sequenze prenarrativizzate) ovvero pronte perché si dia di loro una certa interpretazione narrativa. Non sto giocando con le parole. C’è differenza tra un racconto, garantito da un narratore, che ci autorizza da subito ad accettare che la sua stessa produzione sia già narrativa, e una sequenza prenarrativizzata, che siamo noi lettori a interpretare narrativamente, anche se è certamente stata progettata per favorirci in questo, ma dove non c’è nessuna garanzia, e nessuno che dichiara davvero “sto raccontando”. In questo secondo caso, io semplicemente assumo che ci sia a monte un’intenzionalità narrativa, ma sono io lettore a ricostruire il racconto in quanto tale. Ma poiché sono io, io sono anche libero allora di non farlo, e di fruire il testo in altro modo, presumendo che l’intenzionalità narrativa non sia l’unica, o magari non sia la principale, o magari non fosse nemmeno pertinente all’intenzionalità espressiva (e quindi interpretativa) dell’autore. Le parole esistono perché, convenzionalmente, trasmettono discorsi: se mi rifiuto o non sono in grado di recepire una sequenza di parole come discorso, non le sto nemmeno più ascoltando o vedendo come parole. A questo destino sono talvolta destinate le parole quando vengono messe in musica: a volte restano davvero parole, che trasmettono il loro senso, altre si trovano a essere trattate come semplici suoni articolati, ascoltate per il suono e ignorate per il senso. Dal punto di vista del rapporto con il racconto, il musicista si trova in una situazione ancora più estrema di quella di chi produce immagini. In molti casi le immagini possono essere lette come mimetiche; mentre raramente si può dire lo stesso delle sequenze musicali. Il musicista (compositore o esecutore) ci mette di fronte a delle sequenze articolate di suoni, e nemmeno ci dice che siamo tenuti a recepirle come un’interpretazione del mondo. Ma senza questa assunzione, diventa impossibile assumere che ci possa essere un qualche tipo di intenzionalità narrativa in musica, e quindi delle strutture narrative intimamente in gioco. Si fa fatica persino a pensare che la musica possa essere intesa come una sequenza prenarratizzata, quali il fumetto o il cinema (eccetto nel caso di melodramma e simili, ovviamente, dove la musica accompagna un’azione visiva e/o verbale). Quello che si può dire è che ci sono dei contesti storici e/o culturali in cui un’intenzionalità interpretativa del mondo e quindi espressiva può essere ipotizzata. Da Haydn e Mozart in poi questa ipotesi ha un senso nella musica occidentale. Ma forse bisognerebbe domandarsi, opera per opera, se sia accettabile di vederla come una sequenza prenarrativizzata. Se non lo fosse, e ugualmente vi rinvenissimo delle strutture narrative nascoste, sapremmo con certezza che siamo stati noi stessi, interpretando il testo musicale, a nascondervele. Il problema cruciale delle analisi narrative è dunque questo: per evitare di trovare quello che noi stessi vi mettiamo dentro, dobbiamo poter assumere che il racconto vi sia già, almeno nella forma implicita della sequenza prenarrativizzata. Lo possiamo assumere tranquillamente con il romanzo e con le forme analoghe più brevi. Lo potremmo assumere anche con la poesia, se non fosse che la poesia mette molto in primo piano certi aspetti del piano del significante, i quali con il racconto non hanno nulla che fare – ma la poesia gioca proprio su questo doppio binario. Lo assumiamo convenzionalmente con fumetto e cinema, trattandoli come varianti del racconto verbale – ma ci sono situazioni in cui la differenza salta fuori. A mano a mano che ci si allontana da questo nucleo, l’assunzione di narratività deve essere sempre più forte, e sempre più esplicitamente motivata: in musica, per esempio, è accettabile per il Romanticismo, ma in generale a fatica per le forme strumentali del Barocco – mentre sul jazz credo che potremmo discutere a lungo, caso per caso. In pittura, è accettabile per molti generi, ma la natura morta e il paesaggio la eludono in molti casi – per non dire dell’astrattismo di Mondrian, o dell’informale di Pollock. Non basta, insomma, trovare in qualche tipo di testo un’analogia con la forma-racconto per poter dire di essere di fronte a una struttura narrativa. Siamo noi a vedere racconti dappertutto. L’analogia non è una prova se non del fatto che quello che abbiamo davanti è un frammento di mondo, interpretabile narrativamente come tutto. Di notte, si sa, tutti i gatti sono neri.
Radio-lied. Il racconto trasmutato. . Un testo estetico è tale perché conduce il proprio fruitore lungo un percorso tensivo, fatto di aspettative, di sospensioni, di risoluzioni, di sorprese, giocando sul rilievo per sottolineare certe parti o sulla assenza di rilievo per indurre ad aspettare il suo ritorno. La struttura narrativa contribuisce a questi andamenti, talvolta in misura determinante, talaltra in misura marginale – e può essere a sua volta alterata in modo anche cruciale da modifiche nella struttura tensiva (cfr. Barbieri 2004). Alterazioni di questo genere si producono tipicamente quando un testo viene trasposto da un linguaggio a un altro, con la pretesa di conservarne palesi caratteristiche di identificazione, al punto da permettere di dire che si tratta dello stesso testo, trasposto – o trasmutato – in linguaggi differenti. Succede quando lo stesso racconto, ovvero la stessa sequenza di eventi serve da base per un romanzo, un film, una storia a fumetti, un melodramma. Succede quando un poesia diventa un lied, una canzone. La coppia di testi che rappresenta l’oggetto di questa analisi è costituita da una poesia di Umberto Fiori, intitolata “Compagnia”, e pubblicata nel 1995 nella raccolta Chiarimenti, e un breve originale radiofonico realizzato per Radio Rai Terzo Canale da Luca Francesconi nel 1996, consistente nella drammatizzazione musicale della poesia stessa (che viene comunque recitata, non cantata)[1]. La serie radiofonica, ideata dal medesimo Francesconi, in cui l’originale si inserisce, si chiamava Radio-film, ed era basata sull’idea di proporre a una serie di compositori la drammatizzazione musicale di poesie, per la durata di circa 5 minuti ciascuna. Nello specifico, Francesconi battezzò la propria sottoserie, di venti poesie (tutte da testi originali di Fiori), Radio-lied, ovvero lied per la radio, con evidente riferimento alla forma musicale della musica classico-romantica tedesca – assai più che alla canzone medesima, pure se come “canzone” si traduce solitamente in italiano il termine tedesco “lied”. [1] La poesia di Fiori è riportata più sotto. È possibile ascoltare il brano di Francesconi (per gentile concessione dell’autore) all’interno di un’animazione accessibile all’indirizzo web http://www.danielebarbieri.it/versus/. In questa animazione viene visualizzata la forma d’onda del brano, con le partizioni a cui si fa riferimento nel presente testo. Molto più della canzone, il lied è sempre stato una forma di messa in musica della poesia estremamente rispettosa delle spirito dell’originale – e quindi tanto più interessante per noi perché si propone come un’interpretazione del testo verbale di partenza, in cui la musica dovrebbe servire come da amplificatore delle significazioni originali. Con questo stesso spirito Francesconi si mette a lavorare sulle poesie di Fiori, cercando di costruire un testo che ne restituisca le suggestioni nel mutato contesto dell’audizione radiofonica. Come vedremo, nonostante sia la poesia di Fiori che la sua versione musicale operata da Francesconi siano due piccoli capolavori, la differenza tra loro è molto più grande di quanto non appaia a prima vista. Per metterla in luce sarà necessario tuttavia entrare molto nel dettaglio dell’organizzazione discorsiva di ambedue i testi, e analizzare il processo di fruizione attraverso il quale vengono condotti il lettore dell’una e l’ascoltatore dell’altra. Ecco dunque il testo della poesia: Compagnia
. . 1. La poesia di Umberto Fiori. Si tratta di una composizione di cinque strofe, le prime due composte da sette versi, la terza da cinque e le ultime due rispettivamente da tre e due versi. Non è difficile accorgersi, sin dalla prima lettura, del forte parallelismo presente tra la strofa 1 e la 2 (ne vedremo con precisione le caratteristiche tra poco), parallelismo che suggerisce, per analogia con forme poetiche tradizionali – come il sonetto – una simmetria analoga tra le strofe 3 e 4. Se ai tre versi della 4 aggiungiamo i due della 5 otteniamo infatti di nuovo una strofa di cinque versi come la 3. Ma anche così facendo la simmetria non viene affatto ristabilita. Anzi, quello che si ottiene in questo modo è proprio di sottolineare la cesura che divide il verso 22 dal 23. La poesia è infatti costruita in modo da suggerire che questa cesura non ci debba essere, mettendoci poi di fronte alla sua presenza di fatto. Non si tratta perciò di una cesura di strofa come le altre, ma di un autentico silenzio enfatizzato dalla situazione. Oppure, per dirla in altro modo, mentre le altre cesure di strofa sono funzionali alla struttura sintattica e narrativa della poesia, e risolvono perciò in tale funzionalità il proprio significato, la cesura tra i versi 22 e 23 non lo è, e quindi ha un ruolo che non è solamente strutturale. Tutta la poesia di Fiori (tutta la Poesia, in generale) è intessuta di meccanismi di messa in rilievo come questo, che ne regolano la fruizione e gestiscono le tensioni del lettore. Per comprendere questi meccanismi bisogna entrare nelle logiche specifiche dei vari livelli metrici, fonetici, sintattici e semantici che sono presenti in una composizione in versi. Lo spazio non ci basterà per esaminarli tutti nel dettaglio, anche perché la medesima operazione andrà compiuta con la versione musicale di Francesconi, ma cercheremo comunque di dare un’idea di come viene realizzata questa analisi. Inizieremo dai livelli metrico fonetico e sintattico, per passare poi a quelli lessicale e narrativo….. L’articolo completo (pubblicato originariamente sul n. 98-99, 2004, della rivista VS. Quaderni di studi semiotici) di cui questo che avete letto è l’inizio, è ora scaricabile in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Buona lettura. Be’, sì, è in libreria. L’altro giorno, quando ho detto a un mio amico che stava per uscire, lui mi ha chiesto: “E il blog l’hai fatto?”. Ho avuto un momento di perplessità. Ovviamente lui si riferiva al fatto che ormai quando si pubblica un libro si crea anche il blog per riparlare ed espandere i suoi temi. Ma io il blog ce l’ho già. Anzi è venuto al mondo un anno prima del libro. Un blog ha però una gestazione breve, mentre un libro ce l’ha decisamente più lunga. Il libro in verità esisteva già prima del blog, e il nome che a suo tempo ho dato al blog era anche augurale per il libro. Quindi, in fin dei conti, al mio amico ho risposto “Sì”. Il libro è più specifico del blog, come è giusto. Se volete sbirciare indice e introduzione potete andare qui. Mi sento un po’ come quelli che dal romanzo è uscito il film, o dal film il fumetto, o dal fumetto il romanzo. Il blog non cambierà, ma se qualcuno mi propone qualche tema di cui nel libro si parla, può essere una buona occasione per tornarci sopra. Per adesso, ne parlo pubblicamente in un incontro nell’ambito del festival del fumetto Bilbolbul, sabato mattina 5 marzo alle 11.30 alla libreria Irnerio (via Irnerio 27) a Bologna, con Luca Raffaelli. Spero di vedervi tutti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2025 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commenti recenti