6 Ottobre 2014 | Tags: Dino Campana, enjambement, poesia | Category: poesia |  Con l’enjambement, una clausola che noi sentiamo unitaria, da dire tutta di seguito, si trova divisa dall’acapo di fine verso. La clausola può essere sentita come unitaria perché ci sono un sostantivo o un aggettivo solitamente legati, perché c’è un nome preceduto da un dimostrativo o addirittura da un articolo, perché c’è una negazione seguita da un verbo o da un sostantivo, e così via. Oltre a questo modo di classificare gli enjambement, se ne può ipotizzare un altro, a seconda dell’effetto che si produce. Con l’enjambement, una clausola che noi sentiamo unitaria, da dire tutta di seguito, si trova divisa dall’acapo di fine verso. La clausola può essere sentita come unitaria perché ci sono un sostantivo o un aggettivo solitamente legati, perché c’è un nome preceduto da un dimostrativo o addirittura da un articolo, perché c’è una negazione seguita da un verbo o da un sostantivo, e così via. Oltre a questo modo di classificare gli enjambement, se ne può ipotizzare un altro, a seconda dell’effetto che si produce.
In questa prospettiva, ci sono due tipi di enjambement, a seconda che la prima parte della clausola separata abbia senso anche da sola (rivelando solo alla lettura del seguito la propria parzialità), oppure che l’irrisoluzione della clausola sia evidente da subito. Li chiameremo, rispettivamente, Tipo 1 e Tipo 2. Posso usare, per semplicità (mia) dei miei versi per esemplificare (presi da qui):
……sono dentro la foglia, ora, in questo
……microcosmo di peluzzi appetitosi,
……in questo verde grande, dappertutto,
……smeraldino, colmo così di luce,
5….mi muovo con prudenza, sorseggiando
……gocce micrometriche d’umore,
……preparandomi al primo grande morso,
……il primo affondo
……della mia fame all’universo, il primo
10…bacio al mondo, il primo essere
……quello che sono, e, da adesso in poi,
……che mangio
L’enjambement del verso 1 è di Tipo 2, perché la parola questo richiama con forza qualcosa che immediatamente la segua, e sempre di Tipo 2 è quello del verso 9, perché c’è un aggettivo (il primo) che aspetta un sostantivo. Sono di Tipo 1 invece gli enjambement dei versi 5, 8 (deboli) e 10 (forte).
Spesso gli enjambement di Tipo 1 sono più deboli di quelli di Tipo 2, ma non è sempre così. Al verso 10, per esempio, l’espressione il primo essere ha senso compiuto anche da sola, intendendo essere come un sostantivo (come a dire la prima creatura), ed è solo dopo l’acapo che se ne rivela la natura verbale e il legame tra copula e parte nominale del predicato.
Tutti gli enjambement danno rilievo all’espressione che si trova accavallata. In quelli di Tipo 2 la prima parte viene sottolineata dalla propria singolare incompletezza, e la seconda parte dall’attesa prodotta dal cambio di verso (attesa che normalmente non c’è). Ma il funzionamento degli enjambement di Tipo 1 è diverso, perché quando arriviamo alla fine della prima parte non abbiamo ancora notato niente di particolare, e il rilievo è quello consueto di fine verso. E’ con la scoperta all’inizio del verso successivo che ci accorgiamo di dover reinterpretare il tutto, e il rilievo (molto forte perché scaturito da una sorpresa) finisce per scaricarsi principalmente sulla seconda parte, visto che la prima è già trascorsa.
Poiché frequentemente gli enjambement di Tipo 1 sono deboli, il rilievo che si scarica sull’inizio del secondo verso finisce per essere normale; ma quando l’inarcatura è forte il rilievo sarà fortissimo.
Vediamo adesso questi versi di Dino Campana, da Viaggio a Montevideo:
E vidi come cavalle
Vertiginose che si scioglievano le dune
Qui abbiamo, a prima vista, un enjambement di Tipo 1, piuttosto forte. Le cavalle potrebbero stare anche da sé, ma l’aggettivo vertiginose le qualifica strettamente, e lo si scopre immediatamente legato, ricevendo un fortissimo rilievo (oltre al fatto che la parola è già forte e lunga di per sé). Tuttavia, continuando nella lettura, questa interpretazione non quadra, e alla fine ci si rende conto che la frase andrebbe parafrasata così: “e vidi che le dune si scioglievano vertiginose come cavalle”. Sono cioè le dune nel loro sciogliersi a essere vertiginose, e non le cavalle.
Di conseguenza, l’enjambement, a rigore, non c’è. Ma l’attrazione tra cavalle e vertiginose resta forte, ed è forte anche l’iperbato, che dà un rilievo fortissimo a tutta l’espressione, perché, da un lato, la sorpresa della costruzione sintattica reale è molto forte, e, dall’altro, perché le inversioni concentrano tipicamente il rilievo sulle clausole che vengono posticipate: qui, e in crescendo, si scioglievano le dune. Aggiungete l’allitterazione insistita sulla v e sulle liquide (vidi, cavalle, vertiginose, scioglievano) che si ripete regolarmente (quasi ossessivamente), e avrete la formula di questa straordinaria coppia di versi.
 Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà. Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.
A dispetto delle apparenze, il verso libero non è una forma informe. In apparenza, è una forma di verso che, del verso tradizionale, mantiene solo il principio dell’a capo, senza regole interne, fornendo tuttavia ugualmente al componimento una scansione, per quanto irregolare. Nella sostanza, il verso libero non solo ha il più delle volte una matrice sintattica (come si capisce bene dal fatto che l’eventuale enjambement emerge benissimo pure nel verso libero), ma flirta anche inevitabilmente con varie forme metriche tradizionali, in primis l’endecasillabo (almeno nella poesia italiana).
Se si vanno a studiare le origini del verso libero, nella poesia di lingua inglese, da Blake a Whitman, ci si accorge che il verso libero non nasce dal niente. Blake e Whitman, per fare il loro gran passo, hanno inevitabilmente bisogno di una stampella, ovvero di qualcosa che possa ancora essere sentito come verso dai loro lettori pur facendo a meno della metrica tradizionale. Essi trovano così questa stampella nella Bibbia, e nell’andamento non dei suoi versi, ma dei suoi versetti, ritualmente consacrati da secoli di recitazione. Si tratta di un ideale ritorno alle origini, al testo mitico per eccellenza – del tutto coerente con il tono oracolare che contraddistingue la poesia di entrambi.
La poesia in versi liberi che li segue eredita precisamente questa tensione oracolare, pur temperandola a volte, modulandola, modificandola, però senza perderla mai del tutto. Non la può perdere del tutto, perché la tensione oracolare è implicita nell’uso di una formula che permette di isolare una proposizione o una sua parte, sino una parola, rendendola assoluta nel suo isolamento, senza nemmeno la giustificazione tradizionale del metro, senza la scusa della cantabilità. È la musica che è scomparsa, insomma, lasciando il posto al verso libero come scultura di parole, monumento alla clausola verbale. Il verso non è più una struttura del canto, come almeno formalmente continua a essere nella metrica tradizionale, anche quando la poesia nemmeno viene più letta a voce alta; il verso è una sorta di cornice, che rende icastico, oracolare, assoluto, ciò che contiene.
Questo è ciò che succede in linea di principio. Nella pratica poetica del Novecento sappiamo tuttavia come la metrica tradizionale rimanga ben viva, e come l’endecasillabo, per esempio, rappresenti il calco su cui molti versi liberi si trovano di fatto formati. Molti versi liberi, in altre parole, non sono veri e propri versi liberi: sono piuttosto una versione “liberata” dei metri tradizionali (endecasillabi ipermetri o ipometri, per esempio) che cerca di conciliare una certa cantabilità con una certa oracolarità, giocando a spostarsi ora più sull’uno ora più sull’altro dei due poli.
Alla fin dei conti, dunque, il verso libero non è propriamente un verso liberato, bensì un verso che a un tipo di gabbia ne sostituisce un’altra: non più la gabbia metrica, ma la gabbia dell’icasticità, dell’incorniciamento espressivo.
Si noti che prima dell’entrata in scena e della vittoria del verso libero, la poesia – anche quella italiana – stava già sperimentando strade diverse. E non è solo lo sperimentalismo sui versi latini o sui versi popolari di Carducci e di Pascoli (che è comunque un tentativo di mantenere la cantabilità modificandone le basi metriche – pur mantenendo, nella coincidenza tendenziale tra clausola metrica e clausola sintattica, una certa icasticità e oracolarità). È piuttosto il ricorrente ricorso all’enjambement di Foscolo e Leopardi, che della cantabilità conserva un’apparenza ancora più debole, ma che indebolisce pure la cornice del verso, proprio per il suo trapassare del discorso da un verso all’altro – il che rende impossibile isolarli davvero.
Probabilmente, questo uso insistito dell’enjambement esprimeva in quegli anni una tensione verso l’espressività che il metro tradizionale faticava a contenere; ma nel momento in cui il metro tradizionale viene poi sostituito dal verso libero, scompare anche questa tensione, che non ha più ragione di esistere là dove l’espressività può essere garantita, verso per verso, dal verso stesso. Questo è il prezzo che la poesia paga al verso libero: la coincidenza del verso con la clausola espressiva, senza l’attenuante musicale; l’asservimento del verso al discorso, all’espressione dell’io; la riduzione della poesia stessa a espressione dell’io, a lirica.
Chi comprende molto lucidamente la questione, nel mondo del verso libero, è Amelia Rosselli, mostrandolo nella pratica della sua poesia, ma anche in quel breve ma cruciale saggio del ’63, intitolato “Spazi metrici”, là dove dice: “In effetti nell’interrompere il verso anche lungo ad una qualsiasi terminazione di frase o ad una qualsiasi sconnessa parola, io isolavo la frase, rendendola significativa e forte, e isolavo la parola, rendendole la sua idealità, ma scindevo il mio corso di pensiero in strati ineguali e in significati sconnessi. L’idea non era più nel poema intero, a guisa di un momento di realtà nella mia mente, o partecipazione della mia mente ad una realtà, ma si straziava in scalinate lente, e rintracciabile era soltanto in fine, o da nessuna parte. L’aspetto grafico del poema influenzava l’impressione logica più che non il mezzo o veicolo del mio pensiero cioè la parola o la frase o il periodo”.
Proprio per evitare l’icasticità prodotta dal verso libero, e l’effetto oracolare che ne consegue, Amelia Rosselli inizia quindi a suddividere i versi in maniera apparentemente arbitraria (in realtà con una regola rigorosa, ma che impedisce che l’unità del discorso possa coincidere con quella del verso), facendo dell’enjambement un principio talmente pervasivo da vanificare l’idea stessa del verso come unità conclusa (pur provvisoriamente). In realtà, anche nell’artificio della Rosselli continua a giocare un principio musicale: non è più la cantabilità, nemmeno formalmente, ma è comunque un principio di costanza ritmica, di quantità prosodica ricorrente.
Se veramente il verso libero implica la lirica e l’espressione dell’io, e la metrica tradizionale implica la cantabilità tradizionale (almeno formalmente) con le sue belle forme che non ci rappresentano più (e i poeti neometricismi giocano proprio su questa ostentata e invalicabile distanza), allora la strada indicata da Amelia Rosselli potrebbe essere davvero l’unica praticabile per portare la poesia fuori dalla lirica, senza ricadere nella tradizione. Questo non vuol dire né che si debba per forza fare poesia come faceva lei, e nemmeno che si debba tagliare il verso come faceva lei; ma restano fondamentali, nel mio modo di vedere le cose, la sua messa in crisi del verso libero e il recupero di una qualche musicalità che non coincida con la cantabilità. La Bibbia, con tutto il suo innegabile fascino, ha fatto un’altra volta il suo tempo.
 Amelia Rosselli, frammento da "La libellula (Panegirico della libertà)", 1958 Ho iniziato ad amare la poesia di Amelia Rosselli quando ho scoperto questi versi. Li trovavo insieme irritanti e impossibili da abbandonare con gli occhi, impossibili da abbandonare con la mia voce interiore che li recitava mentre li leggevo con gli occhi. Trovavo insieme eccessivo a avvolgente il riferimento ossessivo ai versi de “La chimera” di Dino Campana. Io che faccio fatica a leggere componimenti poetici che superino le due pagine, qui mi ritrovavo come inglobato in questa struttura vischiosa, forse complessivamente insensata, ma così continuamente piena di echi, di riferimenti, di richiami anche a strutture poetiche e narrative ben note (ma qui destinati a essere trattati allo stesso modo dei versi di Campana).
I versi di Campana sono quelli che iniziano così:
Non so se tra rocce il tuo pallido
Viso m’apparve, o sorriso
Di lontananze ignote
Fosti, la china eburnea
Fronte fulgente o giovine
Suora de la Gioconda:
O delle primavere
Spente, per i tuoi mitici pallori
O Regina o Regina adolescente…
Da Campana, la Rosselli non mutua solo alcune parole, ma anche una tecnica basata sulla ripetizione ossessiva, sul ritorno insistente di parole, di suoni, di formule sintattiche. Tuttavia, mentre in Campana questa insistenza assume la consistenza del favoloso, del fantastico, del meraviglioso (Montevideo, la Pampa, La Verna, Genova, la notte…), l’ossessione della Rosselli sembra quella di un’anima prigioniera di un pensiero fisso, dove tutto ciò che si può pensare non fa che tornare lì, sempre lì, senza uscita. Campana, se vogliamo, era prigioniero della sua libertà, incapace di non fuggire, di non immergersi nel suo epos – che per noi, suoi lettori, non è, in fin dei conti, che un epos letterario. E in questo modo sembra viverlo e recuperarlo anche la Rosselli stessa, perché di quell’epos sono rimaste soltanto le parole e il loro andamento a spirale, il loro sviluppo in realtà lentissimo o impossibile: non sai mai dove questo eterno quasi-ritorno ti stia in verità portando, proprio come se, girando in quasi-cerchio, con minime variazioni a ogni giro, dovessimo dire in che direzione ci stiamo complessivamente muovendo.
Si scoprono cose interessanti sulla poesia della Rosselli se si va un po’ più a fondo sul metro di questi versi. Non c’è qui una misura regolare né quanto a sillabe né quanto ad accenti. Non c’è nemmeno un’accentazione regolare come succede per esempio nelle ossessioni in versi liberi di Campana. A differenza della gran parte dei versi liberi del Novecento, non c’è nemmeno un verso su base sintattica, di matrice biblica, come quello che Campana aveva assunto da Whitman. L’enjambement è talmente frequente da essere la norma nei versi della Rosselli di quegli anni, e in queste condizioni di verso così debolmente definito la divisione di clausole sintattiche unitarie tra versi differenti non suona nemmeno come un enjambement. Tutto, insomma, sembra contribuire a configurare questi come dei non-versi.
Perché allora la Rosselli non scrive in prosa? A che cosa servono dei versi che non conservano nulla del verso? Proprio questa operazione straniante ci permette di fare alcune riflessioni sul rapporto tra il verso e la sintassi. Nella poesia tradizionale, in metrica, quella dove l’enjambement è un fatto raro e notevole, c’è sempre una certa coincidenza tra l’organizzazione metrica e quella sintattica. Poiché l’organizzazione metrica rappresenta l’elemento più musicale della poesia, mentre quella sintattica è legata al senso linguistico, questa coincidenza ha il senso della messa in musica di parole che esprimono un pensiero, una sorta di legame tracciato tra la dimensione rituale del ritmo e quella individuale/interpersonale del discorso. Legandosi al metro, la sintassi ci permette di sentire il senso come un fatto musicale, e l’agire interpersonale del discorso come un fatto collettivo e compartecipativo. Finché le parole della poesia erano fatte per essere messe in musica, la fine del verso era anche una (provvisoria) fine della clausola del senso, il luogo ideale dove respirare; e il verso diventava la figura verbo-orale del respiro.
L’enjambement rompe questa unità logico-ritmica, mettendo in evidenza l’arbitrarietà della loro giunzione. L’effetto di sottolineatura, che le clausole sintattiche interrotte dal cambio di verso ottengono, è funzionale al discorso; e rappresenta un modo, di dare rilievo a certe espressioni, che solo la poesia possiede, perché ha origine dall’infrazione di una regolarità che la prosa, per sua natura, non ha.
Se l’enjambement si diffonde troppo, però, il gioco smette di funzionare. Funziona ancora, e splendidamente, nei sonetti di Foscolo, perché il verso è così nitidamente definito come endecasillabo, e la struttura tradizionale del componimento così familiare alle orecchie dei lettori, che le sue infrazioni emergono come tali, e ottengono una grande forza. Già nella canzone leopardiana l’effetto è più debole, perché la struttura è in sé più libera, e quindi meno definita e meno familiare. Quando si impone il verso libero, la clausola sintattica prende nuovamente il sopravvento, in qualità di nuova misura del verso, sostituendosi alla regolarità delle quantità delle sillabe (o quant’altro sia la regola nella tradizione di riferimento): ma questa nuova misura è più debole della vecchia. Per questo l’enjambement va usato nel verso libero con ancora maggiore parsimonia, pena il rischio di distruggere l’effetto metrico pericolosamente ricostruito.
La Rosselli non ci sta, però, nemmeno a questo gioco. I suoi sono non-versi perché rifiutano persino la sintassi come base neo-metrica del verso. Lei si è accorta, io credo, che il verso, comunque sia costruito, costituisce una sorta di cornice, e le cornici sono quegli apparati che servono per distanziare le figure incorniciate, dichiarandole figure non del mondo, ma della sua rappresentazione – e quindi il prodotto di un discorso sul mondo. L’operazione della Rosselli, in altre parole, ha qualcosa di simile a quella che un grafico compie quando fa stampare un’immagine al vivo, ovvero facendola tagliare dal bordo stesso della pagina, senza margine bianco attorno. Un’immagine al vivo appare più vivida al fruitore perché sembra in qualche modo uscire dalla pagina stessa. Non è che si sia davvero eliminata la cornice, perché è inevitabile che un’immagine abbia un bordo; però si è eliminata quella cosa che convenzionalmente consideriamo la cornice; e il taglio del bordo-pagina assomiglia a quello del margine di una finestra attraverso cui vediamo il mondo. Insomma, si suggerisce che l’immagine al vivo non possieda che quella stessa cornice che può avere una scena reale vista attraverso una finestra; una cornice ben diversa da quella distanziante del quadro. Insomma, ciò che sta dentro il quadro di una finestra appartiene allo stesso mondo a cui appartiene la finestra stessa e noi; è solo un po’ più in là – ma non è rappresentazione.
Se la Rosselli scrivesse in prosa non otterrebbe dunque questo effetto al vivo, perché non potrebbe giocare sull’ostentazione dell’assenza della struttura tradizionale del verso. Solo costruendo dei versi che sono non-versi lo si può fare.
Ecco di conseguenza questo effetto di presa diretta, di estrema non mediatezza che viene prodotta in questo modo dalle parole della Rosselli. Ma non è un flusso di coscienza banale quello che si presenta qui. La presenza del non-verso non è sufficiente di per sé a far percepire questa al lettore come poesia. Anzi, avendo annullato il verso, è necessario rafforzare la sensazione di poesia attraverso altri strumenti. Ecco, quindi, a cosa servono la ripetizione e il riferimento a Campana (e non solo a lui, in altre sezioni del poemetto). La ripetizione ossessiva, il ritorno delle formule e dei suoni e dei ritmi prosodici, sono tutti elementi immediatamente riconoscibili come poetici, attraverso cui il lettore può riconoscere il contesto, sentire questo flusso di parole come autentica poesia.
A questo punto, tuttavia, ci troviamo di fronte a un paradosso. L’occultamento della cornice ha portato il flusso di coscienza dell’autore in primo piano, come se non fosse una rappresentazione, ma il suo stesso diretto grido di ansia; eppure questo stesso occultamento viene con evidenza prodotto attraverso l’enfatizzazione di una serie di procedimenti di carattere chiaramente letterario, e quindi dichiaratamente artificiosi. Lo stesso grido di ansia a cui ci viene dato l’accesso diretto, senza la mediazione della cornice, è un oggetto letterario, pieno di figure retoriche utilizzate con ostentazione.
Insomma, è come se la Rosselli volesse comunque ostentare il fatto di essere una poetessa, e dunque una letterata, e quindi qualcuno che non può che esprimersi attraverso quella lingua lì, la lingua della letteratura e della poesia – e tuttavia quella lingua lì può essere, insieme, anche una lingua estremamente spontanea e diretta, non mediata. Se quella che vediamo in questi versi è la voce ossessiva della sua stessa anima, senza la cornice del verso tradizionale, quella voce si è costruita essa stessa all’interno della parola poetica, e la parola poetica medesima è la sua epressione vera, spontanea, non mediata, costruita intimamente dalla musica del verso perché la musica del verso non è qualcosa che si aggiunga alla parola, ma la parola stessa è già nata in noi (in lei) originariamente intrisa di quella musica, nella sua sintassi, nei suoi accenti e nei suoi significati.
La Rosselli riesce insomma, qui come in tante altre poesie, a restituire un senso profondo all’esperienza dell’espressione letteraria, interiorizzandone in qualche modo la cornice, con questa forma di iper-lirica, dichiarandosi lei stessa in qualche modo letteratura, o almeno costruita dalla letteratura, costruita dai racconti letterari, e specialmente da quelli poetici, e dalle loro parole e dalla loro sintassi e dal loro suono. La Rosselli paga questo successo lirico ponendo se stessa come un altro caso della sovrapposizione tra letteratura e vita; una sovrapposizione da cui la letteratura ha, indubbiamente, ancora oggi, molto da guadagnare. Ma la vita?
17 Marzo 2010 | Tags: Amelia Rosselli, Dante Alighieri, endecasillabo, enjambement, Francesco Petrarca, Giovanni Della Casa, metrica, petrarchismo, poesia, risoluzione, tensione, Ugo Foscolo, verso | Category: poesia | Un’amica che leggeva delle mie poesie mi ha domandato una volta con che criterio si va a capo nei versi. In altre parole, quando scrivi una poesia, come fai a decidere quando è ora di concludere un verso e iniziarne un altro?
La risposta banale è “Quando lo senti”. È vero (perché mentre scrivi è in gioco la sensibilità assai più di qualsiasi tipo di calcolo) ma non basta (perché anche questa stessa sensibilità segue delle regole, che ci siano in quel momento presenti o no).
La risposta non banale è molto complicata. Riflettendo sulla stessa sensibilità che ci porta ad andare a capo in un certo modo, posso però enunciare una serie (tutt’altro che esaustiva) di principi, che hanno come conseguenza l’andata (o meno) a capo:
- l’inizio e (soprattutto) la fine di un verso sono luoghi di rilievo: quello che capita in queste posizioni viene enfatizzato rispetto a quello che si trova nella parte centrale del verso;
- di conseguenza, un verso molto breve enfatizza molto il suo contenuto (che si trova al contempo all’inizio e alla fine del verso);
- la coincidenza tra la clausola metrica (data dal verso) e quella sintattica (data dal periodo, dalla proposizione o dal sintagma compiuto) ha impostazione conclusiva: ne farò uso se voglio enfatizzare la cesura tra un verso e l’altro (e tra una clausola sintattica e l’altra), ottenendo un ritmo diviso; la eviterò se invece voglio minimizzare le cesure, ottenendo un ritmo più fluido;
- le forme regolari sono come la tonica nella musica tonale: un luogo di risoluzione della tensione; finché voglio mantenere la tensione devo mantenere irregolare la forma, e spezzare il verso in modo che lo sia; la regolarità, viceversa, è conclusiva. Posso fare uso dei versi più anomali in una poesia, ma un bell’endecasillabo con accenti sulle sillabe 4 e 6 darà l’impressione di un punto di arrivo, parziale se la sintassi non lo conferma, totale se anche sintatticamente si arriva in fondo;
- quest’ultima regola è particolarmente importante quando si fa uso di versi della stessa lunghezza (cioè non versi liberi): il gioco tra le versioni non canoniche e quelle canoniche del verso che stiamo usando crea tutta la tensione metrico-sintattica della poesia. In questo senso la presenza dell’enjambement permette di rendere forme irregolari anche i versi più canonici, inserendo nel gioco un’ulteriore variabile.
Quest’ultima osservazione riguarda qualcosa che mi è particolarmente presente. Probabilmente la natura sillabico-accentuativa (più sillabica che accentuativa) del verso tradizionale italiano ha a che fare con l’antico legame tra poesia e musica, reciso nel XIII secolo dagli aristocratici siciliani. Dante aveva capito bene, pur nei termini della propria epoca, che il gioco tra versioni più o meno canoniche dell’endecasillabo era uno strumento potente in mano al poeta, visto che non c’era più bisogno di rispettare il requisito della cantabilità (in senso musicale). Poi però Petrarca ha imposto alla poesia italiana un canone di regolarità che ha tagliato fuori questo gioco: purtroppo lui era talmente bravo che riusciva a ottenere gli stessi effetti giocando di variazioni minimali degli accenti; ma per chi l’ha seguito, affascinato dalla sua abilità, il risultato è stato mediamente assai noioso.
Sarà gusto personale, ma nell’universo del sonetto (cioè la forma che Petrarca ha maggiormente segnato) i miei amori sono sempre andati verso gli autori meno petrarcheschi, come Giovanni Della Casa e Ugo Foscolo, specie in A Zacinto. Ecco un bell’esempio da Della Casa (dalle Rime, pubblicate postume nel 1558):
Questa vita mortal, che ‘n una o ‘n due
brevi e notturne ore trapassa, oscura
e fredda; involto avea fin qui la pura
parte di me ne l’atre nubi sue.
Or a mirar le grazie tante tue
prendo: ché frutti e fior, gelo ed arsura,
e sí dolce del ciel legge e misura,
eterno Dio, tuo magisterio fue.
Anzi ‘l dolce aer puro, e questa luce
chiara, che ‘l mondo a gli occhi nostri scopre,
traesti tu d’abissi oscuri e misti.
E tutto quel che ‘n terra o ‘n ciel riluce,
di tenebre era chiuso, e tu ‘apristi;
e ‘l giorno e ‘l Sol de le tue man son opre.
Qui il gioco tra irregolarità (tensiva) e regolarità (risolutiva) è basato sull’enjambement, mentre per quanto riguarda gli accenti il canone petrarchesco viene rispettato.
Ma il principio si trova applicato sino in Amelia Rosselli (da Documento, 1966-73):
Ossigeno nelle mie tende, sei tu, a
graffiare la mia porta d’entrata, a
guarire il mio misterioso non andare
non potere andare in alcun modo con
gli altri. Come fai? Mi sorvegli e
nel passo che ci congiunge v’è soprattutto
quintessenza di Dio; il suo farneticare
se non proprio amore qualcosa di più
grande: il tuo corpo la tua mente e
i tuoi muscoli tutti affaticati: da
un messaggio che restò lì nel vuoto
come se ad ombra non portasse messaggio
augurale l’inquilino che sono io: tua
figlia, in una foresta pietrificata.
In questa corsa affannosa, l’unico punto risolutivo è quello finale, e questa “foresta pietrificata” ne riceve un rilievo straordinario.
(come questo principio sia applicato da me – si parva licet componere magnis – si può ovviamente verificare qui)
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|
 Con l’enjambement, una clausola che noi sentiamo unitaria, da dire tutta di seguito, si trova divisa dall’acapo di fine verso. La clausola può essere sentita come unitaria perché ci sono un sostantivo o un aggettivo solitamente legati, perché c’è un nome preceduto da un dimostrativo o addirittura da un articolo, perché c’è una negazione seguita da un verbo o da un sostantivo, e così via. Oltre a questo modo di classificare gli enjambement, se ne può ipotizzare un altro, a seconda dell’effetto che si produce.
Con l’enjambement, una clausola che noi sentiamo unitaria, da dire tutta di seguito, si trova divisa dall’acapo di fine verso. La clausola può essere sentita come unitaria perché ci sono un sostantivo o un aggettivo solitamente legati, perché c’è un nome preceduto da un dimostrativo o addirittura da un articolo, perché c’è una negazione seguita da un verbo o da un sostantivo, e così via. Oltre a questo modo di classificare gli enjambement, se ne può ipotizzare un altro, a seconda dell’effetto che si produce.



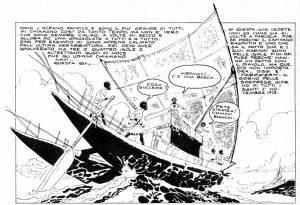




 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.
Voglio presentare un’ipotesi provocatoria. Un’ipotesi e non una teoria, perché richiede ancora verifiche e conferme, puntualizzazioni e distinguo (con una ovvia possibilità che, approfondendo, essa si riveli falsa); e tuttavia, a una prima ricognizione, mi appare plausibile. Riguarda il verso libero, questa forma/non-forma che viene sentita ancora, a due secoli e passa dalla sua invenzione, come liberazione dalle pastoie della metrica tradizionale, e strumento base della possibilità del poeta di dare alla propria opera la forma che più le si confà.




















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco







Commenti recenti