Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.


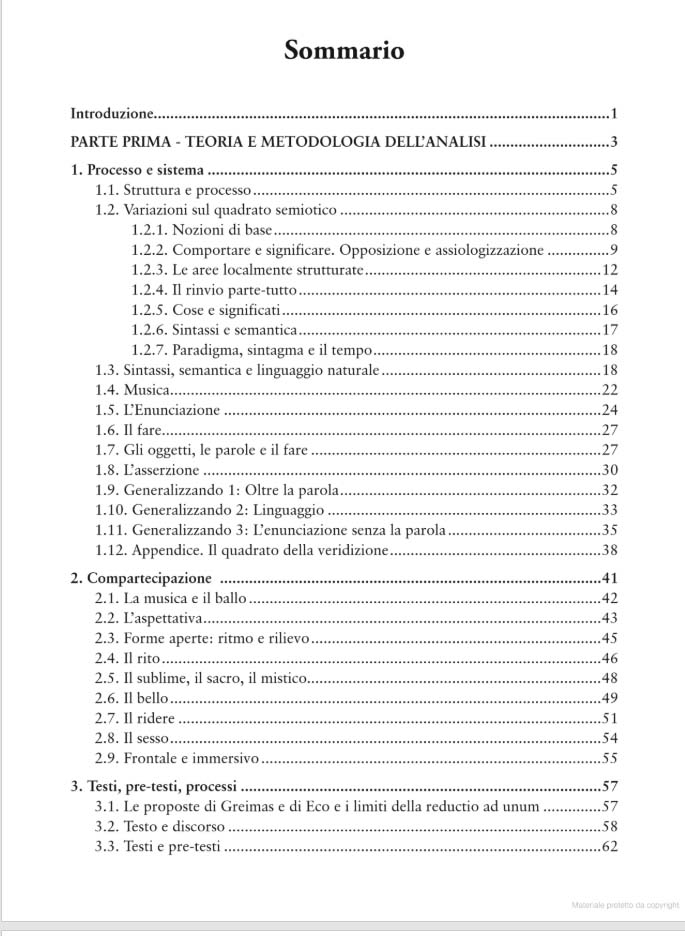
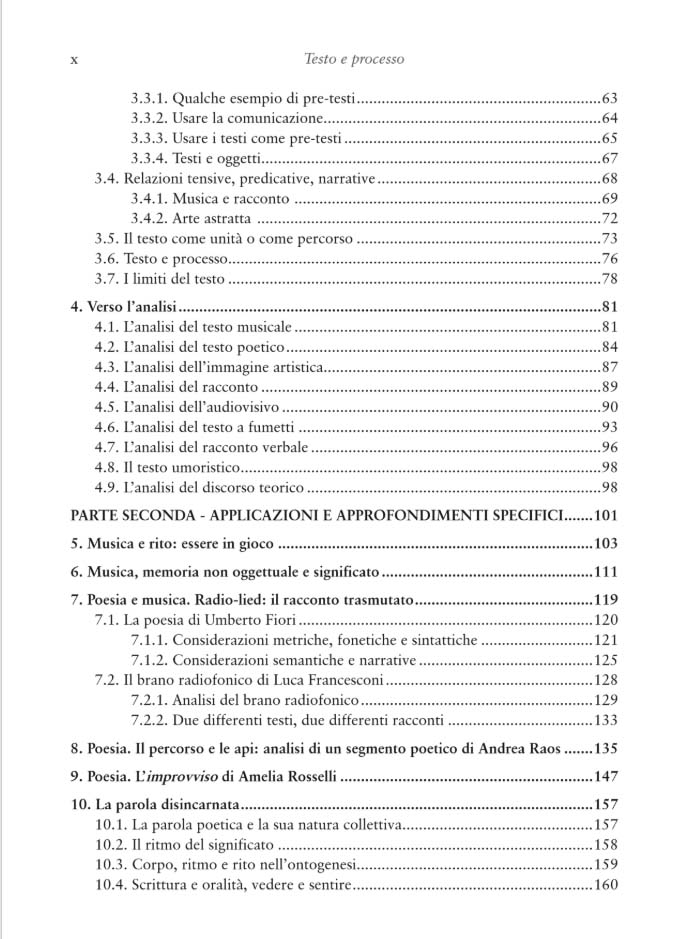
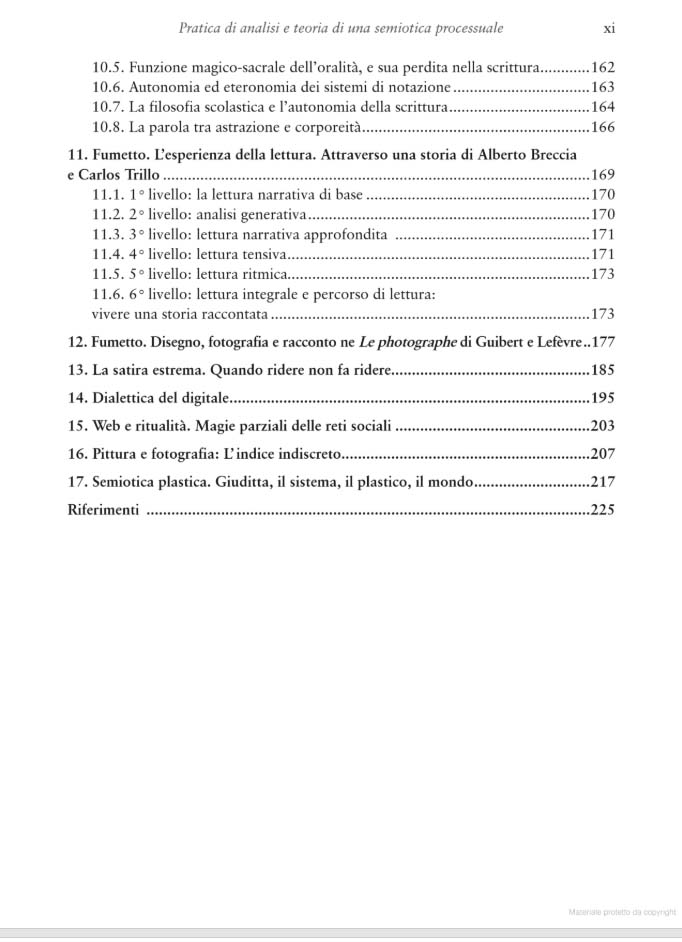

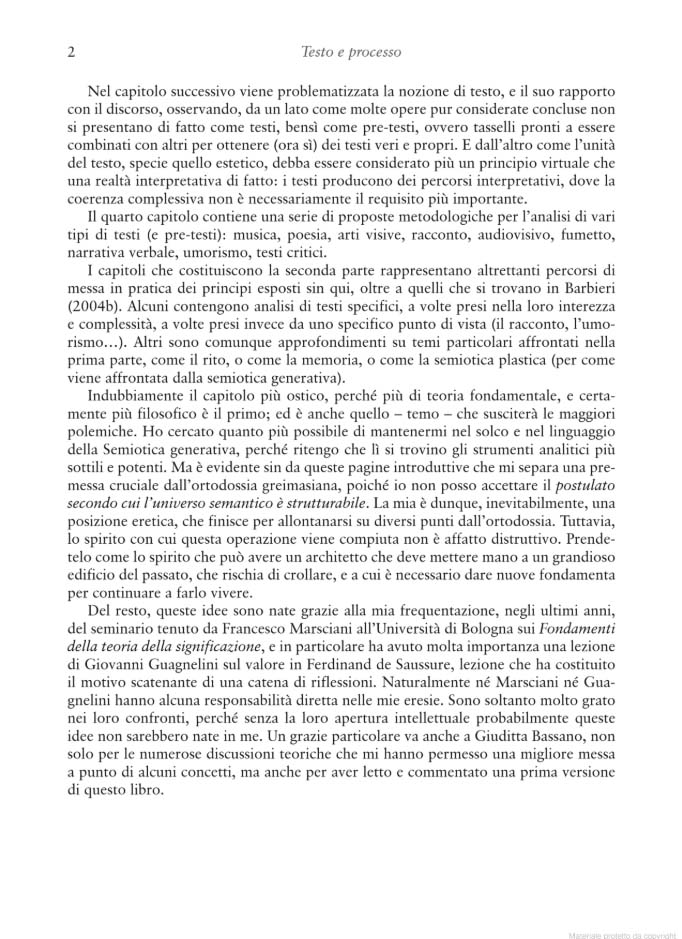
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
|
|
||
|
Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore. Xenofobia è una parola difficile e poco usata, con quella x per cominciare e quello xeno da gas raro. Razzismo è una parola molto più facile: non solo è palesemente condannata dalla storia e possiede un’aura funesta da Olocausto e KuKluxKlan, ma l’aggettivo corrispondente, razzista, è facilmente omologabile ad altre parole con valore offensivo: fascista, sessista, machista, sciovinista, assenteista, fancazzista, buonista e così via. Così, se dobbiamo esprimere vivamente il nostro sdegno per comportamenti che vanno in quella direzione, diremo che il nostro ministro degli interni è razzista, non che è xenofobo. E invece ha ragione lui, col suo compare, e in Italia non c’è pericolo razzismo. La xenofobia esiste da lungo tempo: è la paura del diverso, che può andare dalla semplice diffidenza alla violenza sanguinaria. Non c’è bisogno del razzismo per essere xenofobi: quando un Bolognese dà degli stupidi ai Modenesi sta esprimendo una tradizionale (piccolissima) xenofobia. La razza non c’entra proprio nulla. Eppure otto secoli fa ci massacravamo allegramente tra vicini, e dare del modenese a un Bolognese (o viceversa) era un’offesa grave. L’idea di razza nasce tra sei e settecento, mi pare (ma per i dati precisi e una magnifica serie di informazioni e approfondimenti in materia, il liro da leggere è quello di Maurice Olender, Razza e destino, Bompiani, che ho avuto la ventura di tradurre qualche ano fa), e soprattutto riceve dalla scienza ottocentesa una patente di oggettività, di cui è molto interessante ricostruire la storia – anche per capire quanto valgano le Grandi Verità scientifiche. Ai primi del Novecento, il razzismo non era un’ideologia vergognosa: era quello che era considerato un dato di fatto, perché la scienza aveva dimostrato che le razze umane esistevano. Più discusso era se questa distinzione autorizzasse a ritenere che vi fossero razze superiori e razze inferiori, ma la scienza dava risposte pure a questo, e la famosa teoria dell’asse del profilo del volto (quasi verticale negli europei, molto diagonale nelle scimmie, un po’ diagonale negli africani) dimostrava ai più che i negri erano certamente una via di mezzo tra gli umani e le scimmie. Non tutti – va detto – ci cascavano; ma per i più si trattava di una verità dimostrata. Viste le conseguenze storiche, specie in Germania, non si poteva continuare dopo la metà del Novecento a sostenere la superiorità o inferiorità delle razze. L’idea stessa che vi siano delle razze umane era diventata pericolosa. L’idea di razza è quindi stata dimostrata infondata dalla scienza, che oggi può provare con la stessa infallibile certezza (che prima aveva in senso inverso) che le razze umane non esistono. Mi fido poco di questa conclusione perché non sembra avere molto più valore della precedente, che andava in senso inverso. Il punto è che razza è una parola non così facile da definire tecnicamente ed esattamente; insomma, ci metti dentro un po’ quello che vuoi: può darsi che la razza per come la intendevano gli scienziati dell’Ottocento esistesse davvero, e che per come la si intende oggi non esista affatto. In ogni caso è la parola stessa che è pericolosa: i cani e i cavalli se ne fregano delle razze, e scopano tranquillamente in maniera interraziale. Sono i loro padroni a preoccuparsi della purezza della razza, per motivi di prestigio e di valore economico. A seconda di quello che devo fare con cani e cavalli, o con umani, sarò più o meno interessato a pensarli in termini di razze. In ogni caso, quando si parla di razza non si parla di soggetti, ma di oggetti; non di scambio tra eguali, ma di sfruttamento tra diseguali. Ma lasciamo questi discorsi astratti, e torniamo alla realtà della comunicazione di massa. Abbandonata dalla scienza, l’idea di razza oggi non affascina più nessuno, e tutti sanno che razzista è un’offesa pericolosa. Non c’è però bisogno di essere razzisti per essere xenofobi. La parola etnia (che è talmente vaga da non voler dire nulla, ma ha una patina di scientificità data dal fatto che esiste persino una scienza che si chiama etnologia) è oggi un pericoloso sostituto della parola razza: è persino una parola simpatica, e tutti ascoltiamo la musica etnica, andiamo a cene etniche ecc. Inoltre, mal si presta a esser base di parolacce e insulti: sfido chiunque a coniare la parola etnista per deprecare qualcuno. La differenza che prima era di razza oggi è di etnia; e non c’è bisogno di alcun avallo scientifico. Anzi, in epoca di scie chimiche, di antivaccinisti e di vegani, meno è scientifico e meglio è, perché la scienza puzza ormai di multinazionali, e l’antiscientificità possiede quel bell’odore rustico di capre, tradizionale e rassicurante, che piace molto ai nostri due partiti di governo. Ecco perché Salvini ha ragione a dire che in Italia non c’è nessun rischio razzismo, e ha ragione l’altro a dargli ragione. Hanno ragione perché è vero, ma è anche vero ed evidente che si tratta di una furbonata. E purtroppo siamo noi, proprio nel nostro sdegno, che diamo loro il terreno per furbonate come questa. Finché si accusa Salvini e i suoi di essere razzisti, essi hanno del tutto ragione a dire che non è vero. Infatti non sono razzisti; sono xenofobi, di quelli tradizionali, di pancia, con tanto di odore di capre attorno (con tutto il rispetto per le capre vere, di cui apprezzo persino l’odore). Insomma, lo sdegno va bene, è doveroso. Questa gente ci sta rovinando in almeno due modi: in primo luogo inventandosi un nemico che non c’è, e rivolgendo verso quello delle risorse che andrebbero invece utilizzate per la convivenza civile; in secondo luogo, distraendo l’attenzione dai problemi reali, come fanno le dittature quando incominciano a pencolare, e si inventano una guerra delle Malvine per nascondere le magagne e portare tutti dalla stessa parte. Lo sdegno va bene, ma definire questa gente razzista è un po’ come riconoscere che noi non capiamo che cosa sono davvero, e insistere con un’accusa che non li tocca, perché è sbagliata. Insomma, che fare? In verità non lo so, ma di sicuro non questo. Le parole col tempo si consumano, e anche le offese perdono la punta. Razzista è spuntatissima, e non serve più a niente. p.s. Avevo già affrontato questo tema qui, qualche anno fa, parlando più specificamente di antisemitismo.
(Mentre scrivevo le ultime righe qui sopra, il mio piccolo paradiso è svanito. Nel giro di pochi minuti sono arrivati prima un motoscafo con una dozzina di persone, e poi due battelli piuttosto grandi e così fitti di gente che parevano immigrati. Musica bumbum a tutto volume, schiamazzi, un sacco di gente a riva: un’improvvisa riminizzazione. Non certo l’altro con cui io potrei sentire alcun senso di intimità, nessuna connivenza, nessuna Stimmung – né peraltro nessun desiderio di trasmettere loro qualsiasi senso io possa essere in grado di dare alle cose. Me ne sono andato. Dopo qualche ricerca, nemmeno troppo sofferta, ho trovato questo rifugio che documento qui sotto, se potete capire, ed entrare in una qualche sintonia con me.)
Il punto non è tanto (o non è solo né soprattutto) l’impossibilità di cogliere il mondo nella totalità dei suoi aspetti. Che la cosa in sé fosse inattingibile ce lo diceva già Kant, e Peirce, correggendo la mira, parlava di un avvicinamento asintotico progressivo. Ma credo che il punto non fosse affatto quello, perché quello che sentivo era un’incapacità di dar senso, e quindi comunicare, qualcosa che nella mia esperienza comunque c’era – e quindi non si trova a livello della cosa in sé. Continuando a riflettere (l’eccesso di spiaggia conduce anche a questo) credo che il problema riguardi l’interazione che sto avendo con il mondo attorno – certo, in questo caso, un’interazione estremamente gratificante, e che amerei quindi trasmettere agli altri. Interazione, e quindi azione e percezione dei suoi effetti sul mondo, e conseguente ancora azione con conseguente percezione e così via. Assumiamo (eccedendo un poco, per semplicità) che nel percepire stiamo già dando un senso, e che quindi ciò che percepiamo sia comunicabile (non è vero per ciascun linguaggio specifico – provatevi a descrivere, con Wittgenstein, il suono di un clarinetto, o il sapore della cipolla! – ma se potessimo registrare tutte le dimensioni sensoriali arriveremmo probabilmente più vicini a questo). Rimane comunque il fatto che la nostra azione non è in sé comunicabile: ovvero, possiamo certamente comunicare la percezione che abbiamo della nostra azione (quello che ne sappiamo insomma, a priori come le sue ragioni, o a posteriori come i suoi effetti), ma non comunichiamo l’azione in sé. Nonostante siamo noi a compierla, noi conosciamo l’azione più o meno come conosciamo le cose attorno a noi, con l’aggiunta che ne conosciamo (riteniamo di conoscerne) il perché. Non diamo senso all’azione in sé, bensì alla percezione che ne abbiamo, ed è questo che possiamo comunicare. Ora, il punto è che mentre la cosa in sé appartiene al mondo là fuori, e siamo rassegnati a coglierla solo in parte, l’azione in sé appartiene al mondo qua dentro (l’ho prodotta io, insomma) e ci appare scandaloso, doloroso, non poterle dare senso se non in maniera tanto esteriore come ci accade con le cose. E’ uno smacco profondo al nostro senso dell’io: la drammatica presa di consapevolezza che il nostro fare, il nostro agire, ci è cognitivamente tanto estraneo quanto il mondo attorno. Profondamente dentro di noi c’è insomma un fuori. Il mondo esterno non è solo nella spiaggia attorno a me, bensì anche nella mia interazione con lei, scandalosamente inconoscibile, se non nella stessa maniera parziale con cui diamo senso al mondo. La filosofia occidentale, da Platone a Cartesio, da Kant a Husserl, è sembrata passare di fianco a questo abisso, senza coglierlo. Questo perché Platone (che, da quel genio che era, non faceva che dare chiarezza e precisione filosofica a dei presupposti contenuti nella sua lingua, come un po’ in tutte le lingue indoeuropee) ha impostato la base del nostro pensiero sull’idea, sul conoscere, giocando sempre al limite tra metafisica e gnoseologia – e così è stato per più o meno tutti quelli che hanno discusso con lui, da Aristotele ai giorni nostri. L’Occidente, così, ha messo il conoscere al centro del proprio mito, pensando la filosofia (conoscere il conoscere) come il proprio punto più alto. L’abisso viene intuito da Nietzsche, e sostanzialmente rifiutato – proprio nel guardarlo – da Freud, che proprio mentre fornisce i mezzi per concepirlo, continua a parlare di inconscio come di un soggetto nascosto, ma tutto sommato conoscibile. E comunque una sorta di io, non di mondo: un io segreto, sotterraneo, che lo psicoanalista può almeno in parte portare alla luce. Ma quando lo psicoanalista vi spiega che le ragioni per cui avete compiuto una certa azione non sono quelle che credete, bensì altre, cosa ne è del vostro io? Per un attimo scorgete confusamente l’abisso, poi la nuova spiegazione sostituisce la vecchia, e dove c’era l’Es ecco che c’è di nuovo l’Io; certo diverso, dotato di maggiore conoscenza. E alla lunga il processo analitico funziona… Di fronte al problema di dar compiutamente senso alla mia esperienza su questa spiaggia, l’abisso, invece, si manifesta con forza. La mia interazione con questo amabile intorno non può essere comunicata né più né meno che nei limiti con cui posso comunicare la percezione che ne ho. Peggio anzi: non c’è macchina fotografica, non c’è registratore sonoro, tattile, olfattivo, gustativo, che possa cogliere la mia azione, se non in maniera ancora più esteriore di quanto lo possano le mie parole, già loro evidentemente e ampiamente insufficienti. E la mia azione è l’interazione continua con tutto quello che ho attorno, dal modo di respirare, di muovermi, di toccare le cose: persino la percezione che delle cose sto avendo è intessuta della mia interazione con loro! Posso produrre un report di tutto ciò, con tutta l’inevitabile esteriorità che tale report avrà, come ho abbozzato ieri, come ho continuato a fare con le foto di oggi. Oppure posso scrivere una poesia, girare un film, dipingere, comporre un brano musicale. Sarà tanto più evidente, ora, quanto la credenza che un’opera di questi tipi possa comunicare la mia esperienza del qui ed ora, trasmetterne un senso. Non è certo così che funziona la poesia, né l’arte in generale: non descrivendo il mondo, né le emozioni del soggetto, come credevano i Romantici. Travolti dalla nostra adorazione per il Conoscere, abbiamo trattato l’arte come qualcosa che debba trasmettere un messaggio, e questo messaggio vada colto dal fruitore attraverso il processo di interpretazione. Già Susan Sontag, nei primi anni Sessanta, lamentava il dominio dell’interpretazione (il libro è, appunto, Contro l’interpretazione), facendo osservare che questo modo di vedere le cose ha condizionato gli artisti stessi, che hanno prodotto tante opere affinché fossero poi interpretate, riempiendole di verità nascoste, come in un esercizio di enigmistica. In realtà, quello che capiamo di un’opera d’arte, di una poesia, è importante probabilmente non di più di quello che non capiamo. Un’opera d’arte è tale non per quello che ci dice, ma perché ci propone un’esperienza, intessuta di capire e non capire come le cose del mondo, e a sua volta piena di interazione, perché noi le siamo di fronte, o immersi al suo interno (come nella musica), e quello che percepiamo dipende dalle mosse che facciamo nei suoi confronti. Proprio come con il mondo, non è che percepiamo e basta le opere d’arte, ma il percepire è frutto dell’agire nei loro confronti: dove posiamo lo sguardo, dove e come si fissa l’attenzione, come ci muoviamo nei loro confronti… Insomma, l’opera d’arte, come il mondo, viene vissuta prima che percepita, e quindi percepita nell’interazione con lei. In questo senso è piena, proprio come il mondo, di quell’inumano che finiamo per ritrovare anche dentro di noi. La differenza, come concludevamo ieri, è che di mondo si può anche morire, mentre di poesia no; e questo permette un’interazione molto più disinvolta. Ma questa disinvoltura, se siamo sufficientemente attenti, è anche quella che ci permette più facilmente di cogliere l’abisso. Una grande poesia può essere quindi un’esperienza lancinante, ancora più di questa spiaggia, perché mi riguarda ancora più da vicino.
Prosegue qui, su Nazione Indiana
Questa visione del soggetto e dell’io si oppone, evidentemente, a quella antica e a quella cartesiana, che, in vario modo, contrappongono una res extensa, il mondo, la natura, a una res cogitans, l’autocoscienza, la mente. Questa dicotomia non esiste: la boutade di Rimbaud, “Io è un altro”, è preoccupantemente vera. Essere alienati, per Lacan, è non rendersene conto, e pensare di possedere davvero un’arena interna di cui si è padroni. Ora la domanda è: la poesia può, o magari deve, recepire questa posizione rispetto all’io? Che senso ha parlare di lirica, cioè di espressione dell’io, se l’io è un’illusione? E chi ancora scrive lirica sta davvero sbagliando tutto? Oppure in che senso ha ancora senso scrivere lirica? Quando Alfredo Giuliani parlava di riduzione dell’io (come “l’ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente”) stava parlando di questo? Proseguendo con le perplessità. La posizione di Peirce e Lacan non è storica. Il soggetto è sempre stato una costruzione, anche al tempo di Saffo. Questo vuol dire che la lirica greca è uno sbaglio? Presumibilmente no. Saffo scriveva, ovviamente, basandosi sulle convinzioni del suo tempo. Ma per noi, oggi, che lo sappiamo, allora la lirica è uno sbaglio? E se un poeta non ha studiato filosofia, e non sospetta nulla di tutto questo, continuando a crogiolarsi nella dominante vulgata cartesiana, è già solo per questo un cattivo poeta? Presumibilmente no, ma forse sarà un poeta un po’ anacronistico, o forse ci lascerà la facoltà di interpretarlo come se scrivesse da dentro l’illusione, come se potessimo ancora crederci davvero. E cosa vuol dire, oggi, scrivere poesia essendo consapevoli della relatività del soggetto, e della superficialità alienata dell’io? C’è una forma specifica di questa post-lirica? Aggiungiamo che, se l’io è un’illusione, allora si tratta di un’illusione progressivamente sempre più dominante in Occidente, di cui tutti in misura maggiore o minore, siamo vittime, anche quando dell’illusione siamo consapevoli. Una poesia che agisca dentro l’illusione, rendendone conto, ma senza consapevolezza del suo essere tale, sarà accettabile? Oltre certi limiti è certamente anacronistica, come dicevamo sopra (il che non significa, di per sé, che sia cattiva poesia); ma parlare dell’io è comunque anacronistico? Forse se la poesia ci permette di essere letta come se (nei termini di cui sopra) allora l’anacronismo scompare, o almeno si riduce? Certo, gran parte della lirica del passato appare, se vista con questi occhi, ingenua. Ma tale, se ci leviamo il paraocchi dell’adorazione feticistica del passato, ci appare anche la statuaria della Grecia antica. Ma questo non toglie nulla alla grandezza di Fidia, che va comunque valutato pensando al suo tempo, e non si può trasfondere così com’è nel nostro. Ne era ben consapevole persino Antonio Canova, le cui capacità tecniche sono paragonabili a quelle di Fidia, e che viveva in un’epoca in cui riproporre il classicismo aveva senso; ma Canova sapeva benissimo che una bella statua neoclassica andava comunque interpretata in un modo differente da una bella statua classica – e che parte della differenza stava proprio nella perdita irreparabile di un’ingenuità. Sul soggetto, oggi, non siamo più ingenui. Possiamo perdonare i poeti che continuano ad esserlo? E se possiamo, in che misura li possiamo perdonare? Certamente non del tutto. L’ignoranza, almeno in qualche misura, va pagata. (altre riflessioni, di tono un po’ diverso, ma sullo stesso tema, si trovano qui)
Recentemente ho letto molto Lacan, scoprendovi con sorpresa un sacco di nozioni familiari, anche se spesso chiamate con nomi non familiari. Andando a cercare, su questa base, tracce di Peirce in Lacan, con mia iniziale sorpresa ne ho trovate parecchie, di cui molte assolutamente esplicite, a partire dal Seminario del ’61-62. Facendo un po’ di conti, anche a partire dagli anni di pubblicazione dei Collected Papers, si può ipotizzare che Lacan abbia letto Peirce nei tardi anni Cinquanta, quando già diversi elementi essenziali della sua teoria erano assestati, ma altri ancora dovevano venire. La teoria del soggetto diviso, dell’io (moi) come fenomeno di superficie, e dell’inconscio strutturato come linguaggio erano già state sviluppate prima dell’incontro con Peirce, ma nel momento in cui l’incontro avviene Lacan trova in Peirce tutte le premesse che gli mancavano, essendosi basato sino ad allora sulla semiologia saussuriana e sul suo sviluppo strutturalista. La famosa formulazione “Il significante è ciò che rappresenta il soggetto per un altro significante” è chiaramente un calco dalla definizione peirceana di segno, e rimane oscura sino a quando non si prova a costruirla graficamente in maniera analoga a come normalmente si costruisce la fuga degli interpretanti in Peirce. Ecco qui a destra il diagramma per Peirce: Un representamen (cioè un segno) rimanda al suo oggetto solo attraverso la mediazione di un interpretante, il quale si trova a sua volta nella posizione del representamen iniziale e ha bisogno di un nuovo interpretante, per il quale vale la medesima necessità. Si genera in questo modo una fuga degli interpretanti, virtualmente infinita, ma che ha di fatto termine solo nella prassi (nel formarsi di un abito, ovvero di una disposizione al comportamento, dirà Peirce). Ora, sostituiamo in questo diagramma i termini lacaniani a quelli peirceani, e scriviamo significante là dove c’è scritto representamen o interpretante, e scriviamo soggetto là dove c’è scritto oggetto. Così come in Peirce abbiamo l’immagine di un oggetto a cui di fatto la significazione non arriva, perché è sempre mediata dal passaggio a un altro interpretante, allo stesso modo avremmo in Lacan l’immagine di un soggetto a cui non si arriva (a cui l’analista non arriva) perché qualsiasi significante gli possa rimandare va comunque interpretato alla luce di un altro significante, e così via. Di fatto, il soggetto lacaniano è tutto costruito, per la sua determinante parte simbolica, da questa fuga dei significanti, e per Lacan il soggetto è l’inconscio, mentre l’autocoscienza è un ulteriore sovrastruttura, peraltro illusoria. Il reale lacaniano appare inoltre molto vicino al ground peirceano (per non dire di altro, su cui non scriverò qui). Lacan è erede di una tradizione fenomenologica (quella husserliana-heideggeriana) diversa da quella peirceana, in cui il soggetto non si trova così dissolto. Lacan cresce tuttavia in una cornice anche hegeliana, in cui invece l’idea di un soggetto come epifenomeno è già presente. Anche Peirce ha un retaggio hegeliano, e sviluppa una propria fenomenologia (che lui chiamerà faneroscopia). Con presupposti simili, Lacan sviluppa quindi originalmente una serie di concetti che sono convergenti con quelli peirceani, sino a quando non incontra una fenomenologia diversa da quelle europee, in cui il soggetto è già implicitamente dissolto, e sono presenti da lungo tempo diverse delle sue scoperte (non tutte, certo). Questo è parte di quello che ho raccontato al convegno di Bologna, con altre osservazioni sul Faust di Goethe (che su questo blog erano già comparse qui, e poi di nuovo qui, questa volta sviluppate in un discorso sulla poesia) e ancora altre su Gregory Bateson, che mostrano a loro volta come nemmeno l’idea peirceana che la semiosi sia già presente in natura sia una posizione metafisica, bensì a sua volta fenomenologica. Insomma, una fenomenologia senza soggetto, inquietante e affascinante.
Le letture, non sai mai dove ti portano. L’ultima della mia vacanza greca, imprevista perché il libro non l’avevo portato io ma mia moglie (io avevo finito tutto quello che avevo portato da leggere) è un Michel Foucault, Gli anormali, seminario del 1975. Credevo di avere cambiato del tutto argomento, rispetto alle mie letture precedenti. Foucault ricostruisce la storia della concezione dell’anormalità dal Seicento ad oggi, tra religione, medicina e società. Ecco però che a un certo punto, Foucault si mette a raccontare come, nei primi decenni del Settecento, la Chiesa abbia deciso di sbarazzarsi dei mistici affidandoli alle braccia della psichiatria. In effetti avevo già trovato l’argomento accennato nei libri di Vannini, ma Foucault è più preciso. Vannini si limita a osservare che con Silesius, a metà del Seicento, si conclude la grande stagione del misticismo cristiano, e dopo ci sono soltanto suore invasate. Foucault racconta come la Chiesa decida di sbarazzarsi di queste suore invasate addirittura alienando una parte del proprio potere a vantaggio dei medici, in particolare degli psichiatri, dichiarando, insomma, la Scienza, più competente di lei in almeno un ambito specifico che sino ad allora era stato di sua ristretta competenza. Ci sono tre ordini di considerazioni che mi vengono alla mente, di cui soprattutto la terza mi sembra particolarmente interessante. La prima è che da quel momento in poi i pochi mistici degni di questo appellativo in Occidente non solo non sono più dei religiosi ma talvolta nemmeno dei credenti. Vannini mette in questa (breve) lista Hegel, Nietzsche, Wittgenstein e Simone Weil. Hegel era indubbiamente profondamente cristiano; Nietsche era altrettanto indubbiamente profondamente ateo; Wittgenstein e la Weil sono di origine e cultura ebraica, ma appartengono a famiglie non praticanti e seguono percorsi assolutamente peculiari, basti pensare che la Weil si avvicina al cristianesimo passando attraverso la mistica induista. Insomma, quanto di misticismo rimane in Occidente dal Settecento in poi, non ha più niente a che fare con le chiese cristiane. La seconda considerazione è che l’operazione che la Chiesa compie ai primi del Settecento non deve stupire, perché è, nella sua particolarità e rischiosità (alienarsi una parte di potere è sempre un rischio), qualcosa che segue una logica familiare. In fondo la Chiesa non si è mai trovata a suo agio con i mistici: quando ha potuto, li ha bruciati come eretici, come è accaduto a Margherita Porete alla fine del Duecento e a Giordano Bruno alla fine del Cinquecento, e come non è accaduto a Meister Eckhart e a Nicola Cusano perché erano personalmente troppo potenti e troppo rappresentativi all’interno dell’istituzione (Eckhart era priore di un importante convento domenicano, Cusano era vescovo). Anche se i mistici che ho nominato sono mistici speculativi, la visionarietà della loro ragione è troppo priva di limiti per essere accettabile dalla ragione vincolata alle logiche di potere che caratterizza la Chiesa e le sue teologie. Quando Vannini (in un altro libro) definisce il Cristianesimo come “La religione della ragione”, non ha affatto torto; religione della ragione il Cristianesimo lo è sempre stato, sin da quando l’evangelista Giovanni parlava di Dio come logos. Si tratta però di una ragione controllata, cui si danno limiti severi, formalmente sanciti dalle Sacre Scritture, di fatto sanciti da chi le Scritture le ha sempre controllate, anche perché, da S.Agostino in poi, si sa bene che le interpretazioni possibili delle Scritture sono davvero varie, e non solo quelle canonicamente approvate. L’Illuminismo, a dispetto delle differenze, è innegabilmente un figlio di questa vocazione razionale del cristianesimo (ereditata dai greci più che dagli ebrei), e condivide numerosi aspetti con il padre. Per questo la Chiesa poteva confidare nella nuova scienza per sbarazzarsi definitivamente dei mistici, del sacro e del numinoso. Non prevedeva che quello stesso gesto avrebbe contribuito all’instanziarsi delle condizioni per la Rivoluzione Francese, la cui religione era quella della Dea Ragione, e basta; e alla nascita del positivismo, antireligioso per natura, e tuttavia specularmente simile alla religione cui si oppone (per le ragioni che ho spiegato qui, parlando del fisicalismo). E veniamo alla terza considerazione, quella che più mi interessa. Mi colpisce che il Settecento sia non solo il secolo della fine del misticismo in Occidente, ma anche quello in cui si sviluppa la nozione di sublime. In altre parole, proprio quando la Chiesa si sbarazza definitivamente del sacro, ecco che la società si impossessa del sublime (sulla contiguità di sublime e sacro ho parlato già qui). Il trattatello dello pseudo-Longino viene scoperto in Francia alla fine del Seicento, ma studiato e divulgato soprattutto nell’Inghilterra del Settecento (racconto nel dettaglio la storia qui, ma ho parlato molte volte del sublime in questo blog). Con il Romanticismo, poi, ma già ben anticipata nel secolo precedente, si afferma un’idea di Arte molto più legata al concetto di sublime che a quello tradizionale di bello. Questa idea reggerà alla crisi del Romanticismo e del suo legame con le emozioni, e l’idea di sublime, per quanto mascherata, rimarrà alle spalle di tutte l’arte moderna: in una logica del sublime, per esempio, possono trovar spazio il ready made duchampiano e l’arte concettuale, i quali sarebbero invece inconcepibili in una logica tradizionale del bello. E non inganniamoci con le parole: quello che spesso oggi chiamiamo bello, con riferimento ai prodotti delle arti, è un bello ben diverso da quello tradizionale, e in cui il sublime gioca una parte forte. Sbarazzandosi delle suore invasate, la Chiesa, insomma, non ha solo regalato alla psichiatria scientifica una parte del suo potere; ma si è anche sbarazzata definitivamente, si è purificata, dall’idea pericolosa e antica del sacro. Coloro che percepivano il sacro, i mistici, non erano più degli eretici da bruciare (cosa che, nel Settecento, non si sarebbe certo potuta fare) ma semplicemente degli alienati, dei folli, da consegnare non all’Inquisizione bensì agli erigendi manicomi, all’istituzione politica basata sulla razionalità scientifica. Ma, scomparso il sacro, ecco che fa la sua comparsa in scena il sublime, una nozione quasi identica all’altra, salvo il suo essere slegata dal rapporto con Dio e il suo situarsi, tassonomicamente, nella dimensione estetica, e non in quella ontologico-religiosa. Il nostro modo di concepire le arti, guarda caso, si definisce proprio tra Sette- e Ottocento. L’autogol della Chiesa, insomma, si direbbe duplice, e sempre fatto in nome della ragione (quella, moderata, dei rapporti di potere e della, formale, aderenza alle Scritture): da un lato ha delegato alla scienza il controllo di una parte dei suoi membri, dall’altra ha regalato all’Arte la sua dimensione più antica e profonda (ma anche pericolosa, con cui ha sempre convissuto male). La dimensione rituale della poesia (di cui, recentemente, ho parlato qui) esiste indipendentemente da questi eventi, ed esisteva ben prima del Settecento. Tuttavia, non c’è dubbio che una concezione dell’Arte (in generale) come sublime (cioè, più o meno, come sacro) la rafforzi notevolmente. Prima del Settecento la poesia aveva col sacro una relazione ambigua, che poteva anche essere negata da contenuti esplicitamente profani; ma dopo, e specialmente dal Romanticismo in poi, il sublime è libero da condizionamenti religiosi, e la sacralità del testo poetico può essere percepita senza mettere in gioco né la Chiesa né la religione né Dio. Forse era nel destino stesso del Cristianesimo quello di negarsi, e, hegelianamente, di superarsi. La sua natura razionale, di origine greca, è ciò che l’ha caratterizzato e reso vincente per due millenni. Ma questa stessa natura razionale ha inevitabilmente seminato i germi che stanno distruggendo il Cristianesimo, da un lato perché al di fuori della religione la ragione ha trovato un terreno più libero e fertile, dall’altro perché non di sola ragione vive l’uomo, e le Chiese cristiane sembrano esserselo dimenticato. Ieri mattina non siamo riusciti ad alzarci presto come avremmo voluto. Così abbiamo perso il bus, e abbiamo fatto l’autostop. Dopo dieci minuti ci ha preso su una macchina con un padre e figlio italiani, diretti al traghetto con meta aeroporto, per il figlio, mentre il padre sarebbe rimasto ancora un poco. Simpatici, cordiali, e soprattutto ci hanno fornito l’informazione essenziale su dove trovare un motorino a prezzo più basso. Col motorino siamo andati a Pothià, la cittadina capoluogo dell’isola, con un gran traffico (per i ritmi a cui ci siamo abituati) e un bel museo archeologico, piccolo ma significativo, spaziante dal 3.000 a.C. sino al 1.400 d.C. Abbiamo mangiato in una uzerìa in un vicoletto percorso da un’incredibile brezza fresca, a due passi dal porto. I gestori parlavano solo greco, ma una bella ragazza tra i clienti ci ha fatto da interprete, via inglese, sino a quando ha scoperto che eravamo italiani, e allora è passata all’italiano. Nina, figlia di un greco di Kalymnos e di una slava di Spalato, conosciutisi a Pavia, dove entrambi studiavano, e anche lei nata a Pavia; da piccola i genitori le parlavano in Italiano, perché le restasse in mente (e forse anche perché all’inizio era la lingua che avevano in comune). Poi ci ha presentato un amico del padre, anche lui a suo tempo studente in Italia, che ci ha offerto da bere, come spesso si usa, sulle isole greche… Siamo rimasti lì a lungo, in questa atmosfera così piacevole. Quando abbiamo chiesto a Nina se sapeva di qualche posto dove si facesse musica, ci ha detto semplicemente di tornare lì la sera, dopo le 9. Così ci siamo organizzati per farlo. Siamo ripartito col motorino e andati a Vathìs, qualche km più a est, un paesino di pescatori su un fiordo stretto stretto, così stretto che nemmeno c’è la spiaggia, solo il porticciolo, e intorno tutto a strapiombo, incantevole. Così come incantevole era la spiaggia dove abbiamo riparato, a metà strada tra Vathìs e Pothià, al solito semideserta, con le solite meravigliose tamerici a dare ombra direttamente davanti al mare. Lì mi sono tuffato nella lettura del nuovo libro, che, tanto per restare in tema, è un libro di Marco Vannini, su Mistica e filosofia. Vannini è un ottimo studioso e storico di questi temi. I personaggi di cui parla sono affascinanti (Margherita Porete, Meister Eckhart, Nicola Cusano, Angelus Silesius…), ma io trovo in tutta la mistica speculativa un grave problema di fondo, che deriva in qualche modo dal suo stesso fascino. Leggendo questi autori, o il resoconto del loro pensiero che fa Vannini, non posso fare a meno di avere la sensazione che questo abbandono totale della materia, a favore di un intelletto purissimo, che arriva a guardare nel fondo dell’anima, nell’essere dell’essere, finisca per configurarsi come una sorta di vertigine, in cui la ragione, lasciata a se stessa e senza più qualsiasi resistenza materiale, si avvolge ripetutamente su se stessa, sino a ubriacarci di conclusioni paradossali e straordinarie. La mia sensazione è, per riallacciarsi ai discorsi dei giorni scorsi, che i mistici speculativi finiscano per vedere il sacro (o il sublime, che è lo stesso) esattamente in questo vortice che è in loro. Nella loro prospettiva il ganz andere (totalmente altro) di Rudolf Otto non è Dio, con il quale, al contrario, si cerca una paradossale unità, bensì l’atteggiamento stesso che permette all’uomo di camminare verso Dio, ovvero questa stessa riflessione iper-spirituale, questo stesso avvolgimento plurimo del pensiero su se stesso, in cui si finisce per perdere qualsiasi coordinata. Trovare il sacro così dentro di sé, nel proprio stesso intelletto, è quanto caratterizza questi mistici. Ma se il sacro è un trascendentale, oppure, peggio, se è un effetto linguistico tipico delle lingue occidentali (indoeuropee e semitiche) questo ritrovamento finisce per diventare una possibilità ovvia, e finisce per apparire anche un fertile travisamento. Travisamento perché non si vede altro che quello che la nostra stessa costituzione fenomenologica o linguistica di fatto ha già posto in noi; fertile perché spesso i risultati sono comunque affascinanti, nella prosa paradossale della Porete e di Eckhart o nella poesia altissima di Silesius. Tutto sommato, preferisco trovare il sublime (il sacro) nella musica, piuttosto che nel fondo dell’anima, questa discutibile astrazione. Anche per questo siamo tornati alla nostra uzerìa, la sera (Paradosiakò ouserie), dopo in realtà aver mangiato degli ottimi dolmadies alla taverna sulla spiaggia di fronte al mare. Suonavano quattro amici: lauto, buzuki, un altro chitarrino minuscolo di cui non so il nome ma che potrei chiamare un buzuki o un lauto sopranino, e violino. Il lautista cantava anche. Musica popolare, di qui, suonata da dilettanti di qualità, ma pur sempre tali. Anche di questo genere ho sentito di meglio, per esempio a Creta. Però ascoltare queste cose dal vivo, a due metri dagli interpreti, magari cantando con loro (e il pubblico, greco, lo faceva continuamente) o addirittura ballando (come, dopo un po’, tanti hanno incominciato a fare, nel vicolo strettissimo) è davvero in ogni caso un’esperienza. Questo è davvero il senso del fare musica, con tutto il rispetto per la musica progettata, da concerto, che ha evidentemente comunque i suoi pregi: quello di essere un’attività che non separa un esecutore da un pubblico, ma che unisce chi è un po’ di più esecutore (ma intanto si ascolta anche) e chi è un po’ di più pubblico (ma che canta anche, e balla, e partecipa). Col passare delle ore, e l’aiuto di birra e ouzo, si aveva davvero l’impressione di un fervore collettivo, di un riconoscerci tutti attorno al medesimo qualcosa, e quel qualcosa era la musica. In questo senso di comunione che si costruisce attraverso la musica in questo modo, io vedo più sublime e più sacro che non nelle astrazioni dei mistici speculativi. (Qualcuno, con cui avevo semplicemente scambiato qualche sguardo complice sul piacere della musica, ci ha di nuovo offerto da bere) Siamo tornati nella notte, 25 km sul motorino di cui metà nella strada buia, con gli oleandri attorno, e la consapevolezza dello strapiombo sul mare alla nostra sinistra. Nelle orecchie avevo ancora la musica. Da bravo turista, non ho potuto fare a meno di registrare (e videofilmare) parecchi pezzi della serata, ma per quanto buone posano essere le registrazioni (e non lo sono) non sarà mai la stessa cosa. Però mi permetterà di ricordare meglio l’esperienza. Scritto il pomeriggio del giorno dopo, su una poltrona nel giardino, sotto ulivi e bouganville. Kalispera. Oggi giornata statica. Le punture delle api di ieri hanno gonfiato (un poco) il viso di Daniela e dato a entrambi una certa stanchezza. Effetti ritardati del veleno. Così, mi sono alzato alle 10, ho fatto colazione con calma, ho raggiunto Daniela a un tavolino sulla spiaggia (ben 50m da casa), ho ordinato un frapé, ho letto molte pagine del libro di Tagliaferri. Verso l’una ci siamo fatti da mangiare, e poi ho dormito un’oretta, o più; un altro po’ di lettura, e poi siamo finalmente usciti, con meta l’isolotto di Telendos. Ma prima di raccontare di quello, devo finire le considerazioni fenomenologico/teologiche di ieri, ispirate dal libro di Tagliaferri. Ho due riflessioni da esporre, una ispirata direttamente dalle pagine del libro, e una indirettamente. Se non vi interessano, potete saltare direttamente agli ultimi paragrafi del post, dove racconto di Telendos. La prima riflessione è legata all’idea del sacro come trascendentale, a-priori, e alle definizioni di Rudolf Otto come ganz andere, ovvero totalmente altro, ma anche numinoso, terribile (arreton). Guarda guarda, il sacro visto in questo modo assomiglia incredibilmente al sublime, del quale ugualmente si potrebbe sostenere la trascendentalità. Solo che il sublime, a differenza del sacro, non è legato all’idea di Dio; non che la escluda, ma di per sé non la implica. Il senso di soverchiante, di favoloso, di terribile, di totalmente altro che il sublime produce in noi può essere tranquillamente naturale, materiale; e non ha bisogno di rimandare al divino, se non, al più, metaforicamente (un “come se”). Il sublime, oltretutto, è un concetto non religioso, bensì estetico. Se identifichiamo sacro e sublime non perdiamo l’alterità, la numinosità (ovvero il senso del divino) né la terribilità; perdiamo però il rimando a Dio, anche come trascendentale, e non abbiamo più un posto dove metterlo. Ed ecco la seconda riflessione. E se questa idea del sacro (o del sublime) come a-priori non fosse che un effetto linguistico? Mi sto rifacendo ai lavori, interessantissimi, di François Juillen, che mettono a confronto la cultura occidentale con quella cinese, scoprendo in questo confronto, per esempio, che l’idea di essere non è affatto universale, ma è sostanzialmente un prodotto delle grammatiche occidentali, che permettono la sostantivazione del verbo. In cinese, viceversa, verbo e sostantivo non sono nemmeno categorie differenti, ma solo modi differenti di usare le medesime parole. Non si può sostantivare l’essere, in cinese, e di conseguenza non ci si può nemmeno porre il problema cruciale della filosofia occidentale, che è per l’appunto il problema dell’essere. Cade evidentemente, insieme con questo problema, anche la possibilità di definire Dio come l’essere assoluto. Se ho capito bene le descrizioni di Juillen, la Cina non ha una religione nel senso in cui la intendiamo noi, con un dio, o delle divinità. La cosa che, per noi, più assomiglia alla religione, sono il Tao e il confucianesimo, entrambi piuttosto collezioni di principi morali, esposti con un linguaggio che per un Occidentale è al limite del paradossale, e che richiede una grande competenza sulla tradizione cinese per poter essere compreso davvero. La cosa andrebbe verificata più approfonditamente (cosa che qui, ora, non ho modo di fare, ma che conto di fare, presto o tardi), ma se insieme a questa assenza di divinità, la cultura cinese mancasse pure del senso del sacro/sublime, allora sarebbe dura continuare a pensarlo come un vero trascendentale. Potrebbe continuare a essere precategoriale e antepredicativo, perché in parte il linguaggio agisce anche a quel livello; ma sarebbe comunque un effetto linguistico. Del resto, nel mondo le culture dove il misticismo si è sviluppato di più sono l’Europa e l’India, le due grandi aree dei linguaggi indoeuropei, dalla struttura comune. Lo diceva anche Nietzsche (cito a memoria): “Non avremo ucciso Dio finché non ci sbarazzeremo della grammatica, quella vecchia donnaccola truffatrice!”
Finite le letture del pomeriggio, abbiamo raggiunto le nostre salvatrici di ieri e, in macchina con loro, siamo andati a Mirties, verso la metà dell’isola, ove si prende il traghettino per Telendos, che è un isolotto che sta proprio di fronte. Telemnos è praticamente una montagna (500m di altezza) piantata nel mare, con una penisoletta bassa, dove sta un paesotto. Ci sono diversi ristoranti e un sentiero che porta sull’altro lato della penisola, quello rivolto a Occidente, dove si può vedere il tramonto del sole. Abbiamo camminato un po’, e siamo scesi per una lunga rampa di gradini bianchi a un chiesetta appena sopra il mare, tutta bianca e azzurra come usa qui. Poi siamo tornati un po’ su a guardare il sole che scendeva nel mare, sopra un gruppo di scogli lontani. A me veniva in mente, forse per l’associazione del tramonto, una poesia di Majakowsky, “La blusa di Bellimbusto”, che dice così (cito anche qui a memoria):
Io mi cucirò neri calzoni Per il Nevsky del mondo, Donne che amate la mia carne coprite me, poeta, con i vostri sorrisi: li cucirò come fiori sulla mia blusa di Bellimbusto! La provavo tanti anni fa, quando facevo scuola di recitazione. Mi è sempre piaciuta moltissimo. Dopo il tramonto (a destra del sole che scendeva c’era l’enorme massa frastagliata della montagna, a picco sull’acqua) siamo tornati in paese, e ci siamo fermati in un localino riparato per mangiare. Ancora moussakà, per quanto mi riguarda: per la mia deglutizione ancora incerta è ottima, ed è ottima pure come sapore. L’intera cena, con bevande e tutto, è costate ben 10 euro a testa. Siamo tornati al traghettino, che, dopo qualche attesa, ha attraversato il nero del mare. Poi ci siamo fatti lasciare dalle nostre amiche a circa un km dal paese, per camminare un po’ al buio, e muovere le gambe. Avvicinandoci a Emboriòs abbiamo iniziato a sentire dei suoni, anzi delle note, anzi una musica, poi persino una voce che cantava. Nella piazzetta del paese, dietro la spiaggia, stavano ballando, con due suonatori (organo/voce e buzuki). Non il massima della qualità, forse, ma ugualmente suggestivo, con questi ritmi greci un po’ storti, e queste armonie sospese tra oriente e occidente. Adesso sono qui davanti a casa, che scrivo il mio diario tra i grilli. Kalinichta!
Oggi siamo andati qui, alla baia di Palionissos. Dieci km da Emborios, a piedi, con salita sino a 300m e relativa discesa di là. Ci siamo svegliati alle sei, per camminare col fresco. La salita non è stata faticosa, e il panorama era spettacolare: Kalymnos è un’isola molto frastagliata, e qui davanti è pieno di isolette. Quindi gran combinazione di coste, e aperture e chiusure sul mare aperto, a seconda della posizione e dell’altitudine. Davanti a noi, di là dalla baia, il roccione sporgente della penisoletta di Kastelli, che probabilmente deve il suo nome non tanto al fatto che ospitasse un castello, quanto – io credo – perché il roccione a torre sembra proprio un castello, enorme e favoloso. Tutta la salita è stata all’ombra. La parete è rivolta a sud-ovest, mentre il sole era sorto a nord-est. Al passo siamo emersi nel sole, ed è anche piacevolmente iniziato un po’ di vento. Dopo un paio di curve si è aperta una veduta spettacolare di Leros, l’isola immediatamente a nord. Poi è passato un furgoncino, con dentro una specie di astronauta. Dopo un attimo di perplessità ho capito che si trattava di un apicultore, e mi sono domandato perché si proteggesse anche dentro l’abitacolo. Dopo un minuto ne è passato un altro, che ci ha fatto dei gran segni di coprirci, perché avevano appena preso il miele alle api, e queste erano un po’ arrabbiate. Ci siamo un po’ coperti, ma c’è voluto un po’ per capire che stavamo andando diretti a metterci nei pasticci, insomma, avanzando spediti verso il pericolo. La prima ape mi è arrivata in faccia: mi ha punto la guancia in due punti ed è andata a strapparsi l’aculeo nella pelle della mia nuca. Ho affrettato il passo, ma non sapevo che mi stavo lanciando nella tana del lupo. Dopo un centinaio di metri avevo sei o sette api che mi ronzavano attorno, con un’aria piuttosto aggressiva. Una mi ha punto ancora, su un braccio. E io ancora più veloce, sperando di superare in fretta il punto critico. Daniela si era coperta con l’asciugamano da spiaggia, bianco, ed era uscita dalla strada. Ogni tanto si dimenava imprecando e sbattendo l’asciugamano: ovviamente anche lei veniva punta. Mi sono accorto che da lì in poi le arnie aumentavano ancora. Allora mi sono fermato e sono tornato un po’ indietro. Mi sono messo sulla testa l’asciugamano bianco anch’io. Siamo stati fermi. Ma immaginate di avere intorno a voi, al vostro viso, una piccola nube di api evidentemente piuttosto inferocite. Si cerca di non perdere la calma, ma non è facile, specie quando un’ape supera la rudimentale protezione del telo da bagno e vi va sull’occhio, o sulle labbra. La calma svanisce di colpo, allora, e tutto diventa frenesia di sbattimento dell’asciugamano, e agitare le mani per tenere le bestiole lontane dalle parti vitali. Sono passate due moto. Le api intorno a me scompaiono di colpo. Che abbiano preferito seguire quelli in moto? Tiro un sospiro di sollievo, ma dopo qualche minuto la nube si torna a formare. Un’ape si lancia all’attacco, entra nella fessura e mi punge sul naso, sulla narice sinistra. Dopo un poco un’altra conquista la mia fronte. Chiudo l’asciugamano più che posso, ma ovviamente entrano da sotto. Quella che si posa sulla mia guancia riesco con la mano a buttarla a terra, e poi la pesto. E’ la mia unica vittoria. Poi, finalmente, non so dopo quanto tempo, passano un furgoncino e una macchina. Ci buttiamo per fermarli, urlando “bees, bees”. Sulla macchina ci sono due ragazze italiane, a cui possiamo spiegarci; e ci fanno salire, sigillando poi i finestrini. Fine dell’avventura. Ora si scende senza difficoltà a Palionissos, in pochi minuti. Le due ragazze discutono un attimo su come evitare Nicolas, il ristoratore che conosce tutti per nome e ferma tutti. Ma tanto noi vogliamo fermarci a bere un caffè, e quindi le ragazze concludono che possono farla franca a nostre spese. In effetti Nicolas ferma davvero tutti quelli che passano a piedi per lo stradello che porta al mare, a metà del quale sta la sua taverna, rivolgendosi a ciascuno nella sua lingua. Parla italiano, francese, inglese e tedesco abbastanza bene (l’ho sentito), e ha detto che parla pure svedese e sta studiando lo spagnolo e il turco. Tutto, ovviamente, per agganciare i turisti. Nicolas ha fatto l’insegnante elementare per molti anni, poi si è trasferito a Palionissos. E’ riuscito a farsi costruire e asfaltare la strada, facendo arrivare sul luogo molta più gente. Così, per qualche anno la sua taverna è andata a gonfie vele. Anche troppo gonfie, così che altri hanno aperto altre due taverne, però direttamente sul mare, mentre la sua è almeno a 300m nell’interno. Due taverne una di qua e una di là dalla baia, con gran veduta e arietta fresca. Per questo motivo, Nicolas è ora costretto ad agganciare tutti quelli che passano, a raccontare la sua vita e mostrare le sue foto, in modo da stabilire un rapporto umano e implicitamente costringere i turisti a tornare lì, quando sarà ora di pranzo. E così abbiamo fatto noi. Abbiamo mangiato bene, però la mussakà di ieri era migliore della sua di oggi, e forse le spugne marine che ci ha venduto non erano proprio a buon prezzo. Ma Nicolas è molto gentile, e sa farsi apprezzare. La baia di Palionissos è bella e stretta, con attorno montagne alte e aspre, come sempre qui. Ci siamo sdraiati sotto un’opportuna tamerice, molto grande e ombrosa, vicino a una coppia di anatre che salivano e scendevano nello specchio d’acqua davanti a noi, un piccolo molo con una barca, prima del mare vero e proprio. Sono passate alcune ore pigre, con un bagno nell’acqua molto limpida e la gita da Nicolas per il pranzo. Le punture delle api hanno smesso abbastanza rapidamente di bruciare (è adesso, molte ore dopo, che torno a sentire indolenziti alcuni di quei punti). Sono andato avanti nella lettura del primo dei libri che mi sono portato dietro: Sacrosanctum, di Roberto Tagliaferri. Un libro di teologia, o qualcosa del genere. Dunque, perché io, che sono non credente dall’età di sedici anni, leggo libri di teologia? Dovrei dire, in realtà, leggo libri di Tagliaferri, perché sono soprattutto quelli il mio contatto con la teologia, ma in verità ce ne sono anche altri, specie sul tema del misticismo. Diciamo che trovo una convergenza interessante tra questi temi e quelli della fruizione estetica, e ci sono in certe posizioni teologiche delle idee molto fertili applicabili al senso dell’arte. Ho scoperto Tagliaferri perché si occupa di rito, che è un tema che ha iniziato a interessarmi perché è contiguo a quello del ritmo, di cui mi occupo da anni. E’ andata a finire, tra l’altro, che Tagliaferri sta anche pubblicando un libriccino sul ritmo, che avrà la mia Prefazione. Tagliaferri non è solo un teologo, e professore di liturgia a Santa Giustina (Padova). E’ anche un prete. E ci sono alcune cose che non capisco. Non perché sia un prete esemplare: come prete è decisamente anomalo. Ma resta tale, e quindi evidentemente credente, e non ci sono dubbi su questo. Il libro, Sacrosanctum, affronta il problema del sacro e del santo nel cristianesimo e nella cultura contemporanea. Inizia con alcune rassegne di posizioni sul tema: prima ci sono le posizioni dei teologi, che, con poche eccezioni, hanno screditato il sacro in quanto comune a tutte le religioni, specie le antiche, in nome di una diversità e novità del cristianesimo. Poi ci sono quelle dei fisicalisti, o scientisti: i filosofi o scienziati alla Dennett o alla Dawkins che sostengono l’assurdità della religione (e del sacro) in nome della posizione materialista, nella quale queste cose non trovano posto. Poi si prosegue con altri autori più vicini alla fenomenologia, come Gregory Bateson, che, senza essere religiosi, danno un certo rilievo al tema del sacro, considerandolo come un apriori, o come Roy Rappaport, che vede nel rito l’origine del sacro, e nella coppia rito/sacro la base stessa della vita sociale (il suo librone su questo tema sarà la mia prossima lettura estiva). E poi si arriva ai fenomenologi veri e propri, in particolare Husserl, ma anche lo Heidegger giovane (1920) del saggio sulla religione, e il teologo Rudolf Otto. E la mia lettura si è, al momento, fermata qui. Nel leggere la parte sugli scienziati fisicalisti (o naturalisti, come preferisce chiamarli Tagliaferri), non ho potuto fare a meno di portare avanti questa riflessione: c’è qualcosa che unisce strettamente la posizione scientista (fisicalista, naturalista) a quella del credente cristiano, a dispetto dell’ateismo della prima. Si tratta del problema dell’esistenza di Dio, negata o asserita che sia. La si asserisce in nome della fede (strana parola, in effetti), la si nega in nome della materia, in cui Dio non trova posto. Eppure anche l’ateismo costruito in questo modo si basa su una fede. A metà del Settecento, David Hume dimostrò l’infondatezza dell’idea di causa, mostrando con chiara evidenza che non è possibile osservare la causa in natura, nella quale si osservano solo fenomeni in sequenza, magari in sequenza regolare, ma non direttamente cause ed effetti. Cinquant’anni dopo, Kant risolse genialmente il problema portando la causa all’interno del soggetto che comprende e interpreta: la causa sarebbe cioè per Kant un a-priori, un trascendentale, qualcosa che noi applichiamo in maniera automatica alla spiegazione dei fenomeni naturali, ma che non è in natura, bensì in noi, nel nostro modo di conoscere il mondo. I fisicalisti scientisti sembrano aver dimenticato oggi Hume e Kant, e si comportano come se le cause esistessero in natura. La loro è una vera fede (nel senso cristiano) nell’esistenza della causa, perché non vi è modo di dimostrare la sua esistenza (o non esistenza) in natura. Bisogna credere che la causa esista materialmente per poter essere davvero materialisti in questo modo – un modo che a me appare davvero ingenuo, a questo punto. La fede del materialista nell’esistenza della causa è strettamente speculare a quella del cristiano nell’esistenza di Dio. Materialista e cristiano parlano lo stesso linguaggio, condividono le medesime premesse, solo che uno ha fede nell’esistenza della causa, e l’altro ha fede nell’esistenza di Dio. Una fede vale l’altra, verrebbe da dire. Eppure, se, insieme alla causa, considerassimo trascendentale non solo il sacro ma anche l’idea stessa di Dio? Questo vorrebbe dire che Dio non si trova nella natura, materialmente o spiritualmente, immanentemente o trascendentemente, bensì dentro di noi, nelle forme stesse della nostra conoscenza, ed esiste nel senso stesso in cui esiste la causa, ovvero come modalità di comprensione del mondo. Penso che potrei accettare un’esistenza di Dio intesa in questo modo, tuttavia è evidente che un Dio trascendentale sarebbe qualcosa di ben diverso da un Dio trascendente! Sarebbe, prima di tutto, una forma del nostro rapporto con il mondo, dove l’espressione “nostro” andrebbe presumibilmente a comprendere non solo l’universo umano, bensì, batesonianamente, tutto l’universo del vivente, quello che lo stesso Bateson chiama la creatura. Si potrebbe fondare il cristianesimo su un Dio trascendentale (ed eventualmente trascendente solo attraverso e all’interno del trascendentale)? Io ne dubito fortemente, anche se ho già trovato un’idea simile in un altro teologo singolare, Raimon Panikkar, che sostiene che la religione, o almeno la teologia, ha finalmente superato il problema dell’esistenza di Dio; e credo che Panikkar alludesse a posizioni simili a quella che sto descrivendo (il libro in cui ne parla è Mito, fede ed ermeneutica). Bene, tornando a Tagliaferri, ecco che trovo nel suo libro, nelle pagine dedicate a Husserl, esattamente le conclusioni a cui ero arrivato poco prima, e l’esplicita descrizione di un “trascendente trascendentale”. Ora, se da un lato questo rafforza la mia convinzione che la posizione di Tagliaferri è davvero interessante, dall’altra mi conduce a domandarmi come possa essere questa la posizione di un cristiano, di un credente, di un prete. E’ davvero possibile negare il problema dell’esistenza di Dio (il problema stesso, non la sua risposta!) permanendo ugualmente all’interno di una Chiesa che ha fatto di tale esistenza il suo cardine per duemila anni? Era già stata la posizione di Rudolf Otto, autore, negli anni Dieci del Novecento, di un libro sul sacro che ebbe grande influenza sul pensiero di Husserl, e su varie scienze della religione dei decenni successivi sino a oggi. Non c’è dubbio che la religione regga benissimo queste posizioni, ma l’idea di Dio non va un po’ a ramengo quando la si riduce a trascendentale, ovvero quando ci si rende conto che non c’è altro modo di mantenerla, perché l’idea della sua esistenza nel mondo (materiale o trascendente) è insostenibile? Perché Rudolf Otto e don Roberto Tagliaferri possono continuare a ritenersi cristiani, mentre io, che sembro pensarla come loro, non mi sento cristiano e potrei definirmi soltanto agnostico? Questa riflessione conclusiva (per ora) viene fatta verso le 23.30, sul tavolino davanti la mia stanza, in una bella serata né calda né fredda. Si sta semplicemente bene. Forse per via dello zampirone tra i miei piedi non sono stato nemmeno disturbato dalle zanzare. Domani giornata tranquilla, giri piccoli, mare, lettura. Kalinikta.
La nozione di “verità” di cui si parla nell’articolo è quella utilizzata in filosofia del linguaggio, e il mio articolo ne sostiene la non applicabilità ai testi estetici. L’articolo inizia prendendo come punto di partenza l’analisi critica di una poesia di Giuliano Mesa, sviluppando poi il discorso in maniera molto più generale. L’articolo (insieme a tutta la rivista) è interamente leggibile qui. Eccone le prime righe:
Devo aggiungere ancora qualche osservazione a quello che ho detto su Oltremai di Lorenzo Mattotti la scorsa settimana. Si tratta del rapporto con il tema del sublime, un tema che ho sfiorato molte volte (vedi qui, e in particolare qui). L’innamoramento settecentesco della cultura europea per la nozione di sublime è all’origine tanto del romanzo gotico e dell’horror, quanto del Romanticismo, quanto del mito funzionalista della forma pura. Stupisce un poco pensare che dietro ai lavori di Piet Mondrian e di Howard Phillips Lovecraft ci sia qualche elemento comune (poi, certo, non c’è dubbio che quell’elemento comune si è combinato e contaminato con altri elementi molto diversi tra loro, per arrivare a visioni del mondo così diverse – ma l’aspetto interessante è che l’elemento ci sia!). L’elemento comune potrebbe essere sintetizzato nella parola primitivismo. Per Mondrian si tratta di trovare la forma più semplice, più astratta di tutte, quella che i suo maestri cubisti erano già andati a cercare nell’arte (considerata primitiva) africana, e che lui cerca nei rapporti geometrici e cromatici puri. Per Lovecraft l’horror è l’irruzione nel mondo di forze primitive non controllate, superiori alle nostre possibilità di controllo. I surrealisti cercheranno questa primitiva purezza nell’inconscio, le neo-avanguardie nella ricerca del grado zero della scrittura, certo non immemori dello sberleffo duchampiano, ambiguo tra l’assunzione di un grado zero totale di significatività artistica e la sua devastante parodia. La concezione del sublime non è al polo opposto dell’Illuminismo, e non a caso Kant ne è pure il suo maggiore teorico. L’idea stessa che la matematica possa fornire una spiegazione ultima del mondo è un’idea che ha a che fare col sublime. Per quanto possa apparire complessa, il bello della matematica è che tutto può essere riportato a principi più semplici, a principi elementari… Il problema forse è che, procedendo in questo modo, troppe cose sembrano dipendere da questa idea. Aggiustando un po’ il tiro, possiamo pensare che la riscoperta dello Pseudo-Longino da parte di Boileau e il successivo innamoramento della cultura inglese per le sue idee, siano a loro volta figli dello spirito del tempo; e magari le cose sarebbero andate così anche senza l’affermarsi dell’idea del sublime. Ma, come accade in questi casi, l’idea e la parola che la esprime hanno finito per fare da attrattore, da catalizzatore, per raccogliere e rilanciare quello che era già nell’aria, ma in forma più dispersa. Ed è così che ci possiamo accorgere che lo stesso tipo di tensione sta dietro al razionalismo illuminista, e a quelli che appaiono essere il suo opposto, lo spirito romantico e l’inconscio freudiano. Il famoso Capriccio di Goya, del 1797, El sueño de la razón produce monstruos viene normalmente interpretato (su conferma di altre parole del medesimo Goya) traducendolo come “Il sonno della ragione genera mostri”. Tuttavia, la parola spagnola sueño significa non solo sonno, ma anche sogno. Se seguiamo le parole dei manoscritti di Goya (“La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas.”) penseremo che è quando la ragione non veglia che nascono i mostri. Ma la sua frase originale ci autorizza anche a un’interpretazione diversa: la ragione, quando sogna, produce mostri. Questi mostri, ancora ignoti a Goya, si possono chiamare oggi libero mercato, comunismo, nazismo, Olocausto, scientismo (che non è la scienza, ma il sogno che tutto sia interamente spiegabile attraverso la scienza). Sono il punto di contatto tra Mondrian e Lovecraft, ciascuno dei due innocente, ma rivelatore nella sua sensibilità. E Goya ci riporta al nostro punto di partenza, Oltremai di Mattotti, essendone chiaramente un lontano ispiratore (per ammissione, tra l’altro, di Mattotti stesso). Il sublime di Oltremai è quello dei mostri ed è quello di William Turner; è quello del sonno più che del sogno della ragione. Goya poteva ancora pensare alla ragione come alla possibilità del controllo sull’irrazionale, e quindi all’arte come qualcosa che è figlia di questo controllo, esercitato sull’irrazionale fantasia. Goya poteva pensare che la ragione fosse qualcosa che ha a che fare con la classicità, e con la sua tradizionale capacità di controllo; la sua arte non è già più quella classica, ma condivide con quella il controllo, classico, sull’irrazionale. Due secoli dopo, questi Capricci di Mattotti sembrano essere stati prodotti interamente dal sonno della ragione, attraverso un controllo che non è quello della ragione, non quello del calcolo e nemmeno quello del racconto, e quindi nemmeno quello della classicità. Sono figli dell’improvvisazione musicale e dell’improvvisazione grafica dei calligrafi cinesi e di Jackson Pollock (anche se Mattotti negherà quest’ultima associazione); cioè figli più di un’idea di Stimmung, cioè accordatura, sintonia, che di un’idea di spiegazione razionale (matematica o narrativa che sia). In questo senso, proprio nel loro assumere i temi inquietanti delle poetiche del sublime, questi lavori si trovano sull’orlo del loro superamento. L’orrore, i mostri, sono diventati semplice inquietudine; non ci soverchiano più, ci conviviamo incertamente, pur senza pretendere di controllarli e di spiegarli. È scomparsa, o sembra scomparsa, la dialettica tra primitivo e matematico. La paura che proviamo non è terrore; l’incapacità di controllare il primitivo non ci soverchia; la semplificazione razionale è fuori gioco. Siamo al di là di Lovecraft e al di là di Mondrian: è il tema in comune all’opposizione tra loro che sta per essere messo fuori gioco. Sarà forse perché questa dialettica tra controllo razionale e distruttività primitiva è la dialettica del soggetto individuale, pilastro della nostra cultura (ma non di tutte le altre). Sarà forse perché in questi Capricci di Mattotti è proprio il soggetto a essere scomparso…
Il saggio sviluppa in maniera molto più ampia alcune riflessioni che avevo anticipato in un post di questo blog: “Di Goethe, dell’azione e della poesia”, apparso il 31 marzo 2011. Vi si parte da una riflessione filosofica ispirata ad alcuni versi del Faust per parlare del rapporto tra poesia e senso della collettività, lirica e poesia civile. Mi piacerebbe che su questi temi si potesse dibattere. Il saggio è qui: La poesia e il collettivo.
Eppure esiste, e io lo so. Persino in questa stanza in cui sto scrivendo, che mi è estremamente familiare, vi sono innumerevoli aspetti e dettagli non percepiti, mai percepiti – non solo particolari che non c’è motivo di osservare, ma anche relazioni inosservate tra dettagli osservati e quindi noti. Insomma, io so di non sapere tutto della stanza in cui passo tante ore, e questo fatto non mi preoccupa minimamente: è normale che si viva in una realtà che sfugge in gran parte al senso, e non perché sia insensata, ma perché in gran parte non chiede di essere osservata – almeno sino a quando non arriva il suo momento. Tutto sommato, è una sensazione confortante quella di vivere in un mondo che mi permette di vivere (e magari pure con una certa comodità) anche se non lo comprendo del tutto. Non lo comprendo ma lo vivo, cioè lo attraverso trovando senso, volta per volta, in qualche sua parte. Naturalmente qualcosa devo capire, del mondo che ho attorno, e più ne capisco e meglio è. Ma vivere in un ambiente è accettare la dose di rischio che deriva dal fatto che qualche sua parte è ancora priva di senso per me; e che qualche sua parte priva di senso ci sarà sempre, per quanto io lo esplori e analizzi. Quando si ascolta un brano musicale, si legge una poesia, un racconto, una storia a fumetti, si guarda un film, un’immagine, e così via, ci si trova nella medesima situazione, con una differenza. L’ambiente in cui ci stiamo muovendo non è naturale, ma artificiale, cioè prodotto dall’uomo. Questo comporta che oltre al senso di base che hanno le cose in quanto percepite e interpretate, è presumibilmente presente anche un senso secondo, di carattere simbolico, attraverso cui passa la comunicazione umana. Anche qui, però, non tutto è percepito e non tutto, di conseguenza, arriva ad avere un senso: il testo viene vissuto, proprio come accade con un ambiente, e nel viverlo si sa di non sapere tutto, si sa che ci sono mille aspetti e dettagli che restano in attesa di arrivare a percezione. Questi aspetti e dettagli possono però agire su di noi anche se non ci accorgiamo esplicitamente di loro, anche se non siamo arrivati a dare loro un senso. L’andamento delle cose attorno a noi ci coinvolge anche se non ce ne rendiamo conto. Seguiamo un ritmo, per esempio. I testi artistici, o in generale estetici, vengono vissuti né più né meno degli ambienti del mondo. In questo senso non sono propriamente testi, nel senso in cui lo sono i testi informativi o persuasivi, cioè oggetti costruiti per trasmettere un discorso (che talvolta ha le forme del racconto). Poi, magari un testo artistico sarà anche informativo o persuasivo, perché comunque, sempre, il senso lo attraversa, in quanto prodotto da un autore umano. Tuttavia, ciò che lo rende tale è proprio la sua natura di ambiente, di luogo che va vissuto, attraversato, abitato. Per questo, anche se il lavoro sul significato è importantissimo per l’opera d’arte, l’opera d’arte non si esaurisce nel suo significato, proprio come il mondo stesso non si esaurisce nel senso che gli attribuiamo, perché le scoperte possibili che potrebbero rivoluzionare il senso già assestato sono sempre infinite e potenzialmente imminenti. E se l’opera non si esaurisce nel suo significato, vuol dire che c’è, nel rapporto che intratteniamo con lei, una dimensione di vissuto che rimane cruciale, un sapere che c’è qualcosa che non si sa, e ciononostante la realtà non ci rifiuta, anzi ci accetta, e ci permette di vivere con lei e in lei. L’opera d’arte è una realtà artificiale, fatta dall’uomo per l’uomo. Anche per questo, quando funziona, ci stiamo così bene dentro. Poesia e musica, e molto altro, sono discorsi fatti di mondo, e mondi costruiti di discorso. Una poesia non viene scritta per trasmettere un significato, ma per essere vissuta anche nel significato dei segni che la compongono. Ma siccome, in quel momento, la abitiamo, pure il suono, e l’aspetto visivo dei suoi segni sarà rilevante, proprio come nel mondo – a dispetto del fatto che non sappiamo che senso dare loro, o che non abbiamo la sensazione di accorgercene. Il fraintendimento corrente sta nel fatto che, siccome è fatta di parole, la poesia debba essere interpretata come un normale atto di parola, cioè per comunicare un discorso. Ma chi l’ha detto che un normale atto di parola serve solo a questo? In poesia è evidente che c’è dell’altro. La musica, non possedendo parole, ha evitato questo fraintendimento, ma il problema del suo significato ha ossessionato (e continua a ossessionare) generazioni di studiosi. Io credo che, per il bene del significato, dovremmo accorgerci che non sempre il significato è cruciale. Anche la musica vive una relazione dialettica tra significato e ambiente, dove spesso, sino a qualche secolo fa, il ruolo di trasmettere il significato era di nuovo demandato alla parola (e musica e poesia vivevano a stretto contatto). Poi la musica ha imparato a costruirsi i propri discorsi da sé, ed è diventata un poco più simile alla poesia anche senza fare uso di parole. Nonostante questo, anche nella più concettuosa e intellettuale musica di oggi, è del tutto evidente che per poter cogliere un qualsiasi senso bisogna già esservisi immersi, bisogna già attraversarla e abitarla. Non so se il tema che voglio affrontare qui sia davvero adatto per il post di un blog. Forse avrebbe piuttosto bisogno dello spazio e dello stile di lettura più concentrato di un saggio su una rivista scientifica. Ma ormai mi sono abituato a utilizzare questo blog per mettere giù le riflessioni che mi girano per la testa, e penso che i miei lettori si siano rassegnati a loro volta a questi post dai temi magari un po’ coriacei. In fin dei conti, per male che vada, il lettore ha sempre la possibilità di smettere di leggere e di guardare altrove: il Web è comunque strapieno di cose interessanti. Il tema è quello, profondamente semiotico ma non solo, della narratività. Una delle idee che stanno alla base della semiotica generativa di Greimas è che la struttura narrativa sia fondamentalmente alla base di qualsiasi discorso. Questo sarebbe dovuto al fatto che la struttura narrativa articola un percorso fondato sul quadrato semiotico, il quale a sua volta articola un’opposizione semantica; e le opposizioni semantiche sono alla base di qualsiasi discorso. Io ho qualche dubbio anche su questo, ma non è questo il punto in questione qui. Si può discutere sui dettagli, ma la posizione di Greimas individua nel suo complesso una questione reale, e una centralità del racconto che ne fa inevitabilmente un tema di indagine per chi voglia lavorare a fondo sui testi. Tuttavia, la posizione di Greimas ha un corollario che di solito non viene preso particolarmente in considerazione dai semiologi generativi, troppo intenti a rintracciare le strutture narrative nascoste, e poco interessati a capire come vi siano state nascoste. In altre parole, se il racconto è così pervasivo nei testi, è perché il racconto è evidentemente (come peraltro suggerisce Ricoeur) la forma con cui noi diamo senso al divenire temporale: il tempo, cioè, non è un semplice succedersi insensato di battiti dell’orologio; prende piuttosto senso per noi attraverso l’articolazione delle cause e degli effetti, che è già un’articolazione narrativa. Se volessimo essere kantiani, potremmo dire che la forma-racconto è un trascendentale, ovvero una struttura implicita nella nostra comprensione del mondo. Se invece che kantiani, volessimo essere evoluzionisti alla Bateson, potremmo dire che la forma-racconto è il modo migliore che la nostra evoluzione ha escogitato per metterci in rapporto memoriale con gli eventi del mondo, permettendoci di dar loro un senso – o di trascurarli o dimenticarli quando non entrano in nessuna successione narrativa. Qualunque sia il perché, il come non cambia, il racconto è il modello, lo schema che noi applichiamo alla nostra comprensione del mondo, ogni volta che viene messo in gioco il tempo, cioè un divenire. Ora, se portassimo questa assunzione alle estreme conseguenze, dovremmo dire che non ci sono racconti al di fuori di noi, ma solo sequenze di eventi che noi comprendiamo in modo narrativo. Se il mondo al di fuori di noi fosse fatto solo di natura, potrei anche sottoscrivere queste estreme conseguenze, e farla finita qui, neo-kantianamente. Ma il mondo al di fuori di noi è fatto anche di prodotti di altri esseri umani, i quali esprimono la propria comprensione del mondo; e siccome la loro comprensione del mondo è avvenuta in termini narrativi, allora anche la loro espressione potrebbe essere strutturata narrativamente. Cercare le strutture narrative di un testo significa allora cercare le tracce di questa narrativizzazione. E se mettiamo le cose in questi termini, sembra che i semiologi generativi facciano la cosa giusta quando cercano la forma-racconto alla base di qualsiasi manifestazione testuale, dal romanzo alla pittura alla musica. Il mio sospetto che sia il lettore colui che “nasconde” la forma-racconto nel testo sembra rivelarsi privo di fondamento; l’autore del testo, infatti, prima che autore, è stato a sua volta “lettore” del mondo, e l’ha “letto” in forma di racconto, passandolo poi a noi in questo modo. Continuo a non essere però del tutto convinto. Continuo a sentire della differenza tra il trattamento narrativo di un romanzo (che è sicuramente il prodotto di una lettura già narrativa del mondo), e quello di un dipinto o di un brano musicale. Proviamo a riflettere sulla natura delle nostre percezioni, in particolare sonore e visive. I suoni e le forme visive che arrivano ai nostri sensi vengono prima di tutto interpretati come segnali del mondo circostante; anzi, per la nostra ontologia ingenua, come il mondo circostante stesso. Solo in seconda istanza valutiamo se non siano stati prodotti da qualcuno a scopo comunicativo, e cerchiamo di interpretarli in questo senso. Ma c’è una grande eccezione a questo principio, perché quando i suoni e le figure sono riconosciute come linguaggio (oralità o scrittura, insomma), noi tendiamo a, per così dire, vedere attraverso di loro, per arrivare il più rapidamente possibile al loro significato. La dimensione materiale, quella del significante, non scompare, ma la nostra attenzione è rivolta da subito (e non in seconda istanza) al significato. È solo quando il significato è per noi incomprensibile (per esempio di fronte alle espressioni in una lingua sconosciuta) che ci arrestiamo al significante, con la forte (e ben giustificata) sensazione che ci stiamo perdendo il meglio. Quando sono in gioco le parole (e altri segni dichiaratamente convenzionali), insomma, assumiamo immediatamente che ci sia alle loro spalle qualcuno che le ha pronunciate o scritte. Questa medesima assunzione è molto più problematica, invece, quando le parole non sono in gioco, e siamo di fronte a immagini e/o suoni non verbali. Per portare la cosa al limite, è vero che un dipinto è sicuramente un’immagine prodotta dall’intenzione comunicativa di qualcuno; ma la cosa è molto meno certa (e rilevante) per un’immaigne fotografica o per un audiovisivo. I fotogrammi o le riprese di una telecamera di sorveglianza, per esempio, pur essendo immagini, non sono di solito interpretati come discorsi, bensì come testimonianze, documenti ottenuti attraverso un’estensione della nostra capacità di vedere e udire, che ci permette di vedere e udire anche quello che è accaduto in un luogo e un tempo in cui non eravamo presenti. Senza arrivare a questi estremi, l’assenza di una voce narrativa (orale o scritta) ci mette sempre nella condizione di valutare le percezioni non verbali come segnali del mondo (o direttamente come mondo); poi, subito dopo, nell’eventuale misura in cui sappiamo che sono state prodotte, iniziamo a considerarle anche come discorsi. Una delle conseguenze di questo è che mentre un racconto verbale (orale o scritto che sia) non può non avere un narratore (cioè una voce narrante, che si manifesta – come minimo – attraverso i pronomi e i tempi verbali), un’immagine, una sequenza di immagini o una sequenza di suoni, o una sequenza audiovisiva, possono benissimo non avere un narratore. Avranno un autore, certamente – ma non è la stessa cosa: è la voce narrante, cioè il narratore, che mi garantisce che quello che sto percependo è già una narrazione, ovvero il prodotto di un’interpretazione narrativa del mondo. Se il narratore non c’è, la situazione è molto più incerta. Supponiamo di stare facendo una passeggiata con un amico, in montagna. A un certo punto lui mi dice “Guarda”, indicando qualcosa. Io guardo e vedo una sequenza di eventi (un gruppo di camosci spaventati che fuggono, un falco in picchiata, una valanga): di fronte a quello che ho visto, io sto già interpretando narrativamente – e lo avrei fatto anche se avessi visto autonomamente quella scena. Certo anche il mio amico ha operato un’interpretazione narrativa del mondo, e sulla scorta di quella ha ritenuto opportuno avvertirmi. Ma la sua operazione si è esaurita di fatto con l’avvertimento, e la mia narrativizzazione è tutta mia. Ben diverso sarebbe stato se fosse stato lui a raccontarmi uno di questi eventi. In molti casi, quello che succede con i testi non verbali ha qualcosa in comune con l’esempio appena fatto, e non solo nell’ambito, ovvio, della fotografia. Un disegnatore o pittore traccia delle forme affinché, prima di tutto, io le veda e riconosca narrativamente. Proprio per questo le preparerà (potendolo fare, a differenza del mio compagno di passeggiata) in maniera da favorire una mia certa interpretazione narrativa, piuttosto che qualche altra. Ma, a differenza del narratore del romanzo, non potrà dichiarare implicitamente di stare raccontando – perché questo implicito è una prerogativa dalla parola. Il disegnatore (il pittore, il regista…) crea piuttosto delle situazioni prenarrativizzate (o delle sequenze prenarrativizzate) ovvero pronte perché si dia di loro una certa interpretazione narrativa. Non sto giocando con le parole. C’è differenza tra un racconto, garantito da un narratore, che ci autorizza da subito ad accettare che la sua stessa produzione sia già narrativa, e una sequenza prenarrativizzata, che siamo noi lettori a interpretare narrativamente, anche se è certamente stata progettata per favorirci in questo, ma dove non c’è nessuna garanzia, e nessuno che dichiara davvero “sto raccontando”. In questo secondo caso, io semplicemente assumo che ci sia a monte un’intenzionalità narrativa, ma sono io lettore a ricostruire il racconto in quanto tale. Ma poiché sono io, io sono anche libero allora di non farlo, e di fruire il testo in altro modo, presumendo che l’intenzionalità narrativa non sia l’unica, o magari non sia la principale, o magari non fosse nemmeno pertinente all’intenzionalità espressiva (e quindi interpretativa) dell’autore. Le parole esistono perché, convenzionalmente, trasmettono discorsi: se mi rifiuto o non sono in grado di recepire una sequenza di parole come discorso, non le sto nemmeno più ascoltando o vedendo come parole. A questo destino sono talvolta destinate le parole quando vengono messe in musica: a volte restano davvero parole, che trasmettono il loro senso, altre si trovano a essere trattate come semplici suoni articolati, ascoltate per il suono e ignorate per il senso. Dal punto di vista del rapporto con il racconto, il musicista si trova in una situazione ancora più estrema di quella di chi produce immagini. In molti casi le immagini possono essere lette come mimetiche; mentre raramente si può dire lo stesso delle sequenze musicali. Il musicista (compositore o esecutore) ci mette di fronte a delle sequenze articolate di suoni, e nemmeno ci dice che siamo tenuti a recepirle come un’interpretazione del mondo. Ma senza questa assunzione, diventa impossibile assumere che ci possa essere un qualche tipo di intenzionalità narrativa in musica, e quindi delle strutture narrative intimamente in gioco. Si fa fatica persino a pensare che la musica possa essere intesa come una sequenza prenarratizzata, quali il fumetto o il cinema (eccetto nel caso di melodramma e simili, ovviamente, dove la musica accompagna un’azione visiva e/o verbale). Quello che si può dire è che ci sono dei contesti storici e/o culturali in cui un’intenzionalità interpretativa del mondo e quindi espressiva può essere ipotizzata. Da Haydn e Mozart in poi questa ipotesi ha un senso nella musica occidentale. Ma forse bisognerebbe domandarsi, opera per opera, se sia accettabile di vederla come una sequenza prenarrativizzata. Se non lo fosse, e ugualmente vi rinvenissimo delle strutture narrative nascoste, sapremmo con certezza che siamo stati noi stessi, interpretando il testo musicale, a nascondervele. Il problema cruciale delle analisi narrative è dunque questo: per evitare di trovare quello che noi stessi vi mettiamo dentro, dobbiamo poter assumere che il racconto vi sia già, almeno nella forma implicita della sequenza prenarrativizzata. Lo possiamo assumere tranquillamente con il romanzo e con le forme analoghe più brevi. Lo potremmo assumere anche con la poesia, se non fosse che la poesia mette molto in primo piano certi aspetti del piano del significante, i quali con il racconto non hanno nulla che fare – ma la poesia gioca proprio su questo doppio binario. Lo assumiamo convenzionalmente con fumetto e cinema, trattandoli come varianti del racconto verbale – ma ci sono situazioni in cui la differenza salta fuori. A mano a mano che ci si allontana da questo nucleo, l’assunzione di narratività deve essere sempre più forte, e sempre più esplicitamente motivata: in musica, per esempio, è accettabile per il Romanticismo, ma in generale a fatica per le forme strumentali del Barocco – mentre sul jazz credo che potremmo discutere a lungo, caso per caso. In pittura, è accettabile per molti generi, ma la natura morta e il paesaggio la eludono in molti casi – per non dire dell’astrattismo di Mondrian, o dell’informale di Pollock. Non basta, insomma, trovare in qualche tipo di testo un’analogia con la forma-racconto per poter dire di essere di fronte a una struttura narrativa. Siamo noi a vedere racconti dappertutto. L’analogia non è una prova se non del fatto che quello che abbiamo davanti è un frammento di mondo, interpretabile narrativamente come tutto. Di notte, si sa, tutti i gatti sono neri.
Ho concluso il post precedente sulla poesia con un interrogativo, domandandomi come si concili un’affermazione come quella del Faust di Goethe (“In principio era l’atto”) con il dominio della lirica nel mondo della poesia, che negli anni del Faust era già un fatto, e in seguito lo sarebbe stato ancora di più. In altre parole, come si concilia un’istanza anti-soggettiva come quella espressa dalle parole di Faust (a cui farà seguito Nietzsche e l’invenzione freudiana dell’inconscio, e le prospettive a-soggettive delle scienze sociali) con l’istanza profondamente soggettiva che sta alla base della lirica? Naturalmente non c’è bisogno che si concilino, perché in ogni epoca non esiste un solo spirito del tempo, ma ben più di uno – per cui istanze profondamente soggettive e istanze profondamente anti-soggettive possono condividere la stessa epoca e gli stessi luoghi. Però credo che la questione possa essere affrontata in maniera meno banale di questa, e che il rapporto tra l’anti-soggettività e l’iper-soggettività moderne sia più stretto di una semplice coabitazione. Di lirica ho già parlato in questo blog in più occasioni. Ma mi ha risensibilizzato particolarmente al problema la lettura di due testi interessanti di Guido Mazzoni. Il primo l’ho trovato in rete, nel blog di Punto Critico, ed è un’intervista di Italo Testa al medesimo Mazzoni. Il secondo, letto in seguito all’incontro più o meno fortuito con quell’intervista, è il libro di Mazzoni che ha per titolo Sulla poesia moderna (ed. Il Mulino, 2005). Riassumerò le tesi di Mazzoni (che trovo di grande interesse) con due citazioni. La prima, tratta dall’intervista su Punto Critico, è questa: Ora: non tutta la poesia moderna coincide con la lirica, ma è indubitabile che la lirica sia il centro della poesia moderna. Allo stesso modo, è indubitabile che la perdita di mandato sociale dello scrittore, che segna la storia della scrittura in versi da un secolo e mezzo almeno, valga a maggior ragione per il sottogenere lirico, perché quest’ultimo esprime in forma pura quell’individualismo, quell’egocentrismo, quell’«inesplicato bisogno di individualità», come dice Mallarmé, che è il fondo etico della forma di vita emersa negli ultimi secoli. In particolare, la lirica esprime bene la variante del soggettivismo che Charles Taylor chiama «espressivismo», cioè l’ideale etico per cui il senso della vita starebbe nella capacità – in qualche modo nell’obbligo – di essere all’altezza della propria originalità, di esprimere la propria differenza soggettiva. A partire dall’epoca romantica, l’espressivismo diventa un ethos sempre più condiviso dagli intellettuali; a partire dagli anni Sessanta, si diffonde fra le masse in Occidente. La poesia moderna è l’arte d’élite che più direttamente si lega a un simile bisogno, e la lirica è il centro del sistema. La seconda invece proviene dal volume, a pag. 212: L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi. C’è molto più di questo sia nell’intervista che nel volume (davvero molto interessante) di Mazzoni; ma credo che queste due citazioni bastino per spiegare la posizione di Mazzoni sul rapporto tra dominio della lirica e affermazione del soggettivismo (anzi, dell’espressivismo). Mi sono ritrovato interamente nelle posizioni di Mazzoni (e ne consiglio caldamente la lettura), ma voglio aggiungere alcune altre considerazioni a queste, anche come risposta al problema da cui siamo partiti. Una delle cose su cui Mazzoni insiste nel suo libro è il fatto che, benché l’istanza espressivista sia già chiara nelle teorizzazioni dei primi romantici, e anche in Leopardi, la poesia ha continuato per molto tempo a muoversi all’interno delle maglie della tradizione. La rottura delle regole metriche, che sancisce definitivamente il dominio del soggetto, avviene solo a fine Ottocento, e comunque in maniera progressiva e bisognosa di continui appoggi nella tradizione stessa: il verso libero di Dino Campana proviene da quello di Walt Whitman, e quello di Whitman a sua volta dalla Bibbia… Se pure il dominio del soggettivismo (e di conseguenza della lirica) è chiaro nella teoria da molto tempo, come mai i medesimi poeti che lo dichiarano non riescono, se non nel giro di parecchi decenni, a realizzarlo appieno? La risposta facile è che, per un poeta romantico, già il suo livello di violazione della regola è sentito come sufficiente per esprimere la propria soggettività; e che solo quando quella sua violazione diventa, col passare del tempo, a sua volta regola, si sente il bisogno di fare un passo più in là. Questa risposta facile è vera, ma è insufficiente, perché postula che lo sviluppo del soggettivismo stia in una continua violazione della regola al momento data – e che di conseguenza la poesia (come qualsiasi altra arte) non possieda un nucleo storicamente più duro, dandosi solo rispetto alle aspettative del momento. Io ritengo piuttosto che la poesia possa essere riconosciuta come tale solo quando chi la legge ne riconosce un qualche tipo di valore universale. La natura di questo valore si modifica col tempo; mentre il fatto che ci debba essere è sentito come costante. Il poeta romantico, se vuole sperare che il suo lavoro possa essere riconosciuto come poesia deve necessariamente adeguarlo alle aspettative del suo pubblico, rispetto a quello che il suo pubblico ritiene “valori universali”. Le sue innovazioni sono accettate nella misura in cui sono riconosciute come qualcosa che esprime meglio di prima quegli stessi valori universali. Per questo, si potrà arrivare anche alla distruzione della metrica tradizionale, quando quella metrica inizierà a essere sentita come un vincolo astratto, un ostacolo all’espressione dei valori universali anziché un indispensabile strumento. È parte cruciale di questa dimensione di universalità percepita anche la natura rituale della testualità poetica, una natura che tradizionalmente è passata in larga misura attraverso le regole del metro, e il conseguente irrigidimento dei ritmi prosodici che ne deriva. Il poeta espressivista ha potuto a un certo punto lavorare contro il metro, ma lo ha potuto fare solo recuperando qualche altro tipo di ritualità (come il versetto biblico per Whitman). Universalità attribuibile e ritualità sono i due scogli con cui si è dovuto variamente misurare l’espressivismo: coloro, tra chi scrive poesia, che non hanno capito che questo è comunque un passaggio obbligato, vanno a riempire la grandissima schiera dei poeti della domenica. Sono le vittime della poetica dell’epressivismo, quelli che hanno creduto davvero che la poesia non sia altro che “esprimere se stessi”. Ecco però che, a difesa di queste vittime, entra in gioco la preminenza faustiana del fare, o l’inconscio freudiano, o le strutture sociali studiate dall’antropologia. Se infatti proprio nel cuore del soggetto, nel suo fondo più profondo (e “più profondo che non pensi il giorno”, per dirla con lo Zarathustra di Nietzsche), sta un’istanza non soggettiva, naturale o culturale che sia, cioè l’inconscio, le strutture sociali, il DNA, l’azione, allora paradossalmente è proprio esprimendo se stesso che il soggetto può costruire una nuova universalità. Non è più l’universalità delle regole date dalla tradizione, ma quella “spontanea” del buon selvaggio nascosto dentro ciascuno di noi. Se vediamo le cose in questo modo, abbiamo ancora più ragioni di quanto non ne abbia Mazzoni per riconoscere come lirica anche quello che cerca di spacciarsi oggi come suo superamento o negazione. Se al cuore del soggetto che si esprime liricamente sta un buco di soggettività (alla Nietzsche), allora la sua espressione non sarà né più né meno lirica di quella di chi cerca di “ridurre” quel soggetto (per usare le parole di Alfredo Giuliani nella prefazione ai Novissimi) o di abolirlo attraverso pratiche varie di scrittura automatica o semi-automatica (come il googlism). Non c’è in verità nessun cambio di paradigma in queste pratiche di scrittura, e Mazzoni ha del tutto ragione a denunciarne la soggettiva ricerca di una modalità di espressione diversa, e quindi comunque personale. Resta il fatto che qualsiasi pratica di scrittura poetica deve confrontarsi con i requisiti di universalità percepita e ritualità. L’esistenza di una non-soggettività (culturale o naturale) nel cuore stesso del soggetto va incontro alla prima. Ma la seconda rimane comunque un banco di prova per la qualità poetica del testo. Si tratta di un banco di prova scivoloso e variabile, perché i riti variano con la collettività stessa. Però, se in principio era l’atto, e questa natura originaria dell’atto deve essere trasmessa dalla poesia, la poesia sarà riconosciuta come tale solo se agisce su di me, e lo fa facendomi sentire parte di un agire condiviso, collettivo. La lirica è la forma (molteplice) che questo agire ha preso negli ultimi secoli.
Mi sono sempre domandato se Goethe si rendesse conto dell’importanza della sua proposta filosofica, oppure se volesse soltanto mettere in scena un delirio interpretativo da parte di Faust, quando già Mefistofele si trova presso di lui sotto forma di un can barbone, e di lì a poco si manifesterà, e il patto sciagurato tra loro verrà sancito. Seguendo questa seconda ipotesi potremmo prendere le parole di Faust come semplice testimonianza dello stato confuso della sua mente, già votata all’eresia e poco dopo al patto col diavolo. Ma poiché Goethe questa cosa l’ha poi scritta davvero, e sta lì – e pure il suo Faust alla fine si salva (a differenza dei suoi predecessori nella tradizione) – possiamo legittimamente prenderla per buona, e guardarla più da vicino. Certo, non possiamo prendere davvero le proposte di Faust come traduzioni alternative delle parole di S.Giovanni. Il logos può essere inteso certamente come la parola (il verbo della vulgata), e anche, di conseguenza, come il pensiero. La seconda proposta di Faust è ancora plausibile dunque: qui Sinn viene tradotto come mente, che è corretto, però ancora prima che mente Sinn significa senso, o significato. Pensare che all’inizio di tutto ci stia il senso, o la mente, è ancora coerente con il platonismo di fondo su cui si basa il pensiero cristiano, e la filosofia occidentale sino a Goethe (e ancora dopo di lui). Ma la terza proposta di traduzione di Faust è già rischiosa: la possanza, o meglio (diremmo oggi) la forza (die Kraft), postula un materialismo agnostico, e pone all’inizio delle cose un puro principio naturale, in maniera del tutto slegata dalla trascendenza. È come dire che al principio di tutto sta l’energia, il Big Bang, il cieco scontrarsi delle forze. È la metafisica dello scientismo, decisamente alternativa a quella, idealistica, che mette al principio il logos (parola o pensiero che sia). In questa terza concezione, il principio non è solo un principio logico, ma anche un principio temporale, l’alba di tutte le forze. Faust non è però contento, e vuole andare più in là. In principio, dunque, era l’atto, die Tat, cioè l’azione, il fare (tat è anche il passato di tun, cioè fare, e quindi feci, o facevo). Tutto sommato, mettere al principio di tutto la forza significa sovvertire la gerarchia tradizionale, dichiarando una priorità della natura e delle sue leggi sul pensiero; tuttavia i protagonisti tradizionali della riflessione filosofica occidentale (la natura e la nostra conoscenza) rimangono al loro posto, e muta solo il valore dato all’uno piuttosto che all’altro. Un’ontologia materialista, proprio come una spiritualista, vede il mondo in termini di natura e di pensiero che la conosce; solo che anche il pensiero viene pensato come riducibile alla natura – anziché viceversa, come era prima, quando si metteva al primo posto il pensiero assoluto di Dio. Ma mettere a fondamento di tutto il fare, l’azione, l’atto, è una mossa assolutamente più radicale. Se l’azione si trova al principio, allora non la possiamo considerare come una conseguenza del pensiero, e la dialettica fondante mondo vs conoscenza (con le sue varie soluzioni – materialiste e spiritualiste) va semplicemente a farsi fottere. Se nel principio c’è l’azione, da essa dipendono sia la conoscenza che la natura – con il corollario che ogni tentativo di spiegarla compiutamente è destinato a fallire. Spiegare l’azione vorrebbe infatti dire ricondurla al pensiero o al mondo, ovvero a un sistema cognitivo o naturale. Ma se l’azione si trova al principio, è semmai essa a spiegare il pensiero e il mondo. L’azione in sé però non spiega: fa, e basta. A meno che non sia, appunto, azione esplicativa. Tuttavia l’azione esplicativa rimane fondante solo finché è in atto, cioè finché resta azione; mentre il suo risultato, cioè la spiegazione (ovvero il pensiero) non è più azione. Mettere l’azione al primo posto, in altre parole, significa postulare un fondo inspiegato e inspiegabile dell’essere: il fallimento stesso, dunque, del pensiero occidentale – una buona ragione, in fin dei conti, per vendere l’anima al diavolo. Magari Goethe voleva dire altro, o magari stava solo facendo delirare Faust. Sta di fatto però che, via Schopenhauer e Nietzsche, queste riflessioni arrivano trasversalmente sino al medico positivista Sigmund Freud, il quale, quasi senza rendersene conto – e continuando a pensare di agire nei termini di una metafisica della forza (die Kraft) – mette al centro del soggetto un’entità, l’inconscio, che alla fine dei conti non è riconducibile a nulla. Poiché Freud è ancora un materialista, ritiene di poterla spiegare in termini causali (in termini di forze, appunto). Poiché non possiamo fare a meno di spiegare, presumibilmente la posizione di Freud resta quella corretta, in linea di principio. Postulare l’inconscio vuol dire far fuori infatti con un colpo solo le due prime traduzioni di Faust: in principio non può essere né la parola (Wort) né il senso (o la mente – Sinn), perché entrambe frutto della coscienza; e se esiste l’inconscio, la coscienza non può essere che un concetto emergente. Eppure la posizione di Freud contiene in sé i germi della propria negazione. Se postuliamo infatti l’inconscio, stiamo dicendo che alla base del nostro agire non sta nessuna spiegazione, perché l’inconscio non spiega, e non contiene spiegazioni. La spiegazione materialista, dunque, potrà magari essere valida, ma non è sufficiente a fondare il nostro agire. L’azione viene dunque necessariamente prima della spiegazione, perché ci può essere sempre qualche sua componente che non può essere riportata a una qualche spiegazione. Postulare l’inconscio vuol dire pensare che in molti casi vengono prima le azioni dell’uomo, e solo poi le loro spiegazioni o motivazioni. Questo ribalta il tradizionale meccanismo di causa-effetto, senza però sostituirgli nulla (non la causa finale, non il caso…). Che a ogni azione corrisponda una serie di cause si può certo postulare, ma solo in astratto – perché persino il soggetto che ha agito sarà a conoscenza di solo una parte di loro; e la soluzione riduzionista neurologica è in verità troppo complessa per essere veramente percorribile. Ma, d’altro canto, se davvero assumiamo il primato dell’azione, la spiegazione acquisisce senso solo in prospettiva di un’azione futura. È tutto un gran casino, insomma. Da un lato, infatti, la visione del mondo in termini di natura e conoscenza ci è necessaria (e la filosofia occidentale ha tentato di costruirla al meglio per venticinque secoli); dall’altro, la priorità dell’azione ce la rende falsa, vacua, utile solo localmente. Ma non è tutto merito di Freud. La scoperta dell’inconscio ci ha permesso di mettere in dubbio l’esistenza del soggetto medesimo (quello che S.Agostino e Cartesio prendevano come base certa, attraverso l’atto stesso del dubitare), ma Freud fatica ad abbandonare l’io, e continua a cercarne delle tracce in profondità. Più radicali in questo senso sono certamente Jung e Lacan. Antropologia e sociologia hanno spesso assunto di fatto la presenza di una dimensione non di pensiero al cuore dei processi stessi del pensiero – una posizione che, per quanto riguarda il nostro discorso, è diversa da quella della psicoanalisi solo metodologicamente. Senza parlare di io e di Es, anche qui il soggetto si trova dissolto, e con lui il concetto stesso di parola, di senso, di spiegazione. Ma la conclusione di Faust non può davvero dare origine a una disciplina cognitiva, scienza o filosofia che sia. Una disciplina del sapere non può accettare veramente una preminenza diversa da quella del sapere stesso. Per bene che vada, una disciplina cognitiva potrà giusto ammettere di ritrovarsi localmente confusa. Goethe non era un filosofo, infatti, bensì un poeta. Se manteniamo centrale questa considerazione, potremo pensare che dichiarare la preminenza del fare sul conoscere significa lanciare un monito, un monito nei confronti di chi legge la poesia come se fosse filosofia, cioè (tentativo di) spiegazione, riflessione, pensiero, parola che definisce. Se la poesia manifesta la priorità, le preminenza del fare, essa riproduce in qualche modo la fattività del mondo, senza necessariamente descriverla. In altre parole, non è che la poesia non possa descrivere o spiegare, ma, in tal caso, quello che conta è il fatto che essa sta descrivendo o spiegando, e non ciò che vi si trova descritto o spiegato. Se nel principio c’era l’azione, quello che conta è quello che la poesia fa, non quello che dice, o comunica: lo farà magari anche dicendo o comunicando qualcosa, ma quelli sono semplicemente modi del suo fare, non la sua essenza. Goethe, attraverso Faust, potrebbe dunque stare allertandoci proprio sulla natura non cognitiva della poesia (e delle arti in genere). La poesia è essenzialmente un’azione (poiein), molto prima e molto di più di quanto non sia comunicazione. Per questo, per capirne la natura non abbiamo davvero bisogno di mettere in gioco le problematiche del soggetto (che è un’entità cruciale per la parola e per il senso – ma non per l’azione). Naturalmente, cercare di capire la natura della poesia è già un ricondurla al cognitivo – e quindi un inevitabile sviamento. Dovremmo limitarci a leggerla, e quindi a viverla! Ma noi abbiamo bisogno di spiegazioni, a costo di ingarbugliarci tra le contraddizioni. La poesia, dunque, sarebbe tale proprio perché mette fuori gioco la trasmissione del sapere tra soggetto e soggetto. In questo senso non è solo performativa, o perlocutiva, perché nelle definizioni di performatività e perlocutività i soggetti vengono comunque messi in gioco. E tuttavia la si potrebbe davvero prendere come modello di un certo modo di usare il linguaggio, un modo che veda il linguaggio come prassi sociale, come modo non tanto di comunicare quanto di produrre un qualche tipo di consonanza, di accordo, di Stimmung. È singolare comunque che l’epoca in cui Goethe fa dire queste cose al suo Faust sia anche quella che inaugura, in poesia, il dominio della lirica, ovvero di una forma di poesia che ha al suo centro proprio il soggetto, e la comunicazione del suo sentire nei confronti di altri soggetti. Da questo punto di vista, la lirica sembrerebbe piuttosto presupporre una metafisica centrata sul senso (Sinn), o sulla parola (Wort) in quanto strumento per comunicare. Ma questo potrebbe essere il tema di un prossimo post.
Mi accorgo di essere piuttosto sensibile, in questi giorni, al tema dell’autoriferimento paradossale, quello del Don Chisciotte di Borges che legge le proprie avventure scritte da Cervantes. È il tema tradizionale della mise en abîme, del precipizio ottico scatenato dagli specchi contrapposti, quella cosa che ci fa domandare, come suggerisce Borges, se non siamo pure noi stessi una delle finzioni nel gioco. Oppure – quasi al contrario – forse è quel tema che dovrebbe essere preso (magari proprio per il medesimo farci sorgere quella domanda) come un chiaro indizio di finzione – perché solo nei mondi riflessi o di finzione ci si domanda se ci troviamo nel reale. Questo succede, io credo, perché il reale su cui ci poniamo domande è a sua volta il frutto di un’astrazione, e in particolare il frutto di un’astrazione linguistica, facilmente allargata poi anche a tipi di narrazione e di discorso di carattere maggiormente visivo. Come dire che la domanda di Borges ha senso perché quando ragioniamo del reale in quei termini, il reale stesso è diventato un’astrazione; è diventato cioè la nostra concettualizzazione del mondo della nostra esperienza. Ed è questo che fa sì che abbiano senso teorie logiche come quella cosiddetta dei Mondi Possibili (base delle versioni moderne della logica modale). Quando smettiamo di ragionare, il problema scompare. Tutte le arti di carattere narrativo hanno la possibilità di giocare su questo paradosso, e tuttavia esso è estraneo, per esempio, alla musica pura e alla pittura astratta; è cioè estraneo a quelle situazioni che ci chiedono più di metterci in sintonia che di comprendere concettualmente. Perché allora il tema di Borges mi affascina tanto? Probabilmente è proprio il fascino del paradosso, ovvero di quelle situazioni estreme in cui la ragione si ingarbuglia da sola, e non è in grado di dire con certezza se Epimenide il cretese (che afferma che tutti i cretesi mentono sempre) stia mentendo o no: se dice la verità, poiché è un cretese pure lui, allora sta mentendo; e solo se sta mentendo allora può dire la verità. Nella vita quotidiana non ci domanderemmo mai se non ci sia qualcuno che ci sta leggendo, o che ci sta sognando. Siamo troppo impegnati nel fare e nel sentire, nell’andare a tempo col mondo. Ed è quella la realtà Ma quando la vita quotidiana viene vissuta attraverso il Web, magari scrivendo un blog, o stando attaccati a Facebook, il problema se ci sia qualcuno che ci sta leggendo non è più così peregrino. Anzi, è il problema cruciale, la condizione sine qua non per esistere. Se nessuno ci legge, nel Web non esistiamo. Parafrasando l’arcivescovo Berkeley, essere è essere letti (e di conseguenza percepiti). Potremmo dire che la vita nel Web è una sorta di letteratura condivisa e interattiva, di cui siamo protagonisti e lettori, e, proprio come Don Chisciotte, esistiamo quando qualcun altro scrive di noi e lo possiamo leggere. Tutto questo è importante e insieme anche irrilevante, perché di nuovo un tale gioco irreale di specchi che riflettono specchi di noi stessi e degli altri ci appare davvero reale non quando siamo in grado di dire di essere reali perché altri ci leggono, ma quando di fatto pure nel Web (magari proprio perché qualcuno ci sta leggendo) ci sentiamo vivere, quando abbiamo la sensazione di essere a tempo, di nuotare nel flusso, di vibrare col ritmo di fondo. Sarebbe fantastico poter vivere solo di queste sensazioni, indipendentemente dalle loro ragioni. Se non fosse che, come in una Matrix non cinematografica, queste sensazioni possono essere controllate, e davvero possiamo ritrovarci a essere scritti del tutto da qualcun altro. È proprio in questo caso che la nostra concezione razionale della realtà (con tutti i paradossi cui va soggetta) finisce per essere l’unico paletto sufficientemente solido, quello a cui dobbiamo la nostra sopravvivenza nel mondo, anche se (forse) non il nostro piacere. Chi non ha ancora capito questo continua a pensare che sia meglio sognare con l’uomo del destino del momento piuttosto che vedere l’abisso di squallore in cui quel medesimo uomo ci ha gettato, e quanto quel mondo favoleggiato da lui sia lontano da quello che la nostra ragione ritiene reale. La comunicazione del Web crea indubbiamente un sacco di problemi al nostro senso di realtà, eppure la sua natura scritta la rende comunque molto più prossima alle valutazioni razionali di quanto non accada, per esempio, con la TV. Per quanto Facebook ci possa alienare, insomma, ci manterrà sempre più a contatto dei paradossi di Borges di quanto non faccia l’alienazione televisiva. Orà dirò una cosa che va presa con le pinze, perché i controesempi sono tanti, e la realtà è più complessa, e le singole persone possono essere spesso sia qualcosa sia il suo contrario; eppure, in linea di massima, la mia sensazione è che o si vota l’uomo del destino o si è utenti attivi del Web; o si è sognatori catodici oppure si scrive e si discute. I paradossi mi piacciono, ma solo se potessi essere al sicuro da tutti i Berlusconi del mondo mi potrei abbandonare alla loro (razionalissima) assurdità. Magari mi intrigano così tanto in questi giorni proprio perché, in maniera (razionalmente) contorta, evocano questo sogno, quello di una realtà a cui potersi lasciare un po’ andare, senza doverci domandare chi ci stia leggendo ora, ma anche senza il rischio di nani maligni a controllarla. Giusto un’osservazione veloce (quasi un commento) al post di Roberta Buzzacchino su Sinsemia, perché a mio parere dà credito a un errore concettuale troppo diffuso. Dice la Buzzacchino:
Ho segnato in rosso le asserzioni che mi interessano (i grassetti invece sono suoi). Così, in primo luogo non capisco perché il pensiero debba svilupparsi in senso radiale secondo una struttura gerarchico-associativa ad albero. Se anche accettiamo l’idea che sfrutti al meglio le potenzialità latenti dell’emisfero destro (idea che non contesto in sé qui, ma che è comunque discutibile), una struttura ad albero è già una forma piuttosto forte di ordinamento (per quanto non totale), mentre una struttura di carattere associativo dovrebbe piuttosto essere espressa, molto più genericamente, da una rete. Guarda caso, l’idea della rete come migliore espressione della natura associativa del pensiero ricorreva associata al secondo (e assai più grave) errore già nelle teorizzazioni degli entusiasti dell’ipertesto degli anni Ottanta e primi Novanta. Il secondo errore è infatti quello di fondare la validità delle relazioni non lineari sulla non linearità delle relazioni del nostro cervello: là era la rete ipertestuale, qui è la mappa mentale ad albero, ma entrambi vengono presentati come “traduzione biologica” delle idee. Ora, non si capisce perché il “tracciare una struttura analoga a quella dei neuroni” dovrebbe fornirci una comunicazione più efficace. E allora perché non anche il “tracciare una struttura analoga a quella degli organi intracellulari”, o a quella delle catene molecolari, o a quella degli atomi o dei nuclei o delle relazioni quantiche all’interno dei protoni? Tra il livello dell’organizzazione neuronale e quello dell’organizzazione del pensiero esiste una quantità di mediazioni spaventosa, che non permette di tracciare nessuna corrispondenza diretta tra loro – ma al massimo una qualche relazione metaforica, e questa potrà avere, a sua volta al massimo, un valore di suggestione; anche perché potrebbe essere legittimamente sostituita da qualsiasi altra metafora ugualmente suggestiva. Se la sinsemia è utile non è certo per una qualsiasi corrispondenza diretta con il livello biologico. È tanto più semplice e sensato semmai trovare corrispondenze con la rete delle associazioni concettuali, che si sono accumulate nei secoli molto più nelle attività umane e nelle loro registrazioni, che non nella struttura neuronale degli individui. Quando poi il problema non è solo quello della trasmissione del significato, ma anche quello della persuasione e delle formazione culturale, le cose si fanno ulteriormente più complicate. Anche ammettendo che il principio riduzionista sia valido, le neuroscienze devono ancora fare molta strada per poter ridurre il significato alla neurofisiologia (o, peggio, alla neuroanatomia) – e non sarà comunque, certamente, una relazione diretta.
|
||
|
Copyright © 2025 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||
Commenti recenti