 Barcellona, facciata di una casa vicino all'Arc de Triomf Ho scattato questa foto, insieme a molte altre, a Barcellona, mentre quello che vedevo mi ispirava una riflessione sulle posizioni espresse nel 1908 da Adolf Loos, in un suo testo famoso e influentissimo, Ornamento e delitto (è un articolo breve; lo potete leggere interamente, per esempio, qui). Come è noto, la tesi di Loos, che sarebbe stata ben presto fatta propria e anche oltrepassata dalle correnti funzionaliste, era che sostanzialmente l’architettura (anzi, tutto il campo di ciò che oggi chiameremmo design) doveva fare a meno degli ornamenti, perché la sua bellezza si poteva (anzi, si doveva) trovare nei puri rapporti formali, quelli che esprimono le funzioni stesse dell’edificio o dell’oggetto. Il resto è un sovrappiù, e un sovrappiù colpevole, perché ci nasconde la realtà essenziale delle cose. L’architettura (e non solo) deve essere sincera, e trovare in questa sincerità la sua bellezza – mentre l’ornamento è un imbroglio, una falsità, un delitto, uno spreco di tempo, un diletto infantile, un’attitudine popolare e primitiva.
Non si può negare che la posizione espressa da Loos sia stata fertile, e che il funzionalismo abbia in seguito espresso numerosi capolavori, a partire dai lavori di Wright, Gropius, Le Corbusier… Ma siamo anche costretti a riconoscere che i medesimi principi, una volta applicati senza l’intelligenza di questi (e ancora molti altri) grandi maestri, hanno prodotto pure un intero universo di periferie di gelidi orrori; e che i principi dello stile internazionale si sono facilmente involgariti producendo mostri di cemento senza senso e senz’anima – nel complesso assai peggiori delle vezzose e superficiali case e oggetti ornati aborriti da Loos.
Loos aveva dunque torto? Sì e no. Certo, si può prima di tutto capire bene la sua posizione in un’epoca in cui il bello in architettura doveva essere ornato, e l’ornamento aveva certe regole e certe ricorrenze. Da questo punto di vista Loos aveva sicuramente ragione: l’ornamento non è necessario. E tuttavia la sua è, in fin dei conti, una posizione fondamentalmente aristocratica; e Loos, nel suo scritto, non lo nasconde affatto (anzi, a rileggerlo oggi, a un secolo di distanza, Loos finisce per restarci persino antipatico).
Creare degli edifici interessanti, notevoli, piacevoli da guardare e da vivere seguendo i principi del funzionalismo non è in realtà facile. Lo può sembrare per qualche decennio, sino a quando cioè l’assenza di ornamento appare alla gente come una novità, e l’assenza si nota in quanto tale: sino a quando, cioè, gli stili ornati restano la norma, l’assenza di ornamenti è la presenza di un’assenza, e un edificio senza ornamenti si trova ornato da questa assenza. Ma quando questo diventa a sua volta la norma, l’assenza è assenza e basta, anzi nemmeno quello, perché non c’è più una presenza di riferimento che la faccia sentire.
A questo punto, davvero, gli edifici restano gradevoli solo se sono stati costruiti con un gusto particolarmente sviluppato, e lo sono perché continuano a essere interessanti i loro rapporti formali. Ma gli edifici che godono di queste qualità sono davvero pochi! Solo i grandi architetti ne hanno prodotti.
È un po’ come dire che tutti sono capaci di tirare delle linee nere orizzontali e verticali su una tela, ma solo Mondrian riesce a farne dei capolavori. Solo che abbiamo molto più bisogno di case che di dipinti.
L’ornamento sarà pure accusabile di falsità (non sempre però, in verità), perché una casa ornata distrae l’attenzione dall’insieme richiamandola sui dettagli, cioè sugli ornamenti stessi – ma proprio per questo, è più facile costruire degli edifici il cui interesse resista un poco al tempo. Sarà magari un interesse nei confronti del curioso e del pittoresco – come spesso accade a Barcellona, dove mica tutti gli edifici sono stati progettati da Gaudí – ma è comunque un interesse che c’è, e rimane.
È che l’ornamento, nella sua infinita varietà, finisce per essere meno aristocratico perché le soluzioni accettabili, anche se magari nascondono errori maggiori, sono infinitamente di più di quelle che permette il funzionalismo. Sarà pure pittoresco, vernacolare, curioso, ma in qualche modo funziona.
E nel momento in cui ritorna, storicamente, a imporsi, produce a sua volta un effetto singolare, per cui anche lo stile funzionalista diventa esso stesso uno stile, cioè una forma di ornamento, e l’idea che la forma architettonica debba esprimere la funzione si rivela per quel grande bluff ideologico che è stata. Basta approfondire l’idea di funzione per capirlo e rendersi conto che tra le funzioni di un edificio e di un oggetto ci sono pure quelle simboliche, che non sono affatto meno importanti delle altre.
Nel fascino di Barcellona c’è anche il fatto che la città sembra avere saltato proprio quella fase, quella del funzionalismo. Non del tutto, in verità, specie nei suoi aspetti peggiori – ma sono le cose che si notano meno. Perché a Barcellona c’è un sacco di architettura moderna che si fa notare: c’è quella che precede o ignora l’anatema di Loos, con Gaudí e il modernismo catalano in testa, e c’è quella che segue il tramonto dell’ideologia formalista, quella che si è resa conto che l’ornamento ci può benissimo essere, se serve, ma che non siamo limitati al campionario degli ornamenti storici, e possiamo sbizzarrirci a inventare qualsiasi cosa, purché se ne possa comprendere il senso, purché ci faccia sognare, purché ci faccia sentire parte di qualcosa che vive, e che comunica se stesso.
21 Giugno 2010 | Tags: Ananda K. Coomaraswamy, comunicazione visiva, design industriale, estetica, graphic design, narrazione per immagini, rito, sacro, sublime, William Morris | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Già molti decenni fa (ma io l’ho imparato solo in questi giorni, leggendo il suo Come interpretare un’opera d’arte, Milano Rusconi 1977) Ananda K. Coomaraswamy faceva osservare che la parola arte, tradizionalmente, nelle culture europee, non fa riferimento a oggetti o a una categoria di oggetti (le opere d’arte), bensì a un modo di operare. Per capire cosa questo voglia dire basta far caso al fatto che quest’uso della parola arte è ancora ben presente nell’italiano di oggi, quando si dice, per esempio, che qualcosa è fatto ad arte, o che qualcuno lavora con arte. Come è ovvio, pure la parola artigiano deriva da arte, intesa in questo senso; mentre la parola artista sembra che indicasse, in origine, semplicemente qualcuno che eccelleva nella propria arte (ovvero abilità costruttiva), qualunque essa fosse.
Coomaraswamy fa anche notare che anche il fatto di considerare le arti come oggetto di un’estetica è un’invenzione occidentale e recente. La parola estetica deriva da aisthesis, ovvero sensazione, e che la riflessione sull’arte abbia nome estetica tradisce l’idea di base che il campo dell’arte sia quello della sensazione, nello specifico quello della sensazione piacevole. L’invenzione dell’estetica avrebbe dunque deviato verso il campo della sensazione quello che prima apparteneva al campo della conoscenza.
Credo (io, non Coomaraswamy) che questa deviazione sia parallela allo sviluppo di un’idea di conoscenza razionale esclusiva, che sfocia ai primi del Seicento nella concezione cartesiana della scienza. Dove la conoscenza debba essere fatta di idee chiare e distinte non c’è più posto per una conoscenza tradizionale su base rituale, con una forte componente religiosa. Progressivamente (perché queste cose richiedono secoli, e né Cartesio si è inventato tutto da un giorno all’altro, né dal giorno dopo l’enunciazione delle sue idee il pensiero occidentale è cambiato di colpo) una serie di cose che prima erano sentite come centrali per la vita e la conoscenza del mondo vengono relegate a un ruolo più marginale. Nella misura, poi, in cui esse sono anche legate al culto religioso, secondo il nuovo criterio illuminista finiscono per ritrovarsi nel campo della superstizione.
La parola estetica, usata in senso moderno, è settecentesca; ma l’idea dell’arte come qualcosa che riguarda la sensibilità piuttosto che la conoscenza la precede. Potremmo dire che l’invenzione dell’estetica come tale, nel Settecento, è il tentativo illuminista di dare un posto decoroso all’arte all’interno di un sistema cognitivo che la lascia fuori. Alla fine di questa lunga trasformazione, siamo passati da un sistema in cui la pittura, la scultura, l’architettura e la musica erano modalità rituali (o collegate a situazioni rituali) di conoscenza del mondo, a un altro sistema in cui queste medesime attività sono diventate testimonianza dell’espressione dell’io, e al tempo stesso manifestazioni del sublime – con questa particolare e interessante coincidenza di due estremi, entrambi tenuti ai margini di un mondo sempre più dominato da una conoscenza di tipo razionalistico e dalla sua applicazione attraverso una tecnica che per sua natura esclude l’arte, cioè l’abilità manuale.
Dobbiamo a William Morris e alla sua utopia neoumanistica della seconda metà dell’Ottocento l’idea del design industriale, ovvero l’idea che l’arte (intesa come cura della qualità) possa essere applicata anche ai prodotti della tecnologia. E gli dobbiamo, in qualche modo, anche l’idea del graphic design, ovvero l’idea che pure i prodotti della comunicazione possano essere progettati con cura e con arte.
Ma Morris non poteva cambiare, evidentemente, le regole di fondo. In una società deritualizzata, o in cui i nuovi riti sono effimeri e sempre collegati a una razionalità produttiva, le nuove arti (in senso antico) inventate da lui non possono ricoprire lo stesso ruolo che avevano nel mondo fortemente ritualizzato al cui interno si erano sviluppate. Benché sia figlio della cura dell’artista medievale (ovvero colui che eccelleva nella sua arte), e sia in questo senso ciò che davvero potrebbe legittimamente essere definito arte, il design non può godere della stessa considerazione sociale di cui godeva nel medioevo l’arte: gli manca quel legame con il sacro che allora era parte di qualsiasi opera, di qualsiasi operazione, anche quotidiana.
Nella nostra cultura, quel legame è diventato appannaggio dell’Arte (con la A maiuscola, cioè nel senso corrente dell’espressione), la quale, però, ha dovuto separarsi in maniera radicale dalla tecnica, dalla produzione di buoni oggetti d’uso, e relegarsi nel campo di un tipo particolare di comunicazione, quella espressiva – cercando di ricostruire, solo con i propri mezzi, delle situazioni rituali a cui la società concede diritto di esistere a patto che non riguardino il campo del sapere, e si limitino a quello del bello, dell’aisthesis, della sensazione. L’Arte finisce per diventare, in questo modo, solo una forma più complessa (magari più colta) di intrattenimento – e il sacro stesso finisce per essere oggetto di aisthesis.
Dobbiamo avere nostalgia per come era prima, o per come sarebbe altrove? Non so. Non so quanto prima fosse meglio. Non mi interessa seguire Coomaraswamy in questo. Non credo che sia questo il punto. Quello che è importante, piuttosto, è capire bene quanto fossero diverse prima le cose, e che il senso in cui Giotto era un artista era molto diverso dal senso in cui lo definiremmo tale oggi. Giotto era (di gran lunga) il più bravo a esprimere visivamente quello che la collettività sentiva; a raccontare per immagini quello che tutti sapevano e intorno a cui tutti si raccoglievano.
Non esiste niente di simile a questo, oggi. I presupposti sono cambiati. Il nostro stesso sentire e il nostro stesso conoscere sono differenti.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|

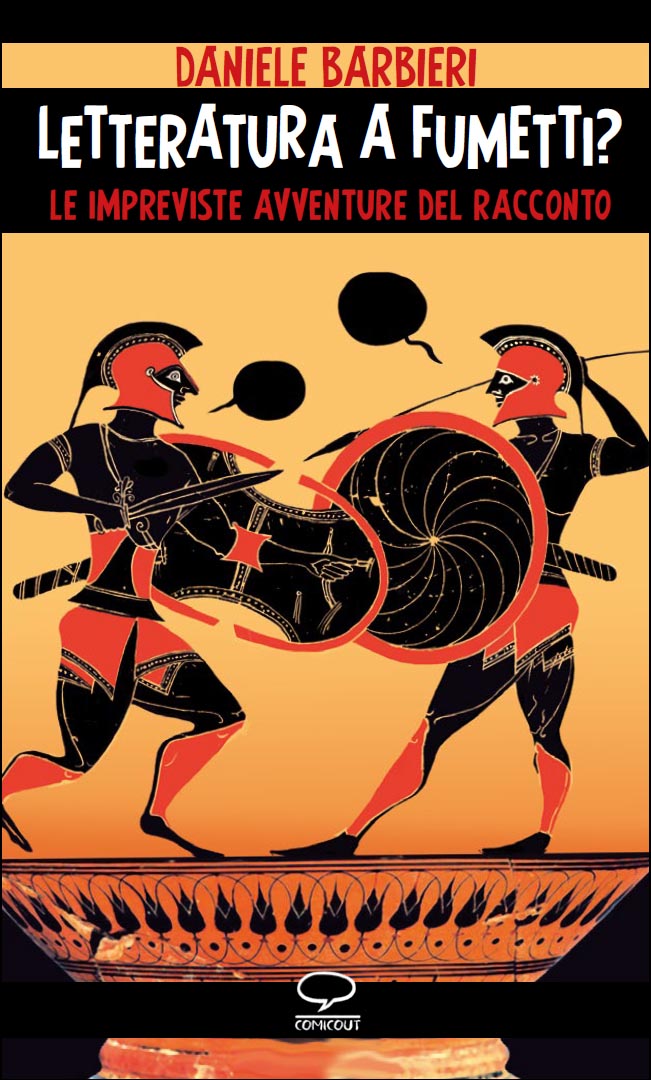
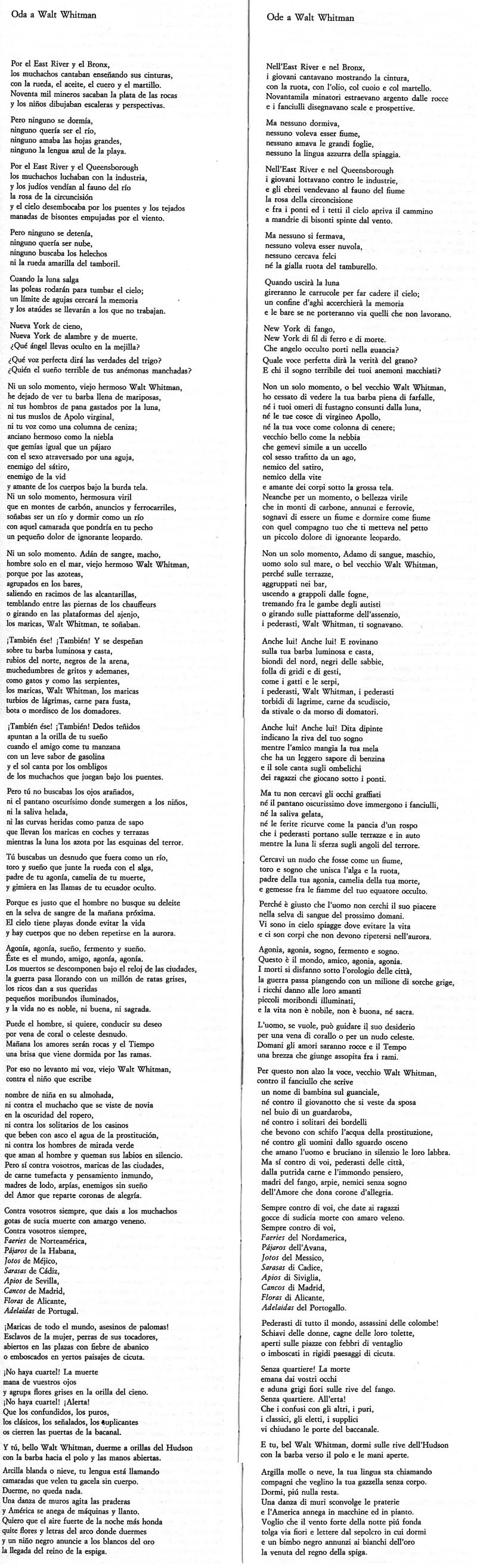


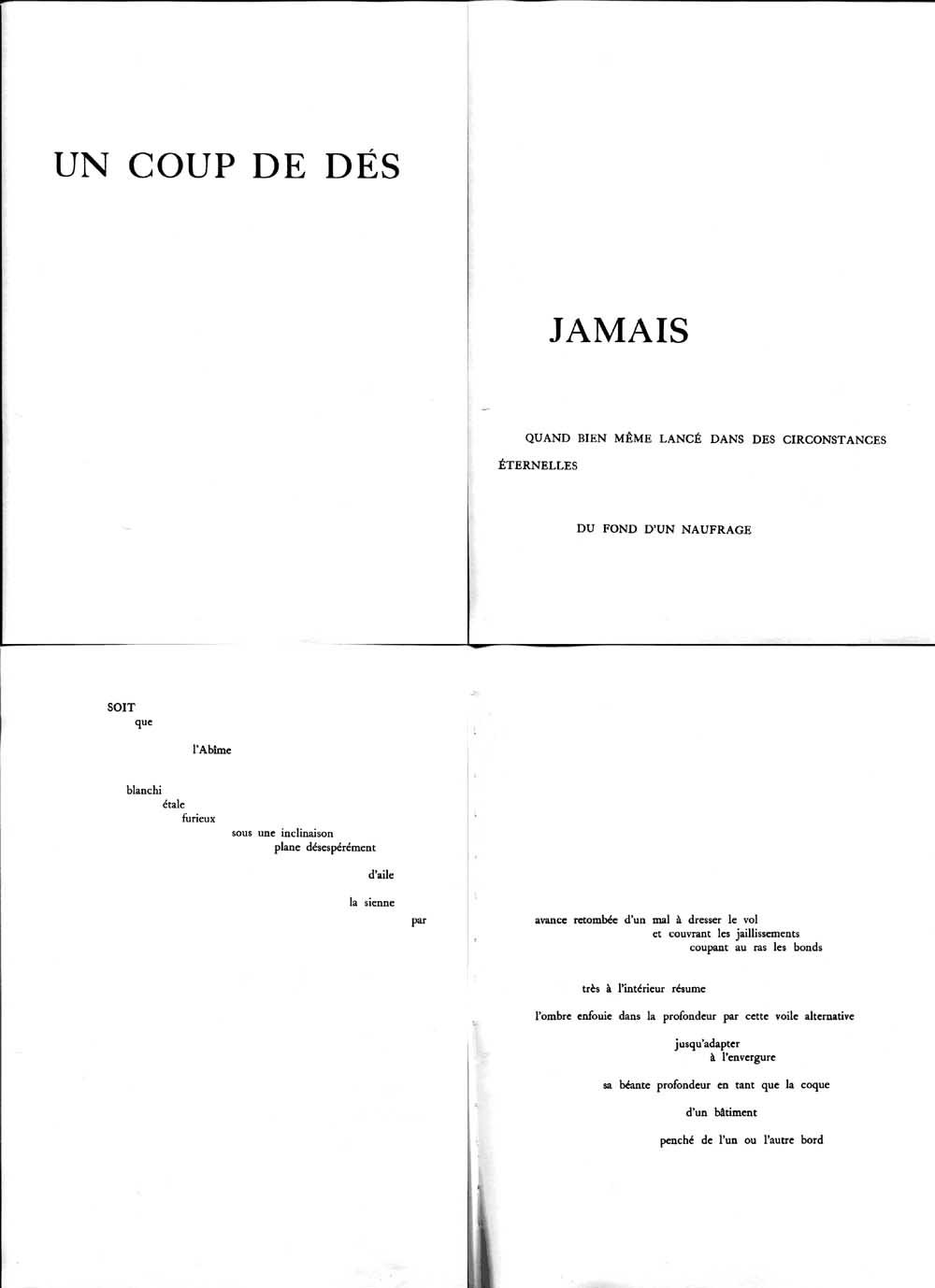




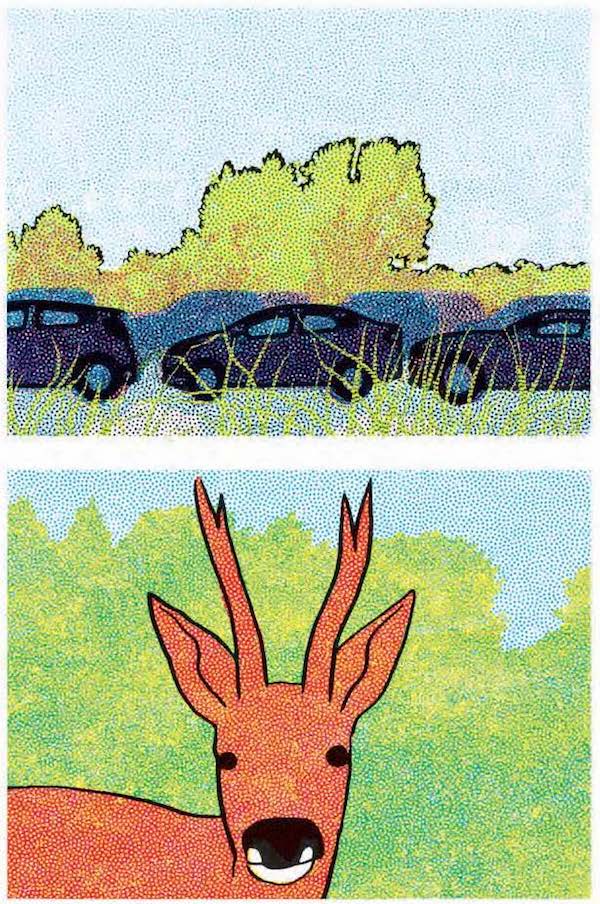


 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email




















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco







Commenti recenti