Mi domanda uno studente se non ci sia qualche relazione tra l’action painting di Jackson Pollock (cui ho già dedicato in questi giorni due post, qui e qui) e la calligrafia cinese. Gli rispondo che non ho notizie precise in merito, ma la cosa mi sembra ugualmente piuttosto probabile, soprattutto pensando a Zhang Xu, un calligrafo dell’VIII secolo, perché queste cose girano da tempo in Occidente – e senza arrivare a questo estremo di precisione, basta considerare l’importanza del giapponismo e la presenza costante dell’immaginario visivo giapponese, calligrafia artistica compresa (il Giappone non è la Cina, certo, ma le loro tradizioni calligrafiche sono molto vicine).
Poi faccio una ricerca rapida sul Web e trovo qua e là dei riferimenti non documentati, secondo i quali Pollock si sarebbe ispirato a Huai Su (il discepolo di Zhang Xu) e avrebbe dichiarato pubblicamente i propri debiti nei confronti della calligrafia cinese. Da nessuna parte mi viene fornito un riferimento preciso, per cui le propongo per come le ho trovate, mettendoci davanti un bel “è possibile che…”, “è plausibile che…”.
Non mi interessa in verità approfondire di più, dal punto di vista storico. Che Pollock sia arrivato alla propria procedura su ispirazione dalla calligrafia cinese (o giapponese) oppure che ci sia arrivato per altre vie, comunque la somiglianza formale tra le due procedure e i loro risultati esiste. Quello che mi colpisce è che mentre in Occidente questo modo di procedere appare come una novità del XX secolo, in Cina è invece una procedura antica e tradizionale, oggetto di innumerevoli aneddoti (come la storiella del pittore, dell’imperatore e del granchio riportata da Calvino nella sezione “Rapidità” delle sue Lezioni Americane). E in ogni caso, anche se davvero Pollock si è ispirato alla procedura cinese, bisognava che lui stesso e l’ambiente che lo riceveva fossero pronti ad accogliere un approccio davvero diverso da quello normale per noi.
La novità di Pollock in Occidente non sta tanto nella priorità data alla fluidità e continuità del gesto, quanto nel fatto che l’opera, il dipinto, propone di essere visto più come un indizio della danza creativa che l’autore ha effettuato nel comporlo, che non come una composizione plastica. Naturalmente non è che la composizione nei suoi dipinti sia irrilevante, così come non era irrilevante, per la pittura occidentale prima di Pollock, la natura indiziale dei tratti di colore per ricostruire la manualità del pittore. Quello che cambia, con Pollock, è il maggiore o minore rilievo da attribuirsi all’una o all’altra: quando guardiamo un dipinto, poniamo, di Kandinsky, è certamente molto più importante comprenderne la composizione, che non analizzare le pennellate per vedere come l’autore si sia mosso nel realizzarla. In Pollock succede invece il contrario, e nel corsivo selvaggio dei calligrafi cinesi pure.
Questa differenza evidente ne sottende una più profonda, che riguarda il senso stesso della comunicazione espressiva: la potremmo descrivere come una differenza tra progettazione e improvvisazione. Questa opposizione, in Occidente, ci è tradizionalmente familiare in un contesto piuttosto piccolo, che contiene sostanzialmente la musica e il teatro, ed è dunque soltanto lì che possiamo facilmente analizzarla nel dettaglio. Tutte le altre arti, infatti, si basano su un supporto statico (o realizzano opere statiche, come la scultura o l’architettura); mentre la musica si manifesta soltanto nel divenire dell’esecuzione e dell’ascolto, e il teatro nel divenire della performance. Ma il teatro ha praticamente da sempre una sua versione scritta, e da oltre mille anni pure la musica può essere registrata su un supporto statico.
È per questo che la dialettica tra progetto e improvvisazione caratterizza in maniera sostanziale queste due arti, per le quali il supporto statico è soltanto un espediente mnemonico (e progettuale), ma che vivono sostanzialmente della propria natura dinamica nell’atto stesso del proprio realizzarsi di fronte al pubblico.
Prendiamo la musica, nella sua versione colta. L’a solo improvvisato (o cadenza) è una costante dei concerti per strumento e orchestra dal Settecento in poi, almeno sino a quando il fossilizzarsi della tradizione non lo trasforma a sua volta in un pezzo scritto, spesso da parte dell’autore medesimo del concerto; così che la libertà dell’esecutore si riduce alla scelta di una cadenza piuttosto che di un’altra. La musica colta occidentale è dunque nel corso della storia sempre più scritta, più progettata a monte. È solo nel momento in cui il jazz assume i caratteri della musica colta che il momento dell’improvvisazione torna in gioco, e ritorna legittimo nell’ascolto la comprensione della musica come tramite di uno stato del momento.
Per quanto la scrittura permetta alla musica di raggiungere livelli di complessità impensabili in sua assenza, configurando la partitura come progetto preciso di un’esecuzione, c’è qualcosa di cruciale che viene perduto in questo. L’idea della musica come progetto si basa su, e insieme sostiene, una concezione formalistica, plastica, del flusso musicale, mettendo in secondo piano gli elementi di compresenza, compartecipazione, consonanza tra i partecipanti – quegli stessi elementi che vengono invece enfatizzati dalle performance improvvisative.
Ma poiché la musica comunque non si risolve nella sua dimensione scritta, e comunque richiede di essere eseguita, essa non è mai del tutto riducibile alla propria costruzione formale, e le componenti gestuali, dirette, del momento, che caratterizzano l’esecuzione, non smettono mai di avere importanza.
In questa prospettiva di carattere optocentrico, è chiaro come invece la comunicazione visiva possa davvero interamente risolversi nella costruzione formale – poiché non c’è necessità di alcuna trasformazione successiva, che possa metterla in discussione. Ciò che Pollock e i calligrafi cinesi hanno in comune è dunque proprio una certa riduzione dell’optocentrismo, a vantaggio di una valutazione del segno grafico che ha aspetti di tipo musicale, poiché mette (tendenzialmente) in sintonia il gesto del fruitore (che segue l’andamento) col gesto dell’autore (che lo ha creato).
Dovremmo assumere, in questa prospettiva, che la cultura cinese sia tradizionalmente meno optocentrica della nostra, visto che mentre da noi si tende a una concezione visiva anche del sonoro, in essa vi sono tracce di una concezione di carattere musicale anche del visivo. Da noi, la valorizzazione dell’improvvisazione al di fuori del campo musicale (e teatrale) si fonda sulle conseguenze di una concezione romantica dell’arte come espressione dell’io, o della sua variante surrealista dove al posto dell’io viene messo l’inconscio. Ma è difficile postulare qualcosa di simile per la Cina dell’ottavo secolo – tanto più che questa concezione non è affatto necessaria per valorizzare l’improvvisazione.
Magari è solo perché i Cinesi non hanno avuto Platone, e la scrittura è rimasta manifestazione della parola senza che la parola dovesse identificarsi col pensiero razionale, o logos. In principio c’era altro, evidentemente, là.

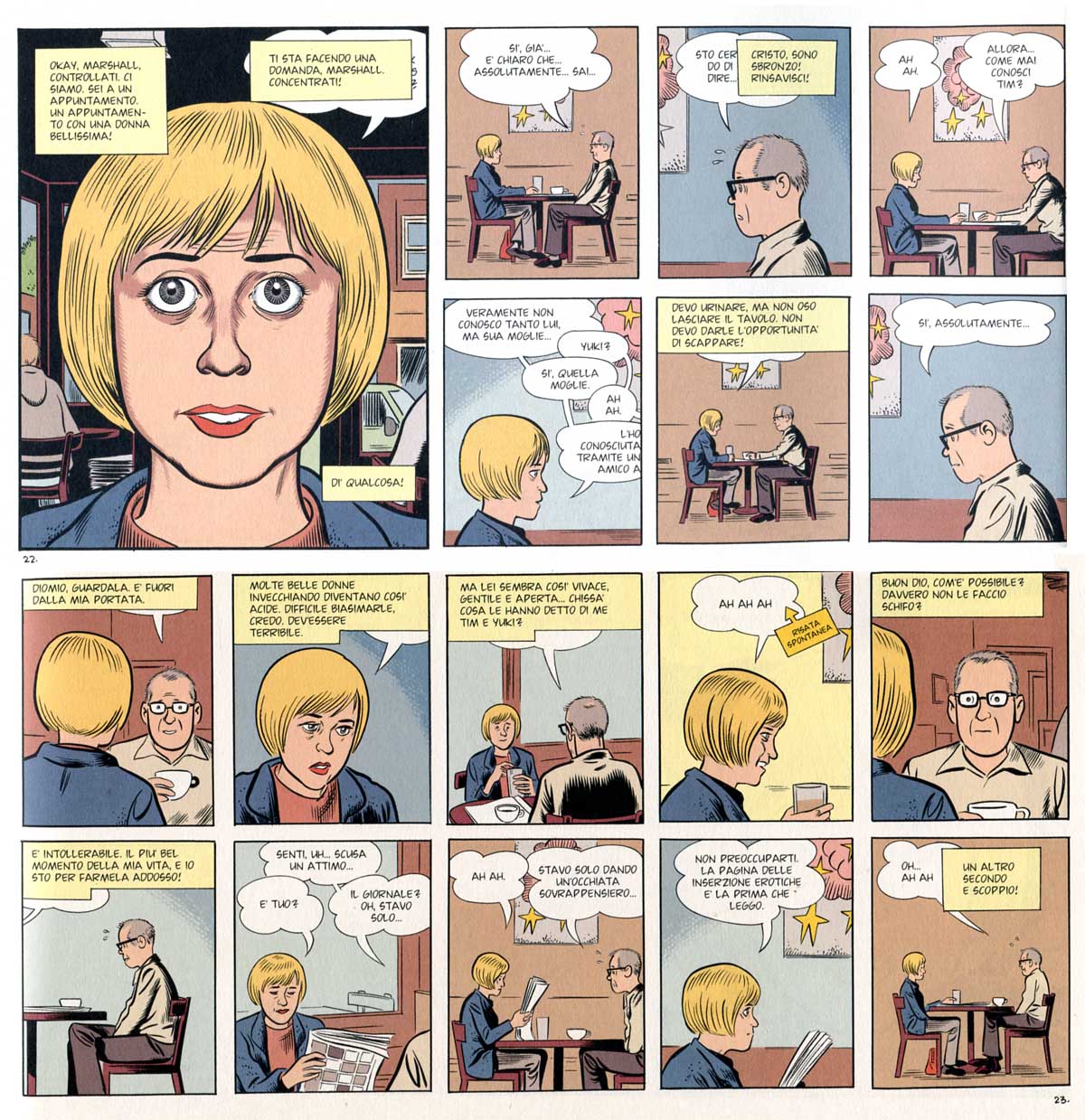








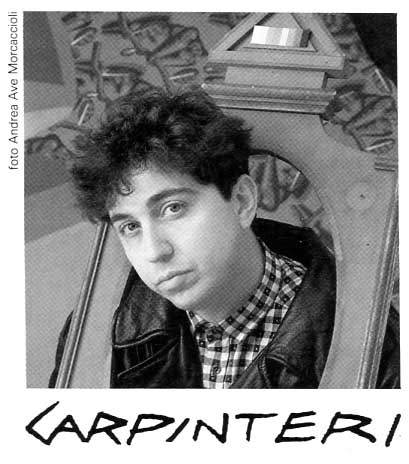



 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email


























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco


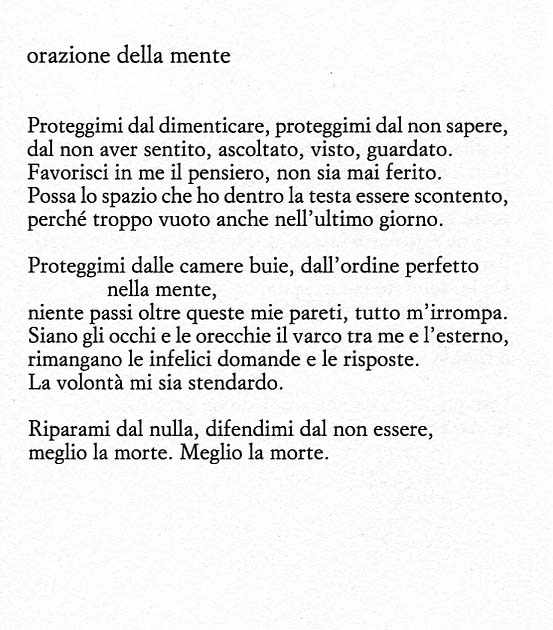



Commenti recenti