Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.


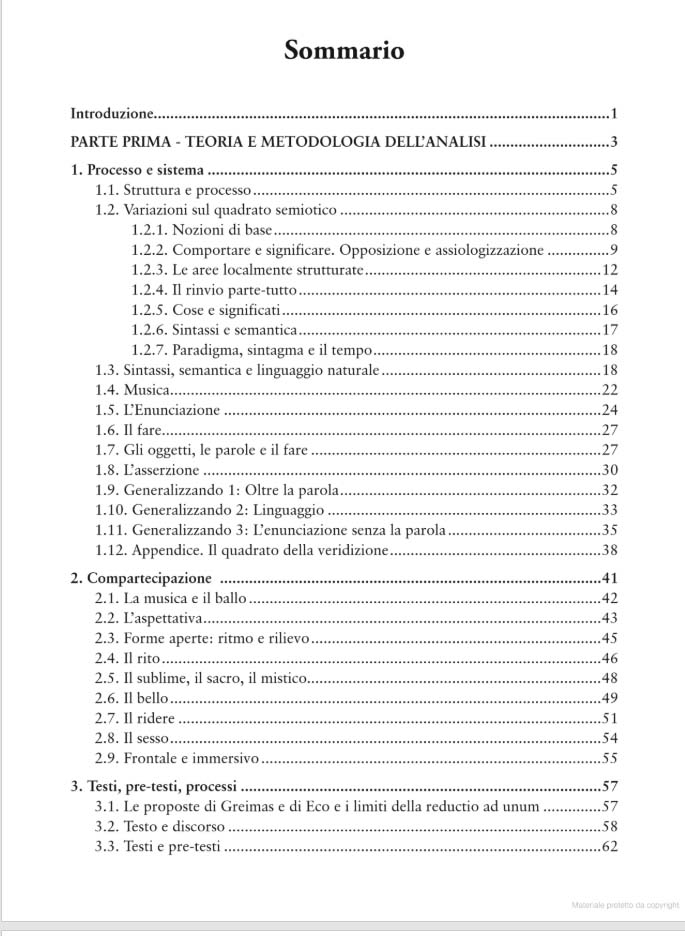
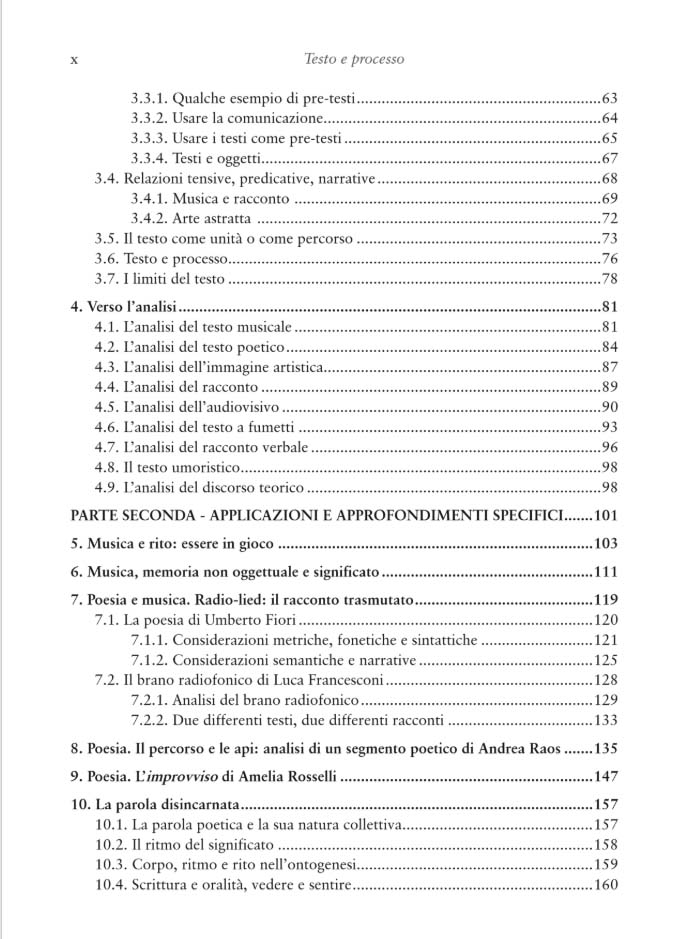
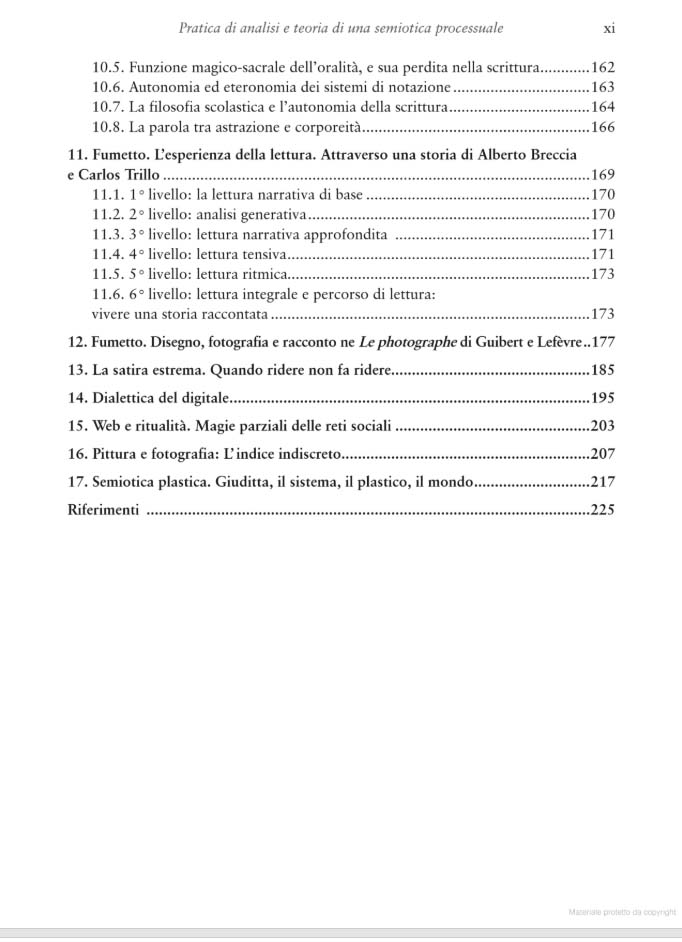

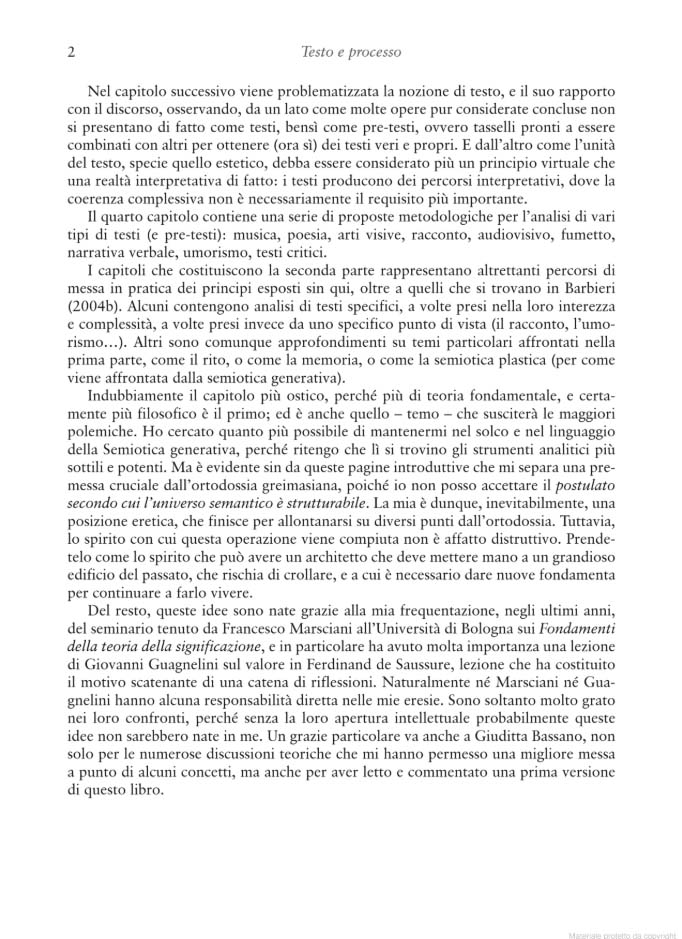
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
|
|
||
|
Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore. Tra una settimana in libreria. Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Un percorso, che riguarda il fumetto, tra il mito, la serialità, la pittura e la scrittura, e – ovviamente – il racconto. Le impreviste connessioni tra mondi che il fumetto ha riportato vicini.
Da fine marzo il libro è disponibile in libreria. Si può acquistare on line sul sito di Comicout (meglio) oppure su Amazon.
Prosegue qui, su Nazione Indiana C’è questa problematica del racconto che mi tormenta da quando ho incominciato a possedere le prime nozioni di semiotica – anzi, in verità ancora da prima, all’epoca delle mie poesie da adolescente. Condivido la posizione di Paul Ricoeur, secondo cui il racconto “è il modo umano di comprendere il tempo”, e penso anch’io che la ricostruzione che facciamo di qualcosa che abbia avuto uno sviluppo temporale sia inevitabilmente di carattere narrativo. Di conseguenza, dove c’è testo e dove ciò di cui si parla ha in qualche modo tempo, allora là c’è racconto. Ma questo non comporta, di per sé, che tutti i testi siano narrativi. Contenere del racconto non è una condizione sufficiente per fare di un testo un testo narrativo, cioè un testo che ha una struttura narrativa (perlomeno implicita o nascosta) persino quando è narrativa la lettura che ne viene fatta. Se io assisto a un evento del mondo, poniamo un incidente stradale, non ho assistito a un racconto – anche se poi lo ricorderò e riporterò ad altri inevitabilmente in termini narrativi. Sono io, qui, a sovrimporre la forma narrativa a un semplice fenomeno mondano. Se il racconto è “il modo umano di comprendere il tempo”, dovrò essere consapevole che il racconto sta non nelle cose bensì nella comprensione che io ne ho. Detto questo, potrei scoprire che esistono testi che si propongono, almeno in parte, proprio come il mio incidente stradale: chiedono cioè di essere interpretati anche in maniera narrativa, ma non sono narrativi in sé (se non magari qua e là, occasionalmente o localmente). Quando pensiamo a un testo, siamo abituati a pensarlo (per esempio in termini di teoria dell’enunciazione) come un discorso, ovvero come la trasmissione di un senso da un enunciante a un enunciatario – a loro volta implicitamente inscritti nel testo stesso. In molti casi questo discorso riguarda eventi, ed è quindi racconto. Concepiamo dunque tipicamente un testo come una piccola interpretazione del mondo, quale ogni racconto, in sé, è: la forma-racconto è, infatti, già una forma esplicativa. Ma i testi artistici non sono necessariamente fatti così. Naturalmente un romanzo è prima di tutto fatto di racconto; e molte volte anche una poesia lo è. Ma altre volte un testo poetico contiene solo brandelli di racconto, accenni; un po’ come se durante l’evento del nostro incidente stradale ci fosse qualcuno che mi sta raccontando qualcosa, e il racconto che mi sta venendo fatto entrerebbe quindi a far parte dell’evento – ma non sarebbe, evidentemente, il racconto dell’evento. Quando racconterò l’incidente, magari racconterò anche che cosa mi si stava raccontando: però nel farlo sto dando un senso nuovo alle parole del racconto che stavo ascoltando nel momento dell’incidente. Certe poesie, come le due di Giuliano Mesa che ho riportato qui sopra, non sono, in sé, testi narrativi. Esse contengono momenti di racconto, indubbiamente, e, nel momento in cui io ne arrivassi a fornire un’interpretazione, questa non potrebbe che essere narrativa. Però quest’ultima sarebbe la mia interpretazione. Certo, si tratta di testi che si prestano a letture di carattere narrativo – però più di una, come il nostro incidente stradale, suscettibile, in quanto evento reale, di molte letture narrative differenti. Ogni struttura narrativa profonda che vi rinvenissi non sarebbe, molto probabilmente, che la struttura della mia interpretazione. Il testo non vuole raccontare, consapevole che raccontare è già spiegare, è già dichiarare un livello di comprensione. Ma come è possibile che un testo non racconti? Credo che basti uscire, almeno in parte, dalle pastoie della visione enunciazionale dei testi. Comprendere, spiegare, sono prerogative del soggetto. Nella misura in cui assumiamo la presenza di un soggetto, il testo ne sarà l’enunciazione. Ma i surrealisti ci hanno a loro tempo insegnato che il soggetto non è necessariamente presente in un testo artistico: i loro automatistici cadaveri squisiti servivano proprio per tagliare fuori del tutto il soggetto, lasciando produrre la scrittura all’inconscio, o alla macchina, o al caso. Senza arrivare a questi squisiti estremi, sarà sufficiente non poter decidere in che misura il soggetto è veramente implicato nella scrittura. In una certa misura il testo sarà dunque il prodotto di un evento del mondo, evento “naturale” esso stesso, quasi una secrezione dell’umano; e, in quanto tale, non spiegazione o espressione della comprensione di alcunché – ma semplice espressione di qualcosa, nemmeno di qualcuno. L’inconscio freudiano è un buon candidato a questo ruolo di qualcosa, ma anche quello collettivo junghiano, o anche – senza scomodare la psicoanalisi – lo spirito del tempo, le parole che stanno nell’aria; o anche quello che Lacan chiamava a suo tempo il reale sarebbe un ottimo candidato, proprio per la sua intrinseca incompatibilità col soggetto che comprende. In misura complementare, il testo poetico sarà però anche espressione consapevole del soggetto, e quindi abbozzo di spiegazione, messa in scena. Eppure l’abilità del poeta starà anche nel non permetterci di capire che cosa nel testo sia artificio e che cosa sia “natura”, e di come la “natura” si celi magari dentro l’artificio, e l’artificio a sua volta dentro la “natura”. È così che la poesia finisce tanto spesso per essere tanto più difficile della prosa, proprio per questo suo possibile rifiuto di dare spiegazioni, per questa sua capacità di gettarci nella situazione, e non di raccontarcela, per la sua oscurità che è rifiuto del racconto, rifiuto della spiegazione. Anche l’andamento, per così dire, musicale, fa parte di questo gioco di ambiguità tra secrezione e costruzione. Poiché il testo poetico è un evento del mondo, le sue qualità sonore non sono meno importanti di quelle semantico-narrative. La sensibilità musicale di Giuliano Mesa, per esempio, è notevole. Il modo in cui le parole escono una dopo l’altra, ripetendosi o richiamandosi, è parte determinante dell’evento e della sua forma che ci colpisce percettivamente. Il che lascia pensare che quello che ho detto prenderebbe una natura ancora più densa e concreta, se la parola poetica si trovasse a essere letta da una voce materiale, sonora, e non solo dai nostri occhi e dalla voce virtuale che ricostruiamo in noi. Indubbiamente, in un caso simile, l’evento sarebbe ancora più vividamente tale, ancora più “natura”, ancora più mondo; e ancora di più il soggetto, con il suo racconto, faticherebbe a manifestarsi. Ma, di questo, prossimamente. Non so se il tema che voglio affrontare qui sia davvero adatto per il post di un blog. Forse avrebbe piuttosto bisogno dello spazio e dello stile di lettura più concentrato di un saggio su una rivista scientifica. Ma ormai mi sono abituato a utilizzare questo blog per mettere giù le riflessioni che mi girano per la testa, e penso che i miei lettori si siano rassegnati a loro volta a questi post dai temi magari un po’ coriacei. In fin dei conti, per male che vada, il lettore ha sempre la possibilità di smettere di leggere e di guardare altrove: il Web è comunque strapieno di cose interessanti. Il tema è quello, profondamente semiotico ma non solo, della narratività. Una delle idee che stanno alla base della semiotica generativa di Greimas è che la struttura narrativa sia fondamentalmente alla base di qualsiasi discorso. Questo sarebbe dovuto al fatto che la struttura narrativa articola un percorso fondato sul quadrato semiotico, il quale a sua volta articola un’opposizione semantica; e le opposizioni semantiche sono alla base di qualsiasi discorso. Io ho qualche dubbio anche su questo, ma non è questo il punto in questione qui. Si può discutere sui dettagli, ma la posizione di Greimas individua nel suo complesso una questione reale, e una centralità del racconto che ne fa inevitabilmente un tema di indagine per chi voglia lavorare a fondo sui testi. Tuttavia, la posizione di Greimas ha un corollario che di solito non viene preso particolarmente in considerazione dai semiologi generativi, troppo intenti a rintracciare le strutture narrative nascoste, e poco interessati a capire come vi siano state nascoste. In altre parole, se il racconto è così pervasivo nei testi, è perché il racconto è evidentemente (come peraltro suggerisce Ricoeur) la forma con cui noi diamo senso al divenire temporale: il tempo, cioè, non è un semplice succedersi insensato di battiti dell’orologio; prende piuttosto senso per noi attraverso l’articolazione delle cause e degli effetti, che è già un’articolazione narrativa. Se volessimo essere kantiani, potremmo dire che la forma-racconto è un trascendentale, ovvero una struttura implicita nella nostra comprensione del mondo. Se invece che kantiani, volessimo essere evoluzionisti alla Bateson, potremmo dire che la forma-racconto è il modo migliore che la nostra evoluzione ha escogitato per metterci in rapporto memoriale con gli eventi del mondo, permettendoci di dar loro un senso – o di trascurarli o dimenticarli quando non entrano in nessuna successione narrativa. Qualunque sia il perché, il come non cambia, il racconto è il modello, lo schema che noi applichiamo alla nostra comprensione del mondo, ogni volta che viene messo in gioco il tempo, cioè un divenire. Ora, se portassimo questa assunzione alle estreme conseguenze, dovremmo dire che non ci sono racconti al di fuori di noi, ma solo sequenze di eventi che noi comprendiamo in modo narrativo. Se il mondo al di fuori di noi fosse fatto solo di natura, potrei anche sottoscrivere queste estreme conseguenze, e farla finita qui, neo-kantianamente. Ma il mondo al di fuori di noi è fatto anche di prodotti di altri esseri umani, i quali esprimono la propria comprensione del mondo; e siccome la loro comprensione del mondo è avvenuta in termini narrativi, allora anche la loro espressione potrebbe essere strutturata narrativamente. Cercare le strutture narrative di un testo significa allora cercare le tracce di questa narrativizzazione. E se mettiamo le cose in questi termini, sembra che i semiologi generativi facciano la cosa giusta quando cercano la forma-racconto alla base di qualsiasi manifestazione testuale, dal romanzo alla pittura alla musica. Il mio sospetto che sia il lettore colui che “nasconde” la forma-racconto nel testo sembra rivelarsi privo di fondamento; l’autore del testo, infatti, prima che autore, è stato a sua volta “lettore” del mondo, e l’ha “letto” in forma di racconto, passandolo poi a noi in questo modo. Continuo a non essere però del tutto convinto. Continuo a sentire della differenza tra il trattamento narrativo di un romanzo (che è sicuramente il prodotto di una lettura già narrativa del mondo), e quello di un dipinto o di un brano musicale. Proviamo a riflettere sulla natura delle nostre percezioni, in particolare sonore e visive. I suoni e le forme visive che arrivano ai nostri sensi vengono prima di tutto interpretati come segnali del mondo circostante; anzi, per la nostra ontologia ingenua, come il mondo circostante stesso. Solo in seconda istanza valutiamo se non siano stati prodotti da qualcuno a scopo comunicativo, e cerchiamo di interpretarli in questo senso. Ma c’è una grande eccezione a questo principio, perché quando i suoni e le figure sono riconosciute come linguaggio (oralità o scrittura, insomma), noi tendiamo a, per così dire, vedere attraverso di loro, per arrivare il più rapidamente possibile al loro significato. La dimensione materiale, quella del significante, non scompare, ma la nostra attenzione è rivolta da subito (e non in seconda istanza) al significato. È solo quando il significato è per noi incomprensibile (per esempio di fronte alle espressioni in una lingua sconosciuta) che ci arrestiamo al significante, con la forte (e ben giustificata) sensazione che ci stiamo perdendo il meglio. Quando sono in gioco le parole (e altri segni dichiaratamente convenzionali), insomma, assumiamo immediatamente che ci sia alle loro spalle qualcuno che le ha pronunciate o scritte. Questa medesima assunzione è molto più problematica, invece, quando le parole non sono in gioco, e siamo di fronte a immagini e/o suoni non verbali. Per portare la cosa al limite, è vero che un dipinto è sicuramente un’immagine prodotta dall’intenzione comunicativa di qualcuno; ma la cosa è molto meno certa (e rilevante) per un’immaigne fotografica o per un audiovisivo. I fotogrammi o le riprese di una telecamera di sorveglianza, per esempio, pur essendo immagini, non sono di solito interpretati come discorsi, bensì come testimonianze, documenti ottenuti attraverso un’estensione della nostra capacità di vedere e udire, che ci permette di vedere e udire anche quello che è accaduto in un luogo e un tempo in cui non eravamo presenti. Senza arrivare a questi estremi, l’assenza di una voce narrativa (orale o scritta) ci mette sempre nella condizione di valutare le percezioni non verbali come segnali del mondo (o direttamente come mondo); poi, subito dopo, nell’eventuale misura in cui sappiamo che sono state prodotte, iniziamo a considerarle anche come discorsi. Una delle conseguenze di questo è che mentre un racconto verbale (orale o scritto che sia) non può non avere un narratore (cioè una voce narrante, che si manifesta – come minimo – attraverso i pronomi e i tempi verbali), un’immagine, una sequenza di immagini o una sequenza di suoni, o una sequenza audiovisiva, possono benissimo non avere un narratore. Avranno un autore, certamente – ma non è la stessa cosa: è la voce narrante, cioè il narratore, che mi garantisce che quello che sto percependo è già una narrazione, ovvero il prodotto di un’interpretazione narrativa del mondo. Se il narratore non c’è, la situazione è molto più incerta. Supponiamo di stare facendo una passeggiata con un amico, in montagna. A un certo punto lui mi dice “Guarda”, indicando qualcosa. Io guardo e vedo una sequenza di eventi (un gruppo di camosci spaventati che fuggono, un falco in picchiata, una valanga): di fronte a quello che ho visto, io sto già interpretando narrativamente – e lo avrei fatto anche se avessi visto autonomamente quella scena. Certo anche il mio amico ha operato un’interpretazione narrativa del mondo, e sulla scorta di quella ha ritenuto opportuno avvertirmi. Ma la sua operazione si è esaurita di fatto con l’avvertimento, e la mia narrativizzazione è tutta mia. Ben diverso sarebbe stato se fosse stato lui a raccontarmi uno di questi eventi. In molti casi, quello che succede con i testi non verbali ha qualcosa in comune con l’esempio appena fatto, e non solo nell’ambito, ovvio, della fotografia. Un disegnatore o pittore traccia delle forme affinché, prima di tutto, io le veda e riconosca narrativamente. Proprio per questo le preparerà (potendolo fare, a differenza del mio compagno di passeggiata) in maniera da favorire una mia certa interpretazione narrativa, piuttosto che qualche altra. Ma, a differenza del narratore del romanzo, non potrà dichiarare implicitamente di stare raccontando – perché questo implicito è una prerogativa dalla parola. Il disegnatore (il pittore, il regista…) crea piuttosto delle situazioni prenarrativizzate (o delle sequenze prenarrativizzate) ovvero pronte perché si dia di loro una certa interpretazione narrativa. Non sto giocando con le parole. C’è differenza tra un racconto, garantito da un narratore, che ci autorizza da subito ad accettare che la sua stessa produzione sia già narrativa, e una sequenza prenarrativizzata, che siamo noi lettori a interpretare narrativamente, anche se è certamente stata progettata per favorirci in questo, ma dove non c’è nessuna garanzia, e nessuno che dichiara davvero “sto raccontando”. In questo secondo caso, io semplicemente assumo che ci sia a monte un’intenzionalità narrativa, ma sono io lettore a ricostruire il racconto in quanto tale. Ma poiché sono io, io sono anche libero allora di non farlo, e di fruire il testo in altro modo, presumendo che l’intenzionalità narrativa non sia l’unica, o magari non sia la principale, o magari non fosse nemmeno pertinente all’intenzionalità espressiva (e quindi interpretativa) dell’autore. Le parole esistono perché, convenzionalmente, trasmettono discorsi: se mi rifiuto o non sono in grado di recepire una sequenza di parole come discorso, non le sto nemmeno più ascoltando o vedendo come parole. A questo destino sono talvolta destinate le parole quando vengono messe in musica: a volte restano davvero parole, che trasmettono il loro senso, altre si trovano a essere trattate come semplici suoni articolati, ascoltate per il suono e ignorate per il senso. Dal punto di vista del rapporto con il racconto, il musicista si trova in una situazione ancora più estrema di quella di chi produce immagini. In molti casi le immagini possono essere lette come mimetiche; mentre raramente si può dire lo stesso delle sequenze musicali. Il musicista (compositore o esecutore) ci mette di fronte a delle sequenze articolate di suoni, e nemmeno ci dice che siamo tenuti a recepirle come un’interpretazione del mondo. Ma senza questa assunzione, diventa impossibile assumere che ci possa essere un qualche tipo di intenzionalità narrativa in musica, e quindi delle strutture narrative intimamente in gioco. Si fa fatica persino a pensare che la musica possa essere intesa come una sequenza prenarratizzata, quali il fumetto o il cinema (eccetto nel caso di melodramma e simili, ovviamente, dove la musica accompagna un’azione visiva e/o verbale). Quello che si può dire è che ci sono dei contesti storici e/o culturali in cui un’intenzionalità interpretativa del mondo e quindi espressiva può essere ipotizzata. Da Haydn e Mozart in poi questa ipotesi ha un senso nella musica occidentale. Ma forse bisognerebbe domandarsi, opera per opera, se sia accettabile di vederla come una sequenza prenarrativizzata. Se non lo fosse, e ugualmente vi rinvenissimo delle strutture narrative nascoste, sapremmo con certezza che siamo stati noi stessi, interpretando il testo musicale, a nascondervele. Il problema cruciale delle analisi narrative è dunque questo: per evitare di trovare quello che noi stessi vi mettiamo dentro, dobbiamo poter assumere che il racconto vi sia già, almeno nella forma implicita della sequenza prenarrativizzata. Lo possiamo assumere tranquillamente con il romanzo e con le forme analoghe più brevi. Lo potremmo assumere anche con la poesia, se non fosse che la poesia mette molto in primo piano certi aspetti del piano del significante, i quali con il racconto non hanno nulla che fare – ma la poesia gioca proprio su questo doppio binario. Lo assumiamo convenzionalmente con fumetto e cinema, trattandoli come varianti del racconto verbale – ma ci sono situazioni in cui la differenza salta fuori. A mano a mano che ci si allontana da questo nucleo, l’assunzione di narratività deve essere sempre più forte, e sempre più esplicitamente motivata: in musica, per esempio, è accettabile per il Romanticismo, ma in generale a fatica per le forme strumentali del Barocco – mentre sul jazz credo che potremmo discutere a lungo, caso per caso. In pittura, è accettabile per molti generi, ma la natura morta e il paesaggio la eludono in molti casi – per non dire dell’astrattismo di Mondrian, o dell’informale di Pollock. Non basta, insomma, trovare in qualche tipo di testo un’analogia con la forma-racconto per poter dire di essere di fronte a una struttura narrativa. Siamo noi a vedere racconti dappertutto. L’analogia non è una prova se non del fatto che quello che abbiamo davanti è un frammento di mondo, interpretabile narrativamente come tutto. Di notte, si sa, tutti i gatti sono neri.
. Dino Buzzati pubblica per la prima volta «Qualcosa era successo» sul Corriere della Sera, l’8 luglio 1949. Lo ripubblica nella raccolta Il crollo della Baliverna nel 1954, poi ancora in Sessanta racconti nel 1958 e infine ne La boutique del mistero nel 1968. Si tratta di un racconto piuttosto breve, adatto per questo a un tipo di analisi ravvicinata che porterebbe via troppe pagine per opere più lunghe. Scopo di questa analisi è vedere come questo breve testo costruisca il percorso di esperienza nel proprio Lettore Modello, e come l’insieme delle interpretazioni che è possibile darne derivi da tale percorso. Percorreremo il testo paragrafo per paragrafo, cercando di vedere come il suo sviluppo lineare costruisca la continuità dell’attenzione del lettore, portandolo progressivamente sempre più dentro al meccanismo passionale preparato per lui – e come si configuri, di conseguenza, l’esperienza cognitiva che il testo produce. (1) (a) Il treno aveva percorso solo pochi chilometri (e la strada era lunga, ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo, così correndo per dieci ore filate) quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna. (b) Fu un caso, potevo guardare tante altre cose invece lo sguardo cadde su di lei che non era bella né di sagoma piacente, non aveva proprio niente di straordinario, chissà perché mi capitava di guardarla. (c) Si era evidentemente appoggiata alla sbarra per godersi la vista del nostro treno, superdirettissimo, espresso del nord, simbolo per quelle popolazioni incolte, di miliardi, vita facile, avventurieri, splendide valigie di cuoio, celebrità, dive cinematografiche, una volta al giorno questo meraviglioso spettacolo, e assolutamente gratuito per giunta. (2) (a) Ma come il treno le passò davanti lei non guardò dalla nostra parte (eppure era là ad aspettare forse da un’ora) bensì teneva la testa voltata indietro badando a un uomo che arrivava di corsa dal fondo della via e urlava qualcosa che noi naturalmente non potemmo udire: come se accorresse a precipizio per avvertire la donna di un pericolo. (b) Ma fu un attimo: la scena volò via, ed ecco io mi chiedevo quale affanno potesse essere giunto, per mezzo di quell’uomo, alla ragazza venuta a contemplarci. (c) E stavo per addormentarmi al ritmico dondolio della vettura quando per caso – certamente si trattava di una pura e semplice combinazione – notai un contadino in piedi su un muretto che chiamava chiamava verso la campagna facendosi delle mani portavoce. (d) Fu anche questa volta un attimo perché il direttissimo filava eppure feci in tempo a vedere sei sette persone che accorrevano attraverso i prati, le coltivazioni, l’erba medica, non importa se la calpestavano, doveva essere una cosa assai importante. (e) Venivano da diverse direzioni chi da una casa, chi dal buco di una siepe, chi da un filare di viti o che so io, diretti tutti al muricciolo con sopra il giovane chiamante. (f) Correvano, accidenti se correvano, si sarebbero detti spaventati da qualche avvertimento repentino che li incuriosiva terribilmente, togliendo loro la pace della vita. (g) Ma fu un attimo, ripeto, un baleno, non ci fu tempo per altre osservazioni. (3) (a) Che strano, pensai, in pochi chilometri già due casi di gente che riceve una improvvisa notizia, così almeno presumevo. (b) Ora, vagamente suggestionato, scrutavo la campagna, le strade, i paeselli, le fattorie, con presentimenti e inquietudini. È già di per sé un fatto notevole e inconsueto, destinato a richiamare l’attenzione del lettore da subito, che nel primo periodo si apra quasi immediatamente una lunga parentesi, con un’evidente funzione tensiva. Si tratta infatti dell’attacco del racconto, una situazione speciale in cui quasi nulla è già impostato: il lettore conosce il titolo, ed è in grado di fare delle ipotesi sul genere del racconto, poiché presumibilmente conosce l’autore e altri racconti della medesima raccolta – ma, per il momento, nient’altro. Si aspetta, come è consuetudine per un attacco, una serie di informazioni ben definite, che forniscano il quadro della situazione. La prima proposizione («Il treno aveva percorso solo pochi chilometri») presenta infatti un tempo imperfetto e l’uso dell’avverbio «solo»: una clausola di tipo introduttivo assai frequente. Il lettore sa che questa clausola deve essere seguita, prima o poi, dalla descrizione dell’evento puntuale rispetto a cui si sta fornendo ora la descrizione del contesto. Quello che immediatamente segue, in casi di questo genere, di solito o è un ulteriore dettagliamento del contesto (p.e. «viaggiava rapidamente nella campagna assolata…») oppure un diretto passaggio alla descrizione dell’evento, separato tipicamente dalla presenza di un punto fermo, oppure collegato da un «quando», come effettivamente accade anche qui, ma più avanti. Deludendo questo genere di aspettative, il narratore inserisce invece a questo punto un inciso assai più lungo della stessa clausola iniziale, che si presenta sì come ulteriore dettagliamento del contesto, ma che in quanto espressione tra parentesi dichiara il proprio ruolo ausiliario proprio mentre le sue parole ci stanno comunicando informazioni evidentemente importanti. Siamo già, nel giro di due righe, in presenza di un primo effetto di saturazione: l’apertura di parentesi promette una notizia rapida e sussidiaria, ma dopo la prima breve asserzione («e la strada era lunga»), ne arriva una seconda («ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo») e poi ancora una terza («così correndo per dieci ore filate»). La tensione si accumula rapidamente, per scaricarsi poi finalmente sulla clausola introdotta dalla congiunzione «quando». Ma quello che accade qui, nel punto messo in rilievo dal concludersi dell’iterazione, è così evidentemente banale («a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna») che il lettore è spinto a ritenere che ci debbano essere delle ragioni ulteriori perché valga la pena di porlo tanto in evidenza, e di situarlo al punto di risoluzione di una situazione così evidentemente tensiva. Ecco quindi che il semplice uso di una modalità sintattica, posto in una posizione cruciale del racconto come è l’attacco, imposta sin dall’inizio una situazione tensiva. Certo, il riconoscimento della banalità dell’evento non è più un fatto sintattico: ha già un valore compiutamente semantico-narrativo, e infatti è sul livello narrativo che questo meccanismo di conduzione della tensione per saturazione continuerà di qui in avanti, come vedremo tra poco. Se provassimo tuttavia nel frattempo, a titolo di ipotesi, a riformulare sintatticamente il periodo iniziale senza mutarne il senso narrativo, ci accorgeremmo che l’eliminazione delle parentesi e del loro ruolo di sospensione porrebbe molto meno rilievo sull’evento, e di conseguenza lo qualificherebbe assai meno come punto di partenza del sistema di tensioni narrative che sta per seguire. Supponiamo che il testo dica, invece di quello che effettivamente dice: Il treno aveva percorso solo pochi chilometri e la strada era lunga: ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo, così correndo per dieci ore filate; quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna. Nemmeno una parola è cambiata dall’originale di Buzzati, ma solo la punteggiatura, e di conseguenza la sintassi. In questa forma tuttavia la parte che va da «Il treno aveva…» sino a «…per dieci ore filate» assume un andamento sintattico autonomo, con un effetto di chiusura. La clausola introdotta dal «quando» riapre perciò la frase apparentemente chiusa. Di conseguenza non vi si arriva con l’impressione di essere inseguiti dalla necessità di chiudere l’inciso, bensì semplicemente per riapertura di un discorso già chiuso. L’iterazione è ancora presente, ma mentre l’incastonamento all’interno delle parentesi la mette in evidenza e favorisce un forte effetto di saturazione, questa divisione sintattica tende a neutralizzarne l’effetto. È nota l’attenzione di Buzzati a costruire una sintassi espressiva, a costo di leggere anomalie, specie nella punteggiatura, rispetto all’uso canonico. Vedremo più avanti altri esempi di queste deviazioni. All’inciso sintattico del primo periodo corrisponde nei due periodi successivi (1b e c) un inciso narrativo. Il rilievo forte che è caduto (con apparente gratuità) sulla visione della giovane donna richiede urgentemente spiegazione, e invece il racconto qui divaga. Divaga, come accadeva nel primo periodo, fornendoci il contesto necessario per comprendere la rilevanza dell’evento; ma dal punto di vista tensivo l’effetto è quello della costruzione di un ritardo, di nuovo per saturazione (si veda il lungo elenco in 1c), proprio dove il lettore è stato indotto a desiderare l’arrivo di una spiegazione. E poi, quando la spiegazione arriva, con il secondo capoverso (2a), ancora una volta il caso descritto appare così banale che la spiegazione evidentemente non basta e il lettore è indotto ad aspettarsi un’ulteriore delucidazione del perché questo evento minimale venga situato in una posizione di tale rilievo. Delucidazione che tuttavia non è destinata ad arrivare: al suo posto, anzi, troviamo un secondo evento, descritto con ancora maggiore dovizia di dettagli (da 2c a g), e solo con il terzo capoverso troviamo tematizzata narrativamente l’inquietudine che è già stata costruita nel lettore, tramite queste tre onde di crescendo progressivamente più ampie, basate sulla sintassi la prima, sull’ordine di successione degli enunciati che descrivono un evento la seconda, e sull’ordine di successione degli eventi la terza. Si noti dunque come è organizzato il racconto del primo evento: c’è un’introduzione (1a) caratterizzata dal crescendo su base sintattica (la lunga clausola tra parentesi) che si conclude sulla presentazione dell’evento; c’è un momento di dilazione (1b e c) caratterizzato dal crescendo di «seconda onda», dove viene fatta attendere la descrizione dell’evento, e che sfocia infine nella descrizione stessa (2a), seguito da una clausola minimizzante (2b), che chiude l’evento in sé, ma che implicitamente dichiara non giustificato il rilievo narrativo assegnato all’evento, e prepara il lettore all’arrivo di un seguito. Anche il secondo evento viene aperto da un periodo (2c) che contiene un inciso. Si tratta di un inciso più breve, ma, come ci insegna Meyer[1956], alle riprese basta assai meno per riproporre il clima dell’esposizione originale: quando la situazione ci è già nota, è sufficiente un accenno per riproporla integralmente all’attenzione. E dopo la presentazione dell’evento, abbiamo pure qui una dilazione (2d) ma nuovamente più breve della precedente («Fu anche questa volta un attimo perché il direttissimo filava…»), mentre alla descrizione dell’evento viene dato più spazio (da 2d a f), come più spazio viene dato alla clausola minimizzante (da 2g a 3b), la quale ora però esplicita il motivo del crescendo di nervosismo del protagonista, tematizzando finalmente lo stato tensivo in cui è stato portato il lettore. Stiamo aspettando, in questa fase del racconto, un evento di carattere Destinante; oppure, in subordine, un evento che possa anche appartenere a una fase successiva, nell’ipotesi che gli eventi della fase della Manipolazione possano venirci raccontati in seguito per mezzo di un flash back. Quello che invece incontriamo qui è una situazione di sfondo nella sua normalità (il viaggio in treno) presentata insieme con una serie di eventi il cui ruolo narrativo non è affatto chiaro – e di cui non sarebbe nemmeno chiaro che hanno un ruolo narrativo se il sistema tensivo in cui si situano non li ponesse nella situazione di doverlo avere. Ciò che ci viene presentato, insomma, è semplicemente il sospetto di trovarci in una situazione narrativa, sospetto basato su una serie di indizi di carattere stilistico fondati a loro volta sulla competenza intertestuale del lettore, e sull’assunzione di base che se qualcuno ci racconta qualcosa è perché ha qualcosa di rilevante da raccontarci. Prima di proseguire è comunque opportuno fare alcune osservazioni sulla sintassi utilizzata da Buzzati in questi paragrafi. Si tratta di una serie di periodi piuttosto lunghi, in cui domina una costruzione paratattica basata su un susseguirsi di clausole separate da virgole, anche là dove una punteggiatura più tradizionale richiederebbe qualcosa di più forte. In qualche caso le virgole addirittura mancano proprio dove se ne dovrebbe aspettare la presenza. L’analisi delle varianti mostra come in 1c l’espressione «simbolo per quelle popolazioni incolte, di miliardi» fosse in precedenza, più correttamente, «simbolo, per quelle popolazioni incolte, di miliardi». È dunque chiaro che l’uso anomalo della punteggiatura, e la sintassi singolare che ne consegue, sono oggetto di un’attenzione particolare da parte dell’autore, che cerca, evidentemente, un effetto stilistico. Si tratta, probabilmente, del tentativo di rendere con un linguaggio realisticamente colloquiale il monologo interiore di un viaggiatore che inganna la monotonia del viaggio con pensieri e piccole osservazioni su quello che vede. Lo stratagemma stilistico è coerente con il fatto che la narrazione sia in prima persona. In questo modo, con una sorta di stile indiretto libero, i pensieri del protagonista si confondono con quelli del narratore. Non dimentichiamo che, anche in un racconto in prima persona, le figure del narratore e del protagonista vanno riconosciute tipicamente come ben distinte: il narratore è l’io qui ed ora, che racconta di un altro io che si trova là e allora. Nel racconto che stiamo analizzando questa differenza viene tuttavia confusa, o almeno resa meno netta, per mezzo dello stile sintattico, che tende a renderci i pensieri del protagonista con un’imprecisione sintattica che può rendere l’andamento rapsodico con cui i pensieri ci vengono alla mente. Come effetto, il narratore stesso viene trascinato verso il là e allora della storia raccontata – qualcosa che per il momento appare come uno stilema senza particolari conseguenze, e peraltro assai frequente in tutta la scrittura di Buzzati, ma che avrà invece più avanti alcuni effetti di grande peso. …………….. _________________________________________________ Quello che avete letto è un frammento di un saggio intitolato Il viaggio del lettore. Una lettura di ‘Qualcosa era successo’, pubblicato originariamente su Studi buzzatiani. Rivista del Centro Studi Buzzati, 2002. Il saggio nella sua interezza è da oggi scaricabile nella sezione Downloads del mio sito. Buona lettura! Il genere musicale del Notturno fu inventato da John Field (1782-1837), ma fu il “plagiario” Frederik Chopin (1810-1849) a passare alla storia per i suoi Notturni. Basta ascoltarli e non è difficile capire il perché: davvero plagio? Harold Bloom ha scritto nel 1973 un bellissimo libro (The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry) sul difficile rapporto che ogni autore ha con gli autori che lo hanno ispirato: e, ovviamente, degli ispiratori ci sono sempre. Riallacciandosi alla polemica di qualche giorno fa sull’origine del fumetto, Matteo Stefanelli rende nota una scoperta sul plagio operato da Winsor McCay nei confronti di (almeno) due autori francesi di qualche anno prima: Rip e Job. Le immagini che vengono mostrate sul suo blog esibiscono una somiglianza che non si può contestare: penso che non ci siano dubbi sul fatto che McCay si sia fortemente ispirato a quelle pagine. Tanto più che, sul suolo americano, le probabilità che qualcuno si accorgesse della somiglianza con una pagina di giornale francese di venti anni prima erano davvero irrilevanti. Ma fa bene Stefanelli a insistere sul fatto che nulla di tutto questo sminuisce il valore di McCay. Basta osservare la comparazione stessa di immagini che ci dimostra il plagio, per rendersi conto perché McCay sia passato alla storia e Job no. Continua a essere dominante la convinzione che il cuore di un testo narrativo sia la storia raccontata, e che chi copia la storia copia il testo stesso. A partire da Shakespeare, dunque, gran parte degli scrittori e commediografi di tutte le epoche sarebbero dei plagiari. In verità, la storia raccontata è solo uno degli elementi che contribuiscono al fascino di un’opera, e spesso nemmeno il principale. La medesima storia è interessante nella pagina di Job e favolosa in quella di McCay. E la differenza sta in una concezione radicalmente diversa del rapporto tra sequenza di vignette e spazio della pagina, del tutto tradizionale in Job, ed estremamente innovativo in McCay. (Meglio, da questo punto di vista, il lavoro di Rip: ma l’abisso rimane) Puntualizzato questo, l’influenza c’è, indubbiamente. E McCay ha indubbiamente visto quei lavori e li ha utilizzati come punto di partenza dei suoi. Il che non sposta di una virgola i termini della polemica sulla nascita del fumetto. Anzi, forse li sposta. Mi viene voglia di proporre di posticipare di 10 anni la data convenzionale di origine del fumetto, dal 1895 (o ’96) al 1905, anno dell’uscita di Little Nemo. Lì sì che succede qualcosa di nuovo, e non solo nel sistema di produzione e consumo! |
||
|
Copyright © 2024 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||
Commenti recenti