Visto che sono in tema di jazz, restiamo in tema di jazz. Nel 1979 sapevo pochissimo di jazz, e lo avevo scoperto, di fatto, da pochi mesi. C’ero entrato da un ingresso strano, non dallo swing né dal bebop. Tutto era iniziato l’autunno prima, quando un amico, che suonava il sax, mi aveva fatto ascoltare un disco di Anthony Braxton, “Five Pieces”. Io ci avevo riconosciuto gli stilemi delle avanguardie, e avevo drizzato le orecchie.
Poi avevo trovato un complice, anzi un maestro, che di jazz era un patito, e mi spiegava un sacco di cose, e mi faceva ascoltare i dischi giusti. Tanto per restare in zona Chicago, oltre ad altri dischi di Braxton, ascoltavo e riascoltavo The Art Ensemble of Chicago, e Muhal Richard Abrams; e poi di lì verso Cecil Taylor e Ornette Coleman, e ancora verso forme di jazz più tradizionali. Avevo molta puzza sotto il naso all’epoca, e benché facessi fatica a negare il piacere che mi procurava comunque Louis Armstrong, faticavo a giustificarne il valore a fronte degli anatemi di Theodor Wiesegrund Adorno.
Iniziai a frequentare i concerti, uno dopo l’altro. Ne ricordo uno molto bello (ma con un’acustica terribile) di Braxton alla sala della Gran Guardia di Verona. Quando il mio amico/maestro mi propose 5 giorni all’International Jazz Festival di Pisa, tutto dedicato alle avanguardie – e avremmo persino potuto dormire da un suo amico! – mi sembrò un’occasione straordinaria. E lo fu davvero.
Era fine maggio o primi di giugno, mi pare. Arrivammo a Pisa in autostop. Le giornate erano pienissime: mattina, pomeriggio e sera fitte di occasioni musicali. Di giorno concerti con caratteri didattici, quasi seminari a volte. Di sera, fino a molto tardi, gli spettacoli.
Ne ho ancora, di alcuni, un ricordo vivissimo. Han Bennink (con Misha Mengelberg e connessa sigaretta penzolante dal lato della bocca) che nel corso di un interminabile assolo si alza e, correndo, suona l’intera cancellata del palasport dove si svolgeva il concerto. Steve Lacy che esegue la sua preghiera tibetana camminando per il giardino Scotto (in seguito lo avrei sentito ripetere questo pezzo in molte, forse troppe occasioni, ma era la prima volta, quella). George Lewis che improvvisa al trombone da solo per un’ora (e forse dopo un po’ non ne potevamo più, ma non si poteva ammettere). Dave Holland pure da solo al contrabbasso, ma il tempo, alla fine, era volato via. Derek Bailey che improvvisava alla chitarra cose incomprensibili. Di molti concerti non ho più ricordo. Mi sembra che ci fosse Roscoe Mitchell, ma potrei confondermi con qualche concerto di qualche mese dopo altrove. Di sicuro il festival si concludeva con un evento differente, un’orchestra del gamelan di Bali, sul palcoscenico all’aperto del giardino Scotto. E sulle loro scenografie già pronte, oscillanti al vento della sera, Anthony Braxton aveva subito prima suonato da solo, in maniera memorabile.
Avevamo fatto gruppo con altri appassionati, amici di amici. La sera, tornando verso casa (e c’era un sacco di strada da fare), si improvvisavano jam session vocali. Ma quando qualcuno aveva buttato lì che però forse Charlie Mingus era anche meglio di quello che ascoltavamo lì (con tutta la passione che ci mettevamo), si era levato immediatamente un coro di approvazioni. Mingus era morto, piuttosto giovane, pochi mesi prima. Io un po’ ignorante e un po’ supponente, non dissi nulla. Pensai che però Mingus rappresentava la tradizione, e comunque l’avanguardia doveva essere meglio; ma mi appuntai di ascoltarlo, questo autore di cui tutti i presenti parlavano con aria sognante.
Racconto tutto questo un po’ perché mi va di condividere questo ricordo, e un po’ per via di un episodio significativo, un piccolo ma enorme passaggio di crinale, quei pochi metri di differenza che fanno sì che poi si scenda verso un mare piuttosto che verso un altro. Voglio dire che cinque giorni passati ad ascoltare, dodici ore al giorno, musica di avanguardia, lasciano per forza il segno. Quando inizi ti sembra tutto straordinario (anche perché è da tempo che corri dietro a questo mito) e dove non capisci dai comunque la colpa a te stesso. Ma poi, col succedersi dei concerti, ti rendi conto che anche nel contesto dell’avanguardia le forme finiscono per ripetersi, la quantità delle combinazioni è limitata, e talvolta quella che all’inizio ti era sembrato un problema di difficoltà per l’asprezza del linguaggio, a un certo punto si rivela come semplice noia: dopo tre, quattro giorni, quella roba lì l’avevamo già sentita, e un sacco di volte. Tra gli altri, emergevano comunque dei concerti di un livello differente, e Braxton e Holland si rivelavano certamente più bravi di molti altri, ma era difficile dire perché, visto che, tutto sommato, ritrovavamo anche nella loro musica quelle stesse forme, quello stesso modo di fare, quelle stesse strutture. Ci appariva quindi a un certo punto impossibile sostenere che Braxton (poniamo) ci piaceva perché faceva quel tipo di musica, il jazz di avanguardia. Lì, al festival di Pisa, tutti facevano quel tipo di musica, ma non tutti erano ugualmente apprezzabili.
Ricordo benissimo che l’ultima sera ebbi una discussione feroce con un amico di amico che sosteneva quello che io stesso avrei sostenuto sino a tre giorni prima, ovvero che il valore di quella musica stava nella sua componente di rottura, di contrapposizione, di non rispetto delle regole, di antagonismo al sistema commerciale. Ma come potevano le cose stare a questo modo quando, dopo tanti concerti, ci appariva evidente che esisteva una norma dell’avanguardia, un sistema di regole condivise anche lì, una – chiamiamola così – banalità del nuovo non meno noiosa della banalità del commerciale? Tanto più che quella stessa musica aveva la sua stessa – per quanto minore, di nicchia, marginale, ma non inesistente – dimensione commerciale.
Non ci era più possibile generalizzare, e salvare il genere per ragioni ideologiche, ora che dopo quattro giorni interi di ascolto, ci stava davanti agli occhi (o dentro alle orecchie) che quello era davvero un genere – contro tutto ciò che pensavamo sino a poco prima. Ma se l’avanguardia era un genere, con i suoi maestri e le sue mezzecalzette, le sue maniere e le sue regole, allora la denominazione “avanguardia” non le si poteva più attribuire in senso proprio; perché, in senso proprio, l’avanguardia è la punta estrema di un processo progressivo. Se la si riconosce come genere, allora le si toglie quel privilegio che la denominazione le vorrebbe attribuire. È solo un genere tra gli altri – magari quello che ci piace, ma non di più. Per bene che vada, può essere qualificato come un genere frequentato da molti artisti di valore: ma anche questo va appurato nei fatti, e si può persino scoprire che i musicisti di valore abbondano pure in altri generi, magari persino meno ideologicamente puri, magari persino più mefistofelicamente commerciali.
E allora tanto valeva davvero provare ad ascoltare Charlie Mingus, per scoprire che sarebbe stato bello sentire dal vivo pure lui, e che la sua intelligenza musicale era comunque straordinaria, anche se con l’“avanguardia” (adesso le virgolette sono diventate d’obbligo) non aveva contatti diretti. E magari poi, la scoperta che andavo facendo rispetto al jazz valeva anche per altri tipi di musica, e pure per altre arti; e chissà mai che persino la neoavanguardia letteraria italiana (quella del Gruppo 63 e dintorni) non fosse altro che l’espressione di un genere, uno tra gli altri, difeso, come tale, solo dalla protervia ideologica dei suoi teorici?
Non ho mai smesso di apprezzare Sanguineti e Porta, e di considerarli tra i più importanti poeti italiani del Novecento, ma l’ho fatto per le loro poesie, non per le loro teorizzazioni. In verità non ho nemmeno mai smesso di leggere Adorno, che continua ad apparirmi un critico musicale (e in generale, estetico) di grande qualità; ma lo è, paradossalmente, più a dispetto che a causa della sua concezione dell’arte come contrapposizione all’industria culturale. Lo trovo un concetto banale, quest’ultimo, alla fin fine: non mi spiega affatto perché in quel giugno del 1979 io abbia potuto trovare tanto più entusiasmanti Braxton e Holland di molti loro colleghi, né perché in seguito mi sia accaduto lo stesso nei confronti di Mingus, o perché in qualsiasi ambito io possa trovare delle differenze di qualità del tutto indipendenti dal genere, ma anche dal rapporto di adesione o contrapposizione al Moloch dell’industria culturale – benché non ne ami le regole, di questa, benché la rifugga ogni volta che posso, benché sia rimasto anche in me un po’ di quello spirito da vecchio aristocratico che certamente muoveva anche Adorno. Ma non posso chiudere gli occhi (o le orecchie) in nome di un’idea, qualunque essa sia.





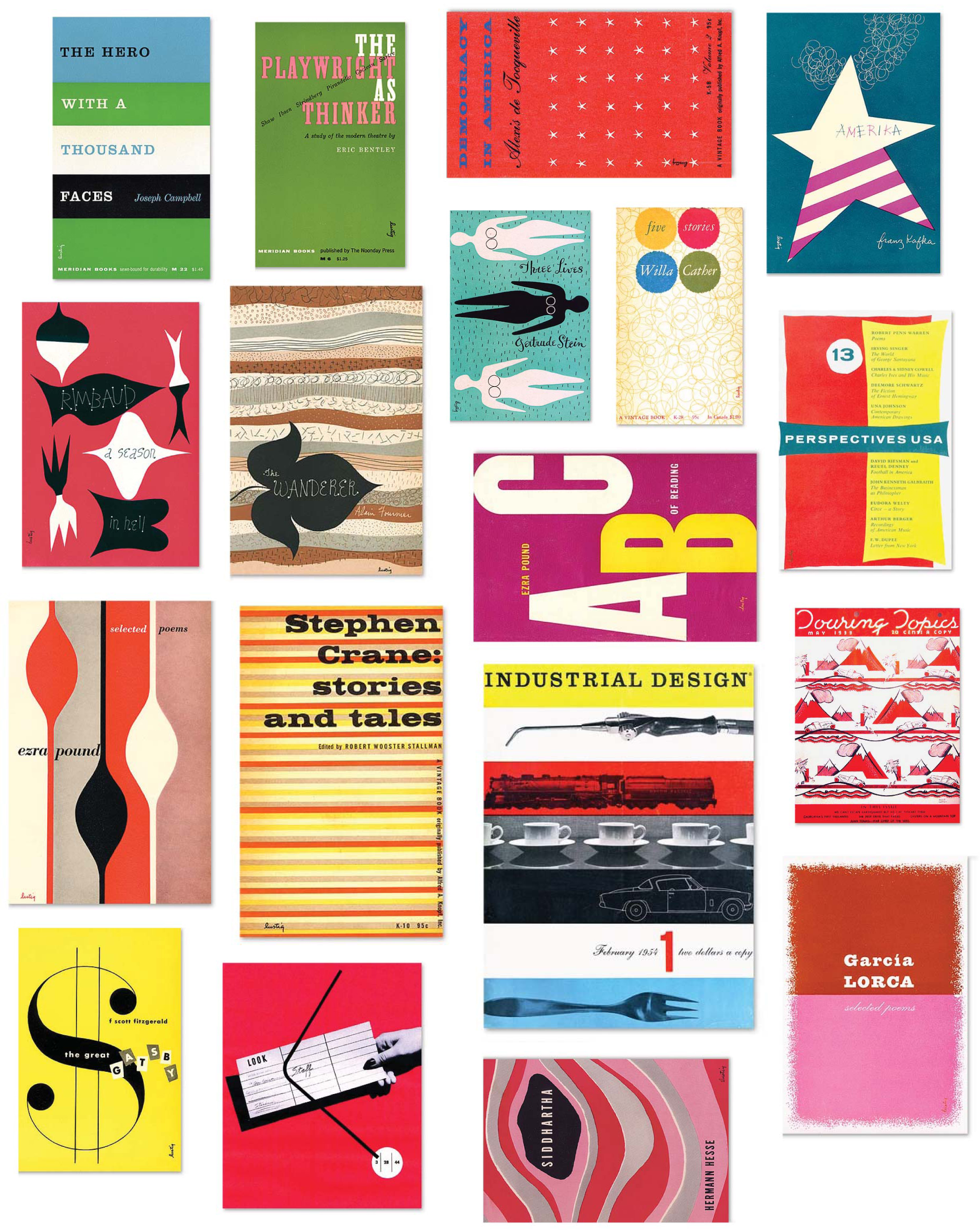









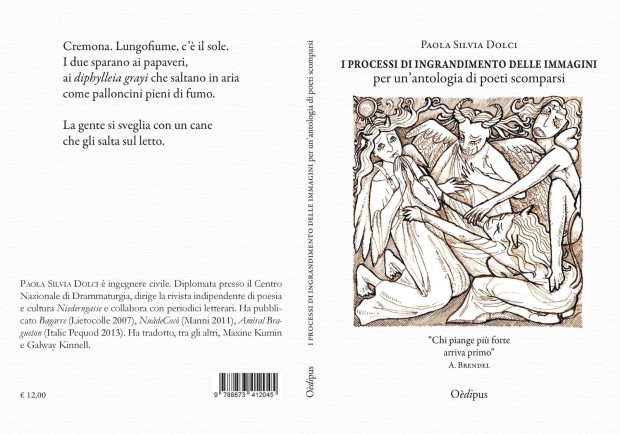
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco




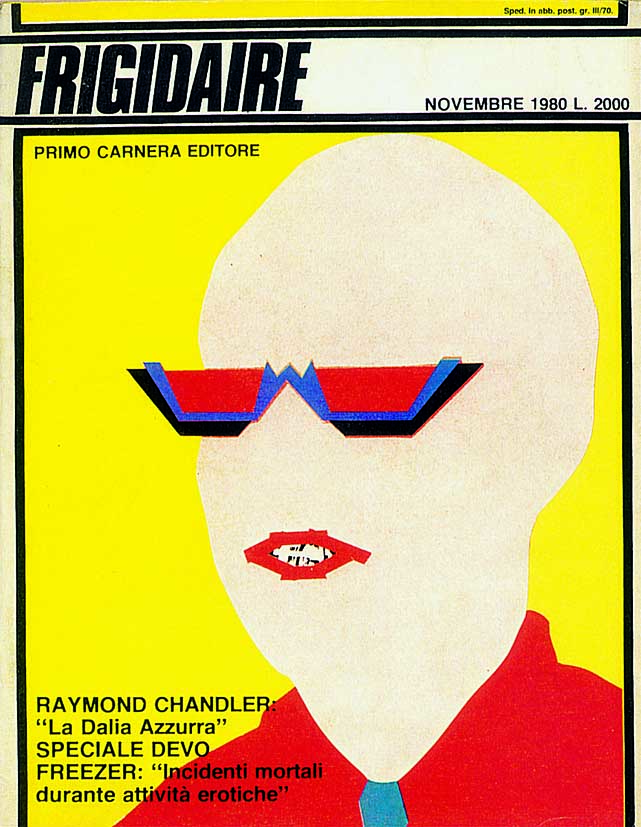

Commenti recenti