Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.


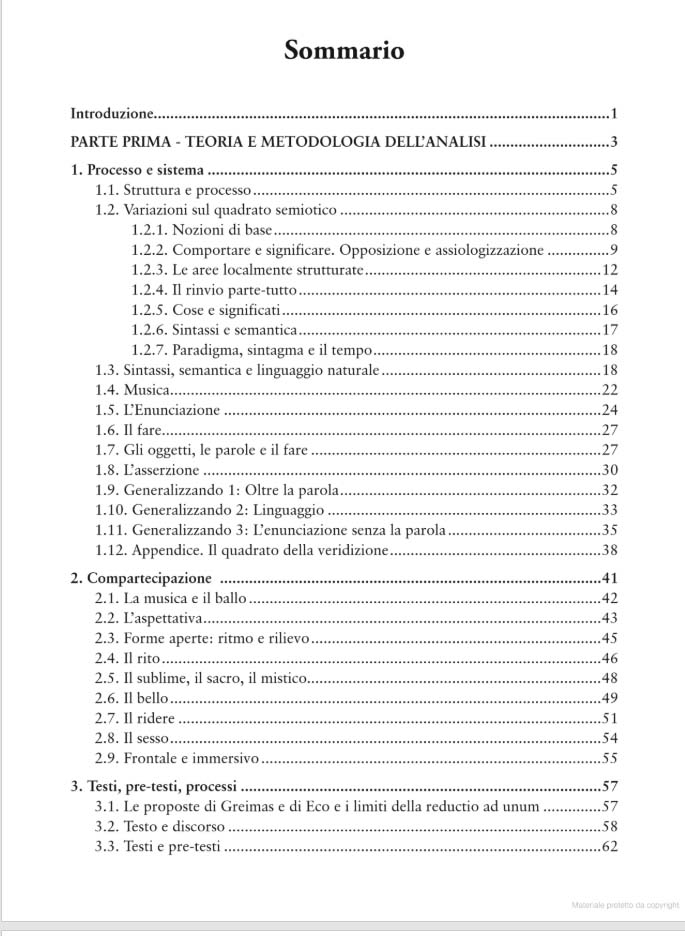
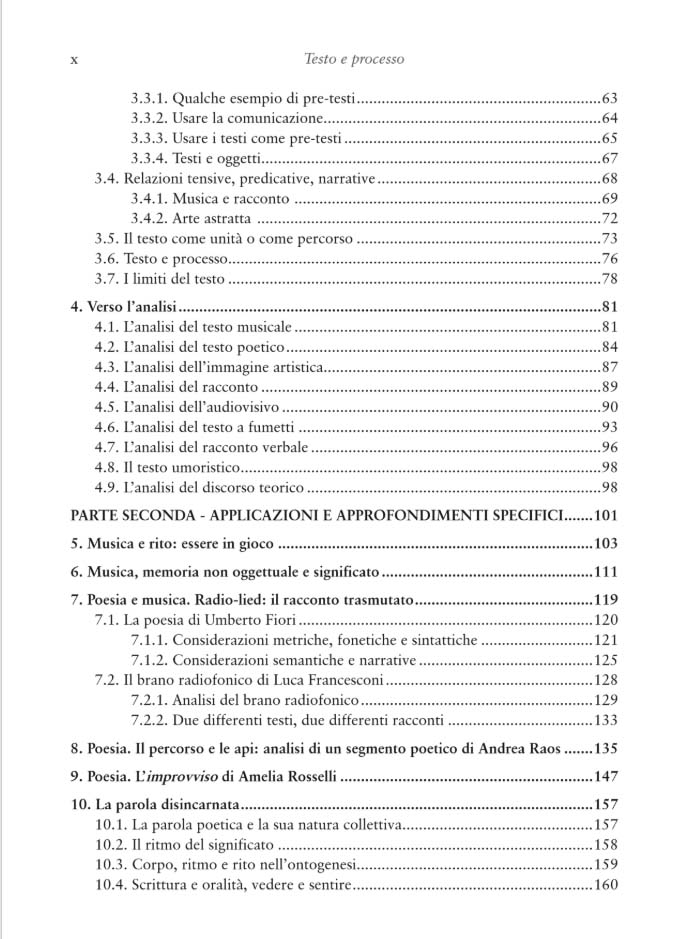
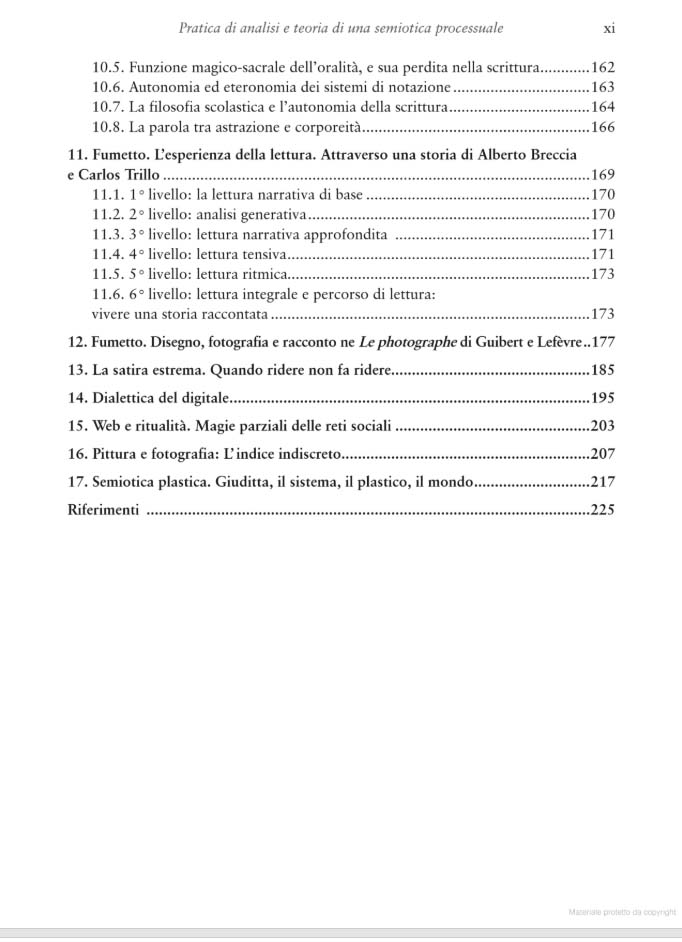

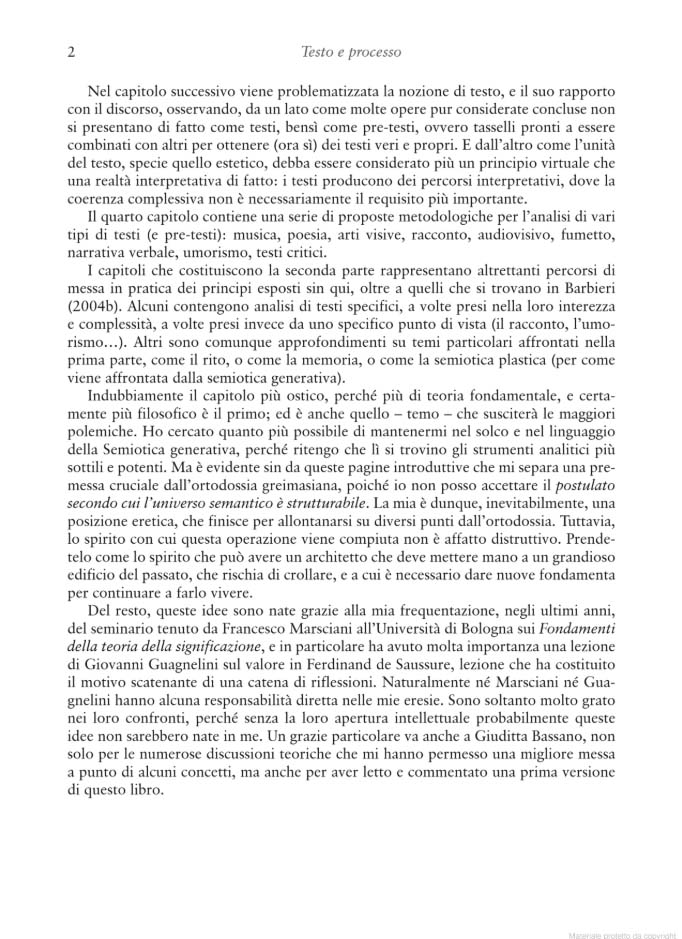
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
|
|
||
|
Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore. Tra una settimana in libreria. Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto. Un percorso, che riguarda il fumetto, tra il mito, la serialità, la pittura e la scrittura, e – ovviamente – il racconto. Le impreviste connessioni tra mondi che il fumetto ha riportato vicini.
Da fine marzo il libro è disponibile in libreria. Si può acquistare on line sul sito di Comicout (meglio) oppure su Amazon.
Sigue aquí – Continua qui, su Signa. Revista de la Asociaciòn Española de Semiòtica, pag. 729
Prosegue su Il Sileno, vol.3 n 2 (dicembre 2016), anzi esattamente qui.
L’articolo intero si trova qui, su Between.
L’articolo nella sua interezza si trova qui, su H-ermes. Journal of Communication.
Recentemente ho letto molto Lacan, scoprendovi con sorpresa un sacco di nozioni familiari, anche se spesso chiamate con nomi non familiari. Andando a cercare, su questa base, tracce di Peirce in Lacan, con mia iniziale sorpresa ne ho trovate parecchie, di cui molte assolutamente esplicite, a partire dal Seminario del ’61-62. Facendo un po’ di conti, anche a partire dagli anni di pubblicazione dei Collected Papers, si può ipotizzare che Lacan abbia letto Peirce nei tardi anni Cinquanta, quando già diversi elementi essenziali della sua teoria erano assestati, ma altri ancora dovevano venire. La teoria del soggetto diviso, dell’io (moi) come fenomeno di superficie, e dell’inconscio strutturato come linguaggio erano già state sviluppate prima dell’incontro con Peirce, ma nel momento in cui l’incontro avviene Lacan trova in Peirce tutte le premesse che gli mancavano, essendosi basato sino ad allora sulla semiologia saussuriana e sul suo sviluppo strutturalista. La famosa formulazione “Il significante è ciò che rappresenta il soggetto per un altro significante” è chiaramente un calco dalla definizione peirceana di segno, e rimane oscura sino a quando non si prova a costruirla graficamente in maniera analoga a come normalmente si costruisce la fuga degli interpretanti in Peirce. Ecco qui a destra il diagramma per Peirce: Un representamen (cioè un segno) rimanda al suo oggetto solo attraverso la mediazione di un interpretante, il quale si trova a sua volta nella posizione del representamen iniziale e ha bisogno di un nuovo interpretante, per il quale vale la medesima necessità. Si genera in questo modo una fuga degli interpretanti, virtualmente infinita, ma che ha di fatto termine solo nella prassi (nel formarsi di un abito, ovvero di una disposizione al comportamento, dirà Peirce). Ora, sostituiamo in questo diagramma i termini lacaniani a quelli peirceani, e scriviamo significante là dove c’è scritto representamen o interpretante, e scriviamo soggetto là dove c’è scritto oggetto. Così come in Peirce abbiamo l’immagine di un oggetto a cui di fatto la significazione non arriva, perché è sempre mediata dal passaggio a un altro interpretante, allo stesso modo avremmo in Lacan l’immagine di un soggetto a cui non si arriva (a cui l’analista non arriva) perché qualsiasi significante gli possa rimandare va comunque interpretato alla luce di un altro significante, e così via. Di fatto, il soggetto lacaniano è tutto costruito, per la sua determinante parte simbolica, da questa fuga dei significanti, e per Lacan il soggetto è l’inconscio, mentre l’autocoscienza è un ulteriore sovrastruttura, peraltro illusoria. Il reale lacaniano appare inoltre molto vicino al ground peirceano (per non dire di altro, su cui non scriverò qui). Lacan è erede di una tradizione fenomenologica (quella husserliana-heideggeriana) diversa da quella peirceana, in cui il soggetto non si trova così dissolto. Lacan cresce tuttavia in una cornice anche hegeliana, in cui invece l’idea di un soggetto come epifenomeno è già presente. Anche Peirce ha un retaggio hegeliano, e sviluppa una propria fenomenologia (che lui chiamerà faneroscopia). Con presupposti simili, Lacan sviluppa quindi originalmente una serie di concetti che sono convergenti con quelli peirceani, sino a quando non incontra una fenomenologia diversa da quelle europee, in cui il soggetto è già implicitamente dissolto, e sono presenti da lungo tempo diverse delle sue scoperte (non tutte, certo). Questo è parte di quello che ho raccontato al convegno di Bologna, con altre osservazioni sul Faust di Goethe (che su questo blog erano già comparse qui, e poi di nuovo qui, questa volta sviluppate in un discorso sulla poesia) e ancora altre su Gregory Bateson, che mostrano a loro volta come nemmeno l’idea peirceana che la semiosi sia già presente in natura sia una posizione metafisica, bensì a sua volta fenomenologica. Insomma, una fenomenologia senza soggetto, inquietante e affascinante.
La nozione di “verità” di cui si parla nell’articolo è quella utilizzata in filosofia del linguaggio, e il mio articolo ne sostiene la non applicabilità ai testi estetici. L’articolo inizia prendendo come punto di partenza l’analisi critica di una poesia di Giuliano Mesa, sviluppando poi il discorso in maniera molto più generale. L’articolo (insieme a tutta la rivista) è interamente leggibile qui. Eccone le prime righe:
Ciò che caratterizza il simbolico, nella posizione di Eco (posizione che, in generale, sostanzialmente condivido), è il fatto che il simbolico cresce come una sorta di escrescenza su di un testo che avrebbe già un significato accettabile a livello letterale (o anche metaforico – ma in questo è differente dall’allegoria o dalla metafora, che di solito rivelano la propria presenza e la necessità di un’interpretazione traslata proprio perché quella diretta, di base, non avrebbe senso). Inoltre, ogni interpretazione simbolica ha alle spalle una teologia – ci dice Eco: in altre parole, poiché si tratta comunque di un uso del testo, le interpretazioni simboliche sono infinite, e possono prendere le vie più particolari; per questo, un’interpretazione simbolica, più che parlare del testo, parla della concezione del mondo che la alimenta. In particolare l’arte basa le proprie costruzioni simboliche su sistemi linguistici assestati e tradizionali, e ne è perciò indirettamente rivelazione – ma attraverso di loro è anche rivelazione di noi stessi (che abitiamo e viviamo questi sistemi). Nel passaggio che il simbolico fa dal misticismo all’arte si inserisce però un’importante differenza, mi sembra. Mentre il misticismo pretende ancora di parlare di una verità, l’arte ha abbandonato del tutto la problematica della verità. Non dimentichiamo che l’arte non è una cosa sempre esistita e universale, ma semplicemente il prodotto di una concezione occidentale del mondo che non arriva ad avere quattro secoli. Non che prima non si facessero cose belle, ma venivano realizzate con un senso diverso da quello che noi oggi attribuiamo all’arte – o nello specifico alla poesia. Nel passaggio dal misticismo all’arte (in senso moderno quindi) si perde la rilevanza della verità perché si passa da un valore collettivo e condiviso (in cui il mistico dice qualcosa che, tendenzialmente, deve essere creduto da tutti) a un valore individuale e scambiato (in cui il poeta non è tenuto a dire cose vere, perché non è quello il suo ruolo: deve piuttosto emozionare, commuovere, stupire…). All’arte (alla poesia) è richiesto di dire la verità solo in un senso molto superficiale; diciamo a livello letterale (o di prima metafora). Tuttavia la dimensione in cui la poesia è davvero poesia non è quella letterale, bensì quella simbolica, e a livello simbolico parlare di verità è molto pericoloso – almeno sinché si intende la verità come corrispondenza tra il concetto espresso e il mondo. Detto in altro modo: se le diverse derive simboliche di un testo sono virtualmente infinite, come si può valutare la verità del testo nei loro termini? Di fatto, la poesia non è fatta per dire particolari verità, se non a livello banale – e in effetti le verità che la poesia davvero dice sono in generale banali. Ma la poesia non è tale solo per quello che esplicitamente dice. La poesia è un tipo di testo che è fatto, che nasce, all’esplicito scopo di fomentare interpretazioni di carattere simbolico (e, nel dire “simbolico” non bisogna pensare solo al Simbolismo, e ai suoi simboli sublimi: il correlativo oggettivo eliotiano/montaliano è un esempio evidente di simbolo, e l’interpretazione simbolica può tranquillamente mirare anche al basso e al quotidiano). Potremmo arrivare a dire che una poesia riuscita (un’opera d’arte riuscita) è una poesia che ben si presta a numerose e affascinanti interpretazioni simboliche. A portare questa tesi sino in fondo, salta fuori, però, che, allora, l’eventuale verità letterale delle parole di un testo poetico è davvero qualcosa di poco rilevante, almeno quanto lo è la “verità” di una successione di note in musica. Ma se questa verità è irrilevante, allora, in verità, ci importerà di sapere quale sia l’argomento di un componimento non perché esso possa dire al proposito qualcosa di vero, ma semplicemente perché ciò di cui un testo poetico parla (insieme al modo in cui lo fa) è la base letterale di tutte le possibili interpretazione simboliche – le quali a loro volta ci interessano non perché possano essere più vere di altre (e in questo sta la differenza col misticismo) ma perché nello stesso processo interpretativo che mettiamo in atto leggendo, ci inoltriamo in un percorso, che è un percorso di suggestioni ed emozioni. La poesia, insomma, non asserisce (se non al livello letterale, di base) ma suggerisce – e suggerisce (al livello simbolico) collegamenti e visioni che poi richiedono di essere eventualmente verificati in altri modi. Tuttavia, se il problema della verità è così marginale in poesia, non si vede perché il testo poetico la debba veramente perseguire al suo livello di base – né si capisce perché la critica debba cercare di estrapolare delle verità dei testi stessi, piuttosto che occuparsi delle modalità del percorso di interpretazione simbolica. Come ho avuto modo di sostenere una volta, la poesia ha il diritto di essere incomprensibile, perché, se il problema della verità resta tagliato fuori, anche la comprensibilità al livello di base condivide la sua sorte. Sin qui, questo discorso sembra portare acqua alla posizione di Marco Giovenale, e in particolare alla sua idea del cambio di paradigma (o almeno così mi pare di riuscire a intenderla). Se capisco bene la sua posizione, il cambio di paradigma riguarderebbe proprio un cambio di atteggiamento interpretativo (che, naturalmente, permetterebbe anche un cambiamento nella poesia stessa in direzione della non assertività) dalla poesia come oggetto chiuso da contemplare nel suo insieme ben definito, alla poesia come percorso da attraversare, senza che essa sia necessariamente dotata di una coerenza a livello letterale. Ho tuttavia due ordini di obiezioni a questa posizione che attribuisco a Giovenale (sperando di non aver dato del suo pensiero un’interpretazione troppo “simbolica”). La prima è che la poesia è sempre stata impicitamente interpretata così (“sempre” è una parolona che va comunque relativizzata alla storia recente, non più vecchia di quattro secoli; più si va indietro e più bisogna farle la tara); per cui non vedo in gioco un cambio di paradigma, bensì una semplice presa di coscienza da parte della critica di qualcosa che di fatto veniva agito già da molto tempo. La seconda è che, anche abbandonando la questione della verità, quella della comprensibilità rimane viva. Giovenale ha detto più volte (perdonatemi, non trovo i riferimenti, e cito a memoria – e quindi in maniera imperfetta) che la poesia deve far lavorare interpretativamente il lettore. Un componimento tranquillamente assertivo non produce questo genere di lavoro; ed è quindi poco interessante. Guardando le cose sotto la luce del modo simbolico, la prima asserzione appare vera (un testo che non fa lavorare il lettore non è nemmeno un testo poetico, secondo me), ma la seconda no, perché anche da un testo banalmente assertivo è possibile far partire una catena infinita di fascinose interpretazioni simboliche (l’esegesi biblica insegna). Quello che forse si potrebbe sostenere, come aveva fatto Jacques Geninasca (in La parola letteraria), è che un testo che si lascia facilmente interpretare a livello letterale non spinge a cercare nuove interpretazioni; come invece fa un testo che a livello letterale apparirebbe insensato. Bisogna però, per dar ragione a Geninasca, immaginare un lettore disposto comunque a interpretare, cioè a dar fiducia al testo, cioè a scommettere che quel testo ricompenserà il faticoso lavoro interpretativo che gli chiede, senza facili soddisfazioni intermedie. Il punto, io credo, è proprio quello della fiducia, e della scommessa che, come lettori, siamo disposti a fare. Un primo elemento di questa scommessa è, per esempio, la fiducia che abbiamo nell’autore: per esempio, ho già avuto modo di apprezzare la poesia di xy, lo stimo, mi aspetto che produca altre cose di valore; quindi mi fido e mi impegno nel lavoro interpretativo (non per cercare verità, ma suggestioni, suggerimenti, evocazioni, senza nemmeno un requisito di coerenza complessiva: già questo mi basta e avanza). Ed è sulla base di una fiducia di questo genere che ho affrontato proprio la raccolta In rebus, del medesimo Marco Giovenale (Editrice Zona, 2012). Certo, il titolo va letto alla latina, nelle cose, ma non si può fare a meno di leggerlo anche all’italiana, con riferimento all’enigmistica, e alla decifrazione. Un riferimento che diventa più forte quando poi si vanno a leggere le poesie al suo interno. Rispetto a La casa esposta, a Shelter, la sensazione è che il gioco dell’evitare qualsiasi possibilità di definizione chiara del senso si sia fatto qui più duro, più estremo. Cito, dalle ultime pagine:
Non c’è niente di neodadaista o di conceptual qui (temi di una mia recente piccola polemica con Giovenale). Non ho obiezioni alla formula. Di Giovenale apprezzo anche la scrittura. Qua e là questi versi iniziano pure a prendermi. Ma poi subito dopo smettono. Continuano piuttosto a darmi la sensazione che l’autore, ogni volta che tocca un tema potenzialmente evocativo, invece di svilupparlo, lo abbandoni al più presto, come se permettere la costruzione di un senso, anche simbolico, fosse un peccato, e si dovesse sempre costringere il lettore (e il primo lettore è l’autore stesso) ad andarlo a trovare più lontano, più lontano, ancora più lontano. Le paronomasie, le allitterazioni, le rime o quasi-rime sono qui spesso forzate, apparentemente gratuite. In un autore tutt’altro che ingenuo come Giovenale questa insensatezza non può che essere apparente; deve per forza nascondere un gioco, deve per forza essere un invito a non fermarsi lì. Ma poi, per quanto io provi ad andare avanti, io resto sempre lì. Può darsi che il mio universo simbolico (la mia teologia di riferimento, per dirla con Eco) sia troppo diverso da quello necessario per leggere questi testi. Di fatto io arrivo a un punto in cui la sensazione più forte che vivo è quella che l’autore non faccia che evitare di permettermi un qualsiasi percorso – e quando questa sensazione diventa troppo forte, la mia fiducia in questi testi crolla, e io smetto di cercare. La sensazione, analizzandola un poco più a fondo, è che l’autore stia cercando di evitare di commettere un peccato, il peccato dell’assertività. E poiché si può asserire in molti modi, e non c’è limite ai modi subdoli e incosapevoli in cui le parole possono arrivare (per via metaforica o anche simbolica) ad asserire qualcosa, tutta l’attenzione dell’autore sta nel cercare di evitarlo – arrivando, se necessario, quanto più vicino possibile all’irraggiungibile puro vuoto del senso, il grado zero della parola, il nulla (un classico delle avanguardie, dallo Zero di Porta agli Zeroglifici di Spatola). In questo senso, allora il lavoro di Giovenale mirerebbe ad avvicinarsi a quelli (in questo senso nichilisti) di Broggi e Zaffarano, sui quali ho già discusso proprio con lui su queste pagine (sempre nello stesso post già menzionato). Eppure, che Giovenale continui a scrivere in senso pieno, inventando, invece di riportare e collegare tra loro frammenti di discorso alienato, mi sembra che sia un indizio a favore della possibilità che la sua ricerca del grado zero sia in verità contrastata e complessa. Sappiamo bene non solo che non c’è bisogno di poesia perché vi sia interpretazione simbolica, ma anche che qualsiasi oggetto del mondo ne è potenziale istigatore, nelle giuste condizioni. Datemi un cavolfiore, una ruota di bicicletta, il sole, o un angolo di marciapiede, e io ve ne ricaverò verità profonde e insondabili per pochi soldi (o per molti, se preferite). La mia sensazione è che Giovenale intuisca il pericolo di ridurre la sua poesia a un cavolfiore, e non intenda davvero arrivare a nullificarla così; per cui la sua poesia resta poesia, in fin dei conti, ma è poesia che cerca di negare il proprio stesso senso. Insomma, anche se non riesco ad apprezzare davvero queste poesie, apprezzo Giovenale perché non arriva sino in fondo, continuando ad aggirarsi pericolosamente in un’area ai confini del senso – e qualche volta il senso risulterà attingibile, in qualche modo, e qualche volta no. Giusto per evitare fraintendimenti: ripeto che non sto parlando né di verità né di assertività, ma solo della possibilità di trovare un percorso, di vivere questi testi come se fossero paesaggi, in cui sono io a dar loro un senso (mentre li attraverso e senza neppure il requisito di una coerenza complessiva).
Eppure esiste, e io lo so. Persino in questa stanza in cui sto scrivendo, che mi è estremamente familiare, vi sono innumerevoli aspetti e dettagli non percepiti, mai percepiti – non solo particolari che non c’è motivo di osservare, ma anche relazioni inosservate tra dettagli osservati e quindi noti. Insomma, io so di non sapere tutto della stanza in cui passo tante ore, e questo fatto non mi preoccupa minimamente: è normale che si viva in una realtà che sfugge in gran parte al senso, e non perché sia insensata, ma perché in gran parte non chiede di essere osservata – almeno sino a quando non arriva il suo momento. Tutto sommato, è una sensazione confortante quella di vivere in un mondo che mi permette di vivere (e magari pure con una certa comodità) anche se non lo comprendo del tutto. Non lo comprendo ma lo vivo, cioè lo attraverso trovando senso, volta per volta, in qualche sua parte. Naturalmente qualcosa devo capire, del mondo che ho attorno, e più ne capisco e meglio è. Ma vivere in un ambiente è accettare la dose di rischio che deriva dal fatto che qualche sua parte è ancora priva di senso per me; e che qualche sua parte priva di senso ci sarà sempre, per quanto io lo esplori e analizzi. Quando si ascolta un brano musicale, si legge una poesia, un racconto, una storia a fumetti, si guarda un film, un’immagine, e così via, ci si trova nella medesima situazione, con una differenza. L’ambiente in cui ci stiamo muovendo non è naturale, ma artificiale, cioè prodotto dall’uomo. Questo comporta che oltre al senso di base che hanno le cose in quanto percepite e interpretate, è presumibilmente presente anche un senso secondo, di carattere simbolico, attraverso cui passa la comunicazione umana. Anche qui, però, non tutto è percepito e non tutto, di conseguenza, arriva ad avere un senso: il testo viene vissuto, proprio come accade con un ambiente, e nel viverlo si sa di non sapere tutto, si sa che ci sono mille aspetti e dettagli che restano in attesa di arrivare a percezione. Questi aspetti e dettagli possono però agire su di noi anche se non ci accorgiamo esplicitamente di loro, anche se non siamo arrivati a dare loro un senso. L’andamento delle cose attorno a noi ci coinvolge anche se non ce ne rendiamo conto. Seguiamo un ritmo, per esempio. I testi artistici, o in generale estetici, vengono vissuti né più né meno degli ambienti del mondo. In questo senso non sono propriamente testi, nel senso in cui lo sono i testi informativi o persuasivi, cioè oggetti costruiti per trasmettere un discorso (che talvolta ha le forme del racconto). Poi, magari un testo artistico sarà anche informativo o persuasivo, perché comunque, sempre, il senso lo attraversa, in quanto prodotto da un autore umano. Tuttavia, ciò che lo rende tale è proprio la sua natura di ambiente, di luogo che va vissuto, attraversato, abitato. Per questo, anche se il lavoro sul significato è importantissimo per l’opera d’arte, l’opera d’arte non si esaurisce nel suo significato, proprio come il mondo stesso non si esaurisce nel senso che gli attribuiamo, perché le scoperte possibili che potrebbero rivoluzionare il senso già assestato sono sempre infinite e potenzialmente imminenti. E se l’opera non si esaurisce nel suo significato, vuol dire che c’è, nel rapporto che intratteniamo con lei, una dimensione di vissuto che rimane cruciale, un sapere che c’è qualcosa che non si sa, e ciononostante la realtà non ci rifiuta, anzi ci accetta, e ci permette di vivere con lei e in lei. L’opera d’arte è una realtà artificiale, fatta dall’uomo per l’uomo. Anche per questo, quando funziona, ci stiamo così bene dentro. Poesia e musica, e molto altro, sono discorsi fatti di mondo, e mondi costruiti di discorso. Una poesia non viene scritta per trasmettere un significato, ma per essere vissuta anche nel significato dei segni che la compongono. Ma siccome, in quel momento, la abitiamo, pure il suono, e l’aspetto visivo dei suoi segni sarà rilevante, proprio come nel mondo – a dispetto del fatto che non sappiamo che senso dare loro, o che non abbiamo la sensazione di accorgercene. Il fraintendimento corrente sta nel fatto che, siccome è fatta di parole, la poesia debba essere interpretata come un normale atto di parola, cioè per comunicare un discorso. Ma chi l’ha detto che un normale atto di parola serve solo a questo? In poesia è evidente che c’è dell’altro. La musica, non possedendo parole, ha evitato questo fraintendimento, ma il problema del suo significato ha ossessionato (e continua a ossessionare) generazioni di studiosi. Io credo che, per il bene del significato, dovremmo accorgerci che non sempre il significato è cruciale. Anche la musica vive una relazione dialettica tra significato e ambiente, dove spesso, sino a qualche secolo fa, il ruolo di trasmettere il significato era di nuovo demandato alla parola (e musica e poesia vivevano a stretto contatto). Poi la musica ha imparato a costruirsi i propri discorsi da sé, ed è diventata un poco più simile alla poesia anche senza fare uso di parole. Nonostante questo, anche nella più concettuosa e intellettuale musica di oggi, è del tutto evidente che per poter cogliere un qualsiasi senso bisogna già esservisi immersi, bisogna già attraversarla e abitarla. Sono stato, qualche sera fa, a una presentazione bolognese del festival ravennate Komikazen, a cui partecipava il mio simpatico omonimo Daniele Barbieri, con il quale, fortunatamente, sono più le opinioni che condivido di quelle su cui dissentiamo – per cui, visto che inevitabilmente veniamo con una certa frequenza confusi, almeno nessuno dei due deve difendersi da accuse di opinioni infamanti. Si parlava di giornalismo a fumetti e di Palestina. Introducendo il dibattito, Daniele diceva che è una cosa terribile quando le vittime diventano aguzzini, e poi domandava a Carlos Latuff come se la cavava con l’accusa di antisemitismo che viene spesso rivolta a chi attacca o critica le politiche del governo israeliano (come è successo, per esempio, a Günter Grass). Vorrei condividere alcune riflessioni che mi sono venute alla mente, mentre ascoltavo le parole di entrambi. Trovo che l’accusa di antisemitismo rivolta a chi attacca il governo israeliano sia politicamente vergognosa e storicamente non giustificabile. Con questa accusa infatti il governo di Israele si arroga il diritto di rappresentare non solo i cittadini israeliani, ma anche la cosiddetta “razza” ebraica nella sua interezza. A guardar bene, se presa alla lettera, le presupposizioni implicite in questa accusa sono mostruose, reazionarie e degne di quel clima culturale che diede vita ai “Protocolli dei Savi di Sion” e alla stessa persecuzione nazista. Si presuppone infatti: – che esistano le “razze” umane: per bollare qualcuno di antisemitismo, bisogna infatti presupporre che esistano i semiti, e che siano un’entità definibile. La scienza dell’Ottocento e di parte del Novecento avallava questa posizione, che è stata invece smentita dalla genetica successiva, e che non trova conferma in antropologia (a meno che non la si intenda nel senso molto più debole di “popolazione che parla una lingua semita” – ma razza e razzismo non c’entrano più, allora). – che “semita” sia sinonimo di “ebreo”: ma questo era falso persino per le teorie razziste. Semiti sono tutti i popoli del Medio Oriente, arabi ed ebrei. Un vero antisemita non potrebbe mai sostenere la causa palestinese, perché i palestinesi sono semiti tanto quanto lo sono gli ebrei. L’antisemitismo è stato davvero una piaga, in Europa, anche prima che i nazisti lo portassero alle estreme conseguenze. Ci sono paesi, come la Russia, in cui continua a serpeggiare nella cultura popolare. Ma nell’Europa occidentale è ormai appannaggio di pochi ignoranti di destra, malati di marginalizzazione e anche per questo tendenti al fondamentalismo (sino ad arrivare ad atti violenti e vergognosi contro le sinagoghe o le persone). L’intolleranza verso i diversi, che sta alla base dell’antisemitismo storico, tende a non avere oggi matrici razziste in senso stretto, perché l’idea di razza non è più di moda. Nemmeno i Leghisti arrivano di solito a scomodare la razza. È più semplice e meno compromettente parlare di diversità culturale, e basare su quella lo sciovinismo, e l’odio del diverso. Alla fine, l’effetto può essere simile a quello che produceva il razzismo, ma il razzismo in senso stretto è quasi scomparso in occidente, o è comunque limitato a frange politiche estreme – pericolose sì, ma marginali. Perché dunque si continua a bollare di razzismo anche chi non parla di razza? Lo si fa, io credo, perché la parola infamante è quella; e se si vuole esprimere disprezzo per una posizione xenofoba come quella della Lega, bollarla di razzismo è il modo più semplice per farsi capire. La parola razzista è diventata insomma una sorta di offesa, dal significato incerto, che non distingue tra chi è razzista davvero (nel senso che crede che esistano le razze, e ve ne siano di inferiori), e chi è ugualmente xenofobo, ma su presupposti diversi. La stessa cosa succede al termine antisemita, applicato in qualità di offensiva condanna sia a chi è razzista davvero, sia ad altri. Chi saranno questi altri? È molto difficile fondare l’antisemitismo su una xenofobia per differenza culturale: dove sono infatti le differenze tra ebrei e gentili, oggi? Sono praticamente solo in una diversa credenza religiosa, un fatto che è sì stato centrale, ma non lo è più da un pezzo. Tanto varrebbe essere xenofobi nei confronti dei luterani, o degli shintoisti. E poi, Israele è il paese culturalmente più vicino all’Europa di tutta l’Asia e l’Africa. I veri antisemiti in termini culturali in Europa sono quelli che ce l’hanno con gli arabi. Ecco dunque che la parola antisemita, con tutti il suo connotato di oscurantismo e l’implicita evocazione spaventosa dell’Olocausto e della vergogna che esso ha portato con sé per tutti i non ebrei d’Europa, si trova pronta all’uso come offesa, e giustificata nella sua applicazione impropria dall’uso improprio che ugualmente si fa della parola razzista. In parole più povere: se la sinistra si sente in diritto di bollare come razzista anche chi non parla di razza, perché la destra (israeliana o sionista) non dovrebbe sentirsi in diritto di bollare come antisemita anche chi non parla di razza o di ebrei? Un errore lava l’altro, un diritto autorizza l’altro. Queste considerazioni ci impongono di renderci conto che la parola razzista a sua volta possiede presupposizioni simili: se io dico a qualcuno “razzista”, sto presupponendo che le razze esistono, e che lui (lei) ha l’opinione sbagliata secondo cui ve ne sarebbero di inferiori. L’uso stesso della parola razzista mette in gioco l’idea di razza. Io proporrei di abbandonare queste parole al loro destino storico; ovvero di usarle solo per quello che hanno significato nel passato, estendendole al presente esclusivamente per quelle mostruosità marginali che sono oggi il razzismo e l’antisemitismo in senso stretto, ovvero basate sull’idea di razza. Non credo di avere alcuna speranza di convincere il governo israeliano e chi ne sostiene le ragioni, dandomi presumibilmente dell’antisemita poiché sostengo la causa palestinese (e non c’è dubbio che, per quello che ho detto, posso essere bollato da loro come tale). Qualche speranza in più potrei avercela con la sinistra, a cui appartengo anche perché ritengo che vi siano più persone ragionevoli e disposte a capire. Troviamo quindi parole diverse, per favore: razzismo e antisemitismo hanno fatto il loro tempo.
Ci sono altre cose che ho detto venerdì scorso a Pordenonelegge, nel dibattito su poesia e fumetto (con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo) di cui ho iniziato a parlare nel post precedente. Cose che magari sono riuscito a dire solo in parte, perché i tempi erano ristretti, e alle quali posso dare qui una seconda possibilità di espressione. Intanto, mi ero portato come ripasso, da rileggermi in treno, il Pasolini di Davide Toffolo, che è un libro molto bello, anche meglio di come lo ricordavo. Non è in nessun senso un esempio di poesia a fumetti, però è un bel libro di prosa fumettistica che parla di un poeta. E così mi è venuto da pensare agli interventi in versi che Pasolini pubblicava su Paese Sera negli anni Sessanta. Erano interventi politici, spesso provocatori, e quindi discutibili tanto quanto interessanti, a cui il fatto di essere in versi non aggiungeva certo qualità. Anzi, come versi davvero non erano memorabili. Niente a che spartire con Le ceneri di Gramsci. Al di là delle opinioni politiche di Pasolini, che non sono pertinenti per il discorso che sto facendo qui, quello che c’era di interessante in quei versi era proprio il fatto che fossero versi, inseriti in un contesto in cui il verso normalmente non trova posto. Con questa operazione, Pasolini centrava due obiettivi, entrambi provocatori. Da un lato, in un contesto – come quello del giornale – in cui la parola conta solo per il significato che trasmette, l’inserimento del verso (che sottolinea invece la natura anche sonora della parola, e la storia del suo uso in contesti poetici, e quindi in cui l’aspetto formale è sempre stato importante) focalizzava l’attenzione sulla parola stessa, sulla sua retorica intrinseca – anche a costo di diminuire l’efficacia del discorso trasmesso. Dall’altro, la parola poetica, inserita in questo modo in un contesto assolutamente prosastico, perdeva di colpo gran parte della sua sacralità. Il primo obiettivo era ovviamente quello più evidente e di maggiore impatto (non foss’altro perché i lettori di quotidiani e le persone interessate agli interventi politici sono molte di più di coloro che hanno a cuore le sorti della poesia). Ma è il secondo quello che ci interessa qui, perché è sul senso di sacralità del discorso poetico che si fonda una delle principali differenze tra poesia e fumetto. In altre parole, benché i lettori di poesia siano in Italia un’infima minoranza, il prestigio culturale di cui la poesia gode resta altissimo, almeno virtualmente – ma resta comunque molto più alto di quanto sarebbe giustificato (in una pura logica di mercato) dall’esiguo numero di lettori. Questo prestigio e questa sacralità fanno sì che chi fa e chi legge poesia si trovino a operare con i piedi di piombo sia nel fare che nel giudicare – e che, di conseguenza, sia difficile innovare davvero, al punto che ogni presunta innovazione debba essere accompagnata da fiumi di giustificazioni critiche. Il mondo del fumetto non possiede né la stessa sacralità né un prestigio paragonabile, ma proprio per questo finisce per essere molto più vivace e in trasformazione di quello della poesia. Ci sono meno regole storicamente sedimentate, e la posta in gioco si presenta come più bassa: l’autore (e il lettore con lui) rischia meno, o almeno vive la sensazione di rischiare meno. Quando dico regole storicamente sedimentate non faccio riferimento alla metrica o al modo di usare il linguaggio; penso piuttosto a regole nel gioco di ruolo della società, in cui la poesia occupa un posto sancito dalla tradizione, con il quale ci si deve confrontare comunque (sia che lo si voglia confermare, sia che – alla Pasolini – si stia cercando di modificarlo). Per mettere altra carne al fuoco, e capire meglio il contesto in cui si può parlare di poetry comics, non bisogna poi trascurare un’altra differenza importante, che riguarda i materiali da costruzione. La poesia fa uso di parole, cioè di un materiale che noi tutti siamo bravissimi ad utilizzare, almeno nella comunicazione quotidiana. Il fumetto fa uso di immagini disegnate, cioè un materiale per produrre il quale è necessaria una capacità che si acquisisce solo dopo un lungo training, anche ai livelli più di base. Da un lato, quindi, il linguaggio di un testo poetico, oltre a confrontarsi con il linguaggio di tutti gli altri testi poetici, si confronta pure con l’uso quotidiano, strumentale o affettivo, della lingua. Dall’altro, il linguaggio (visivo-verbale, ma soprattutto visivo) di un testo a fumetti si confronta solo con il linguaggio visivo di altri testi, soprattutto a fumetti, ma non solo: non, in ogni caso, con un qualche materiale comunicativo quotidiano (se non per la sua componente verbale, che qui è però inserita in un contesto grafico assai più importante). Questa non è una differenza né piccola né scarsamente rilevante. Una delle tensioni potenzialmente presenti nel testo poetico è quella prodotta dalla maggiore o minore distanza tra il suo uso della lingua e quello della prosa letteraria e quello della quotidianità. Quando si parla di fumetto, invece, si parla di un contenitore generale che contiene sia testi più prosastici che testi più poetici (nel senso che si era descritto nel post precedente), senza nessuna distinzione esplicita tra loro, e senza nessun possibile riferimento a una qualche quotidianità: non vi è possibile perciò il tipo di tensione di cui stiamo parlando per la poesia. Il fumetto ha altre tensioni, che a sua volta la poesia non può possedere, che derivano, per esempio, dal rapporto tra parola e immagine. Non è un problema di potenzialità espressive maggiori o minori. Non si sta facendo una gara. Si stanno solo sottolineando differenze. È anche per questo che la strada della comics poetry è difficile, per nulla scontata. Ma il fascino delle commistioni sta anche nella componente di sfida che portano con sé. ————————————— A margine, la mia rilettura del Pasolini di Toffolo durante il viaggio ha avuto un’altra conseguenza. Mi ha riportato così presente alla mente la figura del poeta e cineasta e polemista e tutto quel che è stato, che quando, a Mestre, ho guardato le informazioni sul mio treno per Pordenone e ho scoperto che la fermata dopo la mia sarebbe stata Casarsa, ho avuto un fremito. Casarsa, fino a quel momento, era stato per me soltanto un nome, quello mitico del luogo friulano di Pasolini, della sua esperienza come maestro e delle sue prime poesie. Insomma, un luogo letterario, un luogo simbolico. Non che dubitassi della sua esistenza, certo; però, trovarmelo spiattellato lì, prosaicissimamente, sull’orario ferroviario, insieme con l’informazione implicita che avrei potuto allungare appena un poco il mio viaggio e ritrovarmi là, come fa lo stesso Toffolo personaggio di se stesso che va a cercare le tracce del poeta… insomma, vedermi quel nome calato di colpo nel mondo normale è stato davvero per un attimo qualcosa di inquietante – quasi come incontrare oggi il signor Pasolini di persona, nonostante sia morto nel 1975, quando appena l’avevo visto a un convegno, a Bologna, tanto tempo fa.
Venerdì scorso, a Pordenonelegge, ho discusso con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo di “La poesia a fumetti”. Ecco, più o meno, (almeno in parte) quello che sono andato a dire. Credo che per discutere su questo tema si debba fare chiarezza su alcuni aspetti, relativi da un lato alla letteratura verbale e dall’altro alla letteratura a fumetti. Una prima osservazione, preliminare (ma su cui tornerò alla fine), riguarda il fatto che siamo abituati a considerare il campo della poesia come un sottocampo della letteratura verbale; un sottocampo che si contrappone a quello della prosa, di modo che assumiamo di solito che il campo della letteratura verbale sia diviso in poesia e prosa. La letteratura verbale può essere divisa anche in altri modi, e alcuni tra questi hanno un corrispondente anche per i fumetti (per esempio le divisioni per generi, o per formati di pubblicazione); ma nel fumetto non esiste una distinzione analoga a quella tra poesia e prosa. Forse per questo parlare di poesia a fumetti può suonare strano. Ma cosa distingue la poesia dalla prosa? Una risposta facile, che va nella direzione giusta pur essendo imprecisa, è che la poesia è caratterizzata dalla presenza del verso. La risposta è imprecisa perché esiste anche la cosiddetta poesia in prosa, che resta poesia facendo a meno del verso, e la poesia concreta, che è una forma puramente visiva di poesia… Tuttavia la risposta va nella direzione giusta perché l’insistenza sul verso mette in luce una caratteristica che la poesia ha sempre, che molto spesso si esprime attraverso il verso e il suo uso, ma che si esprime anche in altri modi, persino quando il verso non c’è. Quello che distingue la poesia dalla prosa è insomma una differente attenzione verso il cosiddetto aspetto formale, cioè verso il modo in cui il testo (orale, scritto, visivo che sia) si presenta, indipendentemente dal significato delle parole che usa, o anche solo indipendentemente dal discorso o dal racconto che le parole sembrano trasmettere. Nella prosa, in altre parole, la parola è trasparente, nel senso in cui gli informatici usano questo termine: nel leggere prosa, cioè, ci focalizziamo sul significato delle parole, su ciò a cui rimandano, sul discorso che esse costruiscono, e non percepiamo se non funzionalmente la forma stessa della parola (la sua forma visiva o sonora). Questo è così vero che, nel riportare la prosa, tolleriamo più facilmente le parafrasi o le sostituzioni con sinonimi. Certo, non è vero del tutto; e la parola non è mai del tutto trasparente: però possiamo considerare la prosa come quell’ambito letterario in cui la parola tendenzialmente lo è. In poesia, la parola è al contrario molto opaca. Continua certo a rimandare al suo significato, ma chiede al lettore di essere percepita anche di per sé, e per le relazioni visive e/o sonore che ha con le parole circostanti. Ho usato anch’io, prima, la parola formalismo, ma è una parola fuorviante, a cui bisogna fare molta attenzione: non c’è qui in gioco, infatti, una forma che si vorrebbe contrapporre a una sostanza; ci sono piuttosto due forme semiotiche (o se preferite due sostanze) dal funzionamento differente. Da un lato c’è la forma linguistica, in cui dei simboli (le parole) rimandano convenzionalmente a dei significati secondo delle regole di correlazione altrettanto convenzionali (salvo che l’uso e il contesto agiscono comunque pesantemente anche qui); dall’altro c’è quella che potremmo chiamare la significazione naturale, quella stessa per cui le cose del mondo e la loro organizzazione non sono mute per noi, perché l’esperienza ce le ha riempite di significato. Quando io entro in una città che non conosco, per esempio, sono comunque in grado di dar senso a moltissime cose: riconosco case e strade, distinguo gli edifici pubblici da quelli privati, gli spazi per i pedoni da quelli per le auto, gli edifici storici da quelli nuovi, e così via. La città è uno spazio fin dall’inizio pieno di senso, e questo senso aumenta a mano a mano che la conosco meglio. La forma sonora e/o visiva di una poesia è come lo spazio di una città: è concreto ed esiste; non è stato costruito principalmente per comunicare qualcosa (anche se è fitto di segnali impliciti, oltre a quelli espliciti) ma per essere utilizzato, e quindi a questo scopo deve essere comprensibile, rimandando allo spazio di tante altre città preesistenti. La forma di una poesia è un luogo da vivere, che ha una vita significativa autonoma dai contenuti del discorso che la poesia trasmette. La poesia, rispetto alla prosa, è una forma di letteratura che mette molto più in evidenza questi aspetti di carattere ambientale, indipendenti dal discorso o racconto che le sue stesse parole trasmettono. Osserviamo adesso la tavola di Little Nemo riportata qui sopra. Non posso dire che questa attenzione alla forma della gabbia grafica si manifesti qui storicamente per la prima volta (o meglio per la seconda, la prima essendo stata la settimana precedente – visto che questa è la seconda tavola della serie), perché per dirlo con certezza dovrei conoscere tutto quello che è stato pubblicato nei dieci anni precedenti di vita del fumetto. Ma questa è certamente la prima volta importante, la prima volta che ha lasciato il segno nella storia del fumetto. Quello che è interessante, in questa tavola, è che la costruzione grafica non si risolve in una tecnica per raccontare meglio la storiella del sogno di Nemo (che le immagini permettono di ricostruire con una certa facilità, non meno di quanto facciano le parole della prosa verbale). Certo questo comunque lo fa: la divisione della prima striscia in tre zone fa percepire con più forza lo scorrere del tempo tra l’ordine del re e la risposta del maggiordomo; la ripetizione dell’inquadratura nella seconda striscia enfatizza la discesa del letto e prepara la discesa per le scale delle vignette successive; nel seguito della pagina, l’abbassarsi della base delle vignette corrisponde alla discesa di Nemo nella foresta dei funghi, mentre il conseguente successivo abbassarsi del tetto delle immagini contribuisce all’effetto di schiacciamento. La costruzione grafica aiuta davvero – e come! – l’efficacia del racconto. Tuttavia c’è dell’altro: la struttura verticale in basso e orizzontale in alto ricorda delle forme architettoniche (colonne e architrave) continuamente riecheggiate anche nelle immagini; la scala delle vignette rimanda – invertita – alla scala del palazzo del re; la struttura con orizzontali e verticali rimanda a quella delle prime pagine dei quotidiani (testata e colonne di testo). Ci sono una grande quantità di echi visivi che esistono indipendentemente dalla storia che viene raccontata, e che mi fanno immediatamente rendere conto che Little Nemo è diverso da qualsiasi fumetto che si sia realizzato prima. Prima di allora (e naturalmente anche nella maggior parte dei fumetti successivi) l’organizzazione visiva, planare, è in larghissima misura funzionale a esprimere meglio il racconto, proprio come le parole nella prosa. In Little Nemo, viceversa, e in un certo insieme di opere a fumetti successive, l’organizzazione visiva gioca contemporaneamente su due campi, dei quali l’uno autonomo (“formale”) e l’altro funzionale alla storia: in questo senso, Little Nemo potrebbe essere definito “poesia”, in quanto contrapposto – per esempio – a Tintin, come esempio di ottima prosa. Nella letteratura verbale, l’opposizione poesia/prosa è antichissima, ha radici storiche profonde e una tradizione molto forte. Ma in quella a fumetti non ci sono state vere ragioni per creare un’opposizione analoga, e il campo è rimasto fluido. Che cosa vuol dire allora, fare poesia a fumetti? Forse non basta prendere un testo poetico e aggiungergli delle immagini. Forse non serve avere un testo poetico per aggiungergli delle immagini. Magari bisogna lavorare più da dentro, pensare a un ambiente visivo che abbia senso come tale; e che come tale sia già interessante, ancora prima di quello che andrà poi a comunicare. Pensare a una sorta di metrica visiva, ovvero un sistema di rimandi, una struttura plastica, che mentre è anche funzionale al racconto, possiede un senso autonomo, più relazionale che referenziale. (prosegue, spero) Caro Marco Giovenale In primo luogo, una precisazione doverosa su polemiche passate, rispetto al cambio di paradigma (per esempio, qui da me, e su Nazione Indiana). Se lo posizioni nei primi anni Sessanta, cioè agli inizi della Neoavanguardia italiana, non ho nulla da obiettare. D’altra parte, quello è il periodo in cui i cambi di paradigma di sprecano, nella cultura occidentale: solo per citarne alcuni a me cari, la musica colta ha attraversato Darmstadt da pochissimi anni, e quella di ascolto più diffuso sta incontrando la nascita del Rock e dei Beatles (una via senza ritorno); gli studenti si stanno politicizzando e di lì a poco ci sarà Berkeley e il maggio parigino; il fumetto inizia timidamente (specie in Francia e in Italia) a rivolgersi a un pubblico colto. Tutti questi cambiamenti rispecchiano evidentemente l’assunzione diffusa di una trasformazione sociale, e potrebbe essere benissimo – come dici tu – “la sovrapposizione di due onde sonore contrapposte nella storia – distruzione e ricostruzione (guerra e “boom”)”; ma evidentemente anche – e credo che me lo concederai facilmente – le peculiari caratteristiche di questa ricostruzione, con l’apertura radicale (e quasi improvvisa) di una società mediatizzata e di massa. In secondo luogo, ti ringrazio perché mi hai fornito l’occasione per rileggere il saggio di Eco che citi (“Del modo di formare come impegno sulla realtà”, uscito su Il Menabò nel 1962, poi in Opera aperta), che avevo letto troppi anni fa, e troppo presto; e perché mi hai costretto, per risponderti, ad andarmi a cercare il saggio di Lacan (Dei nomi del padre, che contiene anche il saggio del 1953 “Simbolico immaginario e reale”) che non conoscevo nello specifico, anche se giro da tempo attorno a quegli stessi temi lacaniani attraverso altri scritti. Ed ora veniamo al punto, anzi ai punti – sempre considerando che le tue non sono tesi scolpite nel marmo (mi pare di capire), bensì proposte; e come tali le discuto, pregando chi mi legge di considerare allo stesso modo quello che scrivo qui. Ecco, quindi, la premessa lacaniana del tuo intervento, che trovo, devo dire, un po’ pretestuosa. Capisco bene la posizione di Lacan, pur espressa con la sua solita indelicatezza, che lamenta il fatto che il paziente voglia, in qualche modo, sostituirsi all’analista, cercando di analizzare da sé le proprie esperienze. Tuttavia non capisco affatto come si possa in qualsiasi modo avvicinare la relazione (psico)analitica alla relazione autore-lettore, se non magari sul solo piano del narcisismo (dell’autore che vuole sostituirsi al lettore, così come del paziente che vuole sostituirsi all’analista). Tuttavia, la medesima accusa di narcisismo potrebbe essere rivolta anche all’autore che si esprima con strutture linguistiche e/o concettuali del tutto proprie, e pretenda (narcisisticamente) che il suo pubblico (che non è un terapeuta raffinato, non è pagato per farlo, e non è Lacan, con il suo acume e la sua cultura) lo segua, lo intenda, o perlomeno si sforzi di farlo. Narcisismo per narcisismo, non so quale sia peggio, visto che ambedue questi autori (il tuo e il mio narciso) ignorano evidentemente alcuni fatti di linguaggio piuttosto basilari. Poi, in quello che segue nel tuo intervento mi ritrovo abbastanza, a parte alcuni accostamenti che mi paiono davvero forzosi, come quello tra il suicidio di Vittorio Reta nel 1977 e l’uscita della Parola innamorata nel ’78, o (idem) quello tra il suicidio della Rosselli e l’uscita nel ’96 dell’antologia dei “cannibali”. Ma le prendo come provocazioni evocative, e magari un po’ nostalgiche. Piuttosto, è proprio là dove parli di Amelia Rosselli che la mia attenzione si è improvvisamente risvegliata, per esempio là dove dici “Rosselli era soggetto (oscuro) di scrittura (oscura), brutalmente sintetizzando: un je (quasi) senza moi.” Questo mi piace molto, mi ci ritrovo, lo pensavo anch’io, ma indubbiamente l’uso dell’antinomia lacaniana rende molto più chiara la cosa. Credo che valga la pena di andare maggiormente in profondità, non tanto su Rosselli (già lo faccio parecchio in un saggio sulla metrica della poesia italiana recente, in uscita tra poco su L’Ulisse) quanto in generale sulla questione della lirica e dell’io. L’ipotesi (ed è davvero un’ipotesi, perché sto scrivendo senza avere troppo chiaro a che conclusioni arriverò) è che la distinzione lacaniana tra je (il “soggetto inconscio”, soggetto del desiderio e delle pulsioni) e moi (la sovrastruttura costruita socialmente in cui riconosciamo noi stessi, inevitabile ma inevitabilmente fittizia – una finzione di cui non si può fare a meno per esistere, insomma) possa gettar luce su cosa si intende con espressioni quali “riduzione dell’io”, “dopo la lirica” ecc. Mi sembra abbastanza evidente che l‘io di cui si parla nei dibattiti attuali sulla poesia dovrebbe essere il moi, non certo il je, cioè la sovrastruttura apparentemente coerente con cui ci rivolgiamo al mondo: siccome questa sovrastruttura è costruita a partire da questo stesso mondo che ci circonda, un certo accordo tra moi e mondo circostante sarebbe dunque garantito. Una delle tesi del nuovo paradigma (dagli anni Sessanta a oggi) dovrebbe essere dunque che va smascherata la natura fittizia del moi, in quanto sodale a una natura fittizia e costruita del mondo circostante. Poiché (lacanamente, ma non solo) il linguaggio (nietzschianamente, ma non solo) è il principale garante di questa apparenza di coerenza, il linguaggio va decostruito, e tanto peggio se questo produce delle difficoltà di comunicazione: la facilità di comunicazione non è che un’altra delle illusioni che tengono insieme il moi e il mondo circostante! Si tratta (riferimenti lacaniani a parte) grosso modo di una delle tesi esposte da Eco nel 1962 nel saggio da te ricordato, e che ho citato sopra. Le cose, però, come sempre, non sono così semplici. Intanto il moi c’è, e non se ne può fare a meno, anche se è un’illusione. L’idea che se ne possa sollevare la coperta per vedere la realtà che si trova sotto è a sua volta una illusione; per bene che vada vi si troverà infatti un altro moi, magari più complesso e (forse) meno narcisistico, auspicabilmente meno tormentato (se si tratta del moi di un paziente che si rivolge a un terapeuta). Si tratta del paradosso dello “schema concettuale alternativo” portato in luce da Donald Davidson e sottolineato da Richard Rorty (in Conseguenze del pragmatismo, mi pare): lo “schema concettuale alternativo” è solo una possibilità virtuale, visto che non possiamo concepirlo che nei termini del nostro proprio sistema concettuale. Però, certo, il nostro sistema concettuale può cambiare: ma allora siamo noi stessi che cambiamo, e il nuovo sistema concettuale non è più alternativo; è semplicemente, adesso, il nostro, e ci siamo dentro, e magari leggiamo nei suoi termini quello dentro cui vivevamo prima – ma non possiamo tornare indietro, o, peggio, saltare un po’ di qua e un po’ di là per comparare i due punti di vista. Però, si dirà, la poesia non è filosofia, e non deve spiegare, ma solo esprimere, o meglio, direi io, far vivere al suo lettore una certa condizione. Allora vogliamo dire che se la poesia non fa vivere al suo lettore una certa condizione di problematicità del moi, si tratta di poesia inautentica, falsa? Mi sembra una conclusione eccessiva, che presume che la poesia debba avere sempre a che fare con i massimi sistemi (di questo ho parlato ampiamente in un post della scorsa settimana), e che sia comunque vincolata a dire sempre il vero al livello più profondo possibile, assumendo che il livello più profondo possibile sia quello del rapporto tra je e moi. Potrei aggiungere che quando mi trovo di fronte a una poesia riuscita, fosse anche il prototipo petrarchesco della lirica, un certo superamento del moi è comunque presente, se solo si va oltre, nell’interpretazione, al significato letterale delle parole; perché è la forma stessa della composizione a richiamare qualcosa che non riguarda strettamente l’io. Poi, certo, il tipo di strutture di riferimento che un sonetto di Petrarca richiama è abbastanza diverso da quello delle nostre – anche se non del tutto. Una certa parte di verità gli rimane anche per noi; altrimenti non avremmo alcun modo di apprezzarlo. Ma restiamo sul punto, e assumiamo che, se pure la tematizzazione della finzionalità del moi non sia indispensabile, certo per la poesia del nuovo paradigma essa è importante, e va tenuta in posizione centrale. Anche a queste condizioni, resta comunque la questione del quasi, nel senso in cui la poesia di Rosselli è un je (quasi) senza moi. Dal quasi, evidentemente, non si scappa, per le ragioni dette sopra. Di conseguenza, qualsiasi destrutturazione è, implicitamente, una nuova strutturazione. Io credo (sottolineo io; non so cosa ne pensasse Lacan in proposito) che nella cultura occidentale il moi individuale si sia molto rafforzato negli ultimi due secoli, contestualmente al trionfo della ragione positiva (e poco importa che Kant avesse già dimostrato nella sua prima Critica l’insostenibilità razionale dell’idea di Io – insieme a quelle di Mondo e di Dio), e all’indebolimento delle strutture sociali tradizionali, molto più collettive e comunitarie di quelle moderne. La messa in crisi del moi in poesia diventerebbe perciò un tema caldo solo nella modernità, nel momento in cui questa sovrastruttura diventa sovrabbondante – e al tempo stesso vanno in crisi tutte le Weltanschauung globalizzanti, a partire dalla ragione logica stessa (Gödel docet). Ma credo anche che la prima conseguenza storica (nel nostro campo) di questo predominio del moi sia stato il predominio della lirica in poesia, a danno degli altri generi tradizionali. Sino al punto che qualsiasi epica pensabile oggi è comunque epica di individui, un’epica lirica, come ne “La ragazza Carla”. Paradossalmente, persino la centralità del tema della riduzione dell’io in poesia è espressione della centralità dell’io, del moi. Lo potremmo pensare come un tentativo, consapevole della propria impossibilità, di guardare sotto la superficie del moi, da apprezzare come tentativo eroico, e non per quello che (non) troverà. Una sorta di convivenza della letteratura con la modalità del labirinto, facendosi magari labirinto a sua volta (tanto per chiudere il cerchio con l’altro critico che tu stesso citi, cioè Calvino). Comunque sia, Amelia Rosselli riesce in qualche modo a costruire l’impressione di una destrutturazione del moi. L’impressione conta: magari, lavorandoci sopra, troverò la coerenza nascosta nel suo sistema. Ma intanto l’impressione di scarsa strutturazione del moi c’è già stata, e ha già agito su di me, il suo lettore. Amelia Rosselli, tuttavia, non scrive in maniera incomprensibile. Elimina o trasforma dei nessi, ma ne conserva altri. Scrive, insomma, in maniera da risvegliare continuamente la mia curiosità, e mi spinge ad andare avanti, e ad accorgermi, in qualche modo vivendola, della sua difformità. Molti testi di scrittura di ricerca non sono capaci di fare questo: mi si pongono davanti, semmai, come rebus, e si aspettano che sia io a essere interessato a loro, senza fare nulla per venire verso di me. Sappiamo bene come quello dell’interpretazione sia un campo strano: la Qabbala stessa ci insegna come da qualsiasi sequenza di lettere e/o numeri si possano ricavare un’eternità di significati differenti. Se quello che mi piace è avere un testo che non mi sveli dove sta andando, affinché sia io (lettore) a trovarlo, basta seguire l’indicazione data a suo tempo da Tristan Tzara, costruendo una poesia con le parole estratte a caso da un sacchetto. Ne ricaveremo certamente un testo che sembra esprimere un je (quasi) senza un moi. Quello che io trovo interessante nella poesia di Rosselli, viceversa, non è che sia stata capace di destrutturare (in parte, in apparenza…) il moi, ma che sia stata capace di farlo continuando ugualmente a richiamare il mio interesse di lettore. Per farlo, evidentemente, Rosselli deve giocare su delle strutture semiotiche (cioè linguistiche, ma non solo) condivise, e deve darmi continuamente la sensazione di stare comunicando qualcosa di rilevante. Insomma, deve presentarsi inevitabilmente come un moi che comunica a un altro moi. Certo, se si fermasse lì, probabilmente il nostro interesse non andrebbe molto più in là; ma se di lì non passasse, non vi sarebbe nemmeno motivo di interesse – come di solito non ce n’è per i prodotti del caso, se non, talvolta, come curiosità. Detto questo, la destrutturazione del moi (o almeno la sua impressione) è più una questione di gradi che non di presenza/assenza assolute. E siccome l’interpretazione ha numerosi (tendenzialmente infiniti) livelli, non è difficile accorgersi che a uno di questi livelli persino il crepuscolare pascoliano Pasolini arriva a destrutturare il suo moi nel mito della collettività dei sottoproletari o dell’icona collettiva di Gramsci, benché si esprima con forme canoniche nel linguaggio e nel racconto. Ed è magari anche per questo che comunque noi apprezziamo la sua poesia. E, magari, ciò che è assertivo a un livello si rivela non assertivo a un altro; oppure addirittura viceversa. Mai fidarsi delle apparenze, nel campo della parola. Forse il cambio di paradigma, da questo punto di vista, non ha fatto che spostare più in superficie il livello della destrutturazione dell’io richiesta. Certo non ha cambiato la centralità del moi, anche se magari l’ha ribaltata (apparentemente) in negativo. O forse è proprio l’espressione paradigma a essere fuorviante. Kuhn la impone all’uso parlando delle rivoluzioni scientifiche; e il paradigma è un po’ il criterio soggiacente ai dibattiti scientifici di una certa epoca, quella cosa che, quando cambia, impone una riconsiderazione globale delle verità assodate sino a ora. Forzando un poco (non molto), può aver senso usare la parola paradigma per la critica, anche se lo statuto delle verità critiche è diverso da quello delle verità scientifiche – ma si tratta comunque di un campo caratterizzato da un pubblico dibattito tra i soggetti che ne fanno parte attivamente. Però la poesia, in sé, non è un campo di discussione; le opere d’arte non sono tesi, o asserzioni vere o false. Magari lo diventano attraverso l’occhio della critica; ma questo riguarda la critica, non la poesia. Pensare che ci possa essere un paradigma (e quindi dei cambi di paradigma) in poesia, a me sembra legato all’idea che ci possa essere uno schema di fondo che regoli tutta la poesia di un’epoca; e la poesia che non si adegua si trova fuori dal dibattito. Ma il campo della poesia non è fatto così: solo se lo confondiamo con quello della critica che se ne occupa possiamo pensare che lo sia. È nel campo della critica che il dibattito avviene. Per concludere, due osservazioni su un paio di testi che mi arrivano contestualmente alle tue riflessioni. Uno è quello di Jean-Marie Gleize che citi tu stesso nel post del 26 agosto sulla mimesi (non condivido le riflessioni che fai sulla mimesi, ma ne parliamo un’altra volta); l’altro è una coppia di poesie di Andrea Inglese apparse su poetarumsilva il 24 agosto, attaccate con curiosa violenza da qualche lettore. Il testo di Gleize non è privo di attrattiva, ma sembra uscire dalla prescrizioni di Marinetti (e forse Soffici – entrambi comunque quanto a virulenza del moi non scherzavano) nel Manifesto della letteratura futurista: alla fin fine, “La passeggiata” di Aldo Palazzeschi mi diverte molto di più. Viceversa, trovo molto intrigante l’apparente pochezza delle poesie di Inglese, persino l’apparente ostensione dell’io: c’è qualcosa, in loro, che continua a trattenere l’attenzione, e lo straniamento dell’io ne esce progressivamente e nettamente. Certo, ne emerge, inevitabilmente, anche un’altro moi, più ricco e più critico, che osserva “dall’alto”; però, appunto, della finzione del moi non è possibile fare a meno. A presto, e à suivre.
Una buona descrizione di che cosa sia l’asemic writing si trova su Wikipedia. È una voce che non nasconde il fatto di essere stata scritta da appassionati di questa pratica, ma è comunque precisa, concisa, e cita pure un commento di Bruce Sterling che riassume le perplessità che è lecito sollevare sul tema. Queste perplessità non riguardano la pratica in sé o i suoi risultati. Come si può vedere sfogliando le pagine riportate qui sopra, ci sono cose che si guardano volentieri e altre meno, ma nel complesso l’oggetto è interessante. La perplessità riguarda semmai la definizione di questa pratica, e il suo campo più generale di appartenza. Oppure, in termini leggermente diversi, se queste opere possano essere oggetto di un semplice guardare (tenendo presente che anche il più semplice guardare rivolto a un prodotto comunicativo umano ha comunque in sé delle componenti che derivano dalle pratiche del leggere) oppure se abbia senso parlare anche di un leggere, nei loro confronti. In altre parole, considerare l’asemic writing come una specie del genere arte astratta è qualcosa di abbastanza pacifico: un dipinto (o disegno) astratto ha comunque bisogno di alludere in qualche modo a forme del mondo (senza davvero raffigurarle – sennò sarebbe arte figurativa), e, da questo punto di vista, l’asemic writing è un’arte astratta che prende come riferimento le forme della scrittura (senza davvero raffigurarle – sennò sarebbe scrittura, perché una scrittura raffigurata è ugualmente scrittura). Il problema nasce quando si teorizza la possibilità di un continuum tra immagine e scrittura, come fa Tim Gaze nello schema qui di fianco, oppure si parla decisamente di asemic poetry, come fa spesso Marco Giovenale sul suo blog Slowforward e come rivendica chiaramente in un’intervista su 3:AM Magazine. Ora, io capisco benissimo che chi pratica una disciplina inconsueta, all’interno di un piccolo cerchio (benché di diffusione internazionale), cerchi di evitare come il diavolo l’acqua santa i vincoli e la retorica del mondo delle arti visive, dove tutto si trova schiacciato, in fin dei conti, sulla possibilità delle gallerie di vendere delle opere, e sul giudizio dei critici. Per questo si può tentare di dialogare non con l’arte visiva, benché essa sia evidentemente il primo riferimento concettuale di un’operazione visiva come questa, bensì con il mondo della poesia, più piccolo, più competente, in generale piuttosto estraneo alle operazioni commerciali, e dotato di alcuni precedenti illustri e già storicizzati – quindi citabili come appoggio. Sul valore della poesia concreta ho già espresso le mie perplessità. E tuttavia la poesia concreta rimane legata alla presenza della parola e della scrittura. Persino gli Zeroglifici di Adriano Spatola, pur essendo ormai composizioni primariamente visive, cioè da guardare, sono composti di frammenti di parole o di lettere riconoscibili. Quando si perde anche questo estremo legame con la scrittura, le mie perplessità diventano certezze. Potrei contestare il fatto che l’asemic writing sia ancora writing, cioè scrittura. Per quanto ampia si voglia prendere la definizione di scrittura (e vedi su questo i bei libri di Roy Harris) quello che cambia è il modo in cui essa può essere semica (modo alfabetico, ideografico, pittografico, logografico…), ma l’idea di una scrittura asemica assomiglia a quella di un quadrato rotondo, o degli angoli del cerchio. La parola inglese writing è tuttavia suscettibile di un’altra traduzione, ovvero scrivere; e se mettiamo l’accento sull’idea di uno scrivere asemico (piuttosto che di una scrittura asemica) la cosa riacquista senso: è, appunto, una pratica che è più simile, gestualmente, a quella dello scrivere che a quella del dipingere o disegnare, ma che non persegue alcuno scopo simbolico (nel senso del simbolo peirceano), proprio come il dipingere o disegnare, se non attraverso la mediazione della forma complessiva. Insomma, un’arte astratta che ha come metafora di riferimento quella della scrittura anziché quella del mondo. Ok sullo scrivere asemico, dunque. Ma se invece di asemic writing, io pretendo di parlare di asemic poetry, quest’ancora di salvataggio non funziona più. Forse se potessi trasformarlo in una sorta di asemic poetring, un far poesia asemico, potrei illudermi almeno che la mia pratica possa condurre a un’arte astratta che abbia come metafora di riferimento quella della poesia anziché quella del mondo. Ma questa non sarebbe ugualmente poesia – a prescindere dalla sua qualità visiva. C’è spesso qualcosa di millenaristico nei tentativi delle avanguardie di portare la poesia a estremi vicini all’asemantismo. Per arrivare a queste posizioni, bisogna ritenere che, nel nostro mondo, la funzione tradizionale della poesia si sia esaurita, e quindi il suo discorso in termini tradizionali sia ormai inutile o impraticabile; è così che diventano accettabili idee come quelle del transmentalismo di Velimir Chlebnikov o del lettrismo di Isidore Isou. L’idea della necessità di un grado zero della scrittura, poiché i gradi superiori sono tutti contaminati dal predominio dell’industria culturale e delle sue falsificazioni alienanti, sta dietro a tanta parte del lavoro della Neoavanguardia italiana, e in particolare agli Zeroglifici di Spatola. Ancora senza arrivare a questi estremi, in campo musicale c’è una famosa conferenza di Anton Webern, del 1932 (quella del 15 gennaio), in cui si sosteneva che la musica tonale aveva esaurito le sue possibilità storiche di espressione, e che quindi quella della Nuova Musica dodecafonica era ormai l’unica strada percorribile da parte di un’arte che volesse essere autentica (non sono le parole di Webern, ma mi pare che – anche attraverso Adorno – le si possa leggere così). Sappiamo come nel clima esistenzialista del dopoguerra queste parole di Webern siano state a fondamento del serialismo di Pierre Boulez e di tutta l’avanguardia uscita dalla scuola di Darmstadt. Eppure Webern si sbagliava. Si sbagliava persino sulla musica tonale, perché in quei medesimi anni, costretto dalle condizioni politiche del suo paese, un musicista come Dimitri Shostakovich riusciva ancora a comporre dei capolavori nell’ambito della tonalità tradizionale. Ma soprattutto si sbagliava quando pensava che alla tonalità potessero succedere solo la dodecafonia e le sue conseguenze, come se la storia fosse guidata da un destino ineluttabile di progresso, e in una sola direzione. Da Tedesco ed Europeo troppo orgoglioso della propria tradizione, Webern trascurava l’esistenza di altre tradizioni (nella conferenza del 20 febbraio 1933 ammette esplicitamente di non saperne quasi nulla), e quindi quella di potenzialità che con la tonalità non avevano mai avuto a che fare, ma che non per questo erano vicine alla dodecafonia. Questo millenarismo percorre anche l’idea di asemic poetry, ovvero l’idea che la poesia sia diventata così impossibile nel mondo alienato di oggi da giustificare l’abbandono del senso ordinario della scrittura, ormai contaminato dagli abusi della comunicazione di massa. Senza questo presupposto, quello che si presenta come asemic poetry è in verità semplice asemic writing, cioè un’arte visiva che tenta di stare fuori dalle grinfie del mondo dell’arte, e comunque un’arte da guardare e non da leggere – anche se la sua forma visiva è metaforica di quella del leggere; anche se propone al fruitore uno sguardo sequenziale e non zigzagante come quello dell’arte visiva. Però, appunto, lo propone, proprio come fa la pittura; e non lo può imporre, come fa invece la scrittura vera e propria. Quello che mi indispettisce è che, per salvare una pratica, che ha i suoi pregi, dal ricadere nel campo a cui semioticamente spetterebbe, si debba compromettere il senso di una parola, poesia, allargando surrettiziamente il suo campo sino a inglobare qualcosa che, semioticamente, non dovrebbe stare lì. Certo che le nozioni e il senso delle parole cambiano, nella storia; ma queste trasformazioni non sono mai indenni da problemi. Visto che qui (e in vari luoghi del Novecento) questa trasformazione viene proposta, la mia domanda è: ne vale davvero la pena? Sinché transmentalismo e lettrismo ci appaiono come curiosità, il danno non è grande; ma se si cerca di fare entrare davvero la asemicità in una pratica che è fatta di parole, come la poesia, con l’intero loro portato visivo, sonoro e anche simbolico, non stiamo in verità distruggendo la nozione? Capisco che per chi sostiene e difende la asemic poetry questo possa essere un prezzo accettabile, ma per me non lo è. Concludo con un’osservazione a margine sui precedenti storici dell’asemic writing. Vedo che nella pagina di Wikipedia si cita Zhang Xu, con i suoi illeggibili corsivi selvaggi, in qualità di anticipatore dell’asemic writing. Chi frequenta questo blog (o ha seguito le mie lezioni) conosce la mia passione per Zhang Xu. Ora, io credo che quello della voce di Wikipedia sia un errore. A quanto ne so, Zhang Xu eseguiva i suoi esperimenti di corsivo selvaggio prendendo come oggetto dei testi poetici noti al suo pubblico. La sua scrittura risulta illeggibile solo se non si sa già quello che c’è scritto – e in questo senso certo non è adatta a trasmettere la parola. Ma il lettore (cinese) che conosca già il testo, è in grado di riconoscere i caratteri pur nella deformazione espressiva a cui sono sottoposti. Immaginate un esperimento di calligrafia espressiva estrema sull’Infinito di Leopardi: se già conosco il testo, riconoscerò anche lettere estremamente deformate. Per questo quella di Zhang Xu non è in nessun modo asemic writing; semmai, come tutta la calligrafia espressiva, è ipersemic writing, cioè l’arte di aggiungere al senso delle parole quello del loro aspetto grafico. Non è nemmeno quella che viene definita “relative” asemic writing, ovvero una scrittura che può essere letta da qualcuno ma non da tutti – strana definizione, che prende dentro tutte le scritture del mondo. Ogni scrittura che sia davvero tale è infatti leggibile da qualcuno ma non da tutti; cioè da chi ne possiede il codice, e non dagli altri. Per possedere il codice dello scrivere di Zhang Xu, oltre a conoscere il cinese, bisogna già sapere quello che c’è scritto; ma questo era dato per scontato (a volte, per fugare ogni dubbio, sul retro del foglio la poesia era persino trascritta in caratteri leggibili). . Non posso negare un poco di emozione. Ieri sera, nel tornare a casa ho trovato un pacco con le copie di spettanza del mio nuovo libro. Ho controllato nelle librerie on line, ed è già in vendita. Non sono riuscito ad andare a vedere in quelle tradizionali, ma se ancora non c’è è questione di giorni. Per dare un’idea di che cosa si tratta, ecco qui di seguito l’Indice del volume e l’Introduzione. Se cliccate qui o sulla copertina a sinistra, potete vedere la scheda del libro sul sito Bompiani. .
Introduzione0.1. LinguaggioArgomento di questo libro è il linguaggio della poesia. La parola linguaggio, certo, può essere intesa in sensi abbastanza differenti: quando si parla, per esempio, del linguaggio di Alessandro Manzoni si può fare riferimento alle sue preferenze lessicali e di costruzione sintattica; ma quando si parla del linguaggio dell’arte visiva, o del linguaggio della musica, stiamo evidentemente parlando d’altro. Si parla persino del linguaggio delle api, o del linguaggio del DNA – e non abbiamo la sensazione che si tratti di estensioni metaforiche dell’uso di questo termine. È bene puntualizzare da subito che l’oggetto di questo libro non è il linguaggio della poesia nel senso delle sue scelte lessicali e di costruzione sintattica. Anche di questi aspetti, senza dubbio, si parla in queste pagine – ma è piuttosto l’altra accezione di linguaggio quella che ci riguarda, quella che avvicina il problema del linguaggio della poesia a quello del linguaggio dell’arte visiva, o della musica, o persino delle api. Per dirla con le parole più semplici possibili, l’oggetto di questo libro è il modo in cui la poesia comunica, o agisce su chi la legge. Questo modo è legato anche al problema delle scelte lessicali e sintattiche, ma è ben lontano dal ridursi a questo, così come il problema del linguaggio delle arti visive non si può ridurre al problema della scelta dei colori e delle forme, né il problema del linguaggio musicale può ridursi al problema della scelta delle note. Si potrebbe discutere a lungo se il linguaggio delle api contempli davvero l’uso di un codice. Da fuori, si direbbe che possa essere così. Ma, anche ammettendo che un codice vi sia, nessun linguaggio naturale, compreso quello delle api, si limita e può essere ridotto alla sua componente codificata. Quando pensiamo al linguaggio della musica lo vediamo con chiarezza: la musica comunica, non ci sono dubbi, ma la sua componente codificata è talmente ridotta che la maggior parte della comunicazione ne passa al di fuori. Ferdinand de Saussure (1922) ha parlato, a suo tempo, di fenomeni di langue – cioè legati alla componente codificata, più strettamente linguistica, del discorso verbale – e di fenomeni di parole – cioè dipendenti dalla situazione contingente, dalla particolare combinazione specifica di parole. Il significato delle nostre comunicazioni verbali è costituito sia da elementi di langue che da elementi di parole, e dunque il nostro linguaggio verbale è basato sugli uni non meno che sugli altri. Il linguaggio della poesia enfatizza questa componente, locale e idiosincratica, di parole. Fa uso della langue, evidentemente, in quanto fa uso delle parole della lingua, e quindi del loro significato codificato; ma si allontana da questa base molto, molto di più di quanto non faccia il linguaggio ordinario, e anche più di quanto non faccia la prosa letteraria. Il nostro intento, in queste pagine, è vedere da vicino alcuni degli aspetti di questo linguaggio della poesia, che prende il via dall’uso consueto della parola e arriva lontano.[1] 0.2. Comprensione, emozione e ritmoQuesto libro si occupa dunque del leggere la poesia, non solo del comprenderne il senso. Quando leggiamo cerchiamo sempre di comprendere, ma non leggiamo testi solo per comprenderli – cosa che è vera, in diversa misura, per tutti i tipi di testo, ma è particolarmente vera per i testi che hanno finalità estetiche: tra questi la poesia possiede un ulteriore statuto particolare. Per esempio, non leggiamo un romanzo solo per capirne il significato. Se non ne comprendiamo almeno a qualche livello il significato non lo stiamo in realtà nemmeno leggendo; e, certo, più a fondo lo comprendiamo e più intensa potrà essere la nostra esperienza di lettore. Ma se un romanzo non ci coinvolgesse emotivamente e non ci portasse con sé in un viaggio di sensazioni vivide e profonde, che ragione avremmo di leggerlo? Quanto ci importa dell’ideologia dei nichilisti russi di fine Ottocento? Il nostro scarso interesse per questo specifico tema non ci impedisce di leggere appassionatamente I demoni di Fedor Dostoevskij. E che a un gentiluomo francese vissuto circa un secolo fa sia un giorno capitato di mangiare un biscottino che ha scatenato la sua memoria e la sua ossessione grafomaniacale, è qualcosa di davvero interessante per noi? Non è davvero per sapere che cosa sia accaduto al signor Proust che leggiamo la Recherche. Dostoevskij, come Proust e come ogni altro scrittore di qualità, non ha mai pensato di produrre un semplice resoconto di fatti di relativo interesse. Ciò che ha fatto, piuttosto, è stato costruire un meccanismo emotivo, basato su questi fatti, in cui il lettore si possa immergere, e possa vivere, anche se in forma surrettizia, un percorso emotivo, con risvolti cognitivi (si impara senza dubbio un sacco di cose anche leggendo romanzi) ed etici. Della poesia si può dire lo stesso, però in misura ancora maggiore. Se un qualche interesse a priori per la storia russa o per la vita quotidiana francese di inizio Novecento possono talvolta costituire una ragione per leggere i romanzi di Dostoevskij e di Proust, non riesco proprio a immaginare perché mi dovrei interessare alle fantasie di un signorotto marchigiano di inizio Ottocento al guardare la siepe del suo giardino. E nemmeno trovo particolarmente interessante, in sé, il pessimismo leopardiano, che non è una filosofia di particolare originalità storica, e che nessuno si sarebbe preoccupato di studiare se non stesse alla base di alcune tra le poesie più straordinarie che siano mai state scritte. Ancora più che il romanzo, la poesia costruisce dentro di sé le proprie ragioni di interesse per il suo lettore. Essendo più breve, mira a costruire un’esperienza emotiva più intensa, e per farlo utilizza le risorse del linguaggio in maniera estrema, rendendo pertinenti aspetti che normalmente non lo sono o lo sono poco. Proprio come il romanzo, poi, ma con maggiore intensità, anche la poesia ci insegna qualcosa, ma lo fa a partire dall’esperienza emotiva che induce nel suo lettore. Questa collina solitaria mi è sempre stata cara, come pure quella siepe, che mi impedisce di vedere oltre. Eppure, se mi siedo e guardo, io mi immagino spazi senza fine al di là, silenzi eccezionali e una grande tranquillità, al punto che quasi mi spavento. E quando sento il vento muovere gli alberi, mi viene da fare il paragone tra questo fruscio e quel silenzio: e così penso all’eternità, al passato, al presente e ai suoi rumori. E in questo senso di immensità il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo. Questo breve racconto segue evidentemente la falsariga del discorso di Leopardi ne L’infinito. Potremmo considerarlo come una parafrasi molto libera del testo originale. Probabilmente non tutto il fascino del componimento leopardiano si perde, e qualche ragione di interesse interno continua a sussistere – ma questo testo non sarebbe mai passato alla storia emozionando innumerevoli lettori. Senza l’emozione non si genera l’interesse, e senza interesse non ci può essere acquisizione cognitiva. I meccanismi di sollecitazione emotiva ci interessano dunque per due ragioni: in primo luogo perché sono alla base di una migliore comprensione del significato del testo, e in secondo luogo perché non sempre possono essere ridotti a questo, e possiedono una propria autonomia e un proprio valore intrinseco. C’è una situazione in cui il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo. Infatti, quando mi siedo di fronte a questa collina solitaria, a me molto cara, e guardo quella siepe che mi impedisce di vedere oltre, finisco per immaginarmi al di là di quella un’enormità di spazio e di silenzio, quasi spaventandomi per questo. Ma poi, se paragono queste sensazioni al suono del vento tra gli alberi, mi viene da pensare all’eternità e alle epoche, e provo un senso di immensità che mi fa smarrire. Confrontiamo ora questo breve testo con la parafrasi dell’Infinito proposta appena sopra. Qui non si può più nemmeno parlare di parafrasi, per quanto libera; al più parleremo di “liberamente tratto da”. Entrambe le versioni condividono con l’originale il mero resoconto dei fatti, ma la prima è abbastanza fedele all’originale anche per l’ordine in cui i fatti vengono esposti, e per il risalto che viene dato a ciascuno di loro, mentre la seconda stravolge sia l’ordine che il risalto. Per quanto poco conservi dell’esperienza dell’originale, la prima versione conserva di più della seconda, ed è in grado di produrre nel lettore un percorso emotivo che, per quanto molto più blando, assomiglia a quello dell’originale più di quanto gli possa assomigliare quello prodotto dalla seconda versione. La prima versione ha infatti (parzialmente) in comune con l’originale non solo un percorso discorsivo-narrativo ma anche un ritmo discorsivo-narrativo e un sistema di tensioni. Gli eventi raccontati si succedono grosso modo con lo stesso andamento e con lo stesso specifico rilievo, e producono quindi nel lettore un andamento di interesse simile. In poesia, tradizionalmente, quando si parla di ritmo si fa riferimento a una regolarità di andamento di carattere prosodico e fonetico (ovvero relativo al succedersi delle sillabe e dei loro accenti, nonché di suoni sufficientemente simili) o al massimo sintattico. Quando si parla di ritmo poetico, cioè, si fa tradizionalmente riferimento a eventi situati sul piano del significante (che la semiotica chiama, più propriamente, piano dell’espressione). Il ritmo discorsivo-narrativo si pone invece sul piano del significato (che la semiotica chiama piano del contenuto) e non è un fatto specifico della poesia: qualsiasi discorso verbale possiede un ritmo dell’esposizione dei propri concetti, qualsiasi racconto ha un ritmo narrativo, cioè un andamento del modo in cui gli eventi arrivano alla ricezione del fruitore.[2] Anche i ritmi prosodici, fonetici e sintattici non sono specifici della poesia; tuttavia, mentre nel discorso in prosa sono di solito semplicemente non pertinenti o poco pertinenti, in poesia la relazione di contrasto con la dimensione metrica (che è a sua volta una dimensione ritmica) li rende significativi e influenti. Il ritmo discorsivo-narrativo è influente in qualsiasi tipo di testo, ma in poesia esiste una relazione di contrasto con altri tipi di ritmo dell’espressione e del contenuto – come vedremo più avanti – che modifica e spesso magnifica questa stessa influenza. Analizzare la poesia e la sua efficacia emotiva significa dunque considerare non solo la dimensione ritmica tradizionale e la sua relazione con il metro, ed eventualmente le modalità in cui queste interagiscono con la dimensione del significato, ma anche tutta una sfera ritmica della dimensione del significato che produce effetti sia sul significato stesso che sul coinvolgimento emotivo diretto del lettore. A questo si aggiunge la comprensione del sistema di aspettative e tensioni messo in moto dalla poesia. Anche in questo caso, tutti i testi generano aspettative nel loro fruitore, ma la poesia lo fa con le sue specifiche modalità e i suoi specifici effetti. 0.3. Leggere, guardare, ascoltareIl leggere è naturalmente diverso dal guardare[3]. Certo per leggere è necessario guardare, ma qualsiasi guardare che non comporta un leggere è un guardare che segue regole diverse dal guardare per leggere. Nella sua bella storia dell’arte tipografica, Warren Chappell caratterizza come segue la differenza: Molti dei lavori più notevoli del Settecento, dalle Médailles dell’Imprimerie Royal del 1702 al Manuale tipografico di Bodoni, testimoniano di vere e proprie innovazioni tecniche: una migliore fusione e giustificazione dei caratteri, carta con superfici di stampa più omogenee, inchiostri migliori e migliore impressione. La stampa assunse l’aspetto dell’incisione a un livello stupefacente. La tendenza era iniziata con le grazie artificiali del romain du roi di Grandjean per raggiungere piena espressione nelle lettere drammatiche e rigide di Bodoni e di Firmin Didot. Tali forme sono meravigliosamente immobili. Il carattere e la pagina chiedono di essere ammirati – cioè guardati – e in ciò niente di male, se non fosse per il fatto che guardare e leggere sono due azioni piuttosto diverse, anzi in contraddizione. Siamo legati a quello che leggiamo da un movimento ritmico. Per guardare le cose, o le liberiamo lasciandole vagare, oppure le blocchiamo nel loro movimento. Guardando, tratteniamo il respiro oppure (nel peggiore dei casi) ansimiamo. Leggendo invece respiriamo. (Chappell-Bringhurst 2004:194) La differenza principale tra leggere e guardare è una differenza ritmica. Leggendo, respiriamo, ovvero seguiamo un percorso impostato in maniera più o meno diretta sui ritmi del respiro. Guardando, viceversa, seguiamo un percorso più o meno arbitrario a seconda del caso, ma in ogni caso del tutto indipendente da qualsiasi impostazione ritmica, in particolare da quella del respiro. Per dirla in un altro modo, la scrittura è sì qualcosa che si guarda, ma che non perde mai del tutto la relazione che intrattiene con la dimensione lineare e sonora della lingua parlata. E la lingua parlata è per sua stessa natura impostata sul respiro, è emissione di fiato, ritmata dalla necessità di inspirare l’aria necessaria per produrre i suoni delle parole. Come vedremo tra breve, questa ineludibile natura sonora della lingua agisce in qualche modo anche attraverso la scrittura, e riverbera sulla parola scritta le proprie qualità. La scrittura è però comunque un fatto grafico, ancor prima che sonoro. Di sicuro nella scrittura poetica la dimensione sonora procrastina la propria scomparsa molto più di quanto non faccia nella prosa – eppure sappiamo bene quanto i testi prodotti per essere letti con gli occhi siano differenti da quelli prodotti per essere ascoltati! E la poesia è fatta per essere letta o per essere ascoltata? In questo libro assumiamo che la poesia sia fatta prima di tutto per essere letta, ma che, di questa lettura, una sorta di “recitazione ad alta voce interiore” sia una parte così importante che anche l’ascolto vero e proprio può giocare il suo ruolo. Non a caso una gran parte delle pagine di questo libro è dedicata alla dimensione sonora evocata dal testo poetico. Di sicuro, la poesia è uno strano ibrido: gran parte dei testi poetici sono così complessi da pretendere di essere letti, piuttosto che ascoltati, per poter essere capiti; eppure per loro tradizione e natura sono così legati alla propria sostanza fonica da pretendere l’ascolto, almeno virtuale. Anche se dedicheremo molte pagine a questa sorta di ascolto che la poesia mette in scena, la natura scritta della poesia comporta inevitabilmente una certa rilevanza della sua dimensione visiva, ovvero di un qualche guardare che non si risolva in un leggere. La lunghezza media dei versi, la divisione in strofe, la posizione sulla pagina, sono elementi tradizionali del testo poetico che non hanno necessariamente un effetto diretto nella dimensione sonora. Quando Stéphane Mallarmé scrive il suo Coup de dés[4], distribuendo graficamente i suoi versi sullo spazio bianco della pagina, sta sviluppando una possibilità che esiste da quando la poesia è sostanzialmente una testualità scritta. Nessuna recitazione del poemetto di Mallarmé può esprimere compiutamente la differenza tra la sua impaginazione e quella tradizionale. Quindi, l’impaginazione ha un valore visivo proprio, indipendente dalla qualità sonora della poesia, un valore che dipende da un guardare che, pur se accompagnato da un leggere, non si risolve in quel leggere. All’esperimento di Mallarmé ne faranno seguito tanti, nel corso del Novecento, sino al costituirsi di una vera e propria poesia visiva, spesso molto più da guardare che non da leggere – anche se la componente della lettura non scompare mai del tutto. Questa dimensione puramente visiva, legata al guardare, secondaria ma non assente nella poesia tradizionale e talvolta primaria nella poesia più recente, richiede di essere esplorata. Anche la componente visiva, cioè, contribuisce al significato di un testo poetico e alla sua sollecitazione emotiva. La natura ambigua della parola scritta costituisce un campo di possibilità espressive che la poesia può sfruttare, anche quando gioca soprattutto sull’evocazione della dimensione orale. 0.4. Immersivo vs frontalePer capire la rilevanza specifica della dimensione orale, è necessario approfondire un poco le conseguenze delle differenze percettive che esistono tra visione e ascolto[5]. La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui. Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona. Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato. Attraverso lo scambio di suoni un animale non si limita a segnalare ai suoi simili la propria presenza, o a comunicare la presenza di un pericolo o la propria disponibilità sessuale. Nelle specie più evolute il suono può essere usato a scopo empatico. Le vibrazioni sonore della madre possono ricreare la sensazione di unione che il piccolo ha perso con la nascita, e calmare il suo pianto o la sua paura; con le grida si può trasmettere l’eccitazione o la stessa paura, e comunque rafforzare il senso di appartenenza a una comunità, con la quale, appunto, ci si trova in sintonia. Non c’è ragione di pensare che questa funzione empatica si perda quando nella specie umana il suono si evolve in linguaggio. Il comprendere il significato delle parole non inibisce il nostro vibrare al loro suono. Analogamente abbiamo ragione di pensare che la musica stessa nasca da un raffinamento delle potenzialità di questa dimensione compartecipativa su base immersiva. Come vedremo meglio poco più avanti (par. 1.1), la musica non nasce per essere ascoltata, bensì compartecipata e vissuta, con un atteggiamento che ha caratteri simili a quelli che accompagnano il rito. La danza e la cerimonia sono i contesti in cui per molti secoli la musica viene eseguita, a cui si potrebbe aggiungere la dimensione empatica diretta del canto su base poetica. In questi contesti non esiste un ascoltatore come lo pensiamo oggi, posto di fronte alla musica in un’attività solo ricettiva-interpretativa. Nella danza come nella cerimonia – situazioni tradizionalmente rituali – la musica è il fattore socialmente unificante, è cioè il ritmo, l’andamento nel quale la collettività si può riconoscere come collettività. In questa dimensione sostanzialmente immersiva, al suono, specie se prodotto dalla voce di qualcuno, non viene attribuita una funzione di informazione sul mondo come accade per l’immagine. Il suono è soprattutto latore di una funzione di consonanza, attraverso l’eventuale sintonia con chi lo produce o con gli altri che lo stanno percependo insieme a me: stiamo vibrando insieme, ondeggiando insieme, sentendo insieme. L’andamento della vibrazione può finire per corrispondere all’andamento di sensazioni ed emozioni. Queste sensazioni ed emozioni possono essere comuni, compartecipate, condivise da tutti i presenti. E se questo andamento sonoro ed emotivo si accompagna a un discorso, per esempio sviluppato attraverso quelle stesse parole che sono state espresse con i suoni, inevitabilmente questo discorso verrà interpretato all’interno della dimensione sonora, sensitiva ed emotiva, e al senso di compartecipazione creato dai suoni. Come vedremo in questo libro, la poesia ha una relazione complessa con la dimensione sonora, che necessita di un’analisi precisa. Tuttavia, pur con i limiti che vedremo, questa dimensione sonora è presente e determinante per la fruizione del testo poetico. In altre parole, la fruizione di un testo poetico non si esaurisce nella sua comprensione. Benché la comprensione sia necessaria, l’esperienza del lettore di poesia non è fatta solo del capire quello che il testo gli sta dicendo. La poesia non è solo un discorso complesso e fascinoso, che sfrutta dimensioni del senso che la parola normalmente ignora: è anche l’occasione per un’esperienza immersiva, compartecipativa, rituale, con caratteristiche orfiche. Capire le modalità di questa esperienza ci permette, in molti casi, anche di raggiungere un ulteriore livello di comprensione del testo poetico, e a sua volta questa comprensione può mettere in moto ulteriori risonanze orfiche, con un meccanismo che, nei casi più felici, davvero non si interrompe mai. Che continuiamo oggi a studiare Dante, Catullo, Saffo, a tanti secoli di distanza, è la dimostrazione che esistono testi poetici inesauribili, destinati a produrre nuove significazioni e nuove emozioni ogni volta che si confrontano con un’epoca nuova. 0.5. La questione della liricaÈ ormai un luogo comune osservare che, dei diversi generi in cui era tradizionalmente divisa la poesia, solo la lirica è rimasto in auge, e che, di fatto, il campo della lirica oggi corrisponda a quello della poesia. La lirica è la poesia di espressione soggettiva, quella al centro della quale c’è un io, un io lirico, ingenuamente identificato di solito con l’io del poeta. Ma non c’è bisogno di un io manifesto perché la poesia sia lirica. L’espressione può essere benissimo soggettiva anche se si sta utilizzando la terza persona. Il soggettivismo[6], cioè la tendenza a mettere il soggetto al centro del componimento poetico, si può esprimere anche, per esempio, attraverso la scelta di una forma metrico-ritmica particolare, al di fuori delle regole costituite. In questo senso, la nascita e lo sviluppo del verso libero a fine Ottocento è una conseguenza del dominio della lirica, perché il verso libero è quello attraverso cui il poeta esprime la propria soggettività anche nella forma metrica – che stia esplicitamente dicendo “io” oppure no. Se vediamo le cose in questi termini, praticamente tutta la poesia del Novecento può essere vista come lirica, compresi i tentativi di riduzione dell’io, cioè i tentativi di costruire una modalità poetica che non si presenti come espressione del soggetto[7]. Il luogo comune che riduce la poesia a espressione spontanea della soggettività individuale è a sua voglia un figlio ingenuo di questa prospettiva. Ne riparleremo nelle ultimissime pagine. Due cose vanno osservate a proposito del predominio della lirica. La prima è che esso corrisponde sì, certamente, a un imporsi del valore dell’individuo e del soggetto nella nostra società degli ultimi secoli[8]; ma all’interno di questo medesimo soggetto, la psicoanalisi e l’antropologia hanno situato delle aree che non gli appartengono affatto, e sono piuttosto sociali, condivise. Anche per questa acquisizione (o perdita intrinseca di soggettività, se preferiamo), la soggettività di oggi può pretendere di esprimere l’universale, visto che, in fin dei conti, essa ce l’ha, volente o nolente, dentro di sé. La seconda è che la dimensione lirica si deve comunque confrontare con quella immersiva, rituale, di cui stiamo parlando in questo libro; e quindi confluire in un senso di condivisione sovra-soggettivo. Se non facesse questo, non sarebbe nemmeno riconoscibile come poesia. 0.6. Questo libroQuesto libro cerca di descrivere l’esperienza della fruizione poetica. Per fare questo deve parlare sia della dimensione discorsiva del testo poetico – che dipende dalla sequenza delle parole (proprio come nella prosa) ma anche dalle interazioni tra questa sequenza e una serie di caratteristiche specifiche della poesia – sia della sua dimensione immersiva, partecipativa, orfica. Questa seconda dimensione si articola in sistemi di ritmi e di tensioni che si manifestano sul piano dell’espressione come anche sul piano del contenuto: ritmi e tensioni morfologiche e sintattiche, ma anche ritmi e tensioni semantiche e narrative. Inizieremo (cap. 1) parlando della fruizione musicale, cercando di definire che cosa caratterizzi l’esperienza sonora, quando è diretta a testi di carattere estetico. Questo ci sarà utile per capire subito dopo quale sia lo specifico sonoro della poesia; e su questo quadro di fondo esploreremo le caratteristiche del metro e del ritmo prosodico. Ma questa stessa comprensione ci sarà utile, nel capitolo successivo (cap. 2), anche per capire che cosa siano e come si manifestino i ritmi semantici e narrativi. Un capitolo (cap. 3) sarà dedicato alla costruzione del discorso in prosa, ricercando al suo interno una serie di aspetti (alcuni anche di carattere emotivo) di cui pure la poesia fa uso. Ritroveremo questi aspetti anche nel capitolo 4, dedicato alla costruzione del discorso poetico, ma sarà a questo punto centrale la loro interazione con gli aspetti specificamente poetici che sono stati descritti nei capitoli precedenti. Incominceremo ad avere, a questo punto, un quadro abbastanza dettagliato della situazione, e potremo permetterci di mettere in gioco (cap. 5) quegli elementi, puramente visivi, che non hanno nessuna relazione diretta con la dimensione sonora. La scrittura ha una sua specificità, come ce l’hanno una serie di aspetti visivi presenti da lungo tempo in poesia. Esiste però anche una poesia fortemente basata sulla dimensione visiva, cui è necessario dedicare uno spazio. Nell’ultimo capitolo (cap. 6) cercheremo quindi di descrivere la fruizione poetica nella sua complessità, tracciando alcune linee di un’estetica poetica, con un accenno finale alla dimensione dello scrivere. [1] Vedi il par.3.1, per un’espansione di questo discorso. [2] Sui ritmi del contenuto, vedi sotto Cap. 2. Più in generale, su ritmi e tensioni nei testi, narrativi e non, cfr. Barbieri(2004). [3] Al rapporto tra leggere e guardare nella comunicazione visiva (poesia visiva e poesia concreta incluse) ho dedicato il volume Barbieri (2011). [4] Vedi sotto, par.5.2.1. [5] Ho dedicato a questo tema diversi articoli (Barbieri 2008, 2009 e 2010), ma la problematica nasce in Ong (1967 e 1982). Per quanto riguarda la musica si trova affrontata anche in Piana (1991), in Capuano (2002) e in Sparti (2007). [6] O meglio, quello che Guido Mazzoni (2005) chiama piuttosto espressivismo. [7] Per lo sviluppo di questa tesi, vedi ancora Mazzoni (2005). L’espressione “riduzione dell’io” è invece di Alfredo Giuliani (1965), nell’Introduzione 1961 all’antologia de I Novissimi. [8] Su questo tema, oltre a Mazzoni (2005) vedi anche Ferry (1990). Non so se il tema che voglio affrontare qui sia davvero adatto per il post di un blog. Forse avrebbe piuttosto bisogno dello spazio e dello stile di lettura più concentrato di un saggio su una rivista scientifica. Ma ormai mi sono abituato a utilizzare questo blog per mettere giù le riflessioni che mi girano per la testa, e penso che i miei lettori si siano rassegnati a loro volta a questi post dai temi magari un po’ coriacei. In fin dei conti, per male che vada, il lettore ha sempre la possibilità di smettere di leggere e di guardare altrove: il Web è comunque strapieno di cose interessanti. Il tema è quello, profondamente semiotico ma non solo, della narratività. Una delle idee che stanno alla base della semiotica generativa di Greimas è che la struttura narrativa sia fondamentalmente alla base di qualsiasi discorso. Questo sarebbe dovuto al fatto che la struttura narrativa articola un percorso fondato sul quadrato semiotico, il quale a sua volta articola un’opposizione semantica; e le opposizioni semantiche sono alla base di qualsiasi discorso. Io ho qualche dubbio anche su questo, ma non è questo il punto in questione qui. Si può discutere sui dettagli, ma la posizione di Greimas individua nel suo complesso una questione reale, e una centralità del racconto che ne fa inevitabilmente un tema di indagine per chi voglia lavorare a fondo sui testi. Tuttavia, la posizione di Greimas ha un corollario che di solito non viene preso particolarmente in considerazione dai semiologi generativi, troppo intenti a rintracciare le strutture narrative nascoste, e poco interessati a capire come vi siano state nascoste. In altre parole, se il racconto è così pervasivo nei testi, è perché il racconto è evidentemente (come peraltro suggerisce Ricoeur) la forma con cui noi diamo senso al divenire temporale: il tempo, cioè, non è un semplice succedersi insensato di battiti dell’orologio; prende piuttosto senso per noi attraverso l’articolazione delle cause e degli effetti, che è già un’articolazione narrativa. Se volessimo essere kantiani, potremmo dire che la forma-racconto è un trascendentale, ovvero una struttura implicita nella nostra comprensione del mondo. Se invece che kantiani, volessimo essere evoluzionisti alla Bateson, potremmo dire che la forma-racconto è il modo migliore che la nostra evoluzione ha escogitato per metterci in rapporto memoriale con gli eventi del mondo, permettendoci di dar loro un senso – o di trascurarli o dimenticarli quando non entrano in nessuna successione narrativa. Qualunque sia il perché, il come non cambia, il racconto è il modello, lo schema che noi applichiamo alla nostra comprensione del mondo, ogni volta che viene messo in gioco il tempo, cioè un divenire. Ora, se portassimo questa assunzione alle estreme conseguenze, dovremmo dire che non ci sono racconti al di fuori di noi, ma solo sequenze di eventi che noi comprendiamo in modo narrativo. Se il mondo al di fuori di noi fosse fatto solo di natura, potrei anche sottoscrivere queste estreme conseguenze, e farla finita qui, neo-kantianamente. Ma il mondo al di fuori di noi è fatto anche di prodotti di altri esseri umani, i quali esprimono la propria comprensione del mondo; e siccome la loro comprensione del mondo è avvenuta in termini narrativi, allora anche la loro espressione potrebbe essere strutturata narrativamente. Cercare le strutture narrative di un testo significa allora cercare le tracce di questa narrativizzazione. E se mettiamo le cose in questi termini, sembra che i semiologi generativi facciano la cosa giusta quando cercano la forma-racconto alla base di qualsiasi manifestazione testuale, dal romanzo alla pittura alla musica. Il mio sospetto che sia il lettore colui che “nasconde” la forma-racconto nel testo sembra rivelarsi privo di fondamento; l’autore del testo, infatti, prima che autore, è stato a sua volta “lettore” del mondo, e l’ha “letto” in forma di racconto, passandolo poi a noi in questo modo. Continuo a non essere però del tutto convinto. Continuo a sentire della differenza tra il trattamento narrativo di un romanzo (che è sicuramente il prodotto di una lettura già narrativa del mondo), e quello di un dipinto o di un brano musicale. Proviamo a riflettere sulla natura delle nostre percezioni, in particolare sonore e visive. I suoni e le forme visive che arrivano ai nostri sensi vengono prima di tutto interpretati come segnali del mondo circostante; anzi, per la nostra ontologia ingenua, come il mondo circostante stesso. Solo in seconda istanza valutiamo se non siano stati prodotti da qualcuno a scopo comunicativo, e cerchiamo di interpretarli in questo senso. Ma c’è una grande eccezione a questo principio, perché quando i suoni e le figure sono riconosciute come linguaggio (oralità o scrittura, insomma), noi tendiamo a, per così dire, vedere attraverso di loro, per arrivare il più rapidamente possibile al loro significato. La dimensione materiale, quella del significante, non scompare, ma la nostra attenzione è rivolta da subito (e non in seconda istanza) al significato. È solo quando il significato è per noi incomprensibile (per esempio di fronte alle espressioni in una lingua sconosciuta) che ci arrestiamo al significante, con la forte (e ben giustificata) sensazione che ci stiamo perdendo il meglio. Quando sono in gioco le parole (e altri segni dichiaratamente convenzionali), insomma, assumiamo immediatamente che ci sia alle loro spalle qualcuno che le ha pronunciate o scritte. Questa medesima assunzione è molto più problematica, invece, quando le parole non sono in gioco, e siamo di fronte a immagini e/o suoni non verbali. Per portare la cosa al limite, è vero che un dipinto è sicuramente un’immagine prodotta dall’intenzione comunicativa di qualcuno; ma la cosa è molto meno certa (e rilevante) per un’immaigne fotografica o per un audiovisivo. I fotogrammi o le riprese di una telecamera di sorveglianza, per esempio, pur essendo immagini, non sono di solito interpretati come discorsi, bensì come testimonianze, documenti ottenuti attraverso un’estensione della nostra capacità di vedere e udire, che ci permette di vedere e udire anche quello che è accaduto in un luogo e un tempo in cui non eravamo presenti. Senza arrivare a questi estremi, l’assenza di una voce narrativa (orale o scritta) ci mette sempre nella condizione di valutare le percezioni non verbali come segnali del mondo (o direttamente come mondo); poi, subito dopo, nell’eventuale misura in cui sappiamo che sono state prodotte, iniziamo a considerarle anche come discorsi. Una delle conseguenze di questo è che mentre un racconto verbale (orale o scritto che sia) non può non avere un narratore (cioè una voce narrante, che si manifesta – come minimo – attraverso i pronomi e i tempi verbali), un’immagine, una sequenza di immagini o una sequenza di suoni, o una sequenza audiovisiva, possono benissimo non avere un narratore. Avranno un autore, certamente – ma non è la stessa cosa: è la voce narrante, cioè il narratore, che mi garantisce che quello che sto percependo è già una narrazione, ovvero il prodotto di un’interpretazione narrativa del mondo. Se il narratore non c’è, la situazione è molto più incerta. Supponiamo di stare facendo una passeggiata con un amico, in montagna. A un certo punto lui mi dice “Guarda”, indicando qualcosa. Io guardo e vedo una sequenza di eventi (un gruppo di camosci spaventati che fuggono, un falco in picchiata, una valanga): di fronte a quello che ho visto, io sto già interpretando narrativamente – e lo avrei fatto anche se avessi visto autonomamente quella scena. Certo anche il mio amico ha operato un’interpretazione narrativa del mondo, e sulla scorta di quella ha ritenuto opportuno avvertirmi. Ma la sua operazione si è esaurita di fatto con l’avvertimento, e la mia narrativizzazione è tutta mia. Ben diverso sarebbe stato se fosse stato lui a raccontarmi uno di questi eventi. In molti casi, quello che succede con i testi non verbali ha qualcosa in comune con l’esempio appena fatto, e non solo nell’ambito, ovvio, della fotografia. Un disegnatore o pittore traccia delle forme affinché, prima di tutto, io le veda e riconosca narrativamente. Proprio per questo le preparerà (potendolo fare, a differenza del mio compagno di passeggiata) in maniera da favorire una mia certa interpretazione narrativa, piuttosto che qualche altra. Ma, a differenza del narratore del romanzo, non potrà dichiarare implicitamente di stare raccontando – perché questo implicito è una prerogativa dalla parola. Il disegnatore (il pittore, il regista…) crea piuttosto delle situazioni prenarrativizzate (o delle sequenze prenarrativizzate) ovvero pronte perché si dia di loro una certa interpretazione narrativa. Non sto giocando con le parole. C’è differenza tra un racconto, garantito da un narratore, che ci autorizza da subito ad accettare che la sua stessa produzione sia già narrativa, e una sequenza prenarrativizzata, che siamo noi lettori a interpretare narrativamente, anche se è certamente stata progettata per favorirci in questo, ma dove non c’è nessuna garanzia, e nessuno che dichiara davvero “sto raccontando”. In questo secondo caso, io semplicemente assumo che ci sia a monte un’intenzionalità narrativa, ma sono io lettore a ricostruire il racconto in quanto tale. Ma poiché sono io, io sono anche libero allora di non farlo, e di fruire il testo in altro modo, presumendo che l’intenzionalità narrativa non sia l’unica, o magari non sia la principale, o magari non fosse nemmeno pertinente all’intenzionalità espressiva (e quindi interpretativa) dell’autore. Le parole esistono perché, convenzionalmente, trasmettono discorsi: se mi rifiuto o non sono in grado di recepire una sequenza di parole come discorso, non le sto nemmeno più ascoltando o vedendo come parole. A questo destino sono talvolta destinate le parole quando vengono messe in musica: a volte restano davvero parole, che trasmettono il loro senso, altre si trovano a essere trattate come semplici suoni articolati, ascoltate per il suono e ignorate per il senso. Dal punto di vista del rapporto con il racconto, il musicista si trova in una situazione ancora più estrema di quella di chi produce immagini. In molti casi le immagini possono essere lette come mimetiche; mentre raramente si può dire lo stesso delle sequenze musicali. Il musicista (compositore o esecutore) ci mette di fronte a delle sequenze articolate di suoni, e nemmeno ci dice che siamo tenuti a recepirle come un’interpretazione del mondo. Ma senza questa assunzione, diventa impossibile assumere che ci possa essere un qualche tipo di intenzionalità narrativa in musica, e quindi delle strutture narrative intimamente in gioco. Si fa fatica persino a pensare che la musica possa essere intesa come una sequenza prenarratizzata, quali il fumetto o il cinema (eccetto nel caso di melodramma e simili, ovviamente, dove la musica accompagna un’azione visiva e/o verbale). Quello che si può dire è che ci sono dei contesti storici e/o culturali in cui un’intenzionalità interpretativa del mondo e quindi espressiva può essere ipotizzata. Da Haydn e Mozart in poi questa ipotesi ha un senso nella musica occidentale. Ma forse bisognerebbe domandarsi, opera per opera, se sia accettabile di vederla come una sequenza prenarrativizzata. Se non lo fosse, e ugualmente vi rinvenissimo delle strutture narrative nascoste, sapremmo con certezza che siamo stati noi stessi, interpretando il testo musicale, a nascondervele. Il problema cruciale delle analisi narrative è dunque questo: per evitare di trovare quello che noi stessi vi mettiamo dentro, dobbiamo poter assumere che il racconto vi sia già, almeno nella forma implicita della sequenza prenarrativizzata. Lo possiamo assumere tranquillamente con il romanzo e con le forme analoghe più brevi. Lo potremmo assumere anche con la poesia, se non fosse che la poesia mette molto in primo piano certi aspetti del piano del significante, i quali con il racconto non hanno nulla che fare – ma la poesia gioca proprio su questo doppio binario. Lo assumiamo convenzionalmente con fumetto e cinema, trattandoli come varianti del racconto verbale – ma ci sono situazioni in cui la differenza salta fuori. A mano a mano che ci si allontana da questo nucleo, l’assunzione di narratività deve essere sempre più forte, e sempre più esplicitamente motivata: in musica, per esempio, è accettabile per il Romanticismo, ma in generale a fatica per le forme strumentali del Barocco – mentre sul jazz credo che potremmo discutere a lungo, caso per caso. In pittura, è accettabile per molti generi, ma la natura morta e il paesaggio la eludono in molti casi – per non dire dell’astrattismo di Mondrian, o dell’informale di Pollock. Non basta, insomma, trovare in qualche tipo di testo un’analogia con la forma-racconto per poter dire di essere di fronte a una struttura narrativa. Siamo noi a vedere racconti dappertutto. L’analogia non è una prova se non del fatto che quello che abbiamo davanti è un frammento di mondo, interpretabile narrativamente come tutto. Di notte, si sa, tutti i gatti sono neri.
. Dino Buzzati pubblica per la prima volta «Qualcosa era successo» sul Corriere della Sera, l’8 luglio 1949. Lo ripubblica nella raccolta Il crollo della Baliverna nel 1954, poi ancora in Sessanta racconti nel 1958 e infine ne La boutique del mistero nel 1968. Si tratta di un racconto piuttosto breve, adatto per questo a un tipo di analisi ravvicinata che porterebbe via troppe pagine per opere più lunghe. Scopo di questa analisi è vedere come questo breve testo costruisca il percorso di esperienza nel proprio Lettore Modello, e come l’insieme delle interpretazioni che è possibile darne derivi da tale percorso. Percorreremo il testo paragrafo per paragrafo, cercando di vedere come il suo sviluppo lineare costruisca la continuità dell’attenzione del lettore, portandolo progressivamente sempre più dentro al meccanismo passionale preparato per lui – e come si configuri, di conseguenza, l’esperienza cognitiva che il testo produce. (1) (a) Il treno aveva percorso solo pochi chilometri (e la strada era lunga, ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo, così correndo per dieci ore filate) quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna. (b) Fu un caso, potevo guardare tante altre cose invece lo sguardo cadde su di lei che non era bella né di sagoma piacente, non aveva proprio niente di straordinario, chissà perché mi capitava di guardarla. (c) Si era evidentemente appoggiata alla sbarra per godersi la vista del nostro treno, superdirettissimo, espresso del nord, simbolo per quelle popolazioni incolte, di miliardi, vita facile, avventurieri, splendide valigie di cuoio, celebrità, dive cinematografiche, una volta al giorno questo meraviglioso spettacolo, e assolutamente gratuito per giunta. (2) (a) Ma come il treno le passò davanti lei non guardò dalla nostra parte (eppure era là ad aspettare forse da un’ora) bensì teneva la testa voltata indietro badando a un uomo che arrivava di corsa dal fondo della via e urlava qualcosa che noi naturalmente non potemmo udire: come se accorresse a precipizio per avvertire la donna di un pericolo. (b) Ma fu un attimo: la scena volò via, ed ecco io mi chiedevo quale affanno potesse essere giunto, per mezzo di quell’uomo, alla ragazza venuta a contemplarci. (c) E stavo per addormentarmi al ritmico dondolio della vettura quando per caso – certamente si trattava di una pura e semplice combinazione – notai un contadino in piedi su un muretto che chiamava chiamava verso la campagna facendosi delle mani portavoce. (d) Fu anche questa volta un attimo perché il direttissimo filava eppure feci in tempo a vedere sei sette persone che accorrevano attraverso i prati, le coltivazioni, l’erba medica, non importa se la calpestavano, doveva essere una cosa assai importante. (e) Venivano da diverse direzioni chi da una casa, chi dal buco di una siepe, chi da un filare di viti o che so io, diretti tutti al muricciolo con sopra il giovane chiamante. (f) Correvano, accidenti se correvano, si sarebbero detti spaventati da qualche avvertimento repentino che li incuriosiva terribilmente, togliendo loro la pace della vita. (g) Ma fu un attimo, ripeto, un baleno, non ci fu tempo per altre osservazioni. (3) (a) Che strano, pensai, in pochi chilometri già due casi di gente che riceve una improvvisa notizia, così almeno presumevo. (b) Ora, vagamente suggestionato, scrutavo la campagna, le strade, i paeselli, le fattorie, con presentimenti e inquietudini. È già di per sé un fatto notevole e inconsueto, destinato a richiamare l’attenzione del lettore da subito, che nel primo periodo si apra quasi immediatamente una lunga parentesi, con un’evidente funzione tensiva. Si tratta infatti dell’attacco del racconto, una situazione speciale in cui quasi nulla è già impostato: il lettore conosce il titolo, ed è in grado di fare delle ipotesi sul genere del racconto, poiché presumibilmente conosce l’autore e altri racconti della medesima raccolta – ma, per il momento, nient’altro. Si aspetta, come è consuetudine per un attacco, una serie di informazioni ben definite, che forniscano il quadro della situazione. La prima proposizione («Il treno aveva percorso solo pochi chilometri») presenta infatti un tempo imperfetto e l’uso dell’avverbio «solo»: una clausola di tipo introduttivo assai frequente. Il lettore sa che questa clausola deve essere seguita, prima o poi, dalla descrizione dell’evento puntuale rispetto a cui si sta fornendo ora la descrizione del contesto. Quello che immediatamente segue, in casi di questo genere, di solito o è un ulteriore dettagliamento del contesto (p.e. «viaggiava rapidamente nella campagna assolata…») oppure un diretto passaggio alla descrizione dell’evento, separato tipicamente dalla presenza di un punto fermo, oppure collegato da un «quando», come effettivamente accade anche qui, ma più avanti. Deludendo questo genere di aspettative, il narratore inserisce invece a questo punto un inciso assai più lungo della stessa clausola iniziale, che si presenta sì come ulteriore dettagliamento del contesto, ma che in quanto espressione tra parentesi dichiara il proprio ruolo ausiliario proprio mentre le sue parole ci stanno comunicando informazioni evidentemente importanti. Siamo già, nel giro di due righe, in presenza di un primo effetto di saturazione: l’apertura di parentesi promette una notizia rapida e sussidiaria, ma dopo la prima breve asserzione («e la strada era lunga»), ne arriva una seconda («ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo») e poi ancora una terza («così correndo per dieci ore filate»). La tensione si accumula rapidamente, per scaricarsi poi finalmente sulla clausola introdotta dalla congiunzione «quando». Ma quello che accade qui, nel punto messo in rilievo dal concludersi dell’iterazione, è così evidentemente banale («a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna») che il lettore è spinto a ritenere che ci debbano essere delle ragioni ulteriori perché valga la pena di porlo tanto in evidenza, e di situarlo al punto di risoluzione di una situazione così evidentemente tensiva. Ecco quindi che il semplice uso di una modalità sintattica, posto in una posizione cruciale del racconto come è l’attacco, imposta sin dall’inizio una situazione tensiva. Certo, il riconoscimento della banalità dell’evento non è più un fatto sintattico: ha già un valore compiutamente semantico-narrativo, e infatti è sul livello narrativo che questo meccanismo di conduzione della tensione per saturazione continuerà di qui in avanti, come vedremo tra poco. Se provassimo tuttavia nel frattempo, a titolo di ipotesi, a riformulare sintatticamente il periodo iniziale senza mutarne il senso narrativo, ci accorgeremmo che l’eliminazione delle parentesi e del loro ruolo di sospensione porrebbe molto meno rilievo sull’evento, e di conseguenza lo qualificherebbe assai meno come punto di partenza del sistema di tensioni narrative che sta per seguire. Supponiamo che il testo dica, invece di quello che effettivamente dice: Il treno aveva percorso solo pochi chilometri e la strada era lunga: ci saremmo fermati soltanto alla lontanissima stazione d’arrivo, così correndo per dieci ore filate; quando a un passaggio a livello vidi dal finestrino una giovane donna. Nemmeno una parola è cambiata dall’originale di Buzzati, ma solo la punteggiatura, e di conseguenza la sintassi. In questa forma tuttavia la parte che va da «Il treno aveva…» sino a «…per dieci ore filate» assume un andamento sintattico autonomo, con un effetto di chiusura. La clausola introdotta dal «quando» riapre perciò la frase apparentemente chiusa. Di conseguenza non vi si arriva con l’impressione di essere inseguiti dalla necessità di chiudere l’inciso, bensì semplicemente per riapertura di un discorso già chiuso. L’iterazione è ancora presente, ma mentre l’incastonamento all’interno delle parentesi la mette in evidenza e favorisce un forte effetto di saturazione, questa divisione sintattica tende a neutralizzarne l’effetto. È nota l’attenzione di Buzzati a costruire una sintassi espressiva, a costo di leggere anomalie, specie nella punteggiatura, rispetto all’uso canonico. Vedremo più avanti altri esempi di queste deviazioni. All’inciso sintattico del primo periodo corrisponde nei due periodi successivi (1b e c) un inciso narrativo. Il rilievo forte che è caduto (con apparente gratuità) sulla visione della giovane donna richiede urgentemente spiegazione, e invece il racconto qui divaga. Divaga, come accadeva nel primo periodo, fornendoci il contesto necessario per comprendere la rilevanza dell’evento; ma dal punto di vista tensivo l’effetto è quello della costruzione di un ritardo, di nuovo per saturazione (si veda il lungo elenco in 1c), proprio dove il lettore è stato indotto a desiderare l’arrivo di una spiegazione. E poi, quando la spiegazione arriva, con il secondo capoverso (2a), ancora una volta il caso descritto appare così banale che la spiegazione evidentemente non basta e il lettore è indotto ad aspettarsi un’ulteriore delucidazione del perché questo evento minimale venga situato in una posizione di tale rilievo. Delucidazione che tuttavia non è destinata ad arrivare: al suo posto, anzi, troviamo un secondo evento, descritto con ancora maggiore dovizia di dettagli (da 2c a g), e solo con il terzo capoverso troviamo tematizzata narrativamente l’inquietudine che è già stata costruita nel lettore, tramite queste tre onde di crescendo progressivamente più ampie, basate sulla sintassi la prima, sull’ordine di successione degli enunciati che descrivono un evento la seconda, e sull’ordine di successione degli eventi la terza. Si noti dunque come è organizzato il racconto del primo evento: c’è un’introduzione (1a) caratterizzata dal crescendo su base sintattica (la lunga clausola tra parentesi) che si conclude sulla presentazione dell’evento; c’è un momento di dilazione (1b e c) caratterizzato dal crescendo di «seconda onda», dove viene fatta attendere la descrizione dell’evento, e che sfocia infine nella descrizione stessa (2a), seguito da una clausola minimizzante (2b), che chiude l’evento in sé, ma che implicitamente dichiara non giustificato il rilievo narrativo assegnato all’evento, e prepara il lettore all’arrivo di un seguito. Anche il secondo evento viene aperto da un periodo (2c) che contiene un inciso. Si tratta di un inciso più breve, ma, come ci insegna Meyer[1956], alle riprese basta assai meno per riproporre il clima dell’esposizione originale: quando la situazione ci è già nota, è sufficiente un accenno per riproporla integralmente all’attenzione. E dopo la presentazione dell’evento, abbiamo pure qui una dilazione (2d) ma nuovamente più breve della precedente («Fu anche questa volta un attimo perché il direttissimo filava…»), mentre alla descrizione dell’evento viene dato più spazio (da 2d a f), come più spazio viene dato alla clausola minimizzante (da 2g a 3b), la quale ora però esplicita il motivo del crescendo di nervosismo del protagonista, tematizzando finalmente lo stato tensivo in cui è stato portato il lettore. Stiamo aspettando, in questa fase del racconto, un evento di carattere Destinante; oppure, in subordine, un evento che possa anche appartenere a una fase successiva, nell’ipotesi che gli eventi della fase della Manipolazione possano venirci raccontati in seguito per mezzo di un flash back. Quello che invece incontriamo qui è una situazione di sfondo nella sua normalità (il viaggio in treno) presentata insieme con una serie di eventi il cui ruolo narrativo non è affatto chiaro – e di cui non sarebbe nemmeno chiaro che hanno un ruolo narrativo se il sistema tensivo in cui si situano non li ponesse nella situazione di doverlo avere. Ciò che ci viene presentato, insomma, è semplicemente il sospetto di trovarci in una situazione narrativa, sospetto basato su una serie di indizi di carattere stilistico fondati a loro volta sulla competenza intertestuale del lettore, e sull’assunzione di base che se qualcuno ci racconta qualcosa è perché ha qualcosa di rilevante da raccontarci. Prima di proseguire è comunque opportuno fare alcune osservazioni sulla sintassi utilizzata da Buzzati in questi paragrafi. Si tratta di una serie di periodi piuttosto lunghi, in cui domina una costruzione paratattica basata su un susseguirsi di clausole separate da virgole, anche là dove una punteggiatura più tradizionale richiederebbe qualcosa di più forte. In qualche caso le virgole addirittura mancano proprio dove se ne dovrebbe aspettare la presenza. L’analisi delle varianti mostra come in 1c l’espressione «simbolo per quelle popolazioni incolte, di miliardi» fosse in precedenza, più correttamente, «simbolo, per quelle popolazioni incolte, di miliardi». È dunque chiaro che l’uso anomalo della punteggiatura, e la sintassi singolare che ne consegue, sono oggetto di un’attenzione particolare da parte dell’autore, che cerca, evidentemente, un effetto stilistico. Si tratta, probabilmente, del tentativo di rendere con un linguaggio realisticamente colloquiale il monologo interiore di un viaggiatore che inganna la monotonia del viaggio con pensieri e piccole osservazioni su quello che vede. Lo stratagemma stilistico è coerente con il fatto che la narrazione sia in prima persona. In questo modo, con una sorta di stile indiretto libero, i pensieri del protagonista si confondono con quelli del narratore. Non dimentichiamo che, anche in un racconto in prima persona, le figure del narratore e del protagonista vanno riconosciute tipicamente come ben distinte: il narratore è l’io qui ed ora, che racconta di un altro io che si trova là e allora. Nel racconto che stiamo analizzando questa differenza viene tuttavia confusa, o almeno resa meno netta, per mezzo dello stile sintattico, che tende a renderci i pensieri del protagonista con un’imprecisione sintattica che può rendere l’andamento rapsodico con cui i pensieri ci vengono alla mente. Come effetto, il narratore stesso viene trascinato verso il là e allora della storia raccontata – qualcosa che per il momento appare come uno stilema senza particolari conseguenze, e peraltro assai frequente in tutta la scrittura di Buzzati, ma che avrà invece più avanti alcuni effetti di grande peso. …………….. _________________________________________________ Quello che avete letto è un frammento di un saggio intitolato Il viaggio del lettore. Una lettura di ‘Qualcosa era successo’, pubblicato originariamente su Studi buzzatiani. Rivista del Centro Studi Buzzati, 2002. Il saggio nella sua interezza è da oggi scaricabile nella sezione Downloads del mio sito. Buona lettura! L’esperienza della lettura. Attraverso una storia di Alberto Breccia e Carlos TrilloL’analisi del significato, qualunque sia la metodologia con la quale la si mette in opera, non è sufficiente a dare ragione dell’efficacia retorica di un racconto, ovvero della sua capacità di trasportare il proprio lettore lungo un efficace percorso emotivo. L’individuazione di uno schema narrativo, dei ruoli attanziali, delle attribuzioni di valore ecc. sono tutti passi utili per una migliore comprensione del testo narrativo, ma non ci permettono, di per sé, di distinguere un testo efficace da uno che non lo è. Viceversa, se non siamo in grado di valutare l’efficacia retorica di un testo narrativo, non saremo nemmeno in grado di valutare l’incidenza con cui i suoi significati possono arrivare alla comprensione del fruitore. Questo è tanto più vero quanto più la fruizione del testo non è obbligata, ovvero quanto più si basa sull’interesse da parte del fruitore, stimolato dal testo medesimo. Tanto più siamo, viceversa, obbligati dalle circostanze alla lettura e comprensione di un testo, tanto meno la sua efficacia retorica sarà rilevante. Tuttavia nessuno ci obbliga alla fruizione della maggior parte dei testi narrativi (letterari, filmici, fumettistici…) con cui veniamo continuamente a contatto: per tutti questi testi dunque la qualità del percorso emotivo su cui il lettore verrà trasportato sarà una condizione imprescindibile per la stessa trasmissione del significato. La nostra ipotesi è che l’efficacia retorica dipenda dal sistema di tensioni e risoluzioni che il testo costruisce nel corso della lettura, nonché dagli effetti di ritmo che il testo produce anche attraverso i suoi andamenti tensivi. Andamenti tensivi e effetti ritmici sono prodotti tanto dalla successione dei significanti quanto da quella dei significati, ma in un testo narrativo (a differenza di quello che succede, per esempio, nei testi poetici e musicali) la dimensione del significato è più influente, e richiede quindi anche per questo – oltre che per la sua maggiore complessità – un maggiore approfondimento. Proporremo dunque un percorso analitico a sei livelli, applicato a un oggetto narrativo a fumetti, un testo argentino del 1976 sceneggiato da Carlos Trillo e disegnato da Alberto Breccia, l’episodio “Ojo por ojo” della serie Un tal Daneri (sette pagine in bianco e nero, realizzate a china con varie tecniche e collage). I livelli che organizzano il nostro discorso sono livelli diversi di analisi e comprensione del testo, non necessariamente successivi in una fruizione reale; solo nell’ultimo si cercherà infatti di delineare complessivamente il percorso emotivo sulle cui linee il testo cerca di condurre il lettore. 1° livello: la lettura narrativa di baseIl primo livello, preliminare a qualsiasi altro, è quello della comprensione di base della forma narrativa, cioè della comprensione del racconto. L’effetto di una comprensione di questo tipo sarà qualcosa di simile al seguente resoconto: Daneri entra in un locale dall’aria equivoca per portare a termine una missione: spaccare le mani al pianista Marengo, per conto di Julieta. Dopo aver agito, viene seguito da un amico di Marengo, che gli rivela che Julieta, famosa fotomodella, lo ha ingannato, essendo lei la persecutrice di Marengo e non viceversa, come aveva fatto credere a Daneri. Dopo lunga riflessione, Daneri si reca da Julieta, si fa pagare regolarmente per il lavoro svolto, e poi si vendica dell’inganno vendicando insieme anche Marengo, e distrugge il viso di lei, secondo la legge antica dell’“occhio per occhio”. Non è questo l’unico resoconto di base che si può ricavare dal testo di Breccia e Trillo. Se ne possono immaginare facilmente versioni più concise o più dettagliate, ma anche versioni diverse, con divergenze più o meno accentuate. Poco importa quale sia la comprensione di base, ma è indispensabile che essa ci sia. Questa è comunque quella da cui partiremo noi, ritenendo che sia, presumibilmente, abbastanza simile alla lettura di base che farebbe qualsiasi lettore medio occidentale. 2° livello: analisi generativaAl secondo livello possiamo descrivere il racconto secondo le categorie della semiotica generativa. Ci accorgeremo così che siamo di fronte non a un solo racconto, bensì a due, di cui il primo funge complessivamente da fase di Manipolazione del secondo. [….] . L’articolo completo, di cui questo è l’inizio, può essere scaricato in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Uscirà su un prossimo numero della rivista latinoamericana di semiotica deSignis, in spagnolo. Proprio nel momento in cui esce questo post mi trovo a Siviglia, a un convegno organizzato da loro. Questo post era stato preparato già da qualche giorno, comunque prima della scomparsa improvvisa di Carlos Trillo. Trillo faceva parte, per me, del mito del fumetto argentino. L’articolo gli era già, per il suo argomento, implicitamente dedicato. Mi dispiace molto che ora debba fungere da commemorazione – ma almeno dà un’idea della stima che avevo per lui. |
||
|
Copyright © 2025 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||
Commenti recenti