27 Marzo 2013 | Tags: Aldo Nove, Amelia Rosselli, Andrea Inglese, Elio Pagliarani, Gabriele Frasca, Gian Mario Villalta, Giovanna Frene, Giuliano Mesa, Ivan Fedeli, Lello Voce, Marco Giovenale, Mario Luzi, metrica, Patrizia Valduga, poesia, Sergio Rotino, Umberto Piersanti | Category: poesia | A che cosa serve l’artificiosità del vincolo che caratterizza la poesia nei confronti della prosa? Per quale ragione si coltiva così pervicacemente una forma di scrittura che si rifiuta di scorrere liberamente secondo l’andamento naturale del discorso?
Credo che la risposta debba essere cercata in un sospetto verso quella che potremmo chiamare la trasparenza della parola, ovvero l’idea che il discorso verbale debba essere considerato uno strumento di espressione del pensiero, tendenzialmente senza residui. A questa visione ideale della prosa – ideale perché in verità nemmeno la prosa più tecnica la raggiunge sino in fondo – la poesia contrappone una concezione della parola piuttosto come ambiente. In poesia la sequenza delle parole costruisce un piccolo mondo, i cui oggetti, come nel mondo reale, valgono sia per le loro proprietà fisiche che per quelle simboliche: un tavolo è un oggetto materiale, fatto di legno, metallo e plastica e in relazione spaziale con gli oggetti circostanti, non meno e non più di quanto esso sia il supporto per il rito del pranzo, il simbolo dell’unità famigliare, il ricordo della nonna a cui era appartenuto. Gli oggetti della poesia sono ovviamente le parole e le loro costruzioni, nella propria natura sonora e visiva (con tutte le loro complessità) non meno e non più di ciò per cui stanno (con tutta la complessità dell’universo del significato).
Nella misura in cui siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a un uso strumentale e trasparente della parola, la poesia cerca di restituirci una dimensione globale del linguaggio, in cui la parola riappaia come cosa simbolica e insieme materiale proprio come le altre cose del mondo. Il vincolo posto sulla dimensione del significante serve proprio a imporne la pertinenza, a togliergli ogni possibilità di trasparenza. L’artificiosità è necessaria proprio perché si fa notare. Quando non c’è nulla che si faccia notare non c’è infatti ragione di uscire dall’uso standard, quello assestato, banale: nel nostro caso, appunto, l’uso strumentale del linguaggio.
Riportare il linguaggio alla sua natura di cosa, di oggetto, non significa rivendicarne la naturalità. È per forza evidente che un costrutto linguistico è un manufatto, così come lo è un tavolo e come non lo è un albero. Che cosa resta al linguaggio se si prescinde dalla sua natura di strumento per comunicare idee? Credo che quello che resta sia proprio la sua natura di manufatto, e in particolare di manufatto collettivo: il linguaggio è…
 Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea. Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.
La rivista è comunque, come sempre, di grande interesse anche a prescindere dal mio personale intervento. Segnalo con piacere che mi ritrovo citato, al suo interno, anche negli interventi di Rodolfo Zucco (“Lettera su Bonifazio e Cella”) e di Vincenzo Bagnoli (“Endecasillabi in quattro quarti. Fra Dante e il Rock”).
23 Maggio 2012 | Tags: Lello Voce, poesia, poesia orale, voce | Category: poesia | Lello Voce risponde su Satisfiction (riportato anche su Lello Voce online) alle mie osservazioni su Piccola Cucina Cannibale. Intanto lo ringrazio per il fatto di concordare con molte delle mie analisi, ma lo ringrazio poi anche delle due obiezioni che mi muove, le quali mi forniscono l’occasione per questa ulteriore riflessione.
Lello Voce lamenta la carenza di critica poetica che si occupi di poesia orale, performativa, e sostiene, non a torto, che mancano di fatto gli strumenti critici. Poi sostiene che, paragonando la sua operazione “multimediale” all’origine del Melodramma, io sarei caduto in un luogo comune. Certamente può essere, ma non sono così sicuro come lui che una musica libera dal fraseggiare tonale (il quale certamente, come dice lui, tende ad asservire la parola) sarebbe poi rispettosa nei suoi confronti: qualche volta sì, qualche altra no – e ho molto chiari una serie di esempi di musica contemporanea di ricerca in cui la parola (pur necessaria fonicamente) è del tutto ancillare per la dimensione del significato. Comunque si tratta di un rischio, e non di un destino segnato. Non è questo però il punto che mi interessa approfondire.
Mi viene da dire che il riferimento al Melodramma (quello delle origini, quello in cui la musica sarebbe dovuta essere amplificazione della parola, anche e soprattutto per il suo significato) potrebbe essere inteso, in una situazione in cui gli strumenti critici sono così carenti, come un suggerimento, magari provvisorio, per averne qualcuno in mano. C’è una difficoltà – almeno per me – non piccola, a ragionare per intonazioni di voce, velocità di pronuncia, dinamica, agogica… cioè gli aspetti sonori che caratterizzano una performance poetica orale, oltre che per metro, ritmo, senso, ecc. cioè gli aspetti comuni allo scritto e al parlato. In altri termini, credo di essere ormai bravino a smontare un testo scritto, ad analizzarne gli elementi e le loro relazioni, a spiegare che almeno certi aspetti dell’effetto che produce sul lettore sono riconducibili a certe caratteristiche formali del testo. Non che si spieghi tutto, certo; però qualcosa si capisce meglio, osservando così da vicino.
Ma quando il medesimo testo diventa un testo orale, ecco che entrano in gioco quegli aspetti detti sopra, che sono di evidente carattere musicale, e che un’analisi di carattere musicale potrebbe forse esplorare con qualche utilità. Un lavoro di questo genere, qualche anno fa, lo avevo condotto nei confronti di una poesia (scritta) di Umberto Fiori, tradotta come testo musicale (parlato, non cantato) da Luca Francesconi in uno dei suoi Radio-lied. Quel testo, “Radio-lied. Il racconto trasmutato” (uscito su VS n. 98-99 nel 2004), può essere scaricato dal mio sito. Non nascondo che quell’analisi così dettagliata mi era costata un sacco di lavoro, e che non sono sicuro che sarei in grado di ripeterla per altri tipi, diversi, di performance orali. Lì, comunque, ero aiutato dalla rilevanza della dimensione musicale.
In ogni caso, al di fuori di un lavoro di quel tipo, non resta che la dimensione dell’impressione soggettiva, dell’effetto che mi fa. Non è una dimensione necessariamente da condannare, specie se il soggetto giudicante (quello che valuta l’effetto che gli fa) è un soggetto che ha coltivato il proprio gusto, ed è in grado di collegare a pelle quello che ascolta (o che vede) con altre opere simili o diverse. Non è da condannare perché è inevitabilmente la dimensione su cui si pongono la maggior parte dei giudizi critici, per una banale questione di tempo: se io (o chiunque altro) dovessi lavorare per un mese per ogni giudizio critico, davvero ne potrei produrre ben pochi! E per questo devo comunque allenare la mia sensibilità a cogliere qualcosa anche subito, e a ottenere qualche elemento analitico comunque, che possa essere spendibile in tempi brevi.
Ma questo non toglie che il lavoro analitico sia di qualità enormemente superiore alla critica a pelle, e che dovrebbe essere comunque la meta a cui il critico tende, ogni volta che può. Per fare critica a pelle possono bastare strumenti più approssimativi; ma per analizzare da vicino c’è bisogno di parametri sufficientemente chiari e di un linguaggio descrittivo sufficientemente non ambiguo – due elementi rispetto ai quali confesso di sentirmi davvero un po’ in imbarazzo. E questo conferma che Lello Voce ha ragione quando lamenta la carenza di strumenti critici.
Tuttavia, questa differenza mostra, secondo me, anche che poesia scritta e poesia orale sono davvero due ambiti diversi – per quanto evidentemente collegati. Forse dovremmo possedere persino due parole diverse, o utilizzare in maniera sistematica proprio le espressioni poesia scritta e poesia orale, in modo da non confondere gli oggetti. Non si può infatti trascurare il fatto che una poesia non è lo stesso testo quando lo leggiamo con gli occhi sulla pagina (auspicabilmente facendolo risuonare dentro di noi con una voce virtuale) e quando si trova letta ad alta voce. Non lo è nemmeno quando il lettore ad alta voce è l’autore stesso: non so quanti poeti italiani sopravviverebbero nella pubblica considerazione, se dovessero essere giudicati esclusivamente attraverso le loro performance di lettura.
Il testo orale ha caratteristiche di intonazione, velocità di fruizione, volatilità del suono ecc. che il testo scritto non può avere, e che lo caratterizzano in maniera determinante. Molti testi scritti novecenteschi sono troppo complessi per poter essere davvero apprezzati in una performance orale, a meno che lo spettatore non conosca magari già il testo scritto – ma è una situazione paradossale: sarebbe come pretendere che per ascoltare davvero un brano musicale se ne conosca già la partitura – o a meno che l’ascolto non possa essere ripetuto più e più volte – come si fa col testo scritto e con la musica.
Essere performer anche solo delle proprie poesie è difficile. Nei miei esperimenti privati di lettura ad alta voce, basati su una competenza di recitazione che risale a un’epoca remota e per un periodo relativamente breve, finisce che non sono mai soddisfatto – un po’ perché la mia voce non va esattamente come vorrei, e un po’ perché la voce finisce sempre per decidere un senso interpretativo, e lo fa anche magari proprio là dove io vorrei lasciare l’ambiguità e la possibilità ad ogni voce virtuale del singolo lettore di trovare il proprio senso interpretativo. Forse sono troppo poeta scritto? Certo, il mio immaginario poetico è cresciuto in quel contesto; non lo posso negare.
 Immagini di Claudio Calia per "Piccola cucina cannibale", SquiLibri 2011 Negli ultimi decenni del Cinquecento, a Firenze, un gruppo di intellettuali innamorati di un mito prese un gigantesco granchio storico, e sulla base di quello inventò una delle forme artistiche di maggior successo dei secoli a venire: il Melodramma, detto anche Opera Lirica, o Teatro musicale. Bardi, Galilei (Vincenzo, padre di Galileo), Rinuccini, Peri, Caccini, de’ Cavalieri e Mei credevano di stare facendo rivivere la recitazione musicata dell’antica Grecia. Ancora oggi non abbiamo un’idea chiara di cosa accadesse in verità nei teatri dell’antica Atene, ma di sicuro non è quello che loro credevano. Tuttavia, sulla base di un principio errato, gli amici della Camerata fiorentina avevano fatto l’invenzione giusta, e gettato le basi per quattro secoli e più di ininterrotto successo.
C’è un principio che potremmo definire multimediale all’origine del Melodramma: parola, musica e scena agiscono insieme per determinare uno spettacolo totale, insieme sonoro, verbale e visivo, di grande capacità di coinvolgimento. Certo, per loro si trattava principalmente di un’amplificazione della parola poetica, un recitar cantando in cui la musica doveva sostenere l’espressività, e la scena visiva fornire le coordinate narrative. Solo l’opera francese (pur creata da un italiano) cercherà il più a lungo possibile di mantenere questo modello. In Italia (e l’Italia in musica dettava legge) ci volle poco perché il bel canto trionfasse, facendo del libretto poco più che una scusa – e quindi pazienza se non era gran che. In seguito, certo, tra i librettisti c’è stato pure Da Ponte; ma la grande rivoluzione del Wort-Ton-Drama wagneriano, che a sua volta tornava a inseguire pervicacemente il mito di una musica che esprimesse l’emozione che il testo diceva, non si fonda certo sulle qualità di poeta di Wagner…
Comunque andasse, nella storia del Melodramma, la componente musicale ha finito regolarmente per trionfare su quella poetica. Presumibilmente, quando parola e musica vengono emesse insieme, il portato emotivo della seconda finisce per mangiarsi quello della prima. Se poi c’è anche la componente visiva, cioè la scena (coi fondali, gli attori, l’azione drammatica), la parola conta ancora meno. Non potrebbe scomparire, certo, perché la presenza di certe parole o espressioni chiave è quello che permette di capire lo sviluppo drammatico; ma tutte quelle sottigliezze poetiche che potrebbe avere, o che magari che la parola davvero ha, finiscono poco o per nulla percepite. E allora, perché sforzarsi per mettercele? poco ascoltato per poco ascoltato, un testo banale varrà praticamente come uno interessante!
Questo resta vero anche per le canzoni di oggi. Quanti sono i cantautori che scrivono testi che reggerebbero anche senza la musica? Quanto davvero ci importa dei testi di tante canzoni, anche belle, se non come il supporto su cui articolarne le note? Quanto ci importa delle qualità dei librettisti dell’opera? Sorridiamo con ironia nel leggere certi testi, ma poi La Traviata resta La Traviata!
Poesia e musica sono state a lungo molto vicine. Così vicine che, se si generalizza quello che abbiamo appena detto, viene il sospetto che la poesia si sia separata dalla musica, sostanzialmente diventando poesia scritta, per acquisire visibilità. E la parola magica, visibilità, mi è uscita quasi accidentalmente: la poesia sarebbe quindi stata scritta per poter essere finalmente vista (e non solo udita), ma anche per acquisire un’autonomia che la sottraesse al dominio della musica, rendendola anche culturalmente visibile. Poi, certo, la poesia ha continuato a prestarsi alla musica: l’essenziale è il possedere anche una dimensione che sia interamente propria, non il sottrarsi a quelle condivise.
Piccola cucina cannibale è un’opera a tre mani: il poeta (e performer) Lello Voce, il musicista Frank Nemola, il disegnatore Claudio Calia. Ritrovo, nel loro lavoro, lo spirito mitologico e utopistico della Camerata fiorentina, e la stessa propensione a realizzare un’opera che coinvolga la parola come il suono come l’immagine. Il mito non è forse quello della grecità, ma quello della voce come essenza profonda della poesia, nella sua arcaica radice orale – ma certo è anche, in fin dei conti, quello della grecità, se pensiamo all’aedo Omero, quando la scrittura non era ancora stata adottata. E la multimedialità non è quella del Melodramma, ma comunque qualcosa di più adatto all’epoca della riproducibilità tecnica: un libro scritto, con immagini disegnate, e un cd con le esecuzioni dei brani poetici, accompagnati da musiche.
Il tutto è di ottima qualità. I testi poetici, che sono il centro del lavoro, si leggono e si ascoltano con piacere, accompagnati da belle musiche, con immagini evocative. Il risultato, qualunque cosa esso sia, è interessante, spesso coinvolgente… Alcuni pezzi, come la riscrittura della Canzone del maggio, o il componimento Il verbo essere, con cui si chiudono libro e disco, sono davvero memorabili.
I testi di Voce, non c’è dubbio, reggono anche senza la musica. Eppure, nel loro essere stati concepiti evidentemente per la performance, guadagnano qualcosa mentre perdono qualcos’altro. E tanto più, questo, nell’esecuzione orale, accompagnata dalla musica, nella quale certamente il fatto di essere recitati (e non cantati) li mantiene comunque fortemente presenti, in netto primo piano.
Guadagnano, direi, il portato della voce e dei suoi specifici andamenti e ritmi intonativi, e guadagnano l’intorno emotivo della musica, e quello visivo della scena che in verità non vediamo ma che ci viene in parte restituito dai disegni di Calia. Guadagnano quindi in complessità, in ricchezza.
Perdono però, mi sembra, in essenzialità, in nitidezza, in precisione.
Perdono, presumibilmente, qualcosa che non sono particolarmente interessati ad avere. Come facevo osservare la scorsa settimana, è spesso l’andamento liturgico a essere l’elemento dominante in poesia, e tanto più nella sua versione orale. Quello che la poesia effettivamente dice non è necessariamente dominante rispetto a quello con cui essa ci chiede di metterci in sintonia. L’elemento rituale è indubbiamente più forte in una poesia fatta per l’ascolto, piuttosto che in una nata per la lettura concentrata.
L’operazione di Lello Voce è indubbiamente legittima e interessante, ma corre il rischio di fare la fine del Melodramma: il successo storico, a dispetto del non essere ciò che avrebbe preteso di essere. E solleva un dubbio: tornare alle origini orali della poesia non ci mette a rischio di perdere quello che si è acquisito con la sua dimensione scritta? O, in altre parole: dopo tanti secoli di poesia scritta, quella orale e sonora è ancora poesia per noi? Siamo capaci di sentirla come tale, oppure la nostra sensibilità è ormai diversa, e chiediamo a ciò che chiamiamo poesia qualcosa di differente da quello che le veniva chiesto quando la poesia era davvero orale?
E ancora. Se si rafforza l’elemento rituale, si indebolisce quello dell’io, quello dell’espressione emotiva. E questo appare in linea con le tendenze antiliriche che si agitano in questi giorni. Ma si tratta di una coincidenza apparente. O forse è davvero questa l’unica vera possibile riduzione dell’io, in poesia. Nelle altre, il soggetto tende sempre surrettiziamente a rientrare.
Insomma, Lello, vai avanti, che la strada è interessante. Però permetterci di vedere le differenze, e di salvare non solo la tradizione orale, ma anche quella scritta, più vicina a noi e a quello che immaginiamo, quotidianamente, quando diciamo poesia.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|
 Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.
Quello che avete appena letto è l’inizio del mio (piuttosto lungo) intervento, intitolato “Il vincolo e il rito. Riflessioni sulla (non) necessità della metrica nella poesia italiana contemporanea“, apparso in questi giorni sul numero 16 della rivista L’Ulisse, complessivamente intitolato “Nuove metriche. Ritmi, versi e vincoli nella poesia contemporanea”. L’articolo, dopo una breve introduzione metodologica, cerca di fare un resoconto (parziale, ma nelle mie intenzioni rappresentativo) delle diverse posizioni sulla metrica e dei diversi usi che ne vengono fatti dalla poesia italiana contemporanea.

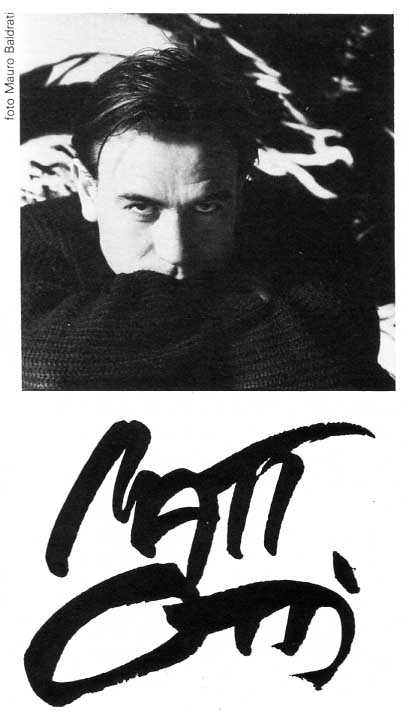







 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email




















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco

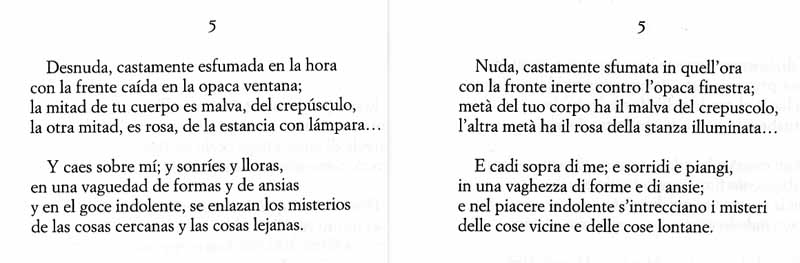






Commenti recenti