Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.


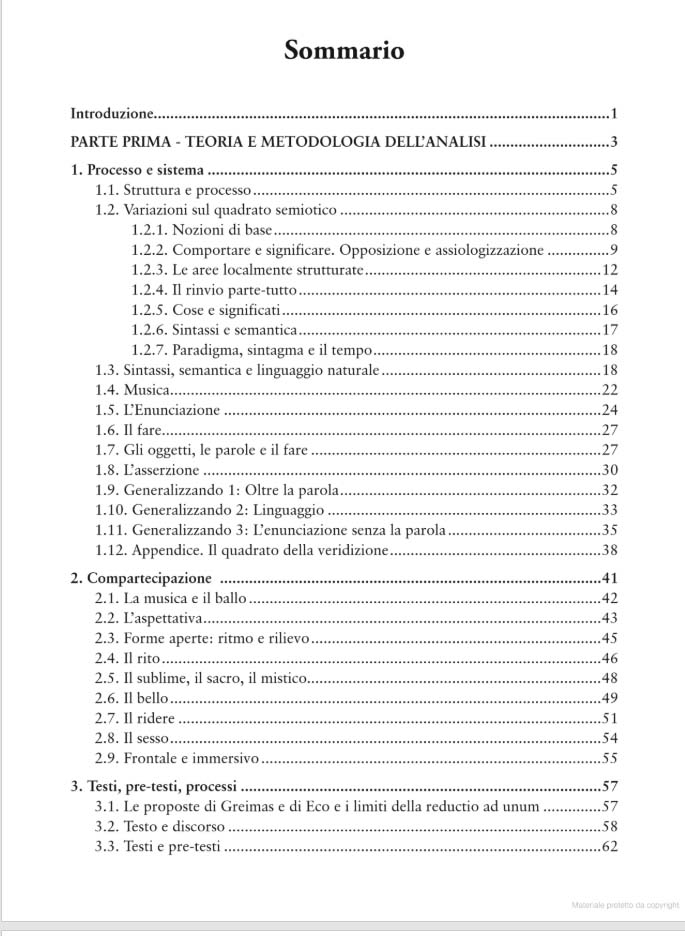
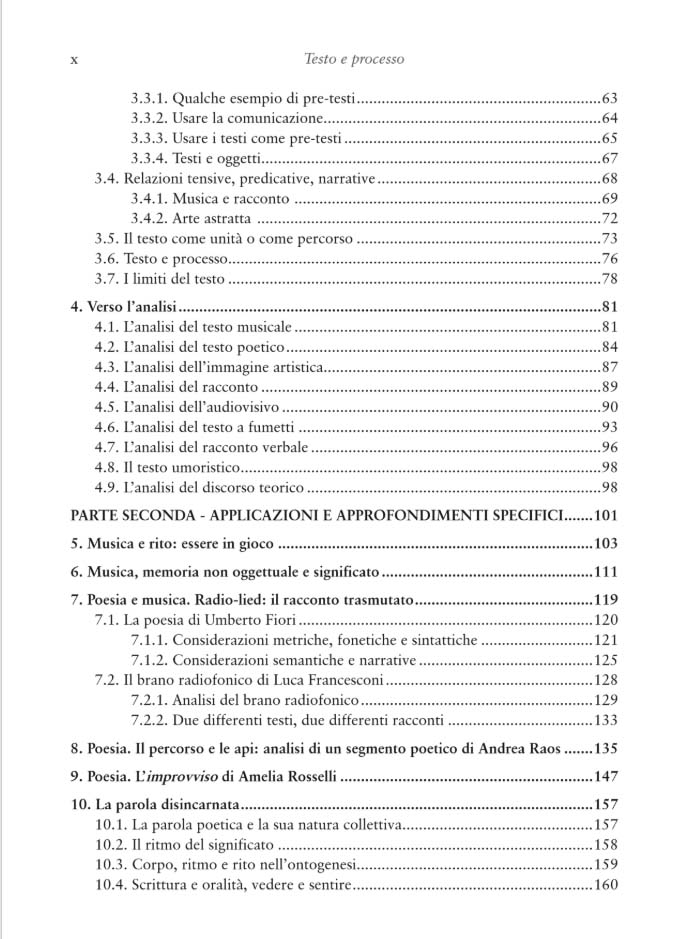
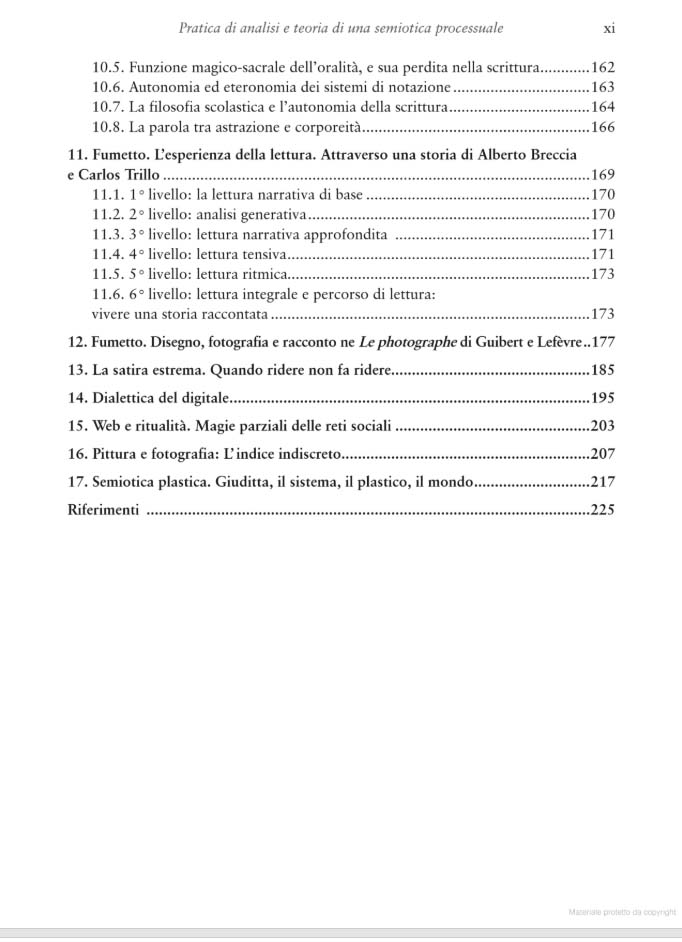

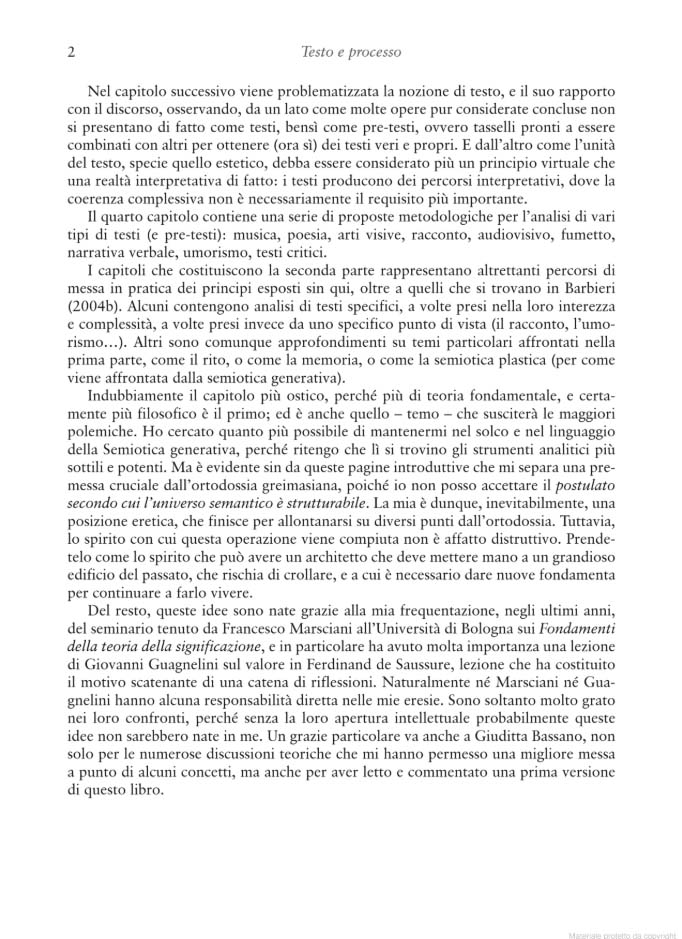
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
|
|
||
|
Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore. L’esperienza della lettura. Attraverso una storia di Alberto Breccia e Carlos TrilloL’analisi del significato, qualunque sia la metodologia con la quale la si mette in opera, non è sufficiente a dare ragione dell’efficacia retorica di un racconto, ovvero della sua capacità di trasportare il proprio lettore lungo un efficace percorso emotivo. L’individuazione di uno schema narrativo, dei ruoli attanziali, delle attribuzioni di valore ecc. sono tutti passi utili per una migliore comprensione del testo narrativo, ma non ci permettono, di per sé, di distinguere un testo efficace da uno che non lo è. Viceversa, se non siamo in grado di valutare l’efficacia retorica di un testo narrativo, non saremo nemmeno in grado di valutare l’incidenza con cui i suoi significati possono arrivare alla comprensione del fruitore. Questo è tanto più vero quanto più la fruizione del testo non è obbligata, ovvero quanto più si basa sull’interesse da parte del fruitore, stimolato dal testo medesimo. Tanto più siamo, viceversa, obbligati dalle circostanze alla lettura e comprensione di un testo, tanto meno la sua efficacia retorica sarà rilevante. Tuttavia nessuno ci obbliga alla fruizione della maggior parte dei testi narrativi (letterari, filmici, fumettistici…) con cui veniamo continuamente a contatto: per tutti questi testi dunque la qualità del percorso emotivo su cui il lettore verrà trasportato sarà una condizione imprescindibile per la stessa trasmissione del significato. La nostra ipotesi è che l’efficacia retorica dipenda dal sistema di tensioni e risoluzioni che il testo costruisce nel corso della lettura, nonché dagli effetti di ritmo che il testo produce anche attraverso i suoi andamenti tensivi. Andamenti tensivi e effetti ritmici sono prodotti tanto dalla successione dei significanti quanto da quella dei significati, ma in un testo narrativo (a differenza di quello che succede, per esempio, nei testi poetici e musicali) la dimensione del significato è più influente, e richiede quindi anche per questo – oltre che per la sua maggiore complessità – un maggiore approfondimento. Proporremo dunque un percorso analitico a sei livelli, applicato a un oggetto narrativo a fumetti, un testo argentino del 1976 sceneggiato da Carlos Trillo e disegnato da Alberto Breccia, l’episodio “Ojo por ojo” della serie Un tal Daneri (sette pagine in bianco e nero, realizzate a china con varie tecniche e collage). I livelli che organizzano il nostro discorso sono livelli diversi di analisi e comprensione del testo, non necessariamente successivi in una fruizione reale; solo nell’ultimo si cercherà infatti di delineare complessivamente il percorso emotivo sulle cui linee il testo cerca di condurre il lettore. 1° livello: la lettura narrativa di baseIl primo livello, preliminare a qualsiasi altro, è quello della comprensione di base della forma narrativa, cioè della comprensione del racconto. L’effetto di una comprensione di questo tipo sarà qualcosa di simile al seguente resoconto: Daneri entra in un locale dall’aria equivoca per portare a termine una missione: spaccare le mani al pianista Marengo, per conto di Julieta. Dopo aver agito, viene seguito da un amico di Marengo, che gli rivela che Julieta, famosa fotomodella, lo ha ingannato, essendo lei la persecutrice di Marengo e non viceversa, come aveva fatto credere a Daneri. Dopo lunga riflessione, Daneri si reca da Julieta, si fa pagare regolarmente per il lavoro svolto, e poi si vendica dell’inganno vendicando insieme anche Marengo, e distrugge il viso di lei, secondo la legge antica dell’“occhio per occhio”. Non è questo l’unico resoconto di base che si può ricavare dal testo di Breccia e Trillo. Se ne possono immaginare facilmente versioni più concise o più dettagliate, ma anche versioni diverse, con divergenze più o meno accentuate. Poco importa quale sia la comprensione di base, ma è indispensabile che essa ci sia. Questa è comunque quella da cui partiremo noi, ritenendo che sia, presumibilmente, abbastanza simile alla lettura di base che farebbe qualsiasi lettore medio occidentale. 2° livello: analisi generativaAl secondo livello possiamo descrivere il racconto secondo le categorie della semiotica generativa. Ci accorgeremo così che siamo di fronte non a un solo racconto, bensì a due, di cui il primo funge complessivamente da fase di Manipolazione del secondo. [….] . L’articolo completo, di cui questo è l’inizio, può essere scaricato in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Uscirà su un prossimo numero della rivista latinoamericana di semiotica deSignis, in spagnolo. Proprio nel momento in cui esce questo post mi trovo a Siviglia, a un convegno organizzato da loro. Questo post era stato preparato già da qualche giorno, comunque prima della scomparsa improvvisa di Carlos Trillo. Trillo faceva parte, per me, del mito del fumetto argentino. L’articolo gli era già, per il suo argomento, implicitamente dedicato. Mi dispiace molto che ora debba fungere da commemorazione – ma almeno dà un’idea della stima che avevo per lui. Sarà per le radici musicali comuni, che rendevano una volta poesia e canzone solo due facce diverse di uno stesso linguaggio (e vedi come se ne discute su Absoluteville anche – e non solo – nelle rubriche di Stefano La Via e di Rosaria Lo Russo) ma sarà anche per la separazione netta che la storia ha poi sancito tra loro. Sarà per questo e probabilmente pure per altro, ma se mi venisse chiesto a bruciapelo che cos’è il verso in poesia, mi verrebbe da rispondere che si tratta della versione stilizzata (ritualizzata) del respiro. Nelle canzoni – è facile – il verso è direttamente l’estensione del respiro, anche quando chi canta non tira davvero il fiato tra un verso e l’altro; ed è così per ragioni fisiologico-musicali di cantabilità. Ma in poesia la componente di stilizzazione non è meno importante del richiamo al respiro stesso. Da diversi secoli a questa parte, la poesia esiste anche senza che nessuno la declami, quando la percorriamo con gli occhi ed è solo una voce interiore stilizzata a renderne per noi i suoni. (Se manca pure la voce interiore, e leggiamo unicamente con gli occhi, allora o quello che leggiamo non è poesia, oppure non sappiamo davvero leggere la poesia, e il verso non è che un disturbo visivo alla continuità della lettura.) Il principio del respiro stilizzato (che l’eventuale declamazione dovrebbe in qualche modo rendere acusticamente, riavvicinando – almeno rispetto a questo – la poesia alla canzone) è ciò che dà senso al verso libero. Nella poesia che fa uso del verso libero, secondo la proposta già di William Blake, quando scriveva Jerusalem intorno al 1804, ogni verso ha un respiro differente, adatto alle sue specifiche necessità espressive (qualche idea sul come si va a capo in poesia l’avevo già presentata qualche mese fa in questo post). Ma allora quello che dovremmo chiarire ora è: che differenza c’è tra usare versi lunghi e usare versi brevi? Oppure, in altre parole: in che cosa è diverso il respiro lungo da quello breve? E come si collega la problematica della lunghezza del verso con quella della lunghezza della proposizione o del periodo? E poi: che differenza si produce tra il fare uso del verso libero, e il sottoporre i versi a un qualche tipo di regolarità (che sia sillabico-accentuativa come nella tradizione italiana, o magari solo accentuativa come in quella germanica, o solo sillabica come in quella francese, o qualsiasi altra purché percepibile)? E infine: perché si usano (o si evitano) i versi canonici? È un po’ di tempo che sto provando, nei miei esperimenti poetici, a fare uso di un verso non canonico relativamente breve, un ottosillabo alla spagnola, senza gli accenti fissi di quello italiano (qualche esempio si può leggere qui, qui o qui). Ultimamente ho invece cercato di sperimentare un modello diverso, basato su un verso molto lungo, con un andamento cantilenante caratterizzato da quattro o cinque accenti e un numero variabile di sillabe – che non è però un vero verso libero, perché la percezione alla lettura è comunque di una certa uniformità ritmica da un verso all’altro (un esempio qui, e un altro qui). L’ottosillabo è stato per me una scoperta importante (ne ho già parlato qui) perché mi ha permesso di costruire delle strutture poetiche con respiro fisso ma senza il richiamo ad andamenti prosodici già troppo presenti nelle orecchie del lettore italiano – come sarebbe, per esempio, quello del settenario, appena differente in apparenza, ma in realtà sancito da secoli di tradizione. La (relativa) brevità dell’ottosillabo, aggiunta alla sua regolarità sillabica, permette di costruire delle strutture sufficientemente ossessive; mentre l’irregolarità degli accenti ne permette un uso narrativo, evitando l’effetto filastrocca tanto caro a Pascoli. Questa combinazione tra formalità (e ripetitività) rituale (e ritmica) da un lato, e varietà sintattica e narrativa dall’altro, è – per me – quello che fa l’essenza della poesia, mettendo in comunicazione il nuovo con il già noto e viceversa, ovvero la comunicazione riguardo al mondo (esteriore ed interiore) con le nostre strutture assestate personali, sociali e naturali. Certo, non è che la ripetitività stia solo dalla parte del metro e la novità solo da quella del racconto. La poesia è qualcosa di molto più complicato di così – ma in qualche caso può trovarsi anche ridotta a questo. D’altra parte, l’adozione di un ottosillabo ad accenti variabili comporta un innesto di variabilità (e quindi di novità) anche nel metro stesso – e si può bene, d’altro canto, giocare di ricorrenze sintattiche o anche narrative… Passare, nella scrittura, da un verso breve a un verso molto lungo significa per me prima di tutto abbassare il livello di ansietà, di tensione ritmica di base. È come abbandonare il respiro affannoso della corsa o della marcia per quello lungo del riposo o del sonno. Tuttavia questa maggiore lunghezza rende anche più probabile la coincidenza tra le cesure metriche di fine verso e quelle sintattico-narrative di fine proposizione o periodo. Questo vuol dire che, nonostante che il respiro sia più calmo, la componente rituale, iterativa, coinvolge in qualche modo anche il racconto. Gli enjambement, che con il verso breve sono probabili e attesi, con quello lungo diventano più rari, e producono perciò, quando si presentano, effetti molto più radicali. A grandi linee (perché esistono anche casi particolari in cui accade il contrario), il verso libero privilegia la componente espressiva, comunicativa; mentre la ricorrenza di una clausola regolare (comunque sia ottenuta questa regolarità) sottolinea la componente rituale (ritmica). Se le cose stanno così, il verso libero avvicina la poesia alla prosa, costringendola – per mantenere la distanza – a enfatizzare altre differenze (per esempio di carattere tematico, o moltiplicando le iterazioni sintattiche o narrative). Giusto per chiudere, è giusto osservare che il rapporto tra espressività e ritualità non caratterizza solo la poesia, bensì – in diversa misura – ogni specifica forma di comunicazione. Quello che potremmo dire della poesia è che si tratta di una forma molto ritualizzata, pur se ancora molto meno della musica. Cosa succede, in questi termini, nel fumetto? Un po’ ne ho già parlato in qualche post precedente, un po’ ci tornerò sopra, spero presto. Un’amica che leggeva delle mie poesie mi ha domandato una volta con che criterio si va a capo nei versi. In altre parole, quando scrivi una poesia, come fai a decidere quando è ora di concludere un verso e iniziarne un altro? La risposta banale è “Quando lo senti”. È vero (perché mentre scrivi è in gioco la sensibilità assai più di qualsiasi tipo di calcolo) ma non basta (perché anche questa stessa sensibilità segue delle regole, che ci siano in quel momento presenti o no). La risposta non banale è molto complicata. Riflettendo sulla stessa sensibilità che ci porta ad andare a capo in un certo modo, posso però enunciare una serie (tutt’altro che esaustiva) di principi, che hanno come conseguenza l’andata (o meno) a capo:
Quest’ultima osservazione riguarda qualcosa che mi è particolarmente presente. Probabilmente la natura sillabico-accentuativa (più sillabica che accentuativa) del verso tradizionale italiano ha a che fare con l’antico legame tra poesia e musica, reciso nel XIII secolo dagli aristocratici siciliani. Dante aveva capito bene, pur nei termini della propria epoca, che il gioco tra versioni più o meno canoniche dell’endecasillabo era uno strumento potente in mano al poeta, visto che non c’era più bisogno di rispettare il requisito della cantabilità (in senso musicale). Poi però Petrarca ha imposto alla poesia italiana un canone di regolarità che ha tagliato fuori questo gioco: purtroppo lui era talmente bravo che riusciva a ottenere gli stessi effetti giocando di variazioni minimali degli accenti; ma per chi l’ha seguito, affascinato dalla sua abilità, il risultato è stato mediamente assai noioso. Sarà gusto personale, ma nell’universo del sonetto (cioè la forma che Petrarca ha maggiormente segnato) i miei amori sono sempre andati verso gli autori meno petrarcheschi, come Giovanni Della Casa e Ugo Foscolo, specie in A Zacinto. Ecco un bell’esempio da Della Casa (dalle Rime, pubblicate postume nel 1558): Questa vita mortal, che ‘n una o ‘n due Or a mirar le grazie tante tue Anzi ‘l dolce aer puro, e questa luce E tutto quel che ‘n terra o ‘n ciel riluce, Qui il gioco tra irregolarità (tensiva) e regolarità (risolutiva) è basato sull’enjambement, mentre per quanto riguarda gli accenti il canone petrarchesco viene rispettato. Ma il principio si trova applicato sino in Amelia Rosselli (da Documento, 1966-73): Ossigeno nelle mie tende, sei tu, a In questa corsa affannosa, l’unico punto risolutivo è quello finale, e questa “foresta pietrificata” ne riceve un rilievo straordinario. (come questo principio sia applicato da me – si parva licet componere magnis – si può ovviamente verificare qui) |
||
|
Copyright © 2024 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||
Commenti recenti