 Leggo l’articolo di Andrea Inglese “Iconoclastia artistica e concetto di littéralité”, apparso su Nazione Indiana (ma già prima in un volume collettivo) e apprezzo, come sempre, la chiarezza di esposizione e l’originalità del tema. Ne condivido, oltre a una serie di premesse, l’atteggiamento critico e “anticalcistico” (sottolineato in uno dei commenti), ed è proprio in questo spirito di critico apprezzamento che vorrei chiarire perché la posizione della littéralité è a mio parere sostanzialmente indifendibile, a meno (come talvolta Inglese sembra suggerire) che non la si prenda come semplice utopia, tendenza influente ma irraggiungibile – e tuttavia, in questo caso, non so quanto davvero desiderabile.
Leggo l’articolo di Andrea Inglese “Iconoclastia artistica e concetto di littéralité”, apparso su Nazione Indiana (ma già prima in un volume collettivo) e apprezzo, come sempre, la chiarezza di esposizione e l’originalità del tema. Ne condivido, oltre a una serie di premesse, l’atteggiamento critico e “anticalcistico” (sottolineato in uno dei commenti), ed è proprio in questo spirito di critico apprezzamento che vorrei chiarire perché la posizione della littéralité è a mio parere sostanzialmente indifendibile, a meno (come talvolta Inglese sembra suggerire) che non la si prenda come semplice utopia, tendenza influente ma irraggiungibile – e tuttavia, in questo caso, non so quanto davvero desiderabile.
Partiamo dalla breve antologia dei presupposti, o delle anticipazioni del letteralismo, che Inglese traccia. Si incomincia con Van Doesburg, 1930, che nel suo manifesto Basi della pittura concreta scrive: “L’opera d’arte deve essere interamente realizzata e formata dallo spirito prima della sua esecuzione. Essa non deve accogliere nulla dei dati formali della natura, della sensualità, della sentimentalità. Noi vogliamo escludere il lirismo, la drammatizzazione, il simbolismo, ecc.” E poi: “Il quadro dev’essere interamente costruito con degli elementi puramente plastici, ossia piani e colori. Un elemento pittorico non ha altro significato che ‘se stesso’, di conseguenza il quadro non altro significato che ‘se stesso’.” E poi ancora: “La tecnica deve essere meccanica, ossia esatta, anti-impressionista”.
Credo che Mondrian, già compagno di strada di Van Doesburg, prima di andarsene sbattendo la porta perché l’amico non era sufficientemente conseguente (aveva introdotto gli angoli di 45 gradi nelle sue composizioni!!), avesse già espresso concetti simili con chiarezza ancora maggiore ben dieci anni prima. In un suo articolo del 1920, “Il Neoplasticismo. Principio generale dell’equivalenza plastica”, Mondrian arriva addirittura a spiegare come dovrebbe essere una musica che segua i principi del neoplasticismo; e così ecco l’idea di una musica che abbandona l’armonia tonale e adotta nuovi strumenti che eliminano l’espressività dai suoni, in nome del tentativo di raggiungere la forma pura, fatta di contrasti puri tra elementi essenziali. Potrebbe sembrare una precognizione della dodecafonia di Schönberg, che il musicista viennese sta sviluppando nei medesimi anni; ma Schönberg non arriverà mai a essere così estremista. Siamo più vicini, semmai, al serialismo di Pierre Boulez, che troverà campo a partire dalla fine degli anni quaranta; ma pure Boulez non arriva a voler eliminare l’espressione dai suoni.
Proviamo a leggere qualche riga al proposito. Mondrian inizia dicendoci che in musica, a parte le fughe di Bach, “nella maggior parte dei casi la plastica costruttiva è velata dalla melodia descrittiva”, espressione dell’individuale; mentre “nella musica, come altrove, lo spirito nuovo esige una plastica equivalente dell’individuale e dell’universale governata da una proporzione equilibrata”. E più sotto: “La scala musicale con le sue sette note si basava sulla morfoplastica. […] La vecchia armonia rappresenta l’armonia naturale. […] La nuova armonia è una doppia armonia, una dualità di armonia spirituale e armonia naturale. […] Pertanto la nuova armonia non può mai essere com’è in natura: essa è l’armonia dell’arte”. E infine: “Se lo spirito nuovo deve essere espresso plasticamente, si deve bandire dalla musica la vecchia scala tonale, insieme agli strumenti tradizionali. Per giungere a una nuova tecnica si devono creare, oltre a una nuova composizione, anche altri mezzi plastici, come avviene nelle cosiddette arti plastiche. […] Archi, fiati, ottoni ecc. vanno sostituiti da una batteria di oggetti duri. […] Per la produzione del suono sarà preferibile ricorrere a mezzi elettrici, magnetici, meccanici, in quanto essi impediscono più facilmente l’intrusione dell’individuale.” Così, ecco la conclusione a cui Mondrian arriva: “Il contenuto della nuova opera d’arte deve essere un’esteriorizzazione plastica chiara, equilibrata ed estetica dei rapporti sonori, niente di più”. (tutti i corsivi di queste citazioni sono di Mondrian)
Mondrian parla della musica, ma ci sta dicendo anche quale sia la sua idea della pittura. Scrivete visivi invece che sonori nell’ultima affermazione, e avrete l’ideale mondrianiano della pittura: la forma pura, irrelata, intesa come un sistema di rapporti plastici. Non siamo lontani dalle affermazioni degli altri precursori citati da Inglese, come Judd, Manzoni, Klein e Buren, attraverso i quali l’iconoclastia novecentesca diventa un’affermazione della sostanza dell’opera, del suo essere stesso. Come dice Piero Manzoni: “Qui l’immagine prende forma nella sua funzione vitale: essa non potrà valere per ciò che ricorda, spiega o esprime (casomai la questione è fondare) né voler essere o poter essere spiegata come allegoria di un processo fisico: essa vale solo in quanto è: essere”. Non siamo lontani nemmeno, come fa giustamente notare Inglese, da certe affermazioni di Adorno: “In generale – scrive Adorno – le opere d’arte potrebbero valere tanto di più quanto più sono articolate: laddove non è rimasto nulla di morto, di non-formato; nessun campo che non sia stato percorso dal configurare. Quanto più profondamente questo se ne è impadronito, tanto più l’opera è riuscita. L’articolazione è il salvataggio della molteplicità nell’uno.” Qui l’articolazione è il progetto, è la plastica costruttiva di Mondrian, è l’essere interamente realizzata e formata dallo spirito prima della sua esecuzione di Van Doesburg. Ciò che è morto, non-formato, è quello che si presenta come semplice imitazione del mondo, melodia descrittiva, morfoplastica.
Andando in una direzione simile (ma senza arrivare tanto in là), nel 1964 Susan Sontag già lamentava l’ossessione dell’interpretazione rispetto ai testi letterari, ormai impostasi a tal punto da portare talvolta gli autori stessi a produrli in funzione di un’interpretazione critica. L’accezione del termine interpretazione nell’uso della Sontag è diversa da quella di uso semiotico corrente, e più vicina semmai a quella dell’ermeneutica, e potrebbe essere considerata grosso modo equivalente a trovare un senso nascosto profondo. Gli autori letteralisti o pre-letteralisti di cui parla Inglese vanno certamente nella direzione auspicata dalla Sontag, e in questo senso la loro posizione è apprezzabile. Eppure, temo, finiscono per buttare via il bambino insieme con l’acqua sporca.
Trovo comunque di grande interesse la posizione di Ponge, e la descrizione che ne fa Inglese. Mi permetto di citarla qui integralmente:
Prenderò in considerazione Méthodes, libro di Ponge uscito nel 1961 e contenente delle riflessioni di poetica redatte negli anni Cinquanta. In esso, è raccolto il testo di una conferenza presentata in Germania nel 1956 dal titolo La pratique de la littérature. Ponge insistite qui su una caratteristica tipica del poeta – sorta di precondizione psicologica o esistenziale al suo mestiere –, che è la particolare sensibilità all’esistenza del mondo e degli oggetti. Questa sensibilità riguarda, nella formulazione che ne do io, l’esteriorità radicale del mondo, ossia il versante più inospitale della realtà. Versante, per altro, che è sempre schermato dall’interiorità del sistema culturale e linguistico in cui siamo per lo più immersi. Ma Ponge sottolinea un altro aspetto cruciale della postura poetica. Bisogna infatti aggiungere a questa sensibilità generale, una sensibilità più ristretta. Ed ecco cosa scrive: “Quindi, c’è questa sensibilità nei confronti del mondo esteriore. E poi c’è una sensibilità a un altro mondo, anch’esso interamente concreto, stranamente concreto ma concreto, che sono il linguaggio, le parole. Credo che siano necessarie entrambe le sensibilità per essere un artista, ovvero avere la sensibilità nei confronti del mondo e avere la sensibilità nei confronti del proprio mezzo espressivo”.
Sembrerebbe una frase tutto sommato banale, se non nascondesse abissi di carattere epistemologico. Nel momento in cui il poeta è colpito, provocato, investito dalla realtà materiale del mondo e degli oggetti, egli reagisce, dando però le spalle a quel mondo, per concentrarsi su un altro mondo, altrettanto materiale, ma più piccolo e sfuggente, che è quello del linguaggio e delle parole. Per altro, in questo scenario si è saltati dal mondo e dagli oggetti al linguaggio e alle parole, senza soffermarsi sul soggetto, sulla sua mente, la sua interiorità, i suoi sentimenti, ecc. Ci si è limitati a sottolineare che il soggetto che scrive poesia dovrebbe possedere una propensione all’attenzione e alla sorpresa nei confronti di ciò che materialmente lo circonda. Ma veniamo al paradosso enunciato da Ponge. Per andare verso il mondo che lo provoca con la sua circostante inospitalità, il poeta è costretto a ripiegarsi sul linguaggio e sulle parole, che hanno una loro specifica consistenza materiale. Ma così facendo, non potrà mai più uscire da quel ristretto mondo linguistico, fatto di certi suoni e certe tracce, per appropriarsi in qualche magico modo dell’oggetto esteriore. L’esito di questa riflessione sembrerebbe condurre allo scacco, all’ammissione di essere finiti in un vicolo cieco. Ma Ponge fa proprio di questa difficoltà lo specifico motore della sua scrittura. La sua strategia potrebbe essere così riassunta: giocare l’estraneità del mondo contro la familiarità del nostro linguaggio; curare il nostro linguaggio, sferzandolo con l’estraneità del mondo. Ma da cosa bisogna curarlo? Innanzitutto dalle idee che in esso si depositano, dai significati, dagli usi comuni delle parole, ma anche – visto che stiamo parlando di linguaggio poetico – dagli usi che la comunità poetica fa del linguaggio. Quindi il linguaggio va s-poeticizzato, o se vogliamo s-figurato, ossia bisogna liberarlo anche dalle figure letterarie e retoriche. Tutto ciò infatti fa ombra alla realtà dell’oggetto, fa ombra alla consistenza del mondo. Questo tipo di cura è stata ben compresa e valorizzata da Gleize. La littéralité, infatti, è animata innanzitutto da un’ideologia dell’emancipazione, e ciò da cui bisogna emanciparsi sono i significati ordinari, da un lato, ma anche le immagini poetiche, dall’altro. Siamo di fronte al sogno iconoclasta di liberare la lingua dalle immagini soggettive, che sono poi, come già sostenevano gli artisti citati in precedenza, inconsapevoli sedimenti di ideologie dominanti.
Mi sembra sufficientemente evidente che le immagini soggettive evocate qui non sono lontane dalla melodia descrittiva aborrita da Mondrian, né dal morto di Adorno. Così come ugualmente evidente mi pare che questo estremo andare verso il mondo, verso il reale finisca per ribaltarsi in un concettualismo altrettanto estremo, come quello di Mondrian, di Boulez e di Adorno. E il paradosso evidentemente c’è, ma non è quello suggerito da Inglese.
L’opposizione di cui paradossalmente in Ponge si vedrebbe la negazione è infatti quella tra parole e cose, ma si tratta di una falsa opposizione. Ponge ha del tutto ragione nel trattare le parole come cose, anzi come quelle cose che ci sono familiari più di tutte le altre: curare il nostro linguaggio, sferzandolo con l’estraneità del mondo è un programma che non si può che condividere. Ma bisogna riconoscere che le cose non sono oggetti meno semiotici delle parole: sono solo strumenti che vengono utilizzati all’interno di pratiche diverse da quelle del parlare (o scrivere) che caratterizzano l’operato del poeta. Riconoscere questa identità semiotica di fondo tra parole e cose è la condizione per un programma come quello di Ponge, ma al tempo stesso lo destituisce di senso (il programma, non le opere, sue e di Gleize, che continuano ad avere un senso e un valore).
Se infatti le cose sono oggetti semiotici quanto le parole, allora anche loro sono stracolme di significati ordinari e di figure retoriche (seppur diverse da quelle dalle parole), così come di immagini soggettive cariche di ideologia (seppur diverse da quelle delle parole). L’operazione di Ponge può allora funzionare non perché ripulisca il linguaggio sporco di soggettività e poeticità attraverso il contatto con il mondo pulito, ma perché questo confronto sporca il linguaggio con una sporcizia che non è specificamente la sua, ma semplicemente quella di un diverso ambito semiotico. Si tratta, insomma, di un effetto di Verfremdung, di straniamento, qualcosa che è ben noto al Novecento anche senza andare a disturbare la letteralità e i suoi antecedenti.
In questa prospettiva, per emanciparsi dai significati ordinari e dalle immagini poetiche non c’è bisogno di idealizzare il mondo, non solo perché il mondo non è che un altro campo di significazione, ma anche perché basta giocare con un qualsiasi campo diverso di significazione per ottenere un effetto analogo (certo, poi, non tutte le scelte saranno ugualmente efficaci, ma non è l’opposizione parole/cose a fare da linea discriminante).
In questa prospettiva, inoltre, nessuna letteralità è davvero possibile. Le forme pure di Mondrian non sarebbero gli oggetti straordinari che spesso sono se non si stagliassero contro vari millenni di immagini, che forniscono inevitabilmente il quadro concettuale di riferimento attraverso cui comprenderle. Qualsiasi paesaggio cittadino è pieno di angoli e incroci di linee e colori molto simili a quelli di Mondrian, ma noi non passiamo le giornate con il naso all’aria estasiati da quello che vediamo, come succede di fronte a una sua opera. Poi, certo, arriva un Franco Fontana a fotografare quelle stesse cose che possiamo vedere tutti i giorni e di colpo ecco che riacquistano quella potenza che in libertà non avevano; ma l’operazione di Fontana è proprio quella di riproporre quelle forme come immagini, e quindi di riproporle nel confronto con i millenni di immagini che hanno dietro, e quindi con il carico di significazione che questo comporta.
La letteralità è l’illusione di poter arrivare a toccare direttamente almeno quelle cose che sono le parole, senza pagare lo scotto che già lamentava la Sontag. Eppure, nel momento stesso in cui Ponge, e Gleize, e gli autori di Prosa in prosa spoetizzano il linguaggio, si stanno già confrontando con l’ombra del linguaggio poetico, e da questa condizione non si esce. L’unico modo per uscirne sarebbe non fare letteratura: così come gli incroci di linee in giro per la città non sono opere di Mondrian, allo stesso modo le banalità dei discorsi quotidiani non sono le quartine da tavolino da caffè di Alessandro Broggi, così come il prodotto quotidiano delle deiezioni di Pietro Manzoni non è la sua Merda d’artista. Uscire dal dominio dell’illusione, come proporrebbe Daniel Buren, abolendo l’arte, impedendo le proiezioni soggettive sull’oggetto artistico, non riproporrebbe nessun accesso diretto al reale, ma semplicemente alimenterebbe l’illusione di poterlo avere, là dove l’arte, almeno, riconosce e ostenta la propria dimensione illusoria, rendendola discorso.
L’interpretazione in senso ermeneutico, esecrata dalla Sontag, è spesso davvero una jattura, e spesso a sua volta una mistificazione di carattere religioso-rivelatorio, come se il critico (novello ermeneuta biblico) potesse rivelare una profonda verità nascosta dell’opera d’arte. Io condivido con Inglese la propensione, piuttosto, a un atteggiamento più vicino al misticismo, all’evitare di spiegare, all’evitare di cercare profonde verità nascoste. Ma di interpretare, in senso semiotico, non possiamo fare a meno. La nostra stessa azione per mezzo degli oggetti è sempre interpret-azione. E non è possibile fermare l’interpretazione al primo passo, quello letterale, specialmente quando ciò che dobbiamo interpretare si presenta come operazione artistica. Senza voler arrivare alle verità profonde, di cui facciamo volentieri a meno, il percorso su cui un’opera d’arte ci conduce è evidentemente un percorso interpretativo: accanirsi contro le immagini, accusandole di tutti i mali della poesia (o della pittura, prima) è come prendersela con i migranti per i mali dell’Italia. Un falso bersaglio, insomma, per uno scopo politico (di solito, in campo artistico, almeno meno becero di quello di Salvini). Per questo, anche solo come polo tensivo, la letteralità non è desiderabile.




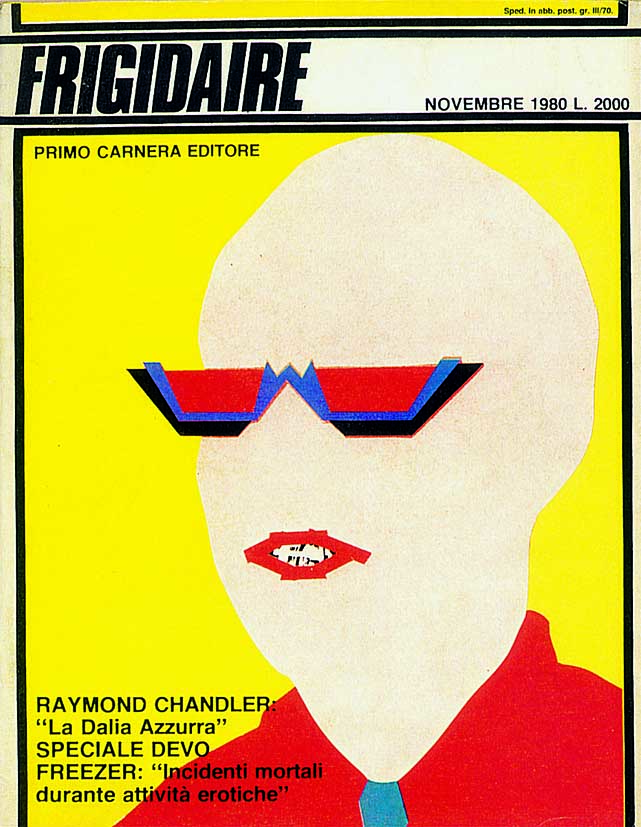




 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email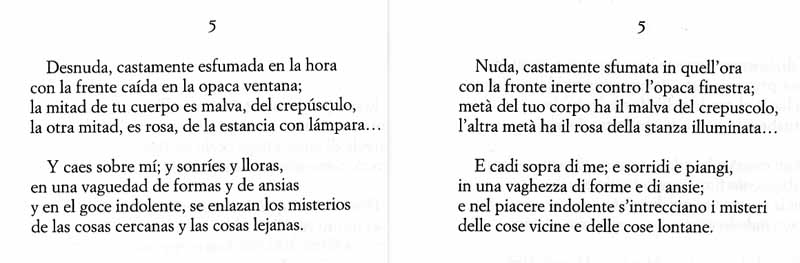




Devo aggiungere una nota, perché il post di Andrea mi ha permesso di chiarire una questione che restava sospesa dal 2012. Sono ricapitato per caso (ma i casi sono sempre guidati da un qualche interesse vagante dovuto a sollecitazioni recenti) su un paio di miei post di allora, con tanto di discussione con Marco Giovenale e lo stesso Andrea. I post sono questo, che a sua volta risponde a questo, il quale a sua volta rispondeva a questo post di Marco Giovenale. Tutti i post sono correlati di ampia e decisiva discussione.
Nel dibattito del post più recente, Marco suggeriva che io, come critico, non riuscissi a cogliere alcuni aspetti specifici della poetica degli autori di “Prosa in prosa”, e io ammettevo che fosse possibile; tuttavia, poiché non li coglievo, non potevo discutere su quelli, e finché non li avessi colti la mia posizione non poteva che rimanere critica.
Direi che ora, grazie all’articolo di Andrea, posso sospettare che ciò che non coglievo fosse proprio il principio di “letteralità”, il quale, se fosse accettabile, giustificherebbe certamente il lavoro di Zaffarano e Broggi (che erano, nelle specifico, i miei bersagli polemici). Direi anche che, poiché – come mostrato qui sopra – non posso accettare quel principio, questo spiega molto bene la mia incapacità di comprendere quelle posizioni di poetica. Ora so, grazie all’articolo di Andrea, che non posso comprendere quelle posizioni perché le trovo insostenibili; e per questo non potevo allora immaginare che le si potesse sostenere.
Detto questo, è buffo che la risposta a un problema sospeso si riveli solo a distanza di sei anni. Ma a volta non ne bastano sessanta, e a volte nemmeno seicento. La storia della cultura è una storia di inerzie. Se non ci sono risposte chiare gli errori non possono che perpetuarsi; e purtroppo spesso lo fanno anche se le risposte chiare ci sono. Basta che esse non possiedano sufficiente forza politica per opporsi a quelle che già sono impostate. (E non sto parlando solo di grandi mainstream: pure i mainstream piccoli o piccolissimi funzionano così. Anche gli errori nelle idee alternative si perpetuano con facilità)