Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.


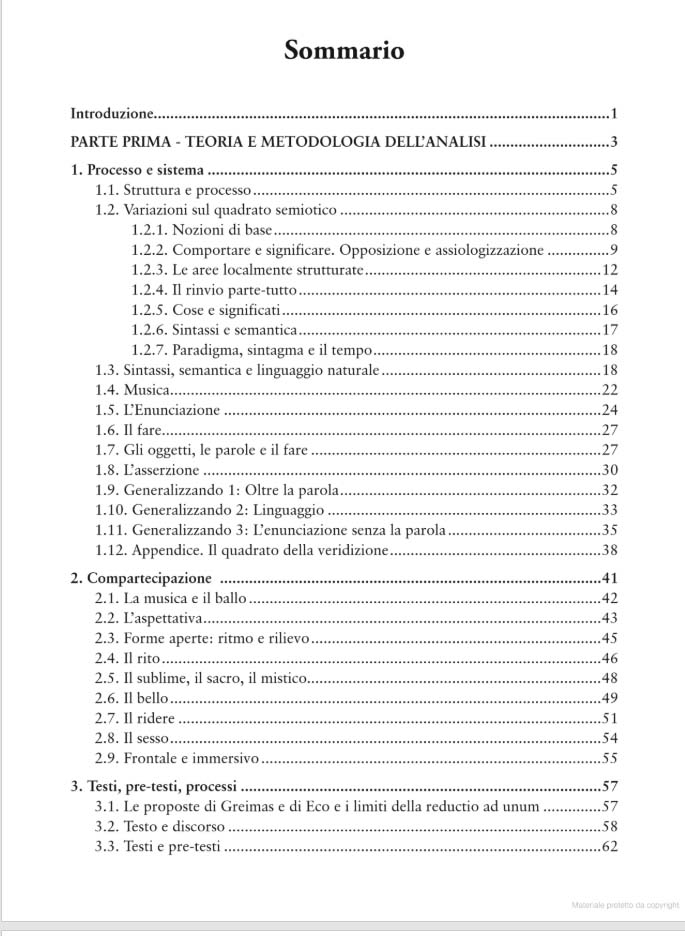
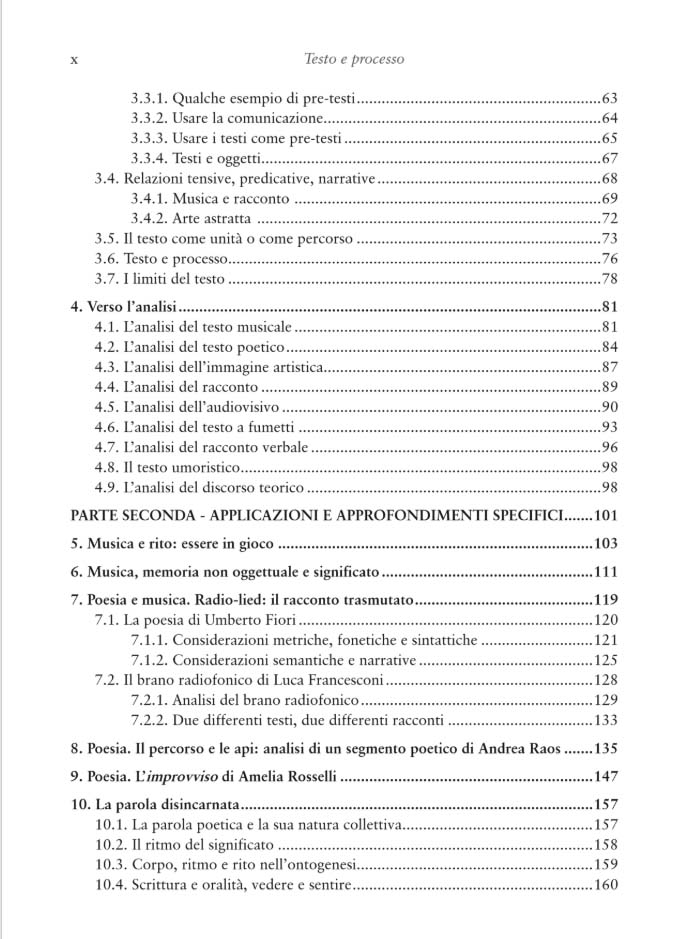
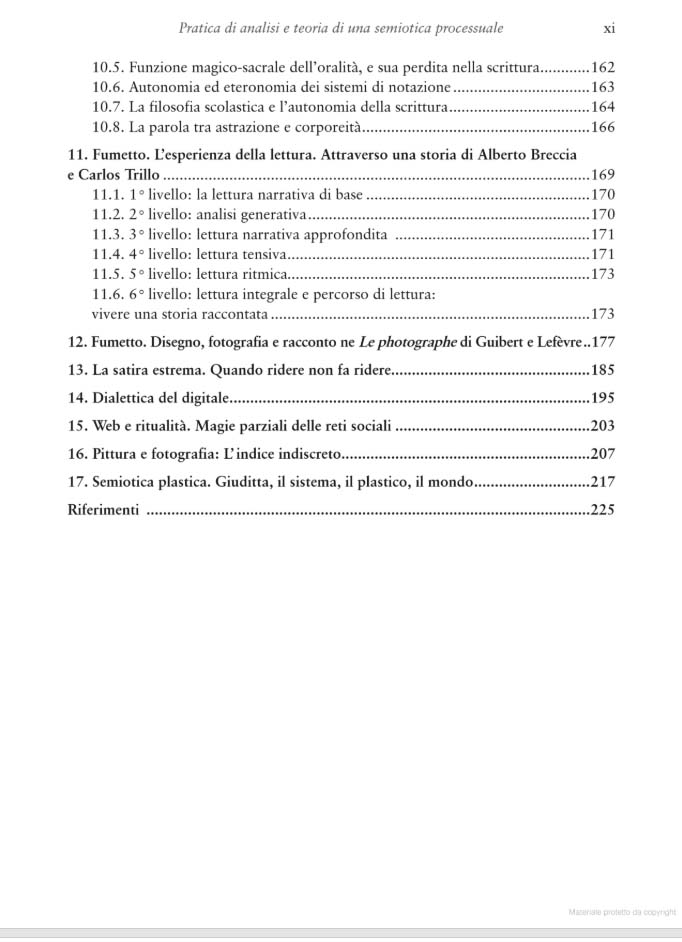

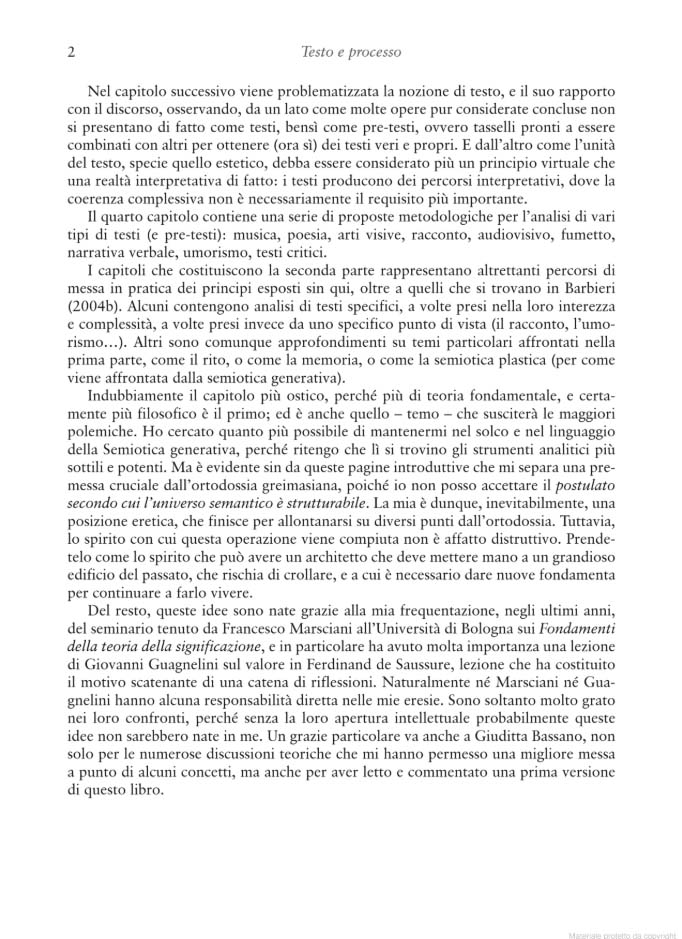
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore.
|
|
||
|
Ecco il mio nuovo libro, che, in tempi di coronavirus, rischia di finire dimenticato.
Lo si trova comunque su Amazon, ma anche – meglio – sul sito dell’editore. Continuo le riflessioni sulla ritualità del testo poetico esposte in questo post. Si diceva che la poesia deriva la sua dimensione sacrale dal porsi come una situazione rituale, in cui il lettore dà vita al testo scritto leggendolo (almeno interiormente) ad alta voce, e così vivendolo, in sintonia ritmica con tutti gli altri lettori del medesimo testo, passati e futuri. Per funzionare, la poesia richiede dunque al suo fruitore un fare, una posizione cioè più attiva del semplice scorrimento con gli occhi cui siamo abituati nel leggere normale prosa. Ma, che cosa succede quando la poesia viene letta ad alta voce da altri, e recepita solo attraverso l’udito? Ci sono diversi ordini di problemi. In primo luogo c’è una potenziale riduzione di comprensibilità. Da secoli, i testi poetici sono fatti per essere fruiti prima di tutto attraverso lo sguardo, un senso globale, che permette in qualsiasi istante di rallentare o interrompere la sequenzialità, per magari tornare indietro, rileggere quanto non era chiaro, confrontare visivamente parti diverse del testo… L’ascolto non permette nulla di tutto questo: siamo vincolati al flusso. Se il recitante è bravo, ovviamente, saprà aggiungere, attraverso l’intonazione, strumenti di interpretazione, almeno in parte riducendo i problemi. Ma non potrà mai arrivare a restituirmi quello che il testo scritto mi avrebbe potuto dare. Permettere all’ascoltatore di leggere autonomamente il testo scritto mentre il recitante lo esegue risolve questo problema. In questo modo non si perde quello che lo sguardo può cogliere dalla versione scritta, e si acquista quello che una buona voce sa dare. In alternativa, bisogna che la poesia sia stata scritta appositamente per l’oralità, pensandola davvero come un meccanismo sonoro. Tali sono, per esempio, i componimenti di Lello Voce, la cui versione scritta non è in realtà che un palinsesto, un canovaccio, un supporto per la memoria, uno spartito. Una poesia pensata per la voce finisce per essere diversa da una pensata per l’occhio, e, inevitabilmente, si allontana da una tradizione basata sulla scrittura. Il secondo ordine di problemi riguarda la dimensione rituale. Se il lettore autonomo entra nella dimensione rituale attraverso il proprio fare, la propria attività pratica come lettore, cosa ne sarà di tutto questo se questa stessa attività gli viene sottratta da un recitante diverso da lui stesso? La ritualità del semplice ascolto è molto più debole di quella della recitazione diretta. A meno che il fare dell’ascoltatore/spettatore non possa riproporsi in diverso modo. Ascoltando musica, per esempio, possiamo ballare, o andare a tempo, o canticchiare tra noi la melodia che sta venendo eseguita. Sono tutti modi attraverso i quali l’ascoltatore si fa attivo, partecipe, e vive la musica avendo almeno una piccola parte nel suo farsi. Ma può la poesia recitata produrre effetti di questo tipo? Di nuovo, la simultanea visione del testo scritto permetterebbe di indebolire il problema, rimettendo in gioco le componenti visive altrimenti escluse. Ma che succede con una poesia radicalmente orale, come negli esempi fatti sopra? La mia sensazione è che le componenti di prevedibilità di un testo poetico siano troppo inferiori a quelle di un brano musicale, per poter permettere una partecipazione attiva sin dal primo ascolto. Probabilmente ascolti ripetuti permetteranno l’istanziarsi della situazione di tipo rituale, perché l’ascoltatore/spettatore ha intanto memorizzato almeno in parte i testi, e può ripeterli (liturgicamente) con il recitante. Quando la poesia era sostanzialmente orale, la situazione era un po’ di questo tipo. Un po’ i testi erano noti, e un po’ la poesia era musicata, cioè era canto, musica. Ma ora che la poesia è sostanzialmente scritta, se la poesia orale non recupera in qualche modo una dimensione musicale, è destinata a perdere la componente rituale, rimanendo puro spettacolo, performance altrui, in cui, come nel teatro o nel cinema, si è attori oppure spettatori, di qua o di là dalla barricata, e comunque non compartecipanti. Certo, la poesia resta conosciuta come tale, e il carattere sacrale che le viene dalla dimensione rituale può restarle attaccato addosso anche là dove la situazione rituale è stata annullata. Ma questo vale perché la situazione rituale della lettura personale è la norma, oggi, mentre la recitazione altrui ad alta voce rimane un’eccezione. Se le parti si invertissero, la poesia subirebbe un cambiamento di status che la porterebbe a essere molto più vicina al teatro – il quale deve, faticosamente, ricostruire la propria dimensione rituale in altri modi, ritualizzando anche la partecipazione come spettatore. Oppure, per sopravvivere, la poesia dovrebbe trasformarsi in musica, e diventare, per esempio, canzone d’autore. Ma qui insorgono altri guai…
Oggi siamo andati qui, alla baia di Palionissos. Dieci km da Emborios, a piedi, con salita sino a 300m e relativa discesa di là. Ci siamo svegliati alle sei, per camminare col fresco. La salita non è stata faticosa, e il panorama era spettacolare: Kalymnos è un’isola molto frastagliata, e qui davanti è pieno di isolette. Quindi gran combinazione di coste, e aperture e chiusure sul mare aperto, a seconda della posizione e dell’altitudine. Davanti a noi, di là dalla baia, il roccione sporgente della penisoletta di Kastelli, che probabilmente deve il suo nome non tanto al fatto che ospitasse un castello, quanto – io credo – perché il roccione a torre sembra proprio un castello, enorme e favoloso. Tutta la salita è stata all’ombra. La parete è rivolta a sud-ovest, mentre il sole era sorto a nord-est. Al passo siamo emersi nel sole, ed è anche piacevolmente iniziato un po’ di vento. Dopo un paio di curve si è aperta una veduta spettacolare di Leros, l’isola immediatamente a nord. Poi è passato un furgoncino, con dentro una specie di astronauta. Dopo un attimo di perplessità ho capito che si trattava di un apicultore, e mi sono domandato perché si proteggesse anche dentro l’abitacolo. Dopo un minuto ne è passato un altro, che ci ha fatto dei gran segni di coprirci, perché avevano appena preso il miele alle api, e queste erano un po’ arrabbiate. Ci siamo un po’ coperti, ma c’è voluto un po’ per capire che stavamo andando diretti a metterci nei pasticci, insomma, avanzando spediti verso il pericolo. La prima ape mi è arrivata in faccia: mi ha punto la guancia in due punti ed è andata a strapparsi l’aculeo nella pelle della mia nuca. Ho affrettato il passo, ma non sapevo che mi stavo lanciando nella tana del lupo. Dopo un centinaio di metri avevo sei o sette api che mi ronzavano attorno, con un’aria piuttosto aggressiva. Una mi ha punto ancora, su un braccio. E io ancora più veloce, sperando di superare in fretta il punto critico. Daniela si era coperta con l’asciugamano da spiaggia, bianco, ed era uscita dalla strada. Ogni tanto si dimenava imprecando e sbattendo l’asciugamano: ovviamente anche lei veniva punta. Mi sono accorto che da lì in poi le arnie aumentavano ancora. Allora mi sono fermato e sono tornato un po’ indietro. Mi sono messo sulla testa l’asciugamano bianco anch’io. Siamo stati fermi. Ma immaginate di avere intorno a voi, al vostro viso, una piccola nube di api evidentemente piuttosto inferocite. Si cerca di non perdere la calma, ma non è facile, specie quando un’ape supera la rudimentale protezione del telo da bagno e vi va sull’occhio, o sulle labbra. La calma svanisce di colpo, allora, e tutto diventa frenesia di sbattimento dell’asciugamano, e agitare le mani per tenere le bestiole lontane dalle parti vitali. Sono passate due moto. Le api intorno a me scompaiono di colpo. Che abbiano preferito seguire quelli in moto? Tiro un sospiro di sollievo, ma dopo qualche minuto la nube si torna a formare. Un’ape si lancia all’attacco, entra nella fessura e mi punge sul naso, sulla narice sinistra. Dopo un poco un’altra conquista la mia fronte. Chiudo l’asciugamano più che posso, ma ovviamente entrano da sotto. Quella che si posa sulla mia guancia riesco con la mano a buttarla a terra, e poi la pesto. E’ la mia unica vittoria. Poi, finalmente, non so dopo quanto tempo, passano un furgoncino e una macchina. Ci buttiamo per fermarli, urlando “bees, bees”. Sulla macchina ci sono due ragazze italiane, a cui possiamo spiegarci; e ci fanno salire, sigillando poi i finestrini. Fine dell’avventura. Ora si scende senza difficoltà a Palionissos, in pochi minuti. Le due ragazze discutono un attimo su come evitare Nicolas, il ristoratore che conosce tutti per nome e ferma tutti. Ma tanto noi vogliamo fermarci a bere un caffè, e quindi le ragazze concludono che possono farla franca a nostre spese. In effetti Nicolas ferma davvero tutti quelli che passano a piedi per lo stradello che porta al mare, a metà del quale sta la sua taverna, rivolgendosi a ciascuno nella sua lingua. Parla italiano, francese, inglese e tedesco abbastanza bene (l’ho sentito), e ha detto che parla pure svedese e sta studiando lo spagnolo e il turco. Tutto, ovviamente, per agganciare i turisti. Nicolas ha fatto l’insegnante elementare per molti anni, poi si è trasferito a Palionissos. E’ riuscito a farsi costruire e asfaltare la strada, facendo arrivare sul luogo molta più gente. Così, per qualche anno la sua taverna è andata a gonfie vele. Anche troppo gonfie, così che altri hanno aperto altre due taverne, però direttamente sul mare, mentre la sua è almeno a 300m nell’interno. Due taverne una di qua e una di là dalla baia, con gran veduta e arietta fresca. Per questo motivo, Nicolas è ora costretto ad agganciare tutti quelli che passano, a raccontare la sua vita e mostrare le sue foto, in modo da stabilire un rapporto umano e implicitamente costringere i turisti a tornare lì, quando sarà ora di pranzo. E così abbiamo fatto noi. Abbiamo mangiato bene, però la mussakà di ieri era migliore della sua di oggi, e forse le spugne marine che ci ha venduto non erano proprio a buon prezzo. Ma Nicolas è molto gentile, e sa farsi apprezzare. La baia di Palionissos è bella e stretta, con attorno montagne alte e aspre, come sempre qui. Ci siamo sdraiati sotto un’opportuna tamerice, molto grande e ombrosa, vicino a una coppia di anatre che salivano e scendevano nello specchio d’acqua davanti a noi, un piccolo molo con una barca, prima del mare vero e proprio. Sono passate alcune ore pigre, con un bagno nell’acqua molto limpida e la gita da Nicolas per il pranzo. Le punture delle api hanno smesso abbastanza rapidamente di bruciare (è adesso, molte ore dopo, che torno a sentire indolenziti alcuni di quei punti). Sono andato avanti nella lettura del primo dei libri che mi sono portato dietro: Sacrosanctum, di Roberto Tagliaferri. Un libro di teologia, o qualcosa del genere. Dunque, perché io, che sono non credente dall’età di sedici anni, leggo libri di teologia? Dovrei dire, in realtà, leggo libri di Tagliaferri, perché sono soprattutto quelli il mio contatto con la teologia, ma in verità ce ne sono anche altri, specie sul tema del misticismo. Diciamo che trovo una convergenza interessante tra questi temi e quelli della fruizione estetica, e ci sono in certe posizioni teologiche delle idee molto fertili applicabili al senso dell’arte. Ho scoperto Tagliaferri perché si occupa di rito, che è un tema che ha iniziato a interessarmi perché è contiguo a quello del ritmo, di cui mi occupo da anni. E’ andata a finire, tra l’altro, che Tagliaferri sta anche pubblicando un libriccino sul ritmo, che avrà la mia Prefazione. Tagliaferri non è solo un teologo, e professore di liturgia a Santa Giustina (Padova). E’ anche un prete. E ci sono alcune cose che non capisco. Non perché sia un prete esemplare: come prete è decisamente anomalo. Ma resta tale, e quindi evidentemente credente, e non ci sono dubbi su questo. Il libro, Sacrosanctum, affronta il problema del sacro e del santo nel cristianesimo e nella cultura contemporanea. Inizia con alcune rassegne di posizioni sul tema: prima ci sono le posizioni dei teologi, che, con poche eccezioni, hanno screditato il sacro in quanto comune a tutte le religioni, specie le antiche, in nome di una diversità e novità del cristianesimo. Poi ci sono quelle dei fisicalisti, o scientisti: i filosofi o scienziati alla Dennett o alla Dawkins che sostengono l’assurdità della religione (e del sacro) in nome della posizione materialista, nella quale queste cose non trovano posto. Poi si prosegue con altri autori più vicini alla fenomenologia, come Gregory Bateson, che, senza essere religiosi, danno un certo rilievo al tema del sacro, considerandolo come un apriori, o come Roy Rappaport, che vede nel rito l’origine del sacro, e nella coppia rito/sacro la base stessa della vita sociale (il suo librone su questo tema sarà la mia prossima lettura estiva). E poi si arriva ai fenomenologi veri e propri, in particolare Husserl, ma anche lo Heidegger giovane (1920) del saggio sulla religione, e il teologo Rudolf Otto. E la mia lettura si è, al momento, fermata qui. Nel leggere la parte sugli scienziati fisicalisti (o naturalisti, come preferisce chiamarli Tagliaferri), non ho potuto fare a meno di portare avanti questa riflessione: c’è qualcosa che unisce strettamente la posizione scientista (fisicalista, naturalista) a quella del credente cristiano, a dispetto dell’ateismo della prima. Si tratta del problema dell’esistenza di Dio, negata o asserita che sia. La si asserisce in nome della fede (strana parola, in effetti), la si nega in nome della materia, in cui Dio non trova posto. Eppure anche l’ateismo costruito in questo modo si basa su una fede. A metà del Settecento, David Hume dimostrò l’infondatezza dell’idea di causa, mostrando con chiara evidenza che non è possibile osservare la causa in natura, nella quale si osservano solo fenomeni in sequenza, magari in sequenza regolare, ma non direttamente cause ed effetti. Cinquant’anni dopo, Kant risolse genialmente il problema portando la causa all’interno del soggetto che comprende e interpreta: la causa sarebbe cioè per Kant un a-priori, un trascendentale, qualcosa che noi applichiamo in maniera automatica alla spiegazione dei fenomeni naturali, ma che non è in natura, bensì in noi, nel nostro modo di conoscere il mondo. I fisicalisti scientisti sembrano aver dimenticato oggi Hume e Kant, e si comportano come se le cause esistessero in natura. La loro è una vera fede (nel senso cristiano) nell’esistenza della causa, perché non vi è modo di dimostrare la sua esistenza (o non esistenza) in natura. Bisogna credere che la causa esista materialmente per poter essere davvero materialisti in questo modo – un modo che a me appare davvero ingenuo, a questo punto. La fede del materialista nell’esistenza della causa è strettamente speculare a quella del cristiano nell’esistenza di Dio. Materialista e cristiano parlano lo stesso linguaggio, condividono le medesime premesse, solo che uno ha fede nell’esistenza della causa, e l’altro ha fede nell’esistenza di Dio. Una fede vale l’altra, verrebbe da dire. Eppure, se, insieme alla causa, considerassimo trascendentale non solo il sacro ma anche l’idea stessa di Dio? Questo vorrebbe dire che Dio non si trova nella natura, materialmente o spiritualmente, immanentemente o trascendentemente, bensì dentro di noi, nelle forme stesse della nostra conoscenza, ed esiste nel senso stesso in cui esiste la causa, ovvero come modalità di comprensione del mondo. Penso che potrei accettare un’esistenza di Dio intesa in questo modo, tuttavia è evidente che un Dio trascendentale sarebbe qualcosa di ben diverso da un Dio trascendente! Sarebbe, prima di tutto, una forma del nostro rapporto con il mondo, dove l’espressione “nostro” andrebbe presumibilmente a comprendere non solo l’universo umano, bensì, batesonianamente, tutto l’universo del vivente, quello che lo stesso Bateson chiama la creatura. Si potrebbe fondare il cristianesimo su un Dio trascendentale (ed eventualmente trascendente solo attraverso e all’interno del trascendentale)? Io ne dubito fortemente, anche se ho già trovato un’idea simile in un altro teologo singolare, Raimon Panikkar, che sostiene che la religione, o almeno la teologia, ha finalmente superato il problema dell’esistenza di Dio; e credo che Panikkar alludesse a posizioni simili a quella che sto descrivendo (il libro in cui ne parla è Mito, fede ed ermeneutica). Bene, tornando a Tagliaferri, ecco che trovo nel suo libro, nelle pagine dedicate a Husserl, esattamente le conclusioni a cui ero arrivato poco prima, e l’esplicita descrizione di un “trascendente trascendentale”. Ora, se da un lato questo rafforza la mia convinzione che la posizione di Tagliaferri è davvero interessante, dall’altra mi conduce a domandarmi come possa essere questa la posizione di un cristiano, di un credente, di un prete. E’ davvero possibile negare il problema dell’esistenza di Dio (il problema stesso, non la sua risposta!) permanendo ugualmente all’interno di una Chiesa che ha fatto di tale esistenza il suo cardine per duemila anni? Era già stata la posizione di Rudolf Otto, autore, negli anni Dieci del Novecento, di un libro sul sacro che ebbe grande influenza sul pensiero di Husserl, e su varie scienze della religione dei decenni successivi sino a oggi. Non c’è dubbio che la religione regga benissimo queste posizioni, ma l’idea di Dio non va un po’ a ramengo quando la si riduce a trascendentale, ovvero quando ci si rende conto che non c’è altro modo di mantenerla, perché l’idea della sua esistenza nel mondo (materiale o trascendente) è insostenibile? Perché Rudolf Otto e don Roberto Tagliaferri possono continuare a ritenersi cristiani, mentre io, che sembro pensarla come loro, non mi sento cristiano e potrei definirmi soltanto agnostico? Questa riflessione conclusiva (per ora) viene fatta verso le 23.30, sul tavolino davanti la mia stanza, in una bella serata né calda né fredda. Si sta semplicemente bene. Forse per via dello zampirone tra i miei piedi non sono stato nemmeno disturbato dalle zanzare. Domani giornata tranquilla, giri piccoli, mare, lettura. Kalinikta. Devo a un piccolo dibattito con Lello Voce (iniziato qui e poi proseguito in privato) la lettura che sto facendo di Paul Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale (Il Mulino, 1984). Vi ritrovo molte cose che mi sono note, ma anche delle osservazioni interessanti, e qua e là annotazioni che mi stimolano la riflessione. A un certo punto Zumthor fa un accenno alle situazioni di diglossia, dicendo (p. 170) che “quando regna una situazione di diglossia, una delle due lingue può farsi carico, sotto la spinta delle circostanze e grazie all’iniziativa di alcuni individui, di una funzione poetica particolare: si pensi ad esempio al joual dei cantanti del Québec intorno al 1970, in un contesto di rivendicazione nazionale… […] O si pensi ancora a certe canzoni parzialmente o interamente in bretone di Gilles Servat o di Alan Stivell” (il joual è una varietà popolare del francese del Québec). La mia attenzione si è fatta qui acuta e non ho potuto fare a meno di domandarmi in quante tradizioni sia o sia stata presente una seconda lingua dedicata alla ritualità, di carattere sacro: il latino per l’Europa, l’ebraico per l’antichità che parlava aramaico, il sanscrito per l’India, o tutte le lingue sacre sciamaniche, come quella di cui descrive l’uso Carlo Severi (in Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, Einaudi 2004, pp. 227 segg.) parlando del rituale del parto difficile dei Kuna. Nel rituale di guarigione descritto da Severi (è lo stesso di cui parla Lévi-Strauss nel noto articolo sull’efficacia simbolica contenuto in Antropologia strutturale) la partoriente comprende solo in piccola parte le parole dello sciamano, il quale parla una lingua differente, esoterica, solo in parte coincidente con quella di uso quotidiano. Ma il rituale funziona lo stesso, un po’ come se la donna proiettasse, come su una sorta di macchia di Rorschach, quello che desidera intendere realmente. Credo che questo funzionamento proiettivo, alla macchia di Rorschach, sia comune a tutte le situazioni rituali in cui entra in gioco una seconda lingua, diversa da quella corrente (latino, ebraico, sanscrito o qualsiasi altra). C’è naturalmente chi (come i sacerdoti) è pienamente in possesso del codice e dunque pienamente in grado di interpretare, ma il rito funziona anche nei confronti di coloro che capiscono poco o nulla. Sono altri fattori, di carattere ritmico e compartecipativo, a garantirne il successo; non esclusa l’oscurità stessa delle parole, garanzia, per il normale partecipante, che si sta avendo accesso a una dimensione differente, quella, appunto, del sacro. La poesia orale di cui parla Zumthor sembra essere assimilabile più facilmente all’ambito della canzone, cioè a un ambito in cui la funzione rituale (su base ritmica e compartecipativa) è sostanzialmente delegata alla musica. Io stesso, quasi come i francesi di Bretagna, ascolto Alan Stivell, e capisco e partecipo quasi come loro. Per questo penso a Stivell come a un musicista, e non come un poeta. Nel medioevo, prima di arrivare a essere in volgare, la poesia era inevitabilmente in latino. E la poesia veniva cantata, e non esisteva la separazione che per noi è del tutto corrente tra le due. Quando la poesia assume le forme della lingua volgare aggiunge di colpo al proprio appeal i vantaggi della comprensibilità, ma cerca di non perdere quelli della ritualità. Per questo, per esempio, conserva e coltiva assiduamente la propria metrica, permettendosi di trasformarla nel tempo solo quando è certa che le innovazioni non vanno a inficiare la sua forza rituale di fondo. Questa forza rituale tende a conservarsi anche quando la poesia non è più legata alla religione, e persino quando non è più legata strettamente all’oralità. I riti si trasformano, sono ormai del tutto diversi da quelli di qualche secolo fa; ma sono nondimeno riti, che richiedono la parola (almeno in una pronuncia interiore, che però mantiene tutta la sua durata). Della poesia non si danno riassunti, né lettura puramente ottica (come quella che state facendo di queste parole), senza pronuncia almeno interiore. Con tutte le sue trasformazioni, la poesia conserva gelosamente non solo le strutture metriche, ma anche il proprio esprimersi in una lingua speciale, diversa, sacralizzata dallo stesso contatto con la poesia. È la lingua della poesia, una lingua che, per noi, ha le stesse regole di base e quasi lo stesso lessico dell’italiano, ma un uso che può essere anche molto differente da quello della prosa o del discorso quotidiano. Questa necessità di separazione dalla lingua ordinaria ha certo anche relegato la poesia in un ambito particolare. Sappiamo bene come l’enfatizzazione di questa differenza abbia segnato l’Ottocento poetico italiano sino a D’Annunzio; sino a provocare la reazione dei Crepuscolari e di ciò che ne è seguito. Ma si noti bene che il Novecento non è sfuggito al principio della diversità della lingua poetica: in un contesto in cui la separatezza della lingua poetica è la norma, persino la parlata colloquiale di Corazzini e Gozzano può apparire come una separatezza: è, perlomeno, infatti, la separatezza dalla separatezza. Ma persino in loro, in realtà, la riacquisizione del linguaggio quotidiano è parziale. Per quanto infatti ci si provi a utilizzare le parole e le strutture sintattiche di ogni giorno, l’immissione medesima in un contesto di versi e di a capo forzati, e di pertinenza dei fenomeni prosodici e fonetici, rende inevitabilmente differenti quelle parole e quelle strutture. Tanti poeti del Novecento poi non si sono affatto riavvicinati alla lingua quotidiana, preferendo semmai cercare un linguaggio rituale differente anche da quello dei propri predecessori, ma indubbiamente riconoscibile come rituale. In questo indimenticabile inizio del suo Laborintus, Edoardo Sanguineti faceva esattamente questo – avendo presumibilmente come riferimento negativo la lingua separata dei poeti ermetisti, con tutta la sua ripresa ottocentesca e dannunziana. Non tutto è comprensibile in questi versi, né tutto vuole essere comprensibile. Non è solo l’intromissione di parole dal latino a creare questa oscurità: l’intera costruzione sintattica, la scelta di parole inconsuete o inconsuetamente utilizzate, l’assenza di punteggiatura, mirano a una costruzione oscura. In questa oscurità semantica, l’andamento liturgico della recitazione rimane l’elemento dominante. Proprio come la partoriente kuna in presenza del suo sciamano, noi comprendiamo solo in parte, solo qua e là, per sprazzi, ma il ritmo ci prende lo stesso, ci coinvolge, ci trasporta in una realtà che si sta sviluppando, della quale cogliamo faticosamente elementi noti e fascinosi, e ci costruiamo il nostro racconto, la nostra personale veduta, ci immergiamo nella Palus Putredinis del Senso e della Storia. Tanto più potente è la parola poetica (e qui lo è moltissimo) e tanto più ricco e intrigante sarà il racconto che possiamo ogni volta costruire sulla base di quello che si presenta ai nostri occhi, o risuona alle nostre orecchie. Se invece di leggere con gli occhi stessimo ascoltando una voce recitante, dovremmo essere consapevoli che la possibilità di cogliere il senso effettivo delle parole è ancora, ulteriormente, ridotto, perché la voce corre, e non può ritornare indietro nel testo come l’occhio può fare. La voce può però aggiungere sfumature al suono, può dare corpo al ritmo, può dare musica alla prosodia; può insomma rendere ancora più concreta e avvolgente la situazione rituale. Se cercate soluzioni, la poesia non è cosa per voi. La poesia si limita ad avanzare proposte, o addirittura accenni di proposte, che ciascuno farà sue a modo proprio. Nel frattempo, proprio nel seguire il suo percorso e nello sforzarci di sentirlo e di dargli un senso, ci ritroveremo in sintonia rituale con tutti coloro che stanno compiendo (o hanno compiuto, o compiranno) la medesima operazione. Molto più che comunicare, la poesia è infatti fare, poiein, anche quando la si sta solo fruendo. E tanto meno la poesia comunica emozioni; al massimo, qualche volta, le produce. . Non posso negare un poco di emozione. Ieri sera, nel tornare a casa ho trovato un pacco con le copie di spettanza del mio nuovo libro. Ho controllato nelle librerie on line, ed è già in vendita. Non sono riuscito ad andare a vedere in quelle tradizionali, ma se ancora non c’è è questione di giorni. Per dare un’idea di che cosa si tratta, ecco qui di seguito l’Indice del volume e l’Introduzione. Se cliccate qui o sulla copertina a sinistra, potete vedere la scheda del libro sul sito Bompiani. .
Introduzione0.1. LinguaggioArgomento di questo libro è il linguaggio della poesia. La parola linguaggio, certo, può essere intesa in sensi abbastanza differenti: quando si parla, per esempio, del linguaggio di Alessandro Manzoni si può fare riferimento alle sue preferenze lessicali e di costruzione sintattica; ma quando si parla del linguaggio dell’arte visiva, o del linguaggio della musica, stiamo evidentemente parlando d’altro. Si parla persino del linguaggio delle api, o del linguaggio del DNA – e non abbiamo la sensazione che si tratti di estensioni metaforiche dell’uso di questo termine. È bene puntualizzare da subito che l’oggetto di questo libro non è il linguaggio della poesia nel senso delle sue scelte lessicali e di costruzione sintattica. Anche di questi aspetti, senza dubbio, si parla in queste pagine – ma è piuttosto l’altra accezione di linguaggio quella che ci riguarda, quella che avvicina il problema del linguaggio della poesia a quello del linguaggio dell’arte visiva, o della musica, o persino delle api. Per dirla con le parole più semplici possibili, l’oggetto di questo libro è il modo in cui la poesia comunica, o agisce su chi la legge. Questo modo è legato anche al problema delle scelte lessicali e sintattiche, ma è ben lontano dal ridursi a questo, così come il problema del linguaggio delle arti visive non si può ridurre al problema della scelta dei colori e delle forme, né il problema del linguaggio musicale può ridursi al problema della scelta delle note. Si potrebbe discutere a lungo se il linguaggio delle api contempli davvero l’uso di un codice. Da fuori, si direbbe che possa essere così. Ma, anche ammettendo che un codice vi sia, nessun linguaggio naturale, compreso quello delle api, si limita e può essere ridotto alla sua componente codificata. Quando pensiamo al linguaggio della musica lo vediamo con chiarezza: la musica comunica, non ci sono dubbi, ma la sua componente codificata è talmente ridotta che la maggior parte della comunicazione ne passa al di fuori. Ferdinand de Saussure (1922) ha parlato, a suo tempo, di fenomeni di langue – cioè legati alla componente codificata, più strettamente linguistica, del discorso verbale – e di fenomeni di parole – cioè dipendenti dalla situazione contingente, dalla particolare combinazione specifica di parole. Il significato delle nostre comunicazioni verbali è costituito sia da elementi di langue che da elementi di parole, e dunque il nostro linguaggio verbale è basato sugli uni non meno che sugli altri. Il linguaggio della poesia enfatizza questa componente, locale e idiosincratica, di parole. Fa uso della langue, evidentemente, in quanto fa uso delle parole della lingua, e quindi del loro significato codificato; ma si allontana da questa base molto, molto di più di quanto non faccia il linguaggio ordinario, e anche più di quanto non faccia la prosa letteraria. Il nostro intento, in queste pagine, è vedere da vicino alcuni degli aspetti di questo linguaggio della poesia, che prende il via dall’uso consueto della parola e arriva lontano.[1] 0.2. Comprensione, emozione e ritmoQuesto libro si occupa dunque del leggere la poesia, non solo del comprenderne il senso. Quando leggiamo cerchiamo sempre di comprendere, ma non leggiamo testi solo per comprenderli – cosa che è vera, in diversa misura, per tutti i tipi di testo, ma è particolarmente vera per i testi che hanno finalità estetiche: tra questi la poesia possiede un ulteriore statuto particolare. Per esempio, non leggiamo un romanzo solo per capirne il significato. Se non ne comprendiamo almeno a qualche livello il significato non lo stiamo in realtà nemmeno leggendo; e, certo, più a fondo lo comprendiamo e più intensa potrà essere la nostra esperienza di lettore. Ma se un romanzo non ci coinvolgesse emotivamente e non ci portasse con sé in un viaggio di sensazioni vivide e profonde, che ragione avremmo di leggerlo? Quanto ci importa dell’ideologia dei nichilisti russi di fine Ottocento? Il nostro scarso interesse per questo specifico tema non ci impedisce di leggere appassionatamente I demoni di Fedor Dostoevskij. E che a un gentiluomo francese vissuto circa un secolo fa sia un giorno capitato di mangiare un biscottino che ha scatenato la sua memoria e la sua ossessione grafomaniacale, è qualcosa di davvero interessante per noi? Non è davvero per sapere che cosa sia accaduto al signor Proust che leggiamo la Recherche. Dostoevskij, come Proust e come ogni altro scrittore di qualità, non ha mai pensato di produrre un semplice resoconto di fatti di relativo interesse. Ciò che ha fatto, piuttosto, è stato costruire un meccanismo emotivo, basato su questi fatti, in cui il lettore si possa immergere, e possa vivere, anche se in forma surrettizia, un percorso emotivo, con risvolti cognitivi (si impara senza dubbio un sacco di cose anche leggendo romanzi) ed etici. Della poesia si può dire lo stesso, però in misura ancora maggiore. Se un qualche interesse a priori per la storia russa o per la vita quotidiana francese di inizio Novecento possono talvolta costituire una ragione per leggere i romanzi di Dostoevskij e di Proust, non riesco proprio a immaginare perché mi dovrei interessare alle fantasie di un signorotto marchigiano di inizio Ottocento al guardare la siepe del suo giardino. E nemmeno trovo particolarmente interessante, in sé, il pessimismo leopardiano, che non è una filosofia di particolare originalità storica, e che nessuno si sarebbe preoccupato di studiare se non stesse alla base di alcune tra le poesie più straordinarie che siano mai state scritte. Ancora più che il romanzo, la poesia costruisce dentro di sé le proprie ragioni di interesse per il suo lettore. Essendo più breve, mira a costruire un’esperienza emotiva più intensa, e per farlo utilizza le risorse del linguaggio in maniera estrema, rendendo pertinenti aspetti che normalmente non lo sono o lo sono poco. Proprio come il romanzo, poi, ma con maggiore intensità, anche la poesia ci insegna qualcosa, ma lo fa a partire dall’esperienza emotiva che induce nel suo lettore. Questa collina solitaria mi è sempre stata cara, come pure quella siepe, che mi impedisce di vedere oltre. Eppure, se mi siedo e guardo, io mi immagino spazi senza fine al di là, silenzi eccezionali e una grande tranquillità, al punto che quasi mi spavento. E quando sento il vento muovere gli alberi, mi viene da fare il paragone tra questo fruscio e quel silenzio: e così penso all’eternità, al passato, al presente e ai suoi rumori. E in questo senso di immensità il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo. Questo breve racconto segue evidentemente la falsariga del discorso di Leopardi ne L’infinito. Potremmo considerarlo come una parafrasi molto libera del testo originale. Probabilmente non tutto il fascino del componimento leopardiano si perde, e qualche ragione di interesse interno continua a sussistere – ma questo testo non sarebbe mai passato alla storia emozionando innumerevoli lettori. Senza l’emozione non si genera l’interesse, e senza interesse non ci può essere acquisizione cognitiva. I meccanismi di sollecitazione emotiva ci interessano dunque per due ragioni: in primo luogo perché sono alla base di una migliore comprensione del significato del testo, e in secondo luogo perché non sempre possono essere ridotti a questo, e possiedono una propria autonomia e un proprio valore intrinseco. C’è una situazione in cui il mio pensiero si perde, e questo perdersi è un sentimento dolcissimo. Infatti, quando mi siedo di fronte a questa collina solitaria, a me molto cara, e guardo quella siepe che mi impedisce di vedere oltre, finisco per immaginarmi al di là di quella un’enormità di spazio e di silenzio, quasi spaventandomi per questo. Ma poi, se paragono queste sensazioni al suono del vento tra gli alberi, mi viene da pensare all’eternità e alle epoche, e provo un senso di immensità che mi fa smarrire. Confrontiamo ora questo breve testo con la parafrasi dell’Infinito proposta appena sopra. Qui non si può più nemmeno parlare di parafrasi, per quanto libera; al più parleremo di “liberamente tratto da”. Entrambe le versioni condividono con l’originale il mero resoconto dei fatti, ma la prima è abbastanza fedele all’originale anche per l’ordine in cui i fatti vengono esposti, e per il risalto che viene dato a ciascuno di loro, mentre la seconda stravolge sia l’ordine che il risalto. Per quanto poco conservi dell’esperienza dell’originale, la prima versione conserva di più della seconda, ed è in grado di produrre nel lettore un percorso emotivo che, per quanto molto più blando, assomiglia a quello dell’originale più di quanto gli possa assomigliare quello prodotto dalla seconda versione. La prima versione ha infatti (parzialmente) in comune con l’originale non solo un percorso discorsivo-narrativo ma anche un ritmo discorsivo-narrativo e un sistema di tensioni. Gli eventi raccontati si succedono grosso modo con lo stesso andamento e con lo stesso specifico rilievo, e producono quindi nel lettore un andamento di interesse simile. In poesia, tradizionalmente, quando si parla di ritmo si fa riferimento a una regolarità di andamento di carattere prosodico e fonetico (ovvero relativo al succedersi delle sillabe e dei loro accenti, nonché di suoni sufficientemente simili) o al massimo sintattico. Quando si parla di ritmo poetico, cioè, si fa tradizionalmente riferimento a eventi situati sul piano del significante (che la semiotica chiama, più propriamente, piano dell’espressione). Il ritmo discorsivo-narrativo si pone invece sul piano del significato (che la semiotica chiama piano del contenuto) e non è un fatto specifico della poesia: qualsiasi discorso verbale possiede un ritmo dell’esposizione dei propri concetti, qualsiasi racconto ha un ritmo narrativo, cioè un andamento del modo in cui gli eventi arrivano alla ricezione del fruitore.[2] Anche i ritmi prosodici, fonetici e sintattici non sono specifici della poesia; tuttavia, mentre nel discorso in prosa sono di solito semplicemente non pertinenti o poco pertinenti, in poesia la relazione di contrasto con la dimensione metrica (che è a sua volta una dimensione ritmica) li rende significativi e influenti. Il ritmo discorsivo-narrativo è influente in qualsiasi tipo di testo, ma in poesia esiste una relazione di contrasto con altri tipi di ritmo dell’espressione e del contenuto – come vedremo più avanti – che modifica e spesso magnifica questa stessa influenza. Analizzare la poesia e la sua efficacia emotiva significa dunque considerare non solo la dimensione ritmica tradizionale e la sua relazione con il metro, ed eventualmente le modalità in cui queste interagiscono con la dimensione del significato, ma anche tutta una sfera ritmica della dimensione del significato che produce effetti sia sul significato stesso che sul coinvolgimento emotivo diretto del lettore. A questo si aggiunge la comprensione del sistema di aspettative e tensioni messo in moto dalla poesia. Anche in questo caso, tutti i testi generano aspettative nel loro fruitore, ma la poesia lo fa con le sue specifiche modalità e i suoi specifici effetti. 0.3. Leggere, guardare, ascoltareIl leggere è naturalmente diverso dal guardare[3]. Certo per leggere è necessario guardare, ma qualsiasi guardare che non comporta un leggere è un guardare che segue regole diverse dal guardare per leggere. Nella sua bella storia dell’arte tipografica, Warren Chappell caratterizza come segue la differenza: Molti dei lavori più notevoli del Settecento, dalle Médailles dell’Imprimerie Royal del 1702 al Manuale tipografico di Bodoni, testimoniano di vere e proprie innovazioni tecniche: una migliore fusione e giustificazione dei caratteri, carta con superfici di stampa più omogenee, inchiostri migliori e migliore impressione. La stampa assunse l’aspetto dell’incisione a un livello stupefacente. La tendenza era iniziata con le grazie artificiali del romain du roi di Grandjean per raggiungere piena espressione nelle lettere drammatiche e rigide di Bodoni e di Firmin Didot. Tali forme sono meravigliosamente immobili. Il carattere e la pagina chiedono di essere ammirati – cioè guardati – e in ciò niente di male, se non fosse per il fatto che guardare e leggere sono due azioni piuttosto diverse, anzi in contraddizione. Siamo legati a quello che leggiamo da un movimento ritmico. Per guardare le cose, o le liberiamo lasciandole vagare, oppure le blocchiamo nel loro movimento. Guardando, tratteniamo il respiro oppure (nel peggiore dei casi) ansimiamo. Leggendo invece respiriamo. (Chappell-Bringhurst 2004:194) La differenza principale tra leggere e guardare è una differenza ritmica. Leggendo, respiriamo, ovvero seguiamo un percorso impostato in maniera più o meno diretta sui ritmi del respiro. Guardando, viceversa, seguiamo un percorso più o meno arbitrario a seconda del caso, ma in ogni caso del tutto indipendente da qualsiasi impostazione ritmica, in particolare da quella del respiro. Per dirla in un altro modo, la scrittura è sì qualcosa che si guarda, ma che non perde mai del tutto la relazione che intrattiene con la dimensione lineare e sonora della lingua parlata. E la lingua parlata è per sua stessa natura impostata sul respiro, è emissione di fiato, ritmata dalla necessità di inspirare l’aria necessaria per produrre i suoni delle parole. Come vedremo tra breve, questa ineludibile natura sonora della lingua agisce in qualche modo anche attraverso la scrittura, e riverbera sulla parola scritta le proprie qualità. La scrittura è però comunque un fatto grafico, ancor prima che sonoro. Di sicuro nella scrittura poetica la dimensione sonora procrastina la propria scomparsa molto più di quanto non faccia nella prosa – eppure sappiamo bene quanto i testi prodotti per essere letti con gli occhi siano differenti da quelli prodotti per essere ascoltati! E la poesia è fatta per essere letta o per essere ascoltata? In questo libro assumiamo che la poesia sia fatta prima di tutto per essere letta, ma che, di questa lettura, una sorta di “recitazione ad alta voce interiore” sia una parte così importante che anche l’ascolto vero e proprio può giocare il suo ruolo. Non a caso una gran parte delle pagine di questo libro è dedicata alla dimensione sonora evocata dal testo poetico. Di sicuro, la poesia è uno strano ibrido: gran parte dei testi poetici sono così complessi da pretendere di essere letti, piuttosto che ascoltati, per poter essere capiti; eppure per loro tradizione e natura sono così legati alla propria sostanza fonica da pretendere l’ascolto, almeno virtuale. Anche se dedicheremo molte pagine a questa sorta di ascolto che la poesia mette in scena, la natura scritta della poesia comporta inevitabilmente una certa rilevanza della sua dimensione visiva, ovvero di un qualche guardare che non si risolva in un leggere. La lunghezza media dei versi, la divisione in strofe, la posizione sulla pagina, sono elementi tradizionali del testo poetico che non hanno necessariamente un effetto diretto nella dimensione sonora. Quando Stéphane Mallarmé scrive il suo Coup de dés[4], distribuendo graficamente i suoi versi sullo spazio bianco della pagina, sta sviluppando una possibilità che esiste da quando la poesia è sostanzialmente una testualità scritta. Nessuna recitazione del poemetto di Mallarmé può esprimere compiutamente la differenza tra la sua impaginazione e quella tradizionale. Quindi, l’impaginazione ha un valore visivo proprio, indipendente dalla qualità sonora della poesia, un valore che dipende da un guardare che, pur se accompagnato da un leggere, non si risolve in quel leggere. All’esperimento di Mallarmé ne faranno seguito tanti, nel corso del Novecento, sino al costituirsi di una vera e propria poesia visiva, spesso molto più da guardare che non da leggere – anche se la componente della lettura non scompare mai del tutto. Questa dimensione puramente visiva, legata al guardare, secondaria ma non assente nella poesia tradizionale e talvolta primaria nella poesia più recente, richiede di essere esplorata. Anche la componente visiva, cioè, contribuisce al significato di un testo poetico e alla sua sollecitazione emotiva. La natura ambigua della parola scritta costituisce un campo di possibilità espressive che la poesia può sfruttare, anche quando gioca soprattutto sull’evocazione della dimensione orale. 0.4. Immersivo vs frontalePer capire la rilevanza specifica della dimensione orale, è necessario approfondire un poco le conseguenze delle differenze percettive che esistono tra visione e ascolto[5]. La visione ci pone di fronte a quello che vediamo. Noi vediamo le cose senza avere con loro necessariamente nessuna ulteriore relazione di carattere fisico: le vediamo senza che nessun tipo di contatto debba avvenire. È così che possiamo concepire le cose separatamente da noi stessi: questo siamo noi, quello è ciò che vediamo. La stessa metafora dell’“osservazione”, che si concretizza nell’osservazione di carattere medico, o nell’osservatore scientifico, rispecchia l’idea di un soggetto che percepisce (con attenzione critica) qualcosa che accade di fronte a lui. Nell’ascolto, viceversa, non ci troviamo di fronte a ciò che percepiamo. Il suono invade l’ambiente e quindi, prima di tutto, vi siamo dentro. E il suono invade anche noi, ci tocca in profondità, producendo vibrazioni nel nostro stesso corpo. Percepiamo queste vibrazioni certamente attraverso i timpani dell’orecchio, ma in molti casi (specie se i suoni sono bassi e molto forti) le percepiamo in tutto il nostro corpo. Non siamo dunque solo dentro al suono, ma il suono entra dentro di noi, facendoci vibrare insieme a ciò che suona. Un’esperienza frontale, come quella della vista, si contrappone dunque a un’esperienza immersiva; un percepire distaccato si contrappone a un percepire inevitabilmente compartecipe. Le metafore dell’ascolto, guarda caso, sono molto diverse da quelle della visione: in italiano, addirittura, abbiamo un verbo, sentire, che viene usato sia per la percezione dei suoni che per quella delle sensazioni ed emozioni: io sento una musica lontana, così come sento freddo, così come mi sento arrabbiato, turbato, innamorato. Attraverso lo scambio di suoni un animale non si limita a segnalare ai suoi simili la propria presenza, o a comunicare la presenza di un pericolo o la propria disponibilità sessuale. Nelle specie più evolute il suono può essere usato a scopo empatico. Le vibrazioni sonore della madre possono ricreare la sensazione di unione che il piccolo ha perso con la nascita, e calmare il suo pianto o la sua paura; con le grida si può trasmettere l’eccitazione o la stessa paura, e comunque rafforzare il senso di appartenenza a una comunità, con la quale, appunto, ci si trova in sintonia. Non c’è ragione di pensare che questa funzione empatica si perda quando nella specie umana il suono si evolve in linguaggio. Il comprendere il significato delle parole non inibisce il nostro vibrare al loro suono. Analogamente abbiamo ragione di pensare che la musica stessa nasca da un raffinamento delle potenzialità di questa dimensione compartecipativa su base immersiva. Come vedremo meglio poco più avanti (par. 1.1), la musica non nasce per essere ascoltata, bensì compartecipata e vissuta, con un atteggiamento che ha caratteri simili a quelli che accompagnano il rito. La danza e la cerimonia sono i contesti in cui per molti secoli la musica viene eseguita, a cui si potrebbe aggiungere la dimensione empatica diretta del canto su base poetica. In questi contesti non esiste un ascoltatore come lo pensiamo oggi, posto di fronte alla musica in un’attività solo ricettiva-interpretativa. Nella danza come nella cerimonia – situazioni tradizionalmente rituali – la musica è il fattore socialmente unificante, è cioè il ritmo, l’andamento nel quale la collettività si può riconoscere come collettività. In questa dimensione sostanzialmente immersiva, al suono, specie se prodotto dalla voce di qualcuno, non viene attribuita una funzione di informazione sul mondo come accade per l’immagine. Il suono è soprattutto latore di una funzione di consonanza, attraverso l’eventuale sintonia con chi lo produce o con gli altri che lo stanno percependo insieme a me: stiamo vibrando insieme, ondeggiando insieme, sentendo insieme. L’andamento della vibrazione può finire per corrispondere all’andamento di sensazioni ed emozioni. Queste sensazioni ed emozioni possono essere comuni, compartecipate, condivise da tutti i presenti. E se questo andamento sonoro ed emotivo si accompagna a un discorso, per esempio sviluppato attraverso quelle stesse parole che sono state espresse con i suoni, inevitabilmente questo discorso verrà interpretato all’interno della dimensione sonora, sensitiva ed emotiva, e al senso di compartecipazione creato dai suoni. Come vedremo in questo libro, la poesia ha una relazione complessa con la dimensione sonora, che necessita di un’analisi precisa. Tuttavia, pur con i limiti che vedremo, questa dimensione sonora è presente e determinante per la fruizione del testo poetico. In altre parole, la fruizione di un testo poetico non si esaurisce nella sua comprensione. Benché la comprensione sia necessaria, l’esperienza del lettore di poesia non è fatta solo del capire quello che il testo gli sta dicendo. La poesia non è solo un discorso complesso e fascinoso, che sfrutta dimensioni del senso che la parola normalmente ignora: è anche l’occasione per un’esperienza immersiva, compartecipativa, rituale, con caratteristiche orfiche. Capire le modalità di questa esperienza ci permette, in molti casi, anche di raggiungere un ulteriore livello di comprensione del testo poetico, e a sua volta questa comprensione può mettere in moto ulteriori risonanze orfiche, con un meccanismo che, nei casi più felici, davvero non si interrompe mai. Che continuiamo oggi a studiare Dante, Catullo, Saffo, a tanti secoli di distanza, è la dimostrazione che esistono testi poetici inesauribili, destinati a produrre nuove significazioni e nuove emozioni ogni volta che si confrontano con un’epoca nuova. 0.5. La questione della liricaÈ ormai un luogo comune osservare che, dei diversi generi in cui era tradizionalmente divisa la poesia, solo la lirica è rimasto in auge, e che, di fatto, il campo della lirica oggi corrisponda a quello della poesia. La lirica è la poesia di espressione soggettiva, quella al centro della quale c’è un io, un io lirico, ingenuamente identificato di solito con l’io del poeta. Ma non c’è bisogno di un io manifesto perché la poesia sia lirica. L’espressione può essere benissimo soggettiva anche se si sta utilizzando la terza persona. Il soggettivismo[6], cioè la tendenza a mettere il soggetto al centro del componimento poetico, si può esprimere anche, per esempio, attraverso la scelta di una forma metrico-ritmica particolare, al di fuori delle regole costituite. In questo senso, la nascita e lo sviluppo del verso libero a fine Ottocento è una conseguenza del dominio della lirica, perché il verso libero è quello attraverso cui il poeta esprime la propria soggettività anche nella forma metrica – che stia esplicitamente dicendo “io” oppure no. Se vediamo le cose in questi termini, praticamente tutta la poesia del Novecento può essere vista come lirica, compresi i tentativi di riduzione dell’io, cioè i tentativi di costruire una modalità poetica che non si presenti come espressione del soggetto[7]. Il luogo comune che riduce la poesia a espressione spontanea della soggettività individuale è a sua voglia un figlio ingenuo di questa prospettiva. Ne riparleremo nelle ultimissime pagine. Due cose vanno osservate a proposito del predominio della lirica. La prima è che esso corrisponde sì, certamente, a un imporsi del valore dell’individuo e del soggetto nella nostra società degli ultimi secoli[8]; ma all’interno di questo medesimo soggetto, la psicoanalisi e l’antropologia hanno situato delle aree che non gli appartengono affatto, e sono piuttosto sociali, condivise. Anche per questa acquisizione (o perdita intrinseca di soggettività, se preferiamo), la soggettività di oggi può pretendere di esprimere l’universale, visto che, in fin dei conti, essa ce l’ha, volente o nolente, dentro di sé. La seconda è che la dimensione lirica si deve comunque confrontare con quella immersiva, rituale, di cui stiamo parlando in questo libro; e quindi confluire in un senso di condivisione sovra-soggettivo. Se non facesse questo, non sarebbe nemmeno riconoscibile come poesia. 0.6. Questo libroQuesto libro cerca di descrivere l’esperienza della fruizione poetica. Per fare questo deve parlare sia della dimensione discorsiva del testo poetico – che dipende dalla sequenza delle parole (proprio come nella prosa) ma anche dalle interazioni tra questa sequenza e una serie di caratteristiche specifiche della poesia – sia della sua dimensione immersiva, partecipativa, orfica. Questa seconda dimensione si articola in sistemi di ritmi e di tensioni che si manifestano sul piano dell’espressione come anche sul piano del contenuto: ritmi e tensioni morfologiche e sintattiche, ma anche ritmi e tensioni semantiche e narrative. Inizieremo (cap. 1) parlando della fruizione musicale, cercando di definire che cosa caratterizzi l’esperienza sonora, quando è diretta a testi di carattere estetico. Questo ci sarà utile per capire subito dopo quale sia lo specifico sonoro della poesia; e su questo quadro di fondo esploreremo le caratteristiche del metro e del ritmo prosodico. Ma questa stessa comprensione ci sarà utile, nel capitolo successivo (cap. 2), anche per capire che cosa siano e come si manifestino i ritmi semantici e narrativi. Un capitolo (cap. 3) sarà dedicato alla costruzione del discorso in prosa, ricercando al suo interno una serie di aspetti (alcuni anche di carattere emotivo) di cui pure la poesia fa uso. Ritroveremo questi aspetti anche nel capitolo 4, dedicato alla costruzione del discorso poetico, ma sarà a questo punto centrale la loro interazione con gli aspetti specificamente poetici che sono stati descritti nei capitoli precedenti. Incominceremo ad avere, a questo punto, un quadro abbastanza dettagliato della situazione, e potremo permetterci di mettere in gioco (cap. 5) quegli elementi, puramente visivi, che non hanno nessuna relazione diretta con la dimensione sonora. La scrittura ha una sua specificità, come ce l’hanno una serie di aspetti visivi presenti da lungo tempo in poesia. Esiste però anche una poesia fortemente basata sulla dimensione visiva, cui è necessario dedicare uno spazio. Nell’ultimo capitolo (cap. 6) cercheremo quindi di descrivere la fruizione poetica nella sua complessità, tracciando alcune linee di un’estetica poetica, con un accenno finale alla dimensione dello scrivere. [1] Vedi il par.3.1, per un’espansione di questo discorso. [2] Sui ritmi del contenuto, vedi sotto Cap. 2. Più in generale, su ritmi e tensioni nei testi, narrativi e non, cfr. Barbieri(2004). [3] Al rapporto tra leggere e guardare nella comunicazione visiva (poesia visiva e poesia concreta incluse) ho dedicato il volume Barbieri (2011). [4] Vedi sotto, par.5.2.1. [5] Ho dedicato a questo tema diversi articoli (Barbieri 2008, 2009 e 2010), ma la problematica nasce in Ong (1967 e 1982). Per quanto riguarda la musica si trova affrontata anche in Piana (1991), in Capuano (2002) e in Sparti (2007). [6] O meglio, quello che Guido Mazzoni (2005) chiama piuttosto espressivismo. [7] Per lo sviluppo di questa tesi, vedi ancora Mazzoni (2005). L’espressione “riduzione dell’io” è invece di Alfredo Giuliani (1965), nell’Introduzione 1961 all’antologia de I Novissimi. [8] Su questo tema, oltre a Mazzoni (2005) vedi anche Ferry (1990). Il bello di non essere un critico musicale è quello di poter dire quello che si pensa senza sentirsi impegnati a una verità universale, senza sentirsi troppo a rischio di dire castronerie, perché comunque quello che si mette in gioco è il proprio personale sentire, le proprie impressioni da dilettante – e non la Storia della Musica. È così che due settimane fa mi sono lanciato in alcune considerazione su Miles Davis, che mi davano l’occasione per arrivare invece a un discorso sull’avanguardia e sul difendere a oltranza le posizioni artistiche – argomento rispetto al quale mi riconosco più direttamente impegnato. Ma poi i commenti a quel post hanno riguardato nello specifico anche lo stesso Miles Davis, e mi sono ritrovato a promettere di cercare di capire (e di spiegare) perché il Miles elettrico e pop mi faccia l’effetto che mi fa – cioè mi piace moltissimo, mentre resto quasi indifferente alle sue performances più tradizionali sino al 1968. Per questo, dunque, nei giorni scorsi mi sono riascoltato un sacco di Davis, compresi brani del primo e del secondo quintetto, che hanno continuato a farmi lo stesso effetto di apprezzamento distaccato – mentre dalle prime note di Pharaoh’s Dance la mia attenzione ha avuto un balzo; e lo stesso succede con tanti dei brani dell’infinita serie di esecuzioni a Montreux (1973-91). Di qui a capire il perché di questo balzo il passo non è stato semplice. Stavo incominciando a pensare di smontare Pharaoh’s Dance o Bitches Brew (il brano che dà il titolo all’albo), un’operazione che spesso mi è stata decisamente utile per riuscire a capire qualcosa del mio oggetto di interesse, quando nella mia testa qualcosa è scattato. Di colpo ho visto un collegamento tra il Davis della svolta e tutto un altro genere di musica: la musica indiana dei raga. Ora, Miles Davis non usa né il sitar né altri strumenti indiani; armonie, melodie e ritmi non hanno nessuna parentela con quelli dei raga; non ho neanche idea (e non molto mi importa) se avesse avuto occasione di ascoltare Ravi Shankar, che già girava per l’Occidente a dar concerti dai tardi anni Cinquanta. Magari l’ha sentito e questo gli ha fatto scattare qualcosa; oppure non gli ha fatto scattare niente, e il suo percorso è stato un altro: non è questo che mi interessa. Mi interessa invece il fatto che i pezzi di Bitches Brew e tanti brani successivi di Davis hanno una struttura complessiva e prevedono una modalità di ascolto che è singolarmente simile a quella dei raga indiani: una modularità ossessiva-ricorsiva di fondo (spesso uniforme solo in apparenza, perché in realtà organizzata nella forma di un lento crescendo/accelerando attraverso una serie minimale di alterazioni) su cui si stagliano episodi improvvisativi che nascono l’uno dall’altro, e che sembrano a un certo punto morire nell’uniformità del fondo – salvo che il fondo in qualche modo ne ingloba gli effetti, e insensibilmente cresce. E tutto questo va ascoltato non con la razionale attenzione frontale dell’ascoltatore critico occidentale, che concepisce la musica come discorso e come sviluppo, e come tale la riconosce e segue; bensì con un atteggiamento ondeggiante tra quello frontale appena detto e una partecipazione rituale che va nella direzione del ballare, o del seguire corporalmente il ritmo, sino a una condizione di semi-trance. È questo che mi affascina delle esecuzioni dei raga indiani: non è che la sensazione di trovarsi di fronte a uno sviluppo e a un discorso (due capisaldi della musica colta occidentale e del suo ascolto – jazz compreso) scompaia, ma il discorso è talmente fatto di ripetizioni e riprese, in cui le variazioni si inseriscono fluidamente, che finisci facilmente per perderne il filo, rimanendo appeso solo alla componente di immersione nel flusso ritmico-melodico. Eppure l’esecuzione di un raga non è fatta della semplice ripetizione ossessiva di un ritmo o di un riff, ripetizione che soddisfa solo la dimensione dell'”andare a tempo”, e a lungo andare annoia. Al contrario, l’effetto immersivo, di semi-trance avvolta dal flusso musicale, viene costruita attraverso la presenza effettiva di un discorso musicale – che però fa parte del gioco senza poter diventare dominante. E questo è sufficiente a rendere impossibile per un raga quell’ascolto strutturale che tanta musica occidentale colta invece richiederebbe. Per godere di un raga devi cercare di seguirne il discorso, ma anche rassegnarti a vivere molto di più il suo flusso di quanto non capirai davvero il suo sviluppo – così che alla fine l’ascolto finisce per essere un’esperienza attiva piuttosto che cognitiva; o meglio, finisce per essere l’esperienza dell’immergersi in un flusso di cui tu cerchi di controllare cognitivamente la forma, mentre è lui che conduce te, a dispetto di tutti i tuoi sforzi. Bene. Senza nessuna parentela ritmica, melodica o armonica con la musica indiana, la musica di Miles Davis produce su di me lo stesso effetto: cioè quello di una musica che chiede sì di essere seguita cognitivamente come discorso e come sviluppo, ma solo per potersi immergere più intensamente e viverne attivamente il flusso, in uno stato di quasi-trance rituale, in uno stato di comunione partecipativa. Una volta che capisco questo, posso forse anche capire che Davis non ha bisogno di Ravi Shankar né della musica indiana per arrivare a un risultato pur così simile. Gli basta risalire alla propria origine africana, e alla natura rituale-compartecipativa delle poliritmie tribali, nelle quali il discorso e lo sviluppo musicali sono comunque presenti, ma non centrali, e comunque subordinati alla convocazione degli ascoltatori a una partecipazione attraverso il ballo, o l’accompagnamento vocale e in ogni caso attraverso l’immersione – ancora una volta – in uno stato di quasi-trance, in cui persino il cercare di seguire lo sviluppo e il discorso musicale è a sua volta parte dell’immersione e della partecipazione. Ora, se vediamo le cose in questo modo, l’operazione di Miles Davis appare di colpo come un altro capitolo della storia del free jazz, ma non quello cerebrale di Coleman (come mi suggerisce Guglielmo Nigro in uno dei commenti), quanto piuttosto quello politico-appassionato di Max Roach. E il disco che, con le mie scarse conoscenze, io ritrovo più vicino, nella storia precedente del jazz, a quello che Davis va a fare dal 1969 in poi, è la Freedom Now Suite – We Insist!, del 1960, proprio di Max Roach – specialmente (ma non solo) in quel brano, intitolato All Africa, in cui Abbey Lincoln canta sopra una base semi-immobile che finisce, dopo un po’, per essere fatta di sole percussioni poliritmiche. Ora, saranno queste le mie personali ossessioni e il mio modo di considerare la musica (e non per questo disprezzo affatto le modalità d’ascolto più intellettuali). Ma la mia sensazione è che Miles Davis abbia finalmente trovato, e solo da quel momento in poi, la sua vera sintonia con la musica e con la sua gente – che sono principalmente gli afroamericani, certo, ma siamo anche noi, nella misura in cui siamo capaci di capire che la musica non è né un freddo discorso intellettuale né un totale abbandono corporeo al ripetersi omogeneo dei suoni e dei gesti, ma un complesso in cui ciascuna delle due dimensioni investe l’altra, e capiamo mentre sentiamo e partecipiamo. E se non capiamo proprio tutto, pazienza, perché è anche il cercare di capire (senza necessariamente riuscirci) che ci fa entrare nel gioco complesso dell’essere a tempo. Quando pensiamo ai miti, quello che ci viene in mente è una collezione ordinata di testi scritti, divisi per culture di appartenenza: i miti greci, quelli romani, quelli germanici, celtici, indiani, maori, polinesiani, maya, aztechi… Ovviamente sappiamo benissimo che non sono nati così, ma che in origine erano racconti tramandati oralmente; eppure la suggestione della scrittura è talmente forte per noi, che anche quando vediamo i miti come parola orale finiamo per vederli come soltanto questo: appunto, parola. L’invenzione e diffusione della scrittura ha reso possibile pensare alla parola, al linguaggio, come qualcosa che esiste di per sé. Poiché nei libri ci sono soltanto parole, la parola può esistere autonomamente, e se esiste autonomamente sarà così anche nell’oralità! Eppure, sappiamo benissimo che, nei contesti quotidiani in cui interagiamo normalmente parlando, la parola è sempre accompagnata da situazioni e da gesti, e non si parla allo stesso modo né si gesticola allo stesso modo in situazioni diverse o con persone diverse. Se non fosse per l’esistenza della scrittura, non ci verrebbe davvero in mente che la parola possa esistere di vita autonoma; e di conseguenza neppure ci verrebbe in mente che si possano costruire oggetti comunicativi fatti solo di parole. Insomma, senza la scrittura, una cosa come il romanzo, o il saggio critico, o l’articolo giornalistico, non è nemmeno concepibile. E il poema epico, e il mito, allora? Be’ quelli, a quanto pare, esistevano lo stesso; solo che, evidentemente, non erano per i nostri antenati orali la stessa cosa che sono per noi oggi: non lo erano non solo per il fatto ovvio che significavano qualcosa di diverso, ma anche per il fatto che erano proprio, materialmente, un’altra cosa. Omero era un aedo, ovvero un poeta orale, abilissimo nell’improvvisare versi e situazioni su un canovaccio tradizionale e già noto: ogni volta che Omero apriva bocca, i brani dell’Iliade gli uscivano nuovi, e diversi. Certo, non troppo diversi: Omero era come un musicista jazz, che improvvisa su temi noti – e proprio come un musicista jazz, Omero non faceva questo in un momento qualsiasi, ma solo in situazioni particolari, con condizioni particolari, dove le piccole differenze del momento (e i suoi stessi cambiamenti interiori dovuti all’invecchiamento e alla sempre maggiore acquisizione di esperienza) ispiravano sviluppi e versi differenti. Presumibilmente, le situazioni in cui i miti venivano raccontati, da Omero come da qualsiasi altro narratore tradizionale, erano situazioni rituali, fortemente codificate. Per gli antichi, e per tutte le culture unicamente o sostanzialmente orali, il mito non è separabile dal rito, cioè da una situazione socialmente regolata, con componenti sacre (non necessariamente religiose, però) più o meno forti. Altro che corpus di testi narrativi autonomi! Il mito era legato alla fisicità della cerimonia, con i suoi gesti, le sue interazioni fisiche, i suoi odori, rumori, aspettative: era teatro, indubbiamente, nel senso antico di un teatro rituale come quello greco, in cui anche il pubblico faceva la sua parte. Se vediamo così le cose, non è difficile accorgersi che la poesia e il romanzo così come li intendiamo oggi sono astrazioni estreme, che provengono da un modo di pensare la parola che è figlio della scrittura; un modo che è diventato così naturale per noi da farci pensare che sia sempre stato così, e che non possa essere diversamente. Eppure siamo noi stessi a resistere interiormente a questa dittatura dell’astrazione, che pure consapevolmente sosteniamo. Lo testimonia il fatto che quando, sul finire del XIX secolo, sono nate due forme di narrazione in cui la parola riassume lo statuto ibrido che aveva nelle situazioni orali, il loro successo è stato rapido e clamoroso: mi riferisco naturalmente al cinema e al fumetto. Non voglio parlare del cinema e mi concentrerò sul fumetto. La sua paradossale situazione è che il fumetto è a sua volta una forma di scrittura, ma combinata in modo da lasciar fuori molto meno di quanto non succeda con la scrittura tout court. Certo, la scrittura tout court è molto più potente di quella del fumetto, ma paga questo potere con un’astrazione estrema, che lascia fuori praticamente tutti (o quasi) i dati sensoriali immediati. Il recupero della visività, della situazione, dell’intorno temporale, rende la scrittura fumettistica meno universale di quella verbale, ma le permette un’efficacia straordinaria per il racconto, e persino – per il tramite della visività – un’efficacia maggiore nell’esprimere quello che le resta, inevitabilmente, esterno: i suoni, i movimenti, gli odori… I fumetto ha il successo immediato che ha, alla sua nascita e in seguito, perché, pur essendo una forma di comunicazione nuovissima, esprime un bisogno antico: quello di recuperare la dimensione concreta della parola, legata alla situazione e all’azione; e, insieme, quello di raccontare anche senza bisogno di parole. Io non credo che Omero e i suoi pari si limitassero a emettere dalla bocca sequenze di versi; li vedo piuttosto agitarsi, interpretare con i toni di voce, con i gesti, con le espressioni del viso, quello che stavano raccontando. In qualche momento, magari, potevano persino tacere, e muovere le mani, o gli occhi, e quel gesto raccontava moltissimo anche senza parole; ma nelle trascrizioni, ovviamente, quel gesto si è perso, e non fa più parte del racconto del mito. Certo, in quanto scrittura, anche il fumetto ha la sua dose di astrazione, che non è piccola. Potremmo vederlo come una sorta di scrittura di mediazione, una sorta di oralità di ritorno in un contesto sociale in cui la scrittura è dominante; un tipo di scrittura (e quindi adatto al nostro mondo) che recupera numerosi aspetti dell’oralità (e quindi capace di recuperare in parte quei bisogni repressi). E del rito, che era così legato una volta al mito e al suo racconto, cosa resta nella fruizione dei racconti di oggi? Il discorso appare molto complicato. Diciamo che ci sto pensando. (Ho già affrontato temi simili a questi in due post precedenti: Del fumetto, della sua nascita e dell’Europa del primo Novecento e Del fumetto, delle immagini, del racconto e del jazz) Riprendo questo tema che ha lanciato Harry qui, e l’ha poi ripreso qui, dopo un mio commento in cui gli chiedevo di spiegarmi perché anch’io leggo così volentieri Dago. Intendiamoci, si parla delle storie contenute nel mensile Dago Ristampa (che contiene le ristampe delle storie già pubblicate sui settimanali della Eura/Aurea), scritte da Robin Wood e disegnate da Carlos Gomez – e non confondiamolo col mensile Dago, che pubblica storie nuove, scritte e disegnate da altri apposta per il mercato italiano, di qualità mediamente molto bassa, e di cui non varrebbe affatto la pena di parlare (e nemmeno di leggerlo, in verità). A vantaggio di chi si è perso quello che è uscito sin qui, dal 2008 è iniziata anche la ristampa della ristampa, a colori, nella Collezione Tuttocolore. Il mistero è questo: Dago è un fumetto seriale. I disegni, prima di Alberto Salinas e in seguito di Carlos Gomez, sono di ottima qualità. Le storie, a giudicare dalla passione con cui io stesso e tanti altri le leggiamo, pure: ma i temi ormai si ripetono, e anche prima che all’interno della serie si ripetessero erano noti e stranoti, puri stereotipi di genere, strabordanti di un moralismo che in altre circostanze io troverei stucchevole, popolati di personaggi già conosciuti mille volte. Inoltre, se uno ha praticato un po’ il fumetto argentino, tutto questo appare ancora più vivido, e più ossessivamente ricalcato. Insomma, la mia testa mi dice che, se devo giudicare da questo, Dago non è che un ennesimo prodotto seriale che non fa che ricalcare percorsi già pesantemente calcati da altre mille storie, roba buona per lettori poco esperti, o dal palato grezzo. Eppure, a dispetto di questo, mi ritrovo ogni tanto a domandarmi quando uscirà il prossimo numero; e poi, quando torno a casa dall’edicola dove ho fatto incetta di nuove uscite, la mia prima lettura è inevitabilmente Dago. Di conseguenza, o il mio palato fumettistico è davvero grezzo, oppure in quello che la mia testa mi dice c’è qualche errore o mancanza. Harry suggerisce questo:
Tutto questo è vero, ma in realtà non mi basta. Ci sono tanti fumetti che affrontano questi temi e non hanno certo la qualità di Dago. Però quello che Harry dice è ugualmente utile a circoscrivere meglio il problema: ovvero, dunque, come fa Wood a mettere a nudo così bene queste dinamiche primarie? In che cosa consiste la sua perfezione? Voglio approfittare anche di un suggerimento che proviene da un altro lettore appassionato di Dago, cioè Umberto Eco, che nell’introduzione al convegno La linea inquieta, nel 2004, diceva: Cito Dago come caso interessante perché in esso si manifestano tre fenomeni molto ben distinti: (i) la rivisitazione visiva sia della tradizione rinascimentale che della tradizione dei grandi illustratori moderni come Gustavino; (ii) la sapienza narratologica di Robin Wood nel realizzare una combinatoria infinita di vari topoi romanzeschi, da quelli picareschi a quelli neogotici e romantici; (iii) l’assoluta banalità stilistica del discorso verbale, che si attiene a una retorica da feuilleton ottocentesco, e senza alcuna ironia sottintesa. Aggiungerei che dal punto di vista sociologico è forse proprio questa strana commistione che giustifica il successo popolare della serie, ma ecco che si vede come un’analisi sociologica debba sovente essere preceduta da una valutazione critica molto rigorosa. Anche qui non andiamo molto al di là di qualche intuizione, però trovo che sul fuoco ci sia già più carne. Intanto vi si osserva che non è che Salinas e Gomez siano semplicemente bravi disegnatori, ma che in questa bravura è presente una competenza iconologica che ci permette di collegare continuamente Dago a una serie disparata di tradizioni, da quella rinascimentale (epoca di ambientazione delle vicende) a quella otto-novecentesca degli illustratori (epoca in cui si forma la nostra competenza visiva di lettori). La banalità stilistica del racconto verbale è quello che potremmo definire il basso continuo della serie: una specie di accompagnamento necessario, senza il quale non si comprenderebbero le vicende, ma che è il più banale e scontato possibile proprio perché non deve attirare l’attenzione: si legge e scorre via. L’accento è su altro. E poi c’è la combinatoria infinita dei topoi romanzeschi, presi dalle tradizioni più diverse, che corrisponde, sul piano narrativo, alla competenza iconologica su quello visivo. È come dire che il lettore di Dago ritrova continuamente il già noto, però intrecciato in combinazioni non necessariamente note. Di nuovo, tutto questo è vero, ma ancora non basta. Ci avvicina un po’ alla soluzione, ma non ce la dà. E allora proverò a esplorare dentro di me, a capire quali sono le sensazioni che mi tengono avvinto a queste storie, senza escludere neanche le più banali. Così, intanto, c’è l’ambientazione storica. La prima metà del Cinquecento è un periodo già di per sé affascinante (per me in particolare, anche prima di Dago): l’Europa è ricca, piena di artisti e di entusiasmo, ma è già scivolata in un’epoca di guerre feroci e di contrapposizioni religiose, che la stanno portando molto vicina al disastro. Da questo punto di vista la documentazione di Wood è davvero rigorosa; è ovvio che la storia di Dago è fantastica, però ogni tanto si incrocia con eventi e personaggi storici: ho fatto diversi controlli, ma non sono riuscito a cogliere Wood storicamente in fallo. Poi, c’è la ricchezza dei temi: è vero che i temi si ripetono e che si rifanno sempre a un qualche modello noto, però sono tantissimi, e di conseguenza è multiforme la loro combinatoria. Non so se si possa dire che Wood è capace di sottigliezza psicologica: i personaggi appartengono tutti a casistiche abbastanza ben definite, di provenienza follettonistica. Però sono combinati così intelligentemente con la storia in cui agiscono che anche nel rispetto dello stereotipo appaiono credibili, convincenti, molto umani. Poi c’è la questione del moralismo. Certo, in Dago il bene è bene e il male è male, però c’è anche un’ampia zona intermedia, e non è detto che il bene trionfi sempre pienamente. Lo stesso Dago, il protagonista, sempre pronto a battersi per cause giuste, porta nel cuore un desiderio sanguinoso di vendetta. Complessivamente i morti sono tantissimi sia dalla parte del bene che da quella del male. Lo potremmo definire un moralismo amaro, e pieno di comprensione per le debolezze della vita. Insomma, anche qui, qualcosa di sufficientemente complesso da non essere sentito come banale. Infine, collegato a tutto questo, c’è la questione dell’epica. Per certi versi Dago è un romanzo cavalleresco popolare, fatto di schemi e stereotipi come già pure quelli del Pulci e dell’Ariosto, che erano i capolavori che erano anche a ragione di questi schemi e stereotipi. In fin dei conti, la mia idea è che il piacere che Dago produce nella lettura sia una questione di ritmo, e di rito. Senza componenti rituali (di cui il ritmo è comunque la base) non si producono testi con qualità estetiche. Nella nostra cultura, alla componente rituale si deve associare una componente di originalità e di novità; ma non è sempre stato così. O meglio, la rilevanza della componente innovativa è diversa da epoca a epoca, da luogo a luogo, da genere a genere, da attività a attività. Nel rito vero e proprio, come quello religioso, la componente innovativa è nulla. Nelle produzioni estetiche, viceversa, è ciò che tiene vivo il nostro interesse, permettendoci di trovare piacere nel frattempo anche in quel ritorno del già noto che crea ritmo e rito. Così, il piacere delle produzioni estetiche ha due tipi di fonte: da un lato quello della scoperta (dovuto alla novità), dall’altro quello della conferma e sicurezza (dovuto al ritmo). Credo che Wood (con Salinas e Gomez) abbia trovato una via inedita per riproporre quell’idea antica di racconto popolare di cui il poema cavalleresco è stata anche a suo tempo espressione, e che è il modello anche del mito: tutto quello che succede ci è in qualche modo già noto e i valori espressi sono i qualche modo i nostri; e tutto è rassicurante, ma non perché sia banalmente positivo, ma semplicemente perché rispecchia, anche nel male, l’idea che abbiamo della vita e del mondo. Dago è una sorta di rassicurante liturgia, che si legge volentieri perché non mette in questione nulla, fondamentalmente, però ci porta alla mente tante cose diverse. È, in questo senso, una telenovela d’alto bordo, dai contenuti tutt’altro che banali. Non dobbiamo aspettarcene nessuna proposta particolarmente originale, perché Wood è sempre attento a tenersi eticamente e psicologicamente sul generico – e la distanza storica aiuta. Ma il suo gioco è comunque affascinante e confortante. Tutto questo forse non svela del tutto il mistero di Dago, però qualche passo avanti mi sembra di averlo fatto. Già molti decenni fa (ma io l’ho imparato solo in questi giorni, leggendo il suo Come interpretare un’opera d’arte, Milano Rusconi 1977) Ananda K. Coomaraswamy faceva osservare che la parola arte, tradizionalmente, nelle culture europee, non fa riferimento a oggetti o a una categoria di oggetti (le opere d’arte), bensì a un modo di operare. Per capire cosa questo voglia dire basta far caso al fatto che quest’uso della parola arte è ancora ben presente nell’italiano di oggi, quando si dice, per esempio, che qualcosa è fatto ad arte, o che qualcuno lavora con arte. Come è ovvio, pure la parola artigiano deriva da arte, intesa in questo senso; mentre la parola artista sembra che indicasse, in origine, semplicemente qualcuno che eccelleva nella propria arte (ovvero abilità costruttiva), qualunque essa fosse. Coomaraswamy fa anche notare che anche il fatto di considerare le arti come oggetto di un’estetica è un’invenzione occidentale e recente. La parola estetica deriva da aisthesis, ovvero sensazione, e che la riflessione sull’arte abbia nome estetica tradisce l’idea di base che il campo dell’arte sia quello della sensazione, nello specifico quello della sensazione piacevole. L’invenzione dell’estetica avrebbe dunque deviato verso il campo della sensazione quello che prima apparteneva al campo della conoscenza. Credo (io, non Coomaraswamy) che questa deviazione sia parallela allo sviluppo di un’idea di conoscenza razionale esclusiva, che sfocia ai primi del Seicento nella concezione cartesiana della scienza. Dove la conoscenza debba essere fatta di idee chiare e distinte non c’è più posto per una conoscenza tradizionale su base rituale, con una forte componente religiosa. Progressivamente (perché queste cose richiedono secoli, e né Cartesio si è inventato tutto da un giorno all’altro, né dal giorno dopo l’enunciazione delle sue idee il pensiero occidentale è cambiato di colpo) una serie di cose che prima erano sentite come centrali per la vita e la conoscenza del mondo vengono relegate a un ruolo più marginale. Nella misura, poi, in cui esse sono anche legate al culto religioso, secondo il nuovo criterio illuminista finiscono per ritrovarsi nel campo della superstizione. La parola estetica, usata in senso moderno, è settecentesca; ma l’idea dell’arte come qualcosa che riguarda la sensibilità piuttosto che la conoscenza la precede. Potremmo dire che l’invenzione dell’estetica come tale, nel Settecento, è il tentativo illuminista di dare un posto decoroso all’arte all’interno di un sistema cognitivo che la lascia fuori. Alla fine di questa lunga trasformazione, siamo passati da un sistema in cui la pittura, la scultura, l’architettura e la musica erano modalità rituali (o collegate a situazioni rituali) di conoscenza del mondo, a un altro sistema in cui queste medesime attività sono diventate testimonianza dell’espressione dell’io, e al tempo stesso manifestazioni del sublime – con questa particolare e interessante coincidenza di due estremi, entrambi tenuti ai margini di un mondo sempre più dominato da una conoscenza di tipo razionalistico e dalla sua applicazione attraverso una tecnica che per sua natura esclude l’arte, cioè l’abilità manuale. Dobbiamo a William Morris e alla sua utopia neoumanistica della seconda metà dell’Ottocento l’idea del design industriale, ovvero l’idea che l’arte (intesa come cura della qualità) possa essere applicata anche ai prodotti della tecnologia. E gli dobbiamo, in qualche modo, anche l’idea del graphic design, ovvero l’idea che pure i prodotti della comunicazione possano essere progettati con cura e con arte. Ma Morris non poteva cambiare, evidentemente, le regole di fondo. In una società deritualizzata, o in cui i nuovi riti sono effimeri e sempre collegati a una razionalità produttiva, le nuove arti (in senso antico) inventate da lui non possono ricoprire lo stesso ruolo che avevano nel mondo fortemente ritualizzato al cui interno si erano sviluppate. Benché sia figlio della cura dell’artista medievale (ovvero colui che eccelleva nella sua arte), e sia in questo senso ciò che davvero potrebbe legittimamente essere definito arte, il design non può godere della stessa considerazione sociale di cui godeva nel medioevo l’arte: gli manca quel legame con il sacro che allora era parte di qualsiasi opera, di qualsiasi operazione, anche quotidiana. Nella nostra cultura, quel legame è diventato appannaggio dell’Arte (con la A maiuscola, cioè nel senso corrente dell’espressione), la quale, però, ha dovuto separarsi in maniera radicale dalla tecnica, dalla produzione di buoni oggetti d’uso, e relegarsi nel campo di un tipo particolare di comunicazione, quella espressiva – cercando di ricostruire, solo con i propri mezzi, delle situazioni rituali a cui la società concede diritto di esistere a patto che non riguardino il campo del sapere, e si limitino a quello del bello, dell’aisthesis, della sensazione. L’Arte finisce per diventare, in questo modo, solo una forma più complessa (magari più colta) di intrattenimento – e il sacro stesso finisce per essere oggetto di aisthesis. Dobbiamo avere nostalgia per come era prima, o per come sarebbe altrove? Non so. Non so quanto prima fosse meglio. Non mi interessa seguire Coomaraswamy in questo. Non credo che sia questo il punto. Quello che è importante, piuttosto, è capire bene quanto fossero diverse prima le cose, e che il senso in cui Giotto era un artista era molto diverso dal senso in cui lo definiremmo tale oggi. Giotto era (di gran lunga) il più bravo a esprimere visivamente quello che la collettività sentiva; a raccontare per immagini quello che tutti sapevano e intorno a cui tutti si raccoglievano. Non esiste niente di simile a questo, oggi. I presupposti sono cambiati. Il nostro stesso sentire e il nostro stesso conoscere sono differenti. Con questo post mi limito a segnalare che è on line da oggi sul numero 2 (Corpo e linguaggio) della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio un mio articolo dal titolo “La parola disincarnata: dal corpo alla scrittura“, in cui vengono sviluppati più ampiamente una serie di temi che sono stati affrontati anche in diversi post di questo blog (in generale quelli etichettati con il tag “sistemi di scrittura”). Un intero paragrafo era anche stato citato all’interno del post del 1 aprile “Della poesia in prosa”. Riporto qui di seguito l’abstract dell’articolo (abstract che sulla rivista appare in inglese): Non è possibile stabilire una corrispondenza diretta tra la parola orale, legata al suono, e la parola scritta, legata alla visione. Il suono scorre, fluisce, la visione resta; i suoni vibrano dentro di noi, le cose viste appaiono esternamente di fronte a noi: quando passa, storicamente, dalla prima dimensione alla seconda, la parola diventa astratta e disincarnata. Analizziamo qui in questi termini diverse forme di testualità, e il percorso storico seguito dalla parola per distaccarsi dalla corporeità. La poesia rimane ancora oggi il tipo di scrittura che mantiene i legami più forti con la dimensione orale: in poesia, infatti, continuano a giocare un ruolo determinante le dimensioni ritmica e rituale, vicine per loro natura all’universo del suono. Nella prosa la separazione è stata più netta, ma ha richiesto comunque un processo molto lungo, che ha avuto il suo momento cruciale nel trionfo della razionalità della Filosofia Scolastica. Nel passaggio dalla lettura ad alta voce dell’antichità alla lettura silenziosa, interiore, dei moderni, la parola scritta si separa radicalmente da quella orale, imponendo decisamente la propria forza di astrazione. Mi piacerebbe approfittare di questo spazio di discussione per sentire qualche opinione e magari anche obiezioni sulle tesi che sviluppo in questo articolo. Non ho ancora letto gli altri articoli presenti sulla rivista, ma dai titoli mi sembra che vi siano affrontati comunque diversi temi interessanti. A consultare Youtube ci si può rendere conto che in quello spazio viene riconfigurata drasticamente l’esperienza percettiva dell’audiovisivo. Dagli studi sull’oralità primaria (ovvero l’oralità delle culture che non hanno ancora fatto esperienza di scrittura – vedi i lavori di Walter Ong, di Jack Goudy e di altri, ben compendiati nel volumetto di Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass-media, Carocci 2006), sappiamo che la comunicazione verbale orale possiede delle caratteristiche che l’introduzione della scrittura indebolisce o cancella del tutto. Finché la parola appartiene esclusivamente all’universo sonoro, ne condivide infatti gli aspetti di fluidità, di coinvolgimento, di vibrazione, di musicalità, di non-permanenza: tutte caratteristiche che la rendono adatta a situazioni di carattere rituale, situazioni in cui, partecipando, la persona si immerge in una collettività che agisce (tendenzialmente) all’unisono. La natura visiva della parola scritta è aliena da tutto questo. Il mondo visibile possiede caratteristiche di stabilità che quello sonoro non ha, e si presta, per questo, all’osservazione attenta e ripetuta. Non a caso le metafore della visione sono utili per parlare della conoscenza scientifica (si pensi, per esempio, all’“osservazione scientifica”) mentre quelle dell’ascolto tendono a essere usate piuttosto per la propriocezione (si pensi al campo semantico del verbo “sentire”, che usiamo tanto per le emozioni che come sinonimo di “udire”). Quando la parola incontra la scrittura (che esisteva, almeno in Mesopotamia, in una forma archetipica già da qualche migliaio di anni, e veniva usata come strumento per le registrazioni contabili – come ho raccontato in questo blog nel mio post del 9 marzo) la parola si arricchisce delle possibilità dell’osservazione ripetuta e del calcolo; e non è un caso che solo in questo contesto possa nascere la filosofia. Certo, d’altro canto, il legame tra parola scritta e orale non viene comunque reciso mai. È interessante però osservare come si indebolisca per gradini, e che un importante gradino (quello della nascita della lettura silenziosa, eseguita solo con gli occhi, senza la resa sonora della parola) coincida con l’esplosione del razionalismo della filosofia scolastica, nei primi secoli del secondo millennio. Da quel momento in poi, esistono generi che si posizionano variamente nello spazio tra oralità e scrittura, ponendosi decisamente dal lato di quest’ultima (come la filosofia e in generale la critica) oppure, all’opposto, conservando una decisiva componente orale, come il teatro – e, con questa, una natura rituale, di cerimonia condivisa. L’invenzione del cinema porta di colpo un tipo di discorso fondamentalmente visivo ad assumere elementi determinanti di oralità. Nel cinema l’immagine scorre e non può essere fermata, e scorre indipendentemente da noi: nella fruizione cinematografica la realtà visibile non è più, dunque, potenzialmente statica. Laddove nel mondo attorno a me, nel mondo reale, ci sono parti stabili, e la scrittura si aggiunge a queste, nel cinema il mondo si trasforma costantemente, e non è mai sufficientemente fermo a lungo per poter essere osservato con i tempi della nostra libera osservazione. Collegandosi naturalmente al teatro, anche il cinema implica una situazione rituale di fruizione, ma l’officiante principale non c’è più, sostituito da un dispositivo che avanza autonomamente, indipendente dalle reazioni del pubblico. Possiamo chiamare neo-oralità questa situazione dall’apparenza paradossale, rafforzata dopo pochi decenni dall’introduzione del cinema sonoro. L’altro grande medium decisamente neo-orale è ovviamente la radio. Per queste loro caratteristiche, radio e cinema saranno i principali strumenti di creazione del consenso (cioè di creazione del mito di base) dei regimi totalitari tra le due Guerre Mondiali. È piuttosto evidente che la televisione non fa che perfezionare e rendere ancora più potente la dimensione neo-orale, con l’introduzione di una presenza virtuale, rafforzata dalla diretta, che mette tutti gli spettatori in sintonia con il medesimo rito, senza che nemmeno debbano entrare in contatto l’uno con l’altro. Il Web nasce con caratteristiche radicalmente opposte. L’idea di Berners-Lee è esplicitamente ispirata all’utopia di Ted Nelson, che è un’utopia di tipo scrittorio, quella del “sistema ipertestuale distribuito per la letteratura universale”, esposta in un volume (Literary Machines) il cui dedicatario è George Orwell: Nelson sogna un mondo in cui la telematica permetta a tutti l’accesso immediato a qualsiasi testo, e renda impossibile la distruzione e il controllo dei libri. Persino l’idea (centrale) di link non è che l’implementazione tecnica di una consuetudine scrittoria, quella del riferimento (o della citazione) – ben poco praticabile in un mondo orale, dove è impossibile da un riferimento risalire alla sua fonte. Quando l’audiovisivo viene inserito in questo universo profondamente visivo, profondamente scritto, qualcosa inevitabilmente cambia nella sua natura. Non siamo più, cioè, di fronte a un evento, che si presenta a noi nel flusso inarrestabile dei programmi TV, bensì a un documento, ben posizionato in un vastissimo archivio da cui possiamo in ogni momento prelevarlo, consultarlo, rivederlo, fermarlo, analizzarlo, ritornarci. Insieme con la natura coinvolgente e immersiva dell’oralità, certo, l’audiovisivo perde anche una certa parte del suo fascino. Non è più ciò che sta accadendo, ma ne è semplicemente la registrazione, la scrittura. Quando appare in Youtube, poi, lo troviamo inserito in un dialogo, quello dei post di commento e degli eventuali video di risposta, che enfatizza la sua natura scritta, perché, comunque, rimane. Certo, il Web 2.0 ha addolcito la propria natura scrittoria con alcuni tratti di oralità, come è facile vedere nel fenomeno delle chat (e gli audiovisivi si inseriscono bene in un contesto a cui qualche tratto di oralità rimane); ma si tratta di un’oralità di superficie che non scalfisce la durabilità e ripetuta osservabilità di quelle che sono comunque registrazioni, anche se magari registrazioni di dialoghi estemporanei. Se la televisione è un grande creatore e diffusore di miti, Youtube è il luogo dove il mito si trasforma in mitologia, ovvero discorso sul mito, registrazione del mito, sguardo (razionale) sul mito. Tutto forse molto meno fantastico e affascinante che in TV o al cinema; ma, insomma, almeno qui si può discutere! (questo post costituisce il resoconto essenziale di una conferenza dal titolo Youtube dal personale al sociale: l’audiovisivo come memoria, che ho tenuto a Urbino il 19 marzo 2010 – appare qui anche come supporto mnemonico per chi l’ha seguita dal vivo. Altri post su temi connessi a questo si trovano sotto la categoria Sistemi di scrittura) |
||
|
Copyright © 2024 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||
Commenti recenti