Chi si ricorda di Monsieur Hulot? Lo aveva creato e lo impersonava Jacques Tati. Con l’apparenza della più assoluta normalità, Hulot affrontava situazioni sempre più sottilmente assurde. Il risultato era insieme imbarazzante ed esilarante. Non sapevi mai se vergognarti per lui, o ridere a crepapelle. Non era il surreale di Mr. Bean. Era qualcosa che continuava a rientrare nei limiti della norma, o quasi – ma ci rientrava al pelo, o forse non ci rientrava del tutto, ma faticavi a capire quale fosse l’elemento davvero deviante. Insomma, sembrava quasi la tua stessa quotidianità, o almeno una tua quotidianità possibile; potevi quasi essere tu, quello. Per questo ti sentivi un idiota mentre insieme ridevi: Monsieur Hulot era insieme lui e te stesso, era l’altro in qualità di deficiente, ma anche te – che di conseguenza non eri migliore di lui.
Nelle strisce del newyorkese Ben Katchor si respira la medesima aria sottilmente surreale, il medesimo soffio di normalità, e la medesima demente genialità. L’ho conosciuto personalmente a Bilbolbul, e mi è parso degno delle sue strisce, quasi un personaggio di se stesso. Ha partecipato a un incontro presso la facoltà di lettere, rispondendo a domande, e proiettando, negli intermezzi, delle sue strisce, a cui dava personale lettura.
Ogni volta la sensazione era la medesima. Un approccio iniziale del tipo: ma perché mi racconta questa cosa così normale? cosa ci sarà mai di interessante? Poi un seguito del tipo: sì, sarà normale, però è veramente assurdo! Infine uno sviluppo surreale, raccontato però con tutti i crismi dell’impersonale e oggettiva normalità.
Credo che il collante che rende le storielle di Katchor irresistibili sia il ritmo pacato e uniforme, ma inesorabile, che le porta avanti – anche sorretto da un disegno ugualmente normale, sino un po’ squallidino, sin quando non si entra nel gioco. La voce fuori campo delle didascalie, distaccata e oggettiva, sembra non fare altro che il resoconto, la cronaca, il report, di un evento normale. Solo che la normalità si rivela, passo dopo passo, sempre più illusoria, e l’ilarità sale, sale, sale, a mano a mano che si entra nel sottile delirio dell’indagine scientifica sul perché vi siano passeggeri del bus che stanno seduti a gambe aperte (costringendo alla fine i tecnici a un’imprevista riprogettazione dei sedili), o sul come si possa inventare una coreografia basata sul balletto spontaneo delle persone che cercano di sfilare il portafoglio dalla propria tasca… e così via.
Katchor coltiva l’apparenza della mediocrità, per fare emergere l’assurdo. Costruisce un ritmo martellante di cronache dall’aria oggettiva affinché l’incongruo possa rivelarsi da solo, senza che nessuno ce ne dichiari la natura. E poi finge di lasciare al lettore il compito di rendersi conto delle stranezze.
Il lettore ci casca. E gli piace pure. Anche questo è il bello del raccontare: è un inganno felice, una willing suspension of disbelief che ci procura piacere.







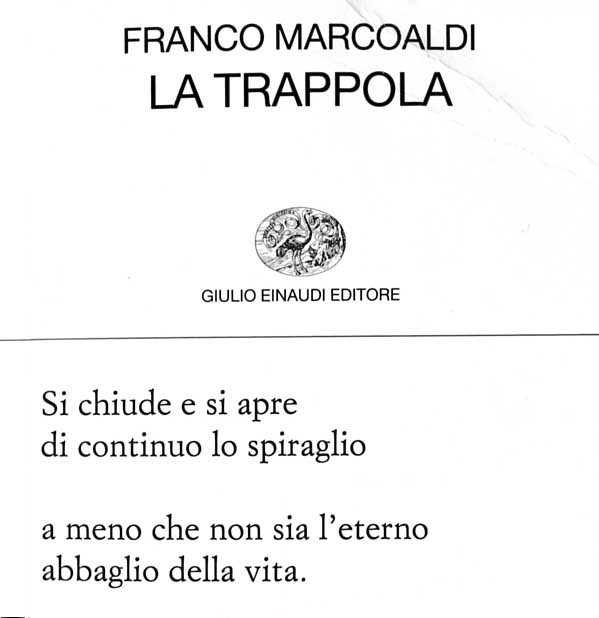






 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email






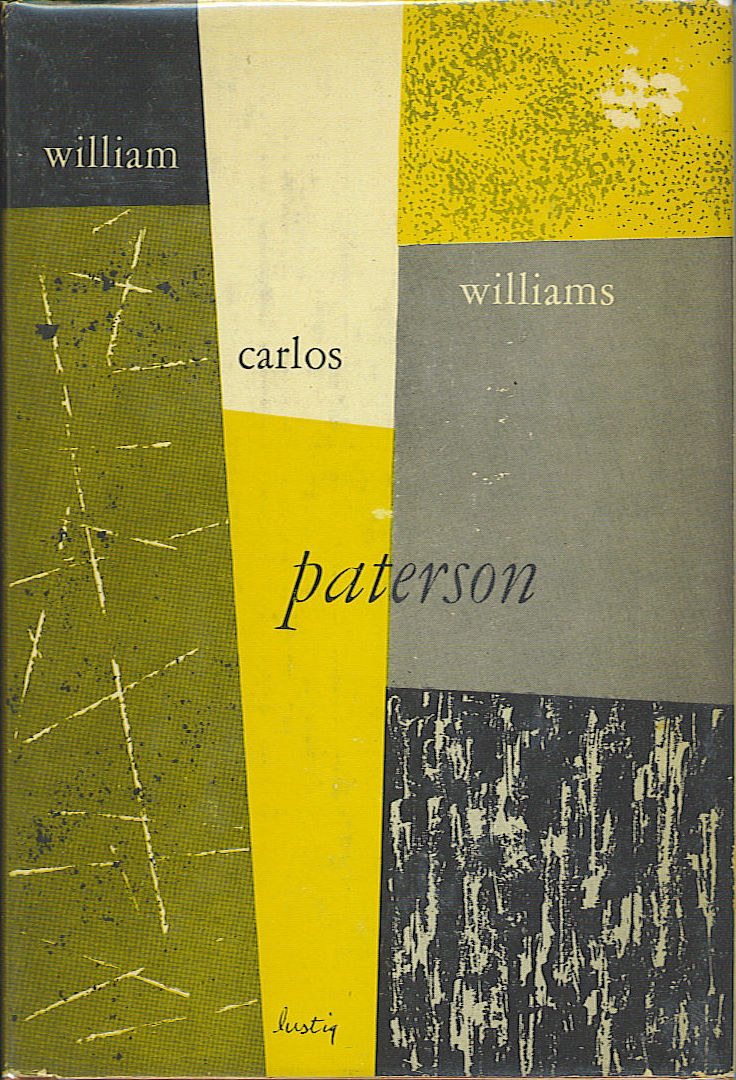

Leave a Reply