Ieri l’altro giornata pigra. Però, a metà pomeriggio abbiamo preso il motorino e siamo saliti a un passo proprio al centro dell’isola, in alto sulla valle di Vathì, proprio sopra Platanos (qui, su Google Maps, si vede la curva in alto – al centro – dove abbiamo lasciato la moto e la forra per cui siamo scesi). Mappa alla mano, il programma era quello di scendere per un sentiero, fare un pezzetto della strada nella valle, e poi risalire prima del buio (per prudenza ci siamo portati le torce) per un altro sentiero.
Di fatto, dopo cinquecento metri del sentiero in alto, abbiamo trovato una serie di bivi, e, pensando di interpretare la mappa, abbiamo preso quello sbagliato e ci siamo persi. Niente di grave, in sé, ma abbiamo sprecato circa un’ora a girare tra i sassi, i cespuglietti spinosi e gli alberi bassi, prima di ritrovare il sentiero giusto; e anche lì, potendo scegliere tra due potenzialmente equivalenti, abbiamo scelto quello sbagliato, che all’inizio sembrava tenuto meglio, ma dopo un poco è risultato abbandonato, e spesso lo si perdeva facilmente.
Insomma, siamo arrivati giù con un grande ritardo. Inoltre, guardando la parete della montagna, non c’era traccia del sentiero per risalire. Così abbiamo fatto l’autostop, e, come spesso succede nelle isole greche, la prima macchina che è passata ci ha raccolto e portato su (non che ne passassero molte: dovremmo dire la prima e unica).
La valle di Vathì è molto bella, e Platanos ne è il paese centrale. E’ una valle agricola e incredibilmente verde, per un’isola arida come sono di solito queste del Dodecaneso. Ci siamo tornati la mattina dopo alle sette, con un altro giro in programma. Sempre da Platanos, ma dall’altro lato della valle, c’è un sentiero che sale a 400m e ridiscende a Pothià, la cittadina capoluogo. Anche lì non è stato facilissimo trovare l’inizio del sentiero, ma poi il giro è stato bello, fresco e panoramico.
A Pothià ci siamo fatti un frapé sul porto, e poi abbiamo fatto l’autostop per tornare di là. Ci ha raccolti, dopo poco, un signore anziano, che parlava un italiano recuperato dalla memoria dei tempi in cui l’aveva studiato a scuola, all’epoca della dominazione italiana. Il dominio italiano era finito nel ’43, e il nostro salvatore stradale aveva la bellezza di 89 anni. Di questi ne aveva passati ben 48 a Bordeaux, facendo il commerciante, e quindi parlava anche un ottimo francese. Insomma, tra una lingua e l’altra, ci siamo capiti bene.
Ci ha raccontato che il platano al centro del paese, e che gli dà il nome, Platanos, appunto, era stato piantato da suo padre nel 1902. Mi è sembrato per un attimo di vivere una saga familiare tipo Cent’anni di solitudine. Poi ha insistito a portarci sino al motorino, benché lui fosse già arrivato. Gentilissimo.
Siamo andati a pranzare a Vlichadia, un po’ deludente. Troppa gente, ma era pure domenica. Abbiamo dormito sulla spiaggia, sino alle 17, poi siamo saliti a visitare il monastero in alto sopra Pothià: veduta stupefacente, aria troppo libera e aperta per sentire davvero un’atmosfera monacale.
Ho proseguito le mie lettura sulla mistica speculativa. Ma mi sembra che Vannini si spinga troppo in là considerando la Fenomenologia dello spirito come il punto più alto della mistica occidentale. Riesce a vederci persino alcune convergenze con lo Zen: presumibilmente ci sono davvero, ma poi, quando elenca le divergenze, mi sembra che non a caso dimentichi quella fondamentale, ovvero il pesante accento che lo Zen (e il Buddhismo in generale) pone sulla prassi, e sull’impossibilità per la speculazione teorica di oltrepassare certi limiti. La prassi implica il corpo, e l’azione materiale, che è esattamente quello che viene lasciato fuori da tutti i mistici di Vannini, se non attraverso le conseguenze di quello che viene chiamato “amore”, parola ambigua più di qualsiasi altra, e che vive il proprio successo nella religione proprio in virtù di questa impossibilità di definirlo.
Mi sembra che Vannini (con tutte le sue innegabili doti di storico) viva e ragioni in un mondo pre-fenomenologia e pre-psicoanalisi, dove si può impunemente parlare di spirito e pensare che questa parola abbia (come amore) un senso definito.
(à suivre)
Ieri mattina non siamo riusciti ad alzarci presto come avremmo voluto. Così abbiamo perso il bus, e abbiamo fatto l’autostop. Dopo dieci minuti ci ha preso su una macchina con un padre e figlio italiani, diretti al traghetto con meta aeroporto, per il figlio, mentre il padre sarebbe rimasto ancora un poco. Simpatici, cordiali, e soprattutto ci hanno fornito l’informazione essenziale su dove trovare un motorino a prezzo più basso.
Col motorino siamo andati a Pothià, la cittadina capoluogo dell’isola, con un gran traffico (per i ritmi a cui ci siamo abituati) e un bel museo archeologico, piccolo ma significativo, spaziante dal 3.000 a.C. sino al 1.400 d.C. Abbiamo mangiato in una uzerìa in un vicoletto percorso da un’incredibile brezza fresca, a due passi dal porto. I gestori parlavano solo greco, ma una bella ragazza tra i clienti ci ha fatto da interprete, via inglese, sino a quando ha scoperto che eravamo italiani, e allora è passata all’italiano. Nina, figlia di un greco di Kalymnos e di una slava di Spalato, conosciutisi a Pavia, dove entrambi studiavano, e anche lei nata a Pavia; da piccola i genitori le parlavano in Italiano, perché le restasse in mente (e forse anche perché all’inizio era la lingua che avevano in comune). Poi ci ha presentato un amico del padre, anche lui a suo tempo studente in Italia, che ci ha offerto da bere, come spesso si usa, sulle isole greche…
Siamo rimasti lì a lungo, in questa atmosfera così piacevole. Quando abbiamo chiesto a Nina se sapeva di qualche posto dove si facesse musica, ci ha detto semplicemente di tornare lì la sera, dopo le 9. Così ci siamo organizzati per farlo. Siamo ripartito col motorino e andati a Vathìs, qualche km più a est, un paesino di pescatori su un fiordo stretto stretto, così stretto che nemmeno c’è la spiaggia, solo il porticciolo, e intorno tutto a strapiombo, incantevole.
Così come incantevole era la spiaggia dove abbiamo riparato, a metà strada tra Vathìs e Pothià, al solito semideserta, con le solite meravigliose tamerici a dare ombra direttamente davanti al mare. Lì mi sono tuffato nella lettura del nuovo libro, che, tanto per restare in tema, è un libro di Marco Vannini, su Mistica e filosofia. Vannini è un ottimo studioso e storico di questi temi. I personaggi di cui parla sono affascinanti (Margherita Porete, Meister Eckhart, Nicola Cusano, Angelus Silesius…), ma io trovo in tutta la mistica speculativa un grave problema di fondo, che deriva in qualche modo dal suo stesso fascino.
Leggendo questi autori, o il resoconto del loro pensiero che fa Vannini, non posso fare a meno di avere la sensazione che questo abbandono totale della materia, a favore di un intelletto purissimo, che arriva a guardare nel fondo dell’anima, nell’essere dell’essere, finisca per configurarsi come una sorta di vertigine, in cui la ragione, lasciata a se stessa e senza più qualsiasi resistenza materiale, si avvolge ripetutamente su se stessa, sino a ubriacarci di conclusioni paradossali e straordinarie. La mia sensazione è, per riallacciarsi ai discorsi dei giorni scorsi, che i mistici speculativi finiscano per vedere il sacro (o il sublime, che è lo stesso) esattamente in questo vortice che è in loro.
Nella loro prospettiva il ganz andere (totalmente altro) di Rudolf Otto non è Dio, con il quale, al contrario, si cerca una paradossale unità, bensì l’atteggiamento stesso che permette all’uomo di camminare verso Dio, ovvero questa stessa riflessione iper-spirituale, questo stesso avvolgimento plurimo del pensiero su se stesso, in cui si finisce per perdere qualsiasi coordinata. Trovare il sacro così dentro di sé, nel proprio stesso intelletto, è quanto caratterizza questi mistici.
Ma se il sacro è un trascendentale, oppure, peggio, se è un effetto linguistico tipico delle lingue occidentali (indoeuropee e semitiche) questo ritrovamento finisce per diventare una possibilità ovvia, e finisce per apparire anche un fertile travisamento. Travisamento perché non si vede altro che quello che la nostra stessa costituzione fenomenologica o linguistica di fatto ha già posto in noi; fertile perché spesso i risultati sono comunque affascinanti, nella prosa paradossale della Porete e di Eckhart o nella poesia altissima di Silesius.
Tutto sommato, preferisco trovare il sublime (il sacro) nella musica, piuttosto che nel fondo dell’anima, questa discutibile astrazione. Anche per questo siamo tornati alla nostra uzerìa, la sera (Paradosiakò ouserie), dopo in realtà aver mangiato degli ottimi dolmadies alla taverna sulla spiaggia di fronte al mare.
Suonavano quattro amici: lauto, buzuki, un altro chitarrino minuscolo di cui non so il nome ma che potrei chiamare un buzuki o un lauto sopranino, e violino. Il lautista cantava anche. Musica popolare, di qui, suonata da dilettanti di qualità, ma pur sempre tali. Anche di questo genere ho sentito di meglio, per esempio a Creta. Però ascoltare queste cose dal vivo, a due metri dagli interpreti, magari cantando con loro (e il pubblico, greco, lo faceva continuamente) o addirittura ballando (come, dopo un po’, tanti hanno incominciato a fare, nel vicolo strettissimo) è davvero in ogni caso un’esperienza. Questo è davvero il senso del fare musica, con tutto il rispetto per la musica progettata, da concerto, che ha evidentemente comunque i suoi pregi: quello di essere un’attività che non separa un esecutore da un pubblico, ma che unisce chi è un po’ di più esecutore (ma intanto si ascolta anche) e chi è un po’ di più pubblico (ma che canta anche, e balla, e partecipa).
Col passare delle ore, e l’aiuto di birra e ouzo, si aveva davvero l’impressione di un fervore collettivo, di un riconoscerci tutti attorno al medesimo qualcosa, e quel qualcosa era la musica. In questo senso di comunione che si costruisce attraverso la musica in questo modo, io vedo più sublime e più sacro che non nelle astrazioni dei mistici speculativi. (Qualcuno, con cui avevo semplicemente scambiato qualche sguardo complice sul piacere della musica, ci ha di nuovo offerto da bere)
Siamo tornati nella notte, 25 km sul motorino di cui metà nella strada buia, con gli oleandri attorno, e la consapevolezza dello strapiombo sul mare alla nostra sinistra. Nelle orecchie avevo ancora la musica. Da bravo turista, non ho potuto fare a meno di registrare (e videofilmare) parecchi pezzi della serata, ma per quanto buone posano essere le registrazioni (e non lo sono) non sarà mai la stessa cosa. Però mi permetterà di ricordare meglio l’esperienza.
Scritto il pomeriggio del giorno dopo, su una poltrona nel giardino, sotto ulivi e bouganville.
Kalispera.
 Canaletto, "Il bacino di San Marco" Sono stato a Rimini, nei giorni scorsi, a vedere la mostra “Da Vermeer a Kandinsky. Capolavori dai musei del mondo a Rimini”. La mostra ha il livello di coerenza interna che il suo titolo promette, cioè nessuna: sala dopo sala, opera dopo opera, non sono riuscito a trovare nessun filo conduttore che le tenesse insieme. Tuttavia, la mostra mantiene anche quello che il titolo promette: pur senza nessuna logica di accostamento, le opere esposte sono davvero dei capolavori, e ci sono sia Vermeer (cosa davvero rara) che Kandinsky, insieme a un mucchio di altri autori (che potete, se vi interessa, scoprire qui).
Tra questi autori, il primo del lungo percorso è Antonio Canal, detto il Canaletto, con la tela poveramente riprodotta qua sopra, in realtà di un formato di circa 4 metri per 2. Si tratta di un dipinto straordinario, di quelli che tengono avvinta l’attenzione a lungo, e si fatica davvero a passar oltre – ed è un esempio perfetto di irriducibilità di un dipinto alle sue riproduzioni in scala ridotta.
Quello che probabilmente potrete cogliere dell’opera originale in questa riproduzione è la struttura complessiva, l’organizzazione plastica generale, il grande senso di apertura, di prospettiva, di cielo – e magari pure, con un poco di attenzione in più, l’inclinazione bassa dei raggi del sole, che enfatizza i contrasti luministici, e contribuisce all’effetto drammatico complessivo. Non è poco. L’immagine di Canaletto continua a rimanere bellissima persino così.
Ma di fronte all’originale che vedevo nella mostra succedeva anche qualcos’altro: quello che il mio occhio non poteva non fare era passare continuamente dalla veduta complessiva ai dettagli (dei muri, delle finestre, delle barche…), e dai dettagli alla veduta complessiva, e poi ancora dal generale al particolare, e così via. È questo che rende per me i dipinti del Canaletto tanto più affascinanti di quelli, per esempio, del suo contemporaneo e conterraneo Francesco Guardi, che ha un gusto plastico complessivo e un senso dello spazio che non sono inferiori a quelli del Canaletto, ma che lavora molto meno sulla puntigliosità del dettaglio, preferendo un, comunque (ma diversamente) affascinante, virtuosismo del pennello e del tratto. (E magari, pure, è meno attento alla luce – però questo potrebbe anche essere soltanto un effetto collaterale della meticolosità di Canaletto).
Insomma, nel trovarmi di fronte a questo grande spazio dipinto, non posso fare a meno di mettere continuamente in relazione microcosmo e macrocosmo, che sono immediatamente compresenti ai miei occhi. È vero che, in ciascuno specifico momento, o sono concentrato sul dettaglio oppure lo sono sull’insieme; però il passaggio dall’una all’altra attenzione è rapidissimo, immediato e immediatamente reversibile. Immaginate la differenza con quanto di meglio si potrebbe ottenere sullo schermo di un computer: se questa immagine qui sopra possedesse una risoluzione sufficiente a rendere merito all’originale, gli strumenti tecnici opportuni per visualizzarla permetterebbero di passare molto rapidamente dalla visualizzazione del dettaglio a quella dell’insieme e viceversa. Tuttavia, questa rapidità continuerebbe a essere in ogni caso incomparabilmente minore di quella dell’occhio, perché richiederebbe sempre un intervento della mano per modificare l’intensità dello zoom; e non ne ricaverei comunque la sensazione di essere di fronte, allo stesso tempo, all’insieme e a tutti i suoi dettagli. Certo che, non potendo possedere l’originale, né una sua copia a grandezza naturale, sarei felice di avere almeno il file ad alta risoluzione – ma il file ad alta risoluzione non potrebbe restituirmi comunque l’esperienza della presenza.
Tengo a precisare che non sto parlando di feticismo dell’originale, dell’emozione di trovarmi vicino a quello che è stato prodotto direttamente dall’artista. Sono ovviamente, queste, emozioni che esistono e hanno il loro peso nella fruzione dell’arte. Ma non sono ciò di cui sto parlando.
Quello che mi interessa qui è osservare che praticamente solo alla pittura (insieme alle altre arti dell’immagine statica: disegno, scultura, fotografia…) è data questa possibilità di associare così strettamente l’atto con cui si coglie l’insieme con quello con cui si coglie il dettaglio. Nelle arti che hanno sviluppo temporale, per esempio, come la musica, il cinema, il romanzo, il fumetto…, non possiamo che cogliere dettagli, mentre l’insieme è inevitabilmente presente solo nella ricostruzione mnemonica che ne facciamo. Non è possibile cogliere l’insieme di una sinfonia o di un racconto, se non in astratto: esso non sta mai davanti a noi nella sua fisicità come l’immagine di Canaletto.
Non è che la fruizione non abbia sviluppo, percorso, temporalità, di fronte alle arti puramente visive – così come ce l’ha, necessariamente, di fronte alle altre arti. Il punto è semmai che questo percorso o sviluppo non è predeterminato, ed è sempre fatto di salti avanti e indietro tra il tutto e le parti, dove il tutto non è un’astrazione mnemonica, bensì una presenza percettiva allo stesso titolo delle parti.
Il dipinto di Canaletto suggerisce così a ogni successivo sguardo una misteriosa consustanzialità tra i dettagli delle finestre, delle sartie e dei muri da un lato, e la meravigliosa apertura dello spazio, della luce e del cielo che cattura immediatamente l’attenzione, dall’altro. E siccome la dimensione del dettaglio è quella che noi viviamo continuamente, nella nostra vita normale, questa misteriosa consustanzialità ci riguarda direttamente, e suggersice a sua volta che noi stessi e la nostra dimensione possono trovarsi in sintonia con lo spazio, con la luce e con il cielo.
Insomma, nel complesso, un dipinto estatico, mistico, quasi una riflessione sul sacro – benché per nulla religiosa, anzi mondanissima.
 Cristina Alziati, da "Come non piangenti" (Marcos y Marcos, 2011) Permettetemi di fare non il critico, ma il lettore, e di tornare a una delle poesie di Cristina Alziati, di cui ho già parlato due settimane fa. Ci voglio tornare perché nel rileggerla una volta apparsa in quel post, mi sono accorto che c’era qualcosa che mi risuonava nelle orecchie, e sono andato a verificare.
Faccio il lettore, e non il critico, perché non ho prove che la mia percezione si fondi in una qualche competenza o interesse dell’autrice, e che questo legame che io ho percepito sia mai stato presente anche a lei. Magari sì, ma non è comunque quello che mi interessa qui. Faccio il lettore perché è della mia sensibilità che parlo, o della sensibilità del lettore in generale, o del modo in cui le idee passano le epoche e attraversano le persone anche a prescindere dalla loro consapevolezza dell’origine di quelle idee.
Quello che voglio dire è che, almeno per me, nella piacevolezza e nell’interesse di questi versi trovo nascosto un collegamento antico e intrigante, quello a un mistico medievale tedesco e alla sua affascinante teologia della negazione. Parlo di Meister Eckhart, nato nel 1260 e morto intorno al 1327, maestro di quella che potremmo definire come una forma affascinante di teologia negativa.
Non c’è bisogno di essere religiosi né credenti per trovare interesse in questo personaggio e nelle sue posizioni (le quali all’epoca gli costarono un processo per eresia, che non lo condusse al rogo solo perché era già un personaggio troppo importante). Basta leggere affermazioni come questa (citata, come le seguenti, nel libro di Marco Vannini, Storia della mistica occidentale, Mondadori, 1999):
Prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era. Quando le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio nelle creature. Ora diciamo che Dio, in quanto è Dio, non è il più alto fine della creatura. Infatti anche la più piccola creatura in Dio ha una dignità grande quanto la sua.
O anche come questa:
Perciò prego Dio che mi liberi di Dio, perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi concepiamo Dio come origine delle creature.
È però quando leggiamo cose come questa che i versi della Alziati diventano di colpo pertinenti:
I maestri dicono che Dio è un essere, un essere dotato di intelletto, che tutto conosce. Ma io dico: Dio non è né essere né essere dotato di intelletto, e neppure conosce questo o quello. Perciò Dio è privo di tutte le cose, e perciò è tutte le cose. Chi deve essere povero nello spirito deve essere povero di ogni sapere proprio, in modo da non sapere niente, né di Dio, né delle creature, né di se stesso. Perciò è necessario che l’uomo desideri di non sapere o conoscere niente delle opere di Dio. In questo modo l’uomo può essere povero nel proprio sapere.
Mezzo millennio prima di Immanuel Kant, Eckhart si è imbattuto nelle aporie di quella che sarà la Dialettica Trascendentale, e si rende conto dell’impossibilità di dire cose certe (ovvero, per un razionalista scolastico, dimostrate) né su Dio, né sul mondo (le creature), né sull’io: guarda caso esattamente le tre idee aporetiche messe a nudo da Kant. Ma Eckhart non possiede gli strumenti concettuali che guideranno poi Kant, e non può che rifugiarsi nella mistica, o nelle definizioni al negativo, sino alle profondità del paradosso.
È questo che mi rispondeva nei versi della Alziati: che l’essenza di un poeta stia nel non scrivere, e nel farsi ingombrare l’anima non tanto dalle cose (il che sarebbe naturale) ma dal loro farsi mute, dal loro silenzio, mi sembra come un meraviglioso paradosso, così affascinante e avvitato su se stesso che continua a muovere la mia immaginazione, e il mio razionalistico tentativo di spiegazione.
In Eckhart si trova anche l’idea che la conoscenza sia in sé qualcosa da evitare, perché manifesta una separazione. In particolare la conoscenza di Dio, quella che lo descrive come soggetto agente, non può essere che l’espressione di quell’impasto di menzogne che è la Eigenschaft, la volontà personale, l’io individuale. La strada di Eckhart è piuttosto quella, mistica, della ricerca dell’identità originaria con Dio (incredibilmente in linea, per probabile pura convergenza storica, con le posizioni filosofico-mistiche dello shivaismo induista).
Il poeta dei versi della Alziati si caratterizza per un rapporto simile non tanto con Dio, che non è in gioco qui, ma con il mondo. Ma è un mondo che a sua volta non sa parlare, e il suo non parlare corrisponde al nostro non scrivere. La rispondenza c’è, e profonda, ma si basa su una comune assenza, su un comune distacco, quello dalla parola come strumento di conoscenza dualistico.
Possiamo ancora parlare di conoscenza, per quanto riguarda la poesia, a questo punto? Forse no, ma non importa molto. Parleremo forse di vita, o di Erlebnis…
Un’altra chicca di Meister Eckhart, per finire:
In quell’essere di Dio in cui Egli è al di sopra di ogni essere e di ogni differenza, là ero io stesso, volevo me stesso e conoscevo me stesso, per creare questo uomo che io sono. Perciò io sono la causa originaria di me stesso secondo il mio essere, che è eterno, e non secondo il mio divenire, che è temporale. Perciò io sono non nato e, secondo il modo del mio non essere nato, non posso mai morire. Secondo il modo del mio non esser nato, io sono stato in eterno, e sono ora, e rimarrò in eterno. Cosa invece sono secondo il mio esser nato dovrà morire ed essere annientato, perché è mortale, e perciò deve corrompersi con il tempo. Nella mia nascita eterna nacquero tutte le cose, e io fui causa originaria di me stesso e di tutte le cose; e, se non lo avessi voluto, né io né le cose saremmo; ma se io non fossi, neanche Dio sarebbe: io sono causa originaria dell’essere Dio da parte di Dio; se io non fossi, Dio non sarebbe Dio.
Duemila anni di teologia vaticana gettati alle ortiche.
 Cristo tra gli angeli a Shantivanam, Kulittalai Questa foto è stata presa presso il monastero camaldolese di Shantivanam, vicino a Kulittalai nel Tamil Nadu. Quel signore con tre teste al centro dell’immagine è Cristo, e quella davanti a lui è una croce. Alle spalle degli altrettanto cristianissimi angeli c’è invece un tempio, in classico stile tamil.
Il Cristo a tre teste non è un’immagine deviante della Trinità, ma semplicemente l’adeguamento a una consuetudine iconografica diffusa in India, dove spesso le divinità sono rappresentate con più teste, senza che questo debba implicare che le hanno per davvero.
Comunque, questo portale (è l’ingresso all’area della chiesa) dà bene l’idea del modo in cui i monaci di Shantivanam intendono il cristianesimo, anzi il cattolicesimo. Dal punto di vista della dottrina è un cattolicesimo sostanzialmente ortodosso, ma nel modo in cui si presenta, e persino nella liturgia, prende una serie di forme della tradizione religiosa induista, in modo da essere più accettabile per la popolazione locale.
Ho passato tre giorni a Shantivanam, in missione – diciamo così – antropologica, ma partecipando alla vita della comunità, liturgie comprese. Il luogo in cui si trova è incantevole, e sono stati giorni molto rilassanti e interessanti.
Devo dire, tuttavia, che, anche se i monaci camaldolesi meritano tutto il rispetto (perché sono camaldolesi, per la vicenda umana e spirituale che ha portato alla nascita di questo luogo, per la vita contemplativa che fanno e per il sostegno educativo e lavorativo che prestano alle popolazioni circostanti) questa isola di cattolicesimo camuffato mi sembra una sorta di piccolo tumore, con componenti benigne e maligne – ma comunque estraneo all’universo in cui si situa. È il prodotto di un sogno, fatto da alcuni Europei infatuati dell’India e del suo misticismo, che non hanno saputo rinunciare alla propria tradizione e hanno preferito cercare di impiantarla qui – per quanto riformata e adattata.
Con tutto l’onore che si può (si deve) tributare ai padri Henri Le Saux e Jules Monchanin, la sensazione oggi è che del loro sogno panreligioso non sia rimasta che questa piccola operazione imperialista cattolica, il cui fascino residuo sta anche nella sua impossibilità di crescere più di tanto. La spiritualità induista qui attorno sembra rigogliosa come la vegetazione che circonda il monastero. E magari qualche volta succede pure che chi si traveste finisce per diventare davvero quello che faceva finta di essere.
I dominatori inglesi consideravano l’induismo una forma di barbarie. Nel mio viaggio in India ho avuto spesso l’impressione, piuttosto, che i veri barbari siamo noi. Buon Natale.
17 Febbraio 2010 | Tags: Arte, arti, comunicazione visiva, Edmund Burke, estetica, fantascienza, fantasy, generi, graphic design, horror, Immanuel Kant, Michelangelo, mistery, misticismo, Nicolas Boileau, Nicolas Poussin, Pseudo-Longino, Raffaello, sacro, Salvator Rosa, Samuel H. Monk, Settecento, sublime | Category: comunicazione visiva, estetica, graphic design | Ho letto da poco un bel libro di Samuel H. Monk: Il Sublime. Teorie estetiche nell’Inghilterra del Settecento (Genova, Marietti, 1991). È un libro scritto negli anni Trenta, il primo che affronta questo tema storiografico. È interessante perché racconta la nascita e diffusione di un concetto destinato a trasformare per sempre la nostra concezione dell’arte.
Quello di sublime è un concetto antico. Proviene da un testo di incerta datazione (Peri Hypsous, I secolo d.c., secolo più, secolo meno) e ignota paternità. Poiché tradizionalmente lo si attribuiva a Cassio Longino, oggi ci riferiamo al suo (ignoto) autore come Pseudo-Longino. Lo riprende Nicolas Boileau, uno studioso francese della fine del Seicento, che per primo pubblica nel 1674 un trattato di arte poetica ispirato allo Pseudo-Longino, aprendo la strada, assai più di là che di qua dalla Manica, a un dibattito che, decennio dopo decennio, cresce sempre più, e finisce per imporre un’idea dell’arte basata sul lampo di genio e sull’imponderabile, piuttosto che sul rispetto delle regole e sulla capacità di modularne le possibilità.
Ovviamente, è l’Enquiry di Edmund Burke il testo cruciale del secolo, che impone a partire dal 1757 il nuovo paradigma. Già nel 1764, Kant (che era notoriamente un appassionato di cultura inglese) pubblica le sue leggere Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, testimoniando la presenza del dibattito anche in Germania, e il suo debito con Burke. Qualche decennio più tardi farà del sublime uno dei capisaldi della sua teoria estetica.
Il dibattito che si sviluppa nel Settecento inglese è di grande interesse perché testimonia il passaggio tra una concezione dell’arte come rispetto (intelligente e creativo) delle regole, a una concezione dell’arte come furore creativo, prodotto di un’ispirazione di tipo divino, quella sorta di misticismo non religioso che sarà il pane quotidiano del Romanticismo, e che ancora oggi ci induce a pensare all’Arte (con la A maiuscola) come qualcosa di particolarmente elevato, che attinge comunque alla sfera del sacro (anche quando questo sacro non ha niente a che fare con la religione). Insomma, se a inizio Settecento l’ideale della pittura è per gli inglesi Raffaello, a fine secolo sarà Michelangelo; se a inizio secolo il paesaggio ideale è per gli inglesi quello classicistico di Nicolas Poussin, a fine secolo sarà quello selvaggio e sublime di Salvator Rosa.
Non è difficile vedere gli effetti di questa trasformazione nella concezione dell’Arte ancora oggi dominante. Per noi, l’opera d’Arte è quella cosa che in qualche modo ci travolge, ci porta con sé, e sembra schiuderci di colpo nuovi orizzonti di comprensione. L’artista è il genio, magari immortale, che ha saputo forgiare questo oggetto così straordinario. Anche se la parola sublime non è molto di moda (ha smesso di esserlo già ai primi dell’Ottocento) siamo talmente addentro a una visione dell’arte come sublime che facciamo addirittura fatica a capire come prima del XVIII secolo si potesse concepire l’Arte in maniera differente, e cerchiamo conforto nel fatto che, tutto sommato, non è difficile trovare il sublime in Michelangelo come in Dante, in Fidia come in Saffo: tutto sommato, dunque, l’Arte sarebbe stata sempre sublime, anche prima che qualcuno arrivasse ad accorgersene.
Si tratta però di un errore di prospettiva, come se ritenessimo che, poiché noi vediamo le cose da un certo punto di vista, non si possa che vederle da quello. Forse un’idea dell’arte come adeguamento (creativo e intelligente) alle regole ci può apparire più comprensibile se la confrontiamo non con l’idea diffusa oggi dell’Arte, bensì con l’idea diffusa oggi di che cosa sia la comunicazione visiva, nelle sue espressioni, per esempio, del graphic design e della pubblicità.
Nessuno va a scomodare il sacro per parlare della bellezza di un’impaginazione, di una copertina o di un cartellone pubblicitario. Piuttosto, parliamo di efficacia comunicativa, di gioco tra rispetto e trasgressione delle regole, di opportunità nei confronti di ciò che si desidera comunicare. Questa non è naturalmente la stessa cosa che i teorici pre-sublime dicevano dell’arte, ma ci va sufficientemente vicino da permetterci di capire che l’estetica del sublime si contrappone a un’estetica funzionale dell’arte, che la vede come una tecnica (creativa) di prodotti di consumo comunicativo, non così lontana dal graphic design di oggi. Una visione di questo genere non esclude, ovviamente, che anche all’interno di un’arte funzionale non possano nascere opere sublimi: succedeva con Michelangelo e Salvator Rosa assai prima che il requisito diventasse essenziale, e succede ancora oggi nel lavoro di tanti comunicatori visivi che pure non operano all’interno del campo dell’Arte.
Del resto che i confini tra arti e Arte siano labili è cosa sufficientemente evidente, e la presenza o meno di aspetti sublimi (o sacri, in senso laico) mi produce semmai differenze di valutazione, ma non necessariamente di campo di appartenenza – salvo quando i sacerdoti dell’Arte non decidono di ammettere nel proprio recinto qualcuno che, per il modo in cui lavora, ne dovrebbe presumibilmente star fuori, come il Toulouse-Lautrec cartellonista, o El Lisitskij. La mia sensazione è che la distinzione tra arti e Arte, che corrisponde storicamente all’entrata in gioco del sublime, sia legata alla diffusione della razionalità illuministica, che mette in crisi il sentimento religioso: poiché del sacro l’uomo non può comunque fare a meno, a un sacro di carattere religioso come quello tradizionale, l’Arte sostituisce un sacro laico, un misticismo del bello e dell’elevato, che diventa cruciale in un campo in cui magari esso era già presente, ma con un ruolo molto più marginale.
C’è un secondo motivo di interesse nel libro di Monk. Come sempre succede quando si diffonde un’idea nuova, se ne cercano tutte le applicazioni possibili e non di rado si esagera. Poiché il sublime è legato all’idea dell’ignoto e del mistero, le estetiche inglesi della fine del Settecento vedono la sua massima espressione nella letteratura cosiddetta gotica: il mistery, l’horror, il fantastico. L’idea dura abbastanza da produrre il grande successo del più riuscito falso della storia della letteratura, i Canti di Ossian, ma è sufficientemente balorda da non durare troppo a lungo, travolgendo il termine stesso sublime (ma non i suoi effetti) nel proprio tramonto.
Quando tramonta l’idea dell’horror come massima espressione del sublime, non tramonta però l’horror, né il fantastico, né i loro figlioletti (il poliziesco, la fantascienza, il supereroico, il fantasy…), i quali proseguono, con alterne ma mai misere fortune, sino a noi. È divertente osservare come l’Arte (con la A maiuscola) e questi generi che tipicamente vivono ben al di fuori dai suoi confini, abbiano la medesima origine. La Storia procura sempre un sacco di sorprese.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|








 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email






















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco
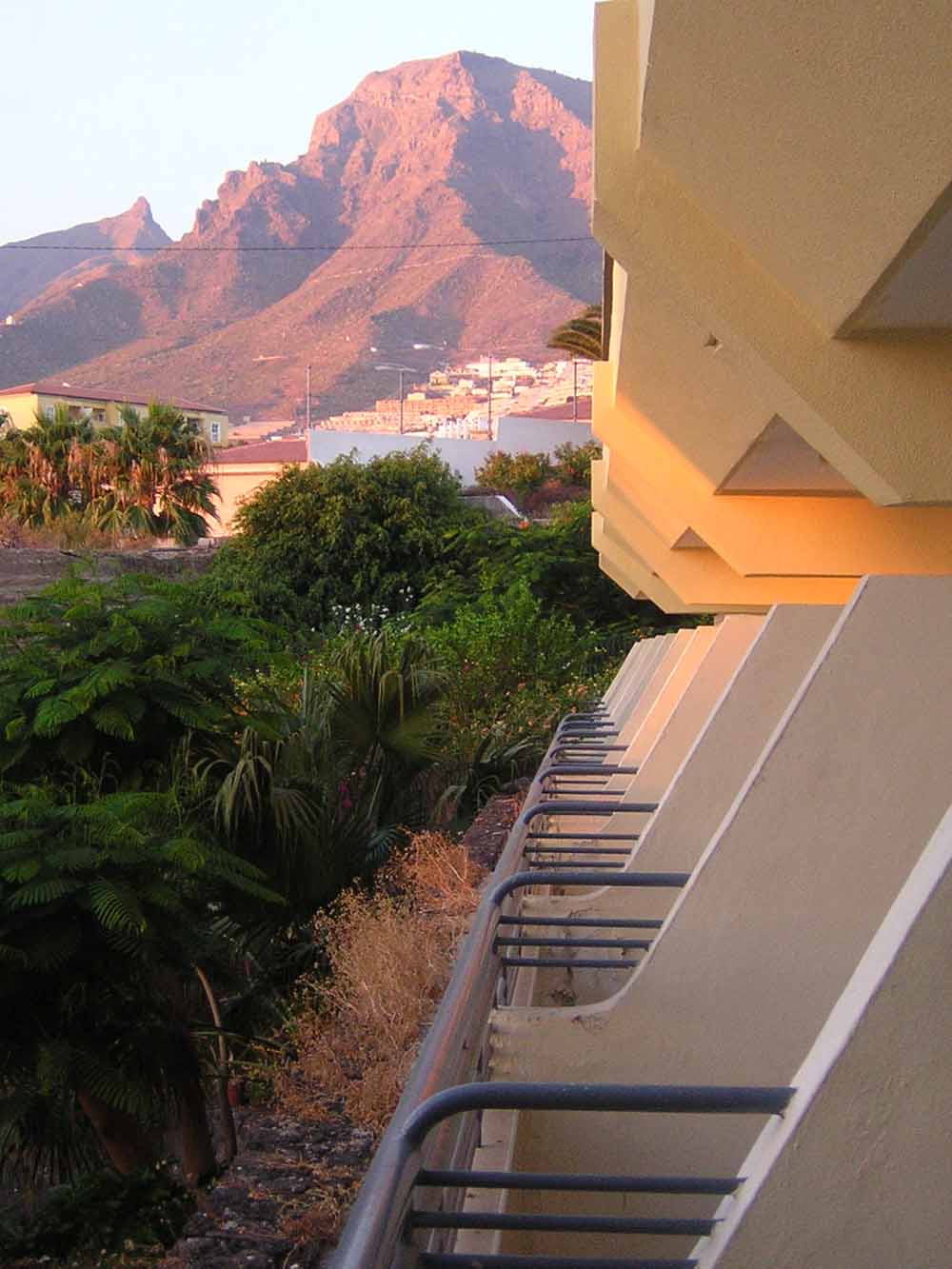





Commenti recenti