
Carlos Gomez, Dago
Riprendo questo tema che ha lanciato Harry qui, e l’ha poi ripreso qui, dopo un mio commento in cui gli chiedevo di spiegarmi perché anch’io leggo così volentieri Dago. Intendiamoci, si parla delle storie contenute nel mensile Dago Ristampa (che contiene le ristampe delle storie già pubblicate sui settimanali della Eura/Aurea), scritte da Robin Wood e disegnate da Carlos Gomez – e non confondiamolo col mensile Dago, che pubblica storie nuove, scritte e disegnate da altri apposta per il mercato italiano, di qualità mediamente molto bassa, e di cui non varrebbe affatto la pena di parlare (e nemmeno di leggerlo, in verità). A vantaggio di chi si è perso quello che è uscito sin qui, dal 2008 è iniziata anche la ristampa della ristampa, a colori, nella Collezione Tuttocolore.
Il mistero è questo: Dago è un fumetto seriale. I disegni, prima di Alberto Salinas e in seguito di Carlos Gomez, sono di ottima qualità. Le storie, a giudicare dalla passione con cui io stesso e tanti altri le leggiamo, pure: ma i temi ormai si ripetono, e anche prima che all’interno della serie si ripetessero erano noti e stranoti, puri stereotipi di genere, strabordanti di un moralismo che in altre circostanze io troverei stucchevole, popolati di personaggi già conosciuti mille volte. Inoltre, se uno ha praticato un po’ il fumetto argentino, tutto questo appare ancora più vivido, e più ossessivamente ricalcato.
Insomma, la mia testa mi dice che, se devo giudicare da questo, Dago non è che un ennesimo prodotto seriale che non fa che ricalcare percorsi già pesantemente calcati da altre mille storie, roba buona per lettori poco esperti, o dal palato grezzo. Eppure, a dispetto di questo, mi ritrovo ogni tanto a domandarmi quando uscirà il prossimo numero; e poi, quando torno a casa dall’edicola dove ho fatto incetta di nuove uscite, la mia prima lettura è inevitabilmente Dago. Di conseguenza, o il mio palato fumettistico è davvero grezzo, oppure in quello che la mia testa mi dice c’è qualche errore o mancanza.
Harry suggerisce questo:
Ma osservando da un altro punto di vista la risposta è antropologica: Wood sa raccontare la vita nei suoi bisogni primari. Prima ancora che tecnico, è un successo basato sulla sensibilità artistica dello sceneggiatore. Wood mette a nudo le dinamiche primarie che muovono le esistenze. Il filtro della guerra in forma di dramma svela gli attaccamenti, il desiderio sessuale, il bisogno di affermazione, la crudeltà, la fame, la vendetta, la sacralità della vita, e così via. Di questo Wood sa raccontare alla perfezione. E ogni tassello, ogni ritorno, ogni variazione, offrono un’opportunità di comprensione. Il gioco funziona, insomma, per forza dell’occhio con cui Wood osserva e della sua forza evocativa. Doni rari.
Tutto questo è vero, ma in realtà non mi basta. Ci sono tanti fumetti che affrontano questi temi e non hanno certo la qualità di Dago. Però quello che Harry dice è ugualmente utile a circoscrivere meglio il problema: ovvero, dunque, come fa Wood a mettere a nudo così bene queste dinamiche primarie? In che cosa consiste la sua perfezione?
Voglio approfittare anche di un suggerimento che proviene da un altro lettore appassionato di Dago, cioè Umberto Eco, che nell’introduzione al convegno La linea inquieta, nel 2004, diceva:
Cito Dago come caso interessante perché in esso si manifestano tre fenomeni molto ben distinti: (i) la rivisitazione visiva sia della tradizione rinascimentale che della tradizione dei grandi illustratori moderni come Gustavino; (ii) la sapienza narratologica di Robin Wood nel realizzare una combinatoria infinita di vari topoi romanzeschi, da quelli picareschi a quelli neogotici e romantici; (iii) l’assoluta banalità stilistica del discorso verbale, che si attiene a una retorica da feuilleton ottocentesco, e senza alcuna ironia sottintesa. Aggiungerei che dal punto di vista sociologico è forse proprio questa strana commistione che giustifica il successo popolare della serie, ma ecco che si vede come un’analisi sociologica debba sovente essere preceduta da una valutazione critica molto rigorosa.
Anche qui non andiamo molto al di là di qualche intuizione, però trovo che sul fuoco ci sia già più carne. Intanto vi si osserva che non è che Salinas e Gomez siano semplicemente bravi disegnatori, ma che in questa bravura è presente una competenza iconologica che ci permette di collegare continuamente Dago a una serie disparata di tradizioni, da quella rinascimentale (epoca di ambientazione delle vicende) a quella otto-novecentesca degli illustratori (epoca in cui si forma la nostra competenza visiva di lettori).
La banalità stilistica del racconto verbale è quello che potremmo definire il basso continuo della serie: una specie di accompagnamento necessario, senza il quale non si comprenderebbero le vicende, ma che è il più banale e scontato possibile proprio perché non deve attirare l’attenzione: si legge e scorre via. L’accento è su altro.
E poi c’è la combinatoria infinita dei topoi romanzeschi, presi dalle tradizioni più diverse, che corrisponde, sul piano narrativo, alla competenza iconologica su quello visivo. È come dire che il lettore di Dago ritrova continuamente il già noto, però intrecciato in combinazioni non necessariamente note.
Di nuovo, tutto questo è vero, ma ancora non basta. Ci avvicina un po’ alla soluzione, ma non ce la dà.
E allora proverò a esplorare dentro di me, a capire quali sono le sensazioni che mi tengono avvinto a queste storie, senza escludere neanche le più banali.
Così, intanto, c’è l’ambientazione storica. La prima metà del Cinquecento è un periodo già di per sé affascinante (per me in particolare, anche prima di Dago): l’Europa è ricca, piena di artisti e di entusiasmo, ma è già scivolata in un’epoca di guerre feroci e di contrapposizioni religiose, che la stanno portando molto vicina al disastro. Da questo punto di vista la documentazione di Wood è davvero rigorosa; è ovvio che la storia di Dago è fantastica, però ogni tanto si incrocia con eventi e personaggi storici: ho fatto diversi controlli, ma non sono riuscito a cogliere Wood storicamente in fallo.
Poi, c’è la ricchezza dei temi: è vero che i temi si ripetono e che si rifanno sempre a un qualche modello noto, però sono tantissimi, e di conseguenza è multiforme la loro combinatoria. Non so se si possa dire che Wood è capace di sottigliezza psicologica: i personaggi appartengono tutti a casistiche abbastanza ben definite, di provenienza follettonistica. Però sono combinati così intelligentemente con la storia in cui agiscono che anche nel rispetto dello stereotipo appaiono credibili, convincenti, molto umani.
Poi c’è la questione del moralismo. Certo, in Dago il bene è bene e il male è male, però c’è anche un’ampia zona intermedia, e non è detto che il bene trionfi sempre pienamente. Lo stesso Dago, il protagonista, sempre pronto a battersi per cause giuste, porta nel cuore un desiderio sanguinoso di vendetta. Complessivamente i morti sono tantissimi sia dalla parte del bene che da quella del male. Lo potremmo definire un moralismo amaro, e pieno di comprensione per le debolezze della vita. Insomma, anche qui, qualcosa di sufficientemente complesso da non essere sentito come banale.
Infine, collegato a tutto questo, c’è la questione dell’epica. Per certi versi Dago è un romanzo cavalleresco popolare, fatto di schemi e stereotipi come già pure quelli del Pulci e dell’Ariosto, che erano i capolavori che erano anche a ragione di questi schemi e stereotipi.
In fin dei conti, la mia idea è che il piacere che Dago produce nella lettura sia una questione di ritmo, e di rito. Senza componenti rituali (di cui il ritmo è comunque la base) non si producono testi con qualità estetiche. Nella nostra cultura, alla componente rituale si deve associare una componente di originalità e di novità; ma non è sempre stato così. O meglio, la rilevanza della componente innovativa è diversa da epoca a epoca, da luogo a luogo, da genere a genere, da attività a attività. Nel rito vero e proprio, come quello religioso, la componente innovativa è nulla. Nelle produzioni estetiche, viceversa, è ciò che tiene vivo il nostro interesse, permettendoci di trovare piacere nel frattempo anche in quel ritorno del già noto che crea ritmo e rito. Così, il piacere delle produzioni estetiche ha due tipi di fonte: da un lato quello della scoperta (dovuto alla novità), dall’altro quello della conferma e sicurezza (dovuto al ritmo).
Credo che Wood (con Salinas e Gomez) abbia trovato una via inedita per riproporre quell’idea antica di racconto popolare di cui il poema cavalleresco è stata anche a suo tempo espressione, e che è il modello anche del mito: tutto quello che succede ci è in qualche modo già noto e i valori espressi sono i qualche modo i nostri; e tutto è rassicurante, ma non perché sia banalmente positivo, ma semplicemente perché rispecchia, anche nel male, l’idea che abbiamo della vita e del mondo.
Dago è una sorta di rassicurante liturgia, che si legge volentieri perché non mette in questione nulla, fondamentalmente, però ci porta alla mente tante cose diverse. È, in questo senso, una telenovela d’alto bordo, dai contenuti tutt’altro che banali. Non dobbiamo aspettarcene nessuna proposta particolarmente originale, perché Wood è sempre attento a tenersi eticamente e psicologicamente sul generico – e la distanza storica aiuta. Ma il suo gioco è comunque affascinante e confortante.
Tutto questo forse non svela del tutto il mistero di Dago, però qualche passo avanti mi sembra di averlo fatto.











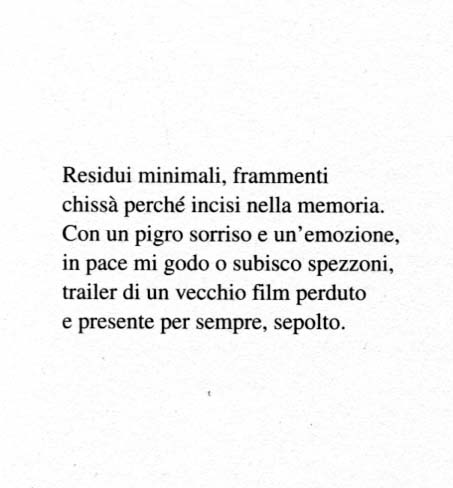
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email





















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco



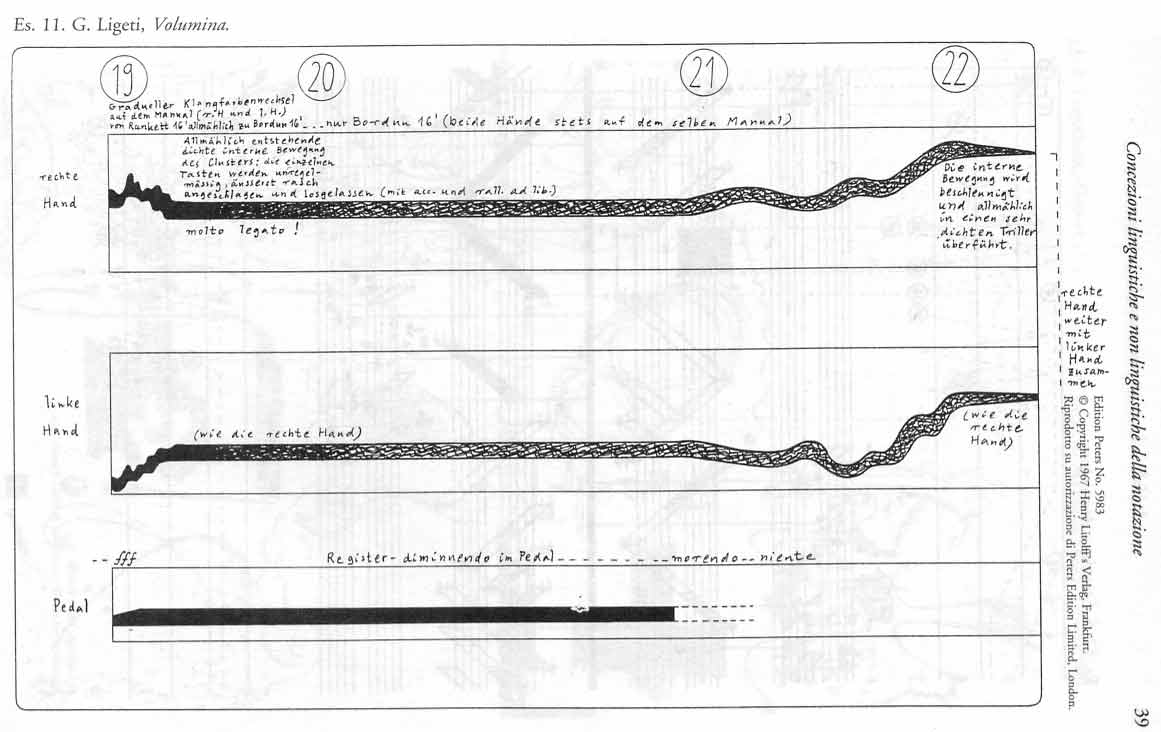


Commenti recenti