Il bello di non essere un critico musicale è quello di poter dire quello che si pensa senza sentirsi impegnati a una verità universale, senza sentirsi troppo a rischio di dire castronerie, perché comunque quello che si mette in gioco è il proprio personale sentire, le proprie impressioni da dilettante – e non la Storia della Musica. È così che due settimane fa mi sono lanciato in alcune considerazione su Miles Davis, che mi davano l’occasione per arrivare invece a un discorso sull’avanguardia e sul difendere a oltranza le posizioni artistiche – argomento rispetto al quale mi riconosco più direttamente impegnato.
Ma poi i commenti a quel post hanno riguardato nello specifico anche lo stesso Miles Davis, e mi sono ritrovato a promettere di cercare di capire (e di spiegare) perché il Miles elettrico e pop mi faccia l’effetto che mi fa – cioè mi piace moltissimo, mentre resto quasi indifferente alle sue performances più tradizionali sino al 1968. Per questo, dunque, nei giorni scorsi mi sono riascoltato un sacco di Davis, compresi brani del primo e del secondo quintetto, che hanno continuato a farmi lo stesso effetto di apprezzamento distaccato – mentre dalle prime note di Pharaoh’s Dance la mia attenzione ha avuto un balzo; e lo stesso succede con tanti dei brani dell’infinita serie di esecuzioni a Montreux (1973-91).
Di qui a capire il perché di questo balzo il passo non è stato semplice. Stavo incominciando a pensare di smontare Pharaoh’s Dance o Bitches Brew (il brano che dà il titolo all’albo), un’operazione che spesso mi è stata decisamente utile per riuscire a capire qualcosa del mio oggetto di interesse, quando nella mia testa qualcosa è scattato. Di colpo ho visto un collegamento tra il Davis della svolta e tutto un altro genere di musica: la musica indiana dei raga.
Ora, Miles Davis non usa né il sitar né altri strumenti indiani; armonie, melodie e ritmi non hanno nessuna parentela con quelli dei raga; non ho neanche idea (e non molto mi importa) se avesse avuto occasione di ascoltare Ravi Shankar, che già girava per l’Occidente a dar concerti dai tardi anni Cinquanta. Magari l’ha sentito e questo gli ha fatto scattare qualcosa; oppure non gli ha fatto scattare niente, e il suo percorso è stato un altro: non è questo che mi interessa. Mi interessa invece il fatto che i pezzi di Bitches Brew e tanti brani successivi di Davis hanno una struttura complessiva e prevedono una modalità di ascolto che è singolarmente simile a quella dei raga indiani: una modularità ossessiva-ricorsiva di fondo (spesso uniforme solo in apparenza, perché in realtà organizzata nella forma di un lento crescendo/accelerando attraverso una serie minimale di alterazioni) su cui si stagliano episodi improvvisativi che nascono l’uno dall’altro, e che sembrano a un certo punto morire nell’uniformità del fondo – salvo che il fondo in qualche modo ne ingloba gli effetti, e insensibilmente cresce. E tutto questo va ascoltato non con la razionale attenzione frontale dell’ascoltatore critico occidentale, che concepisce la musica come discorso e come sviluppo, e come tale la riconosce e segue; bensì con un atteggiamento ondeggiante tra quello frontale appena detto e una partecipazione rituale che va nella direzione del ballare, o del seguire corporalmente il ritmo, sino a una condizione di semi-trance.
È questo che mi affascina delle esecuzioni dei raga indiani: non è che la sensazione di trovarsi di fronte a uno sviluppo e a un discorso (due capisaldi della musica colta occidentale e del suo ascolto – jazz compreso) scompaia, ma il discorso è talmente fatto di ripetizioni e riprese, in cui le variazioni si inseriscono fluidamente, che finisci facilmente per perderne il filo, rimanendo appeso solo alla componente di immersione nel flusso ritmico-melodico. Eppure l’esecuzione di un raga non è fatta della semplice ripetizione ossessiva di un ritmo o di un riff, ripetizione che soddisfa solo la dimensione dell'”andare a tempo”, e a lungo andare annoia. Al contrario, l’effetto immersivo, di semi-trance avvolta dal flusso musicale, viene costruita attraverso la presenza effettiva di un discorso musicale – che però fa parte del gioco senza poter diventare dominante. E questo è sufficiente a rendere impossibile per un raga quell’ascolto strutturale che tanta musica occidentale colta invece richiederebbe. Per godere di un raga devi cercare di seguirne il discorso, ma anche rassegnarti a vivere molto di più il suo flusso di quanto non capirai davvero il suo sviluppo – così che alla fine l’ascolto finisce per essere un’esperienza attiva piuttosto che cognitiva; o meglio, finisce per essere l’esperienza dell’immergersi in un flusso di cui tu cerchi di controllare cognitivamente la forma, mentre è lui che conduce te, a dispetto di tutti i tuoi sforzi.
Bene. Senza nessuna parentela ritmica, melodica o armonica con la musica indiana, la musica di Miles Davis produce su di me lo stesso effetto: cioè quello di una musica che chiede sì di essere seguita cognitivamente come discorso e come sviluppo, ma solo per potersi immergere più intensamente e viverne attivamente il flusso, in uno stato di quasi-trance rituale, in uno stato di comunione partecipativa.
Una volta che capisco questo, posso forse anche capire che Davis non ha bisogno di Ravi Shankar né della musica indiana per arrivare a un risultato pur così simile. Gli basta risalire alla propria origine africana, e alla natura rituale-compartecipativa delle poliritmie tribali, nelle quali il discorso e lo sviluppo musicali sono comunque presenti, ma non centrali, e comunque subordinati alla convocazione degli ascoltatori a una partecipazione attraverso il ballo, o l’accompagnamento vocale e in ogni caso attraverso l’immersione – ancora una volta – in uno stato di quasi-trance, in cui persino il cercare di seguire lo sviluppo e il discorso musicale è a sua volta parte dell’immersione e della partecipazione.
Ora, se vediamo le cose in questo modo, l’operazione di Miles Davis appare di colpo come un altro capitolo della storia del free jazz, ma non quello cerebrale di Coleman (come mi suggerisce Guglielmo Nigro in uno dei commenti), quanto piuttosto quello politico-appassionato di Max Roach. E il disco che, con le mie scarse conoscenze, io ritrovo più vicino, nella storia precedente del jazz, a quello che Davis va a fare dal 1969 in poi, è la Freedom Now Suite – We Insist!, del 1960, proprio di Max Roach – specialmente (ma non solo) in quel brano, intitolato All Africa, in cui Abbey Lincoln canta sopra una base semi-immobile che finisce, dopo un po’, per essere fatta di sole percussioni poliritmiche.
Ora, saranno queste le mie personali ossessioni e il mio modo di considerare la musica (e non per questo disprezzo affatto le modalità d’ascolto più intellettuali). Ma la mia sensazione è che Miles Davis abbia finalmente trovato, e solo da quel momento in poi, la sua vera sintonia con la musica e con la sua gente – che sono principalmente gli afroamericani, certo, ma siamo anche noi, nella misura in cui siamo capaci di capire che la musica non è né un freddo discorso intellettuale né un totale abbandono corporeo al ripetersi omogeneo dei suoni e dei gesti, ma un complesso in cui ciascuna delle due dimensioni investe l’altra, e capiamo mentre sentiamo e partecipiamo. E se non capiamo proprio tutto, pazienza, perché è anche il cercare di capire (senza necessariamente riuscirci) che ci fa entrare nel gioco complesso dell’essere a tempo.





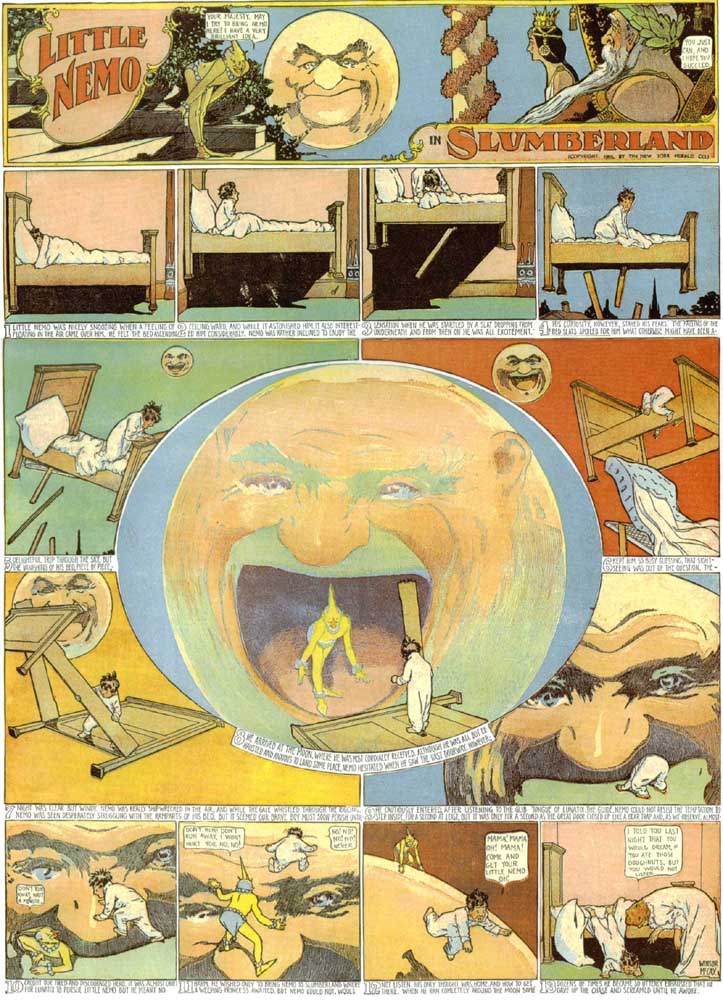






 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email






Riflessioni interessanti, e che spiegano anche il tuo interesse per Coltrane, in cui questo elemento di adorcismo e di trance è sempre stato forte (se non lo conosci, ti consiglio il bel volume di Marcello Piras “John Coltrane: un sax sulle vette e negli abissi dell’io”, Stampa Alternativa, dove parla a lungo di questi aspetti).
Però c’è anche da dire che il processo di trasformazione della forma da stampo predefinito in processo costruito “in diretta”, “passo per passo”, Miles l’aveva già intrapreso da tempo. Era perlomeno dai tempi di Kind of Blue che stava lavorando su strutture aperte, che sfuggissero alla tirannia del chorus e della struttura accordale (ad es. Flamenco Sketches, costruito su scale modali di durata ad libitum). E lo stesso faceva con il quintetto Hancock-Shorter, dove spesso gli standard tipo My Funny Valentine erano aperti e destrutturati (un bell’esempio è All of Me, con il turnround finale che può essere prolungato ciclicamente, a piacere dell’esecutore).
In realtà, devo dire che io il percorso di Miles, nonostante tutti i twists and turns, le rivoluzioni, le “svolte”, ecc., l’ho sempre visto come intimamente lineare. Ci sono poche idee su cui Miles lavora fin dall’inizio, con coerenza, attraverso tutte le sue cosiddette “fasi”: il suo suono, la capacità di rompere gli schemi, l’abilità nel servirsi dei musicisti per raggiungere i propri scopi (pensa a Birth of the Cool, dove lui fu solo il catalizzatore di una tendenza già in atto, ma nonostante ciò fu riconosciuto come il leader del progetto).
ecco si, sergio dice più o meno tutto sull’avventura musicale di davis.
è interessante la distinzione che fai tra il lavoro modale di davis e il free di coleman.
ho citato free jazz perché è un album collettivo che conosco molto bene, avendolo ascoltato parecchio.
e l’approccio che dici essere “cerebrale” di coleman, quindi, per distinzione, lontano da quello di davis… ecco, questo mi convince poco.
free jazz è costruito come un rito, secondo un tipico processo di impro collettiva, con i diversi musicisti che si alternano e “sfidano”. è cerebrale? oltre allo schema, al riferimento tematico e ritmico… il musicista è “solo” con la sua espressività e inventiva. e qui, accade di tutto. in particolare mi ha sempre colpito sentire freddy hubburd suonare in questo contesto. o scott la faro… loro che fanno impro bellissime ma che non riescono ad abbandonare i loro schemi armonici. pensano in modo armonico, quando altri (coleman, certo, cherry…) usano altri riferimenti. ecco, vedo il processo come un modo per superare il controllo cerebrale e arrivare al cuore pulsante della creatività.
anche i brani di b.b. o del davis elettrico hanno schemi precostituiti, che sono condotti dal leader attraverso cenni, suoni, fischi e altro. per non parlare del grosso lavoro di editing fatto in studio che, come ci dice la storia, non ha precedenti nel jazz. certo, il risultato è molto vicino alla descrizione che ne fai. ma non sempre il risultato all’ascolto nasce dal processo che immaginiamo.
un processo che come dice sergio, era già ampiamente collaudato con l’ultimo quintetto.
per quanto riguarda coltrane… strano pensare a come i lavori di coltrane e davis a un certo punto sembrino incontrarsi, pur essendo davis un feroce detrattore della svolta free di coltrane. senza dubbio coltrane conosceva i raga e la musica indiana. senza dubbio ha cercato un ritorno alle radici africane. credo che fosse un humus collettivo, in quegli anni e anche davis ne ha respirato le fragranze. ma la sua connessione con il grande pubblico, con le sue origini afro-americane, per come sento io il suo suono, nasce molto prima.
se non lo conosci, ti consiglio di ascoltare tutto quello che trovi di steve coleman, che riprende la strada di coltrane nei giorni nostri.
ciao
Grazie dei commenti sia a Sergio che a Guglielmo, che mi danno materia per riflettere.
Solo una nota sul perché ho definito “cerebrale” il free jazz di Ornette Coleman.Non stavo pensando dal punto di vista della produzione (per la quale vale presumibilmente il principio della ricerca di pulsante creatività) ma da quello dell’ascolto. All’ascolto, “Free Jazz” è qualcosa che assomiglia a un dipinto di Jackson Pollock, con la differenza che quello è fermo e ti lascia il tempo di percorrere i suoi percorsi anche autonomamente, mentre la musica prosegue e i percorsi andrebbero seguiti tutti insieme, come con un’improbabile fuga a otto voci, con l’aggravante che mentre le voci di una fuga sono tematicamente legate, e seguono delle regole note per le entrate, qui tutto è libero. Quindi, o non senti altro che una diffusa cacofonia, oppure fai il grande sforzo intellettuale di discriminare e coordinare le singole voci.
In questo senso la musica di Coleman è cerebrale.
Ma lo è anche in un altro senso. Chi suona è consapevole della condizione di chi ascolta, e della sua difficoltà. Se sceglie, come qui, di privilegiare la propria libertà espressiva su un qualche tipo, anche complesso, di coordinamento, sta facendo una scelta ideologica, comunicando all’ascoltatore che la propria libertà espressiva è più importante del piacere dell’ascolto, cioè è più importante di qualsiasi consonanza emotiva tra esecutore e ascoltatore. Di nuovo, come ascoltatore, o rifiuto questa pretesa e squalifico la musica di Coleman, oppure, accettandola, accetto anche una presa di posizione ideologica, che appare più forte della musica stessa.
In tutti i casi, il possibile coordinamento tra l’ascoltatore e la musica non si può basare sull’entrare nel flusso (come con Coltrane o con il secondo Davis – e anche il primo, certo), ma ha bisogna di una operazione intellettuale a monte.
Mi sembra interessante, magari, mettere a fianco “Free Jazz” con “Ascension”, che apparentemente compie la stessa operazione. Ma l’effetto non è lo stesso. La versione coltraniana del free resta stranamente calda, coinvolgente. “Ascension” non è certamente il Coltrane che preferisco – ma certamente me lo sento molto più vicino di Coleman (Ornette, ovviamente).
Comunque, Bitches Brew, al contrario di Free Jazz, è un disco costruitissimo. Però abbiamo poi, negli anni successivi, una serie di pezzi live di Davis che seguono i medesimi principi, come si può sentire nelle registrazioni di Montreux, per esempio. E comunque, anche qui, non è tanto la condizione dell’esecutore che mi interessa, quanto il modo in cui il pezzo appare all’ascoltatore. Cioè non mi interessa se l’improvvisazione sia vera, o preparata a tavolino; mentre mi interessa molto che appaia come spontanea e coinvolgente. Credo che anche i musicisti indiani, pur improvvisando, abbiano spesso una chiara consapevolezza del proprio percorso, non foss’altro perché hanno già eseguito quel raga decine di volte.
Insomma, si può essere cerebrali improvvisando integralmente, e coinvolgenti lavorando a tavolino – come pure viceversa, certo. E si può essere anche cerebrali e coinvolgenti insieme. Però Coleman su di me non ci riesce. Colpa mia, probabilmente.
Ciao
db
C’è anche da dire che quel che sentiamo di Bitches Brew NON è affatto quel che fu improvvisato in studio.
Davis e il produttore Teo Macero lasciarono scorrere i nastri e poi fecero un profondo lavoro di taglio e di rimontaggio. Per vui B. B. è in realtà una (ri)costruzione razionale, a posteriori, frutto del lucido intelletto di Miles.
[…] settimane fa, rispondendo a un commento di Guglielmo Nigro su Miles Davis, mi è capitato di avvicinare l’ascolto di […]