 Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.
Ho avuto una piccola illuminazione sulla critica (che sia poetica, letteraria, cinematografica, musicale, fumettistica…). I testi artistici, si sa, sono i testi mitici di oggi. Assolvono alla funzione di cantare (in positivo o in negativo) gli aspetti della nostra vita nel presente.
Ma se ne producono tanti! o almeno, vengono prodotti tanti testi che aspirano a essere artistici, cioè a ricoprire questo ruolo mitologizzante, che trasforma la quotidianità in leggenda, fornendo un senso alla banalità del mondo. Ne vengono prodotti tanti, ma sono pochi quelli che riescono davvero ad assolvere il proprio ruolo.
La critica non serve principalmente a fornire delle chiavi di lettura dei testi artistici, anche se qualche volta per fortuna lo fa. Il suo scopo principale, mi sembra, è sacralizzare, mitologizzare i testi (gli autori) di cui sceglie di occuparsi. Insomma, se gli artisti, quelli veri, sono i sacerdoti del mondo, poiché producono opere che danno senso al mondo, i critici sono i sacerdoti degli artisti, poiché fanno sì che un artista (un creatore di miti) possa essere riconosciuto come tale.
Così, artisti e critici sono tutti creatori di miti, pur secondo ambiti diversi e con strumenti diversi. I critici rendono mitici gli artisti che sanno rendere mitico il mondo.
E chi rende mitici i critici? Be’, di nuovo i critici stessi, citandosi e riferendosi a.
(In questo senso, in forma più debole, anche il pubblico è formato di critici, almeno nella misura in cui si scambia opinioni su quello che ha letto/visto/ascoltato)
Si può fare a meno dei critici? Evidentemente no. Se non si rendono mitici i testi, questi non possono rendere mitico il mondo. Quando i testi sono già mitici, come quelli di Omero, è proprio perché generazioni di critici (lettori compresi, evidentemente) li hanno resi tali. Senza Omero (o chi per lui) saremmo tutti più poveri; ma lo saremmo anche senza coloro che lo hanno reso un mito.
L’universo del senso è, a quanto pare, un universo di valorizzazioni intrecciate, un castello di carte in cui la parte tiene su il tutto, e il tutto tiene su la parte. Quando crolla una carta, che cosa succede?


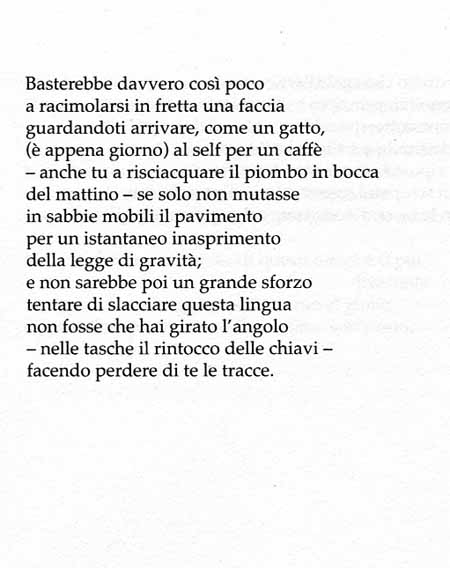
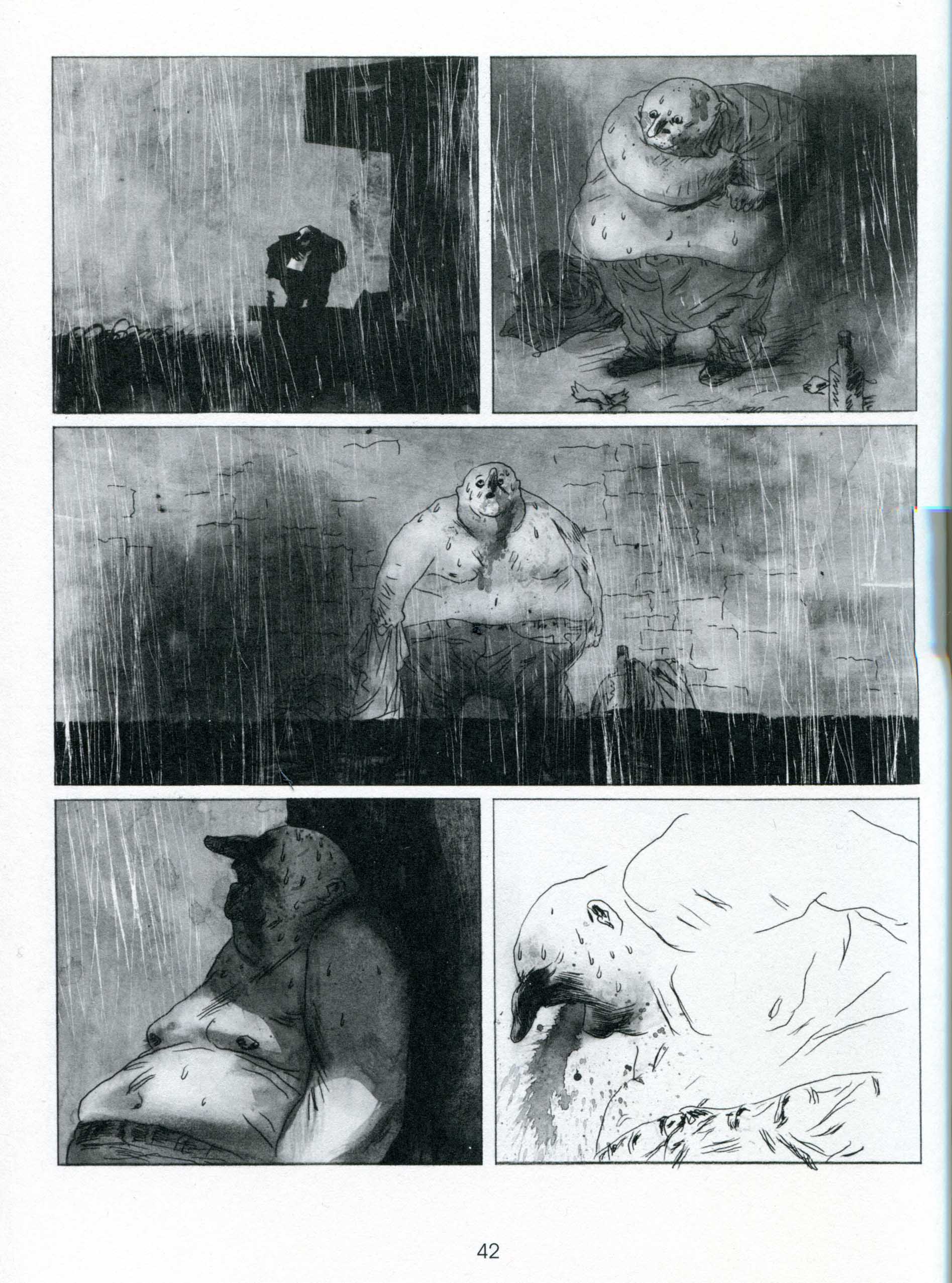
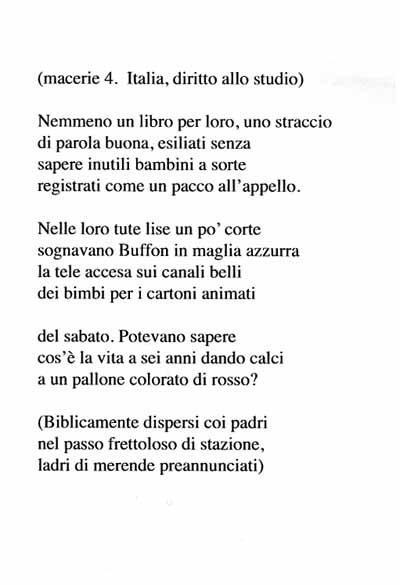




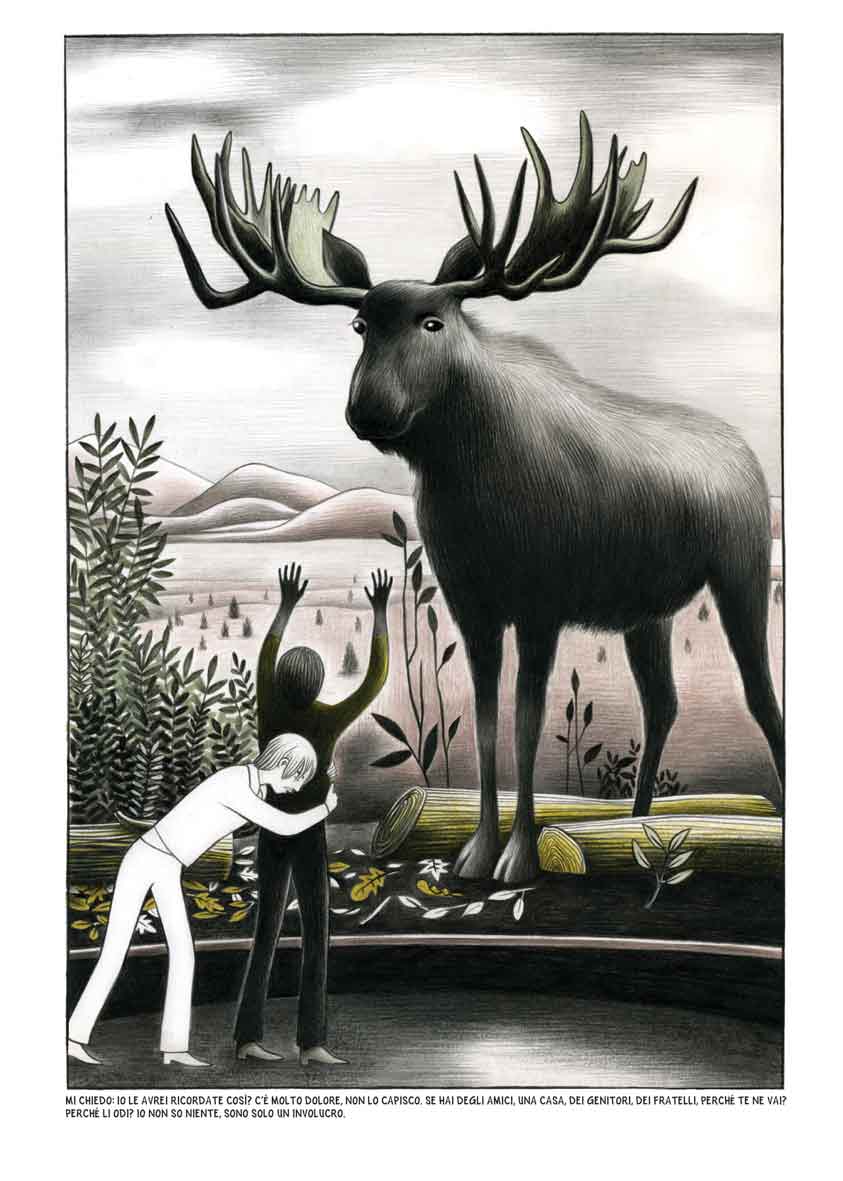

 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



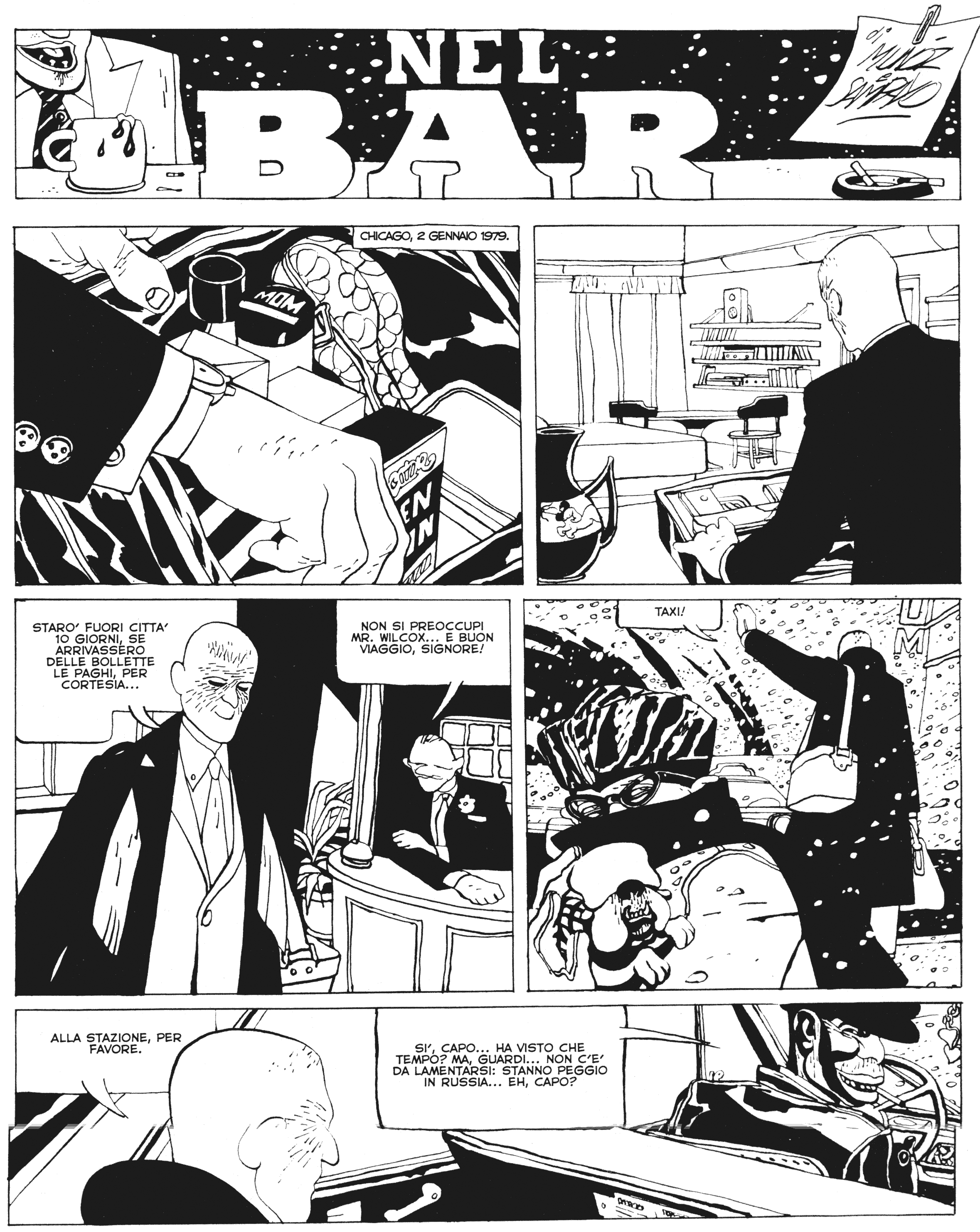
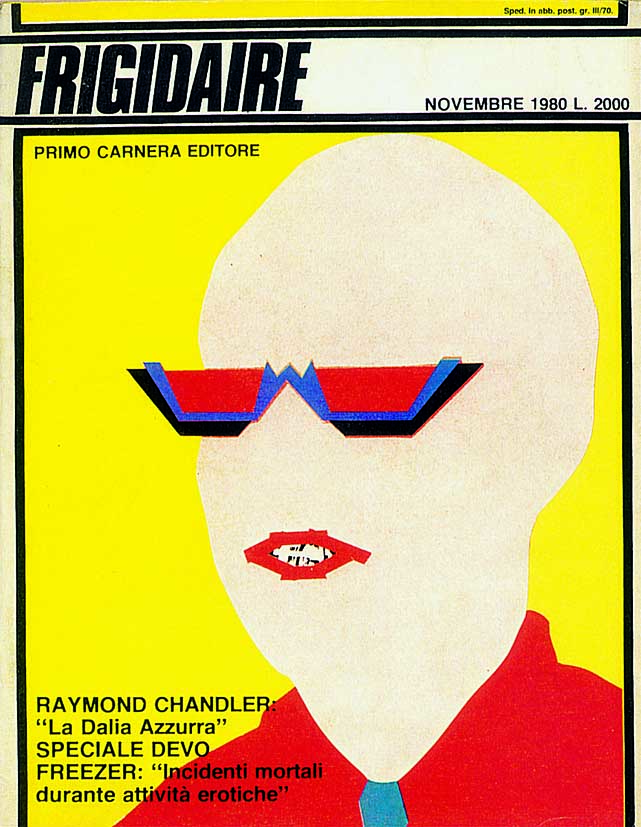
e infatti il fumetto stenta da sempre ad esistere perchè la carta non è mai stata realizzata/accettata pienamente dai suoi stessi autori/editori/lettori.
comunque sono d’accordo.
la carta era la critica..
Sì, si capiva
Quello che mi vien da chiedermi è: ma se l’universo del senso è qualcosa di percepito fin al principio come “prodotto”, è possibile davvero avere dei miti (almeno in senso totalizzante)?
Confesso di non capire questa domanda. Me la potresti riformulare?
ci provo:
attacco da questo paragrafo:
“Ma se ne producono tanti! o almeno, vengono prodotti tanti testi che aspirano a essere artistici, cioè a ricoprire questo ruolo mitologizzante, che trasforma la quotidianità in leggenda, fornendo un senso alla banalità del mondo.”
se un testo artistico viene prodotto con alle spalle l’idea (prometeica?) di fornire un senso alla banalità del mondo: non è già dal principio destinato al fallimento di diventare “mito”? (il che non vuol dire che non possa essere comunque artistico: semplicemente in una maniera tale che non comprenda al suo interno la dimensione, appunto, “mitica”)
quando è avvertibile questo stacco tra universo ed universo del senso, non è già in qualche modo morta la tensione al mito? sto ragionando a partire dall’assunto che il mito si voglia come spiegazione (estetica?) del mondo e non sua sostituzione.
forse potrei inserire un ulteriore livello nel ragionamento distinguendo tra “mito” e “forza mitologizzante” (credo d’aver letto almeno un paio di saggi che propongono una tesi simile a riguardo dell’arte di origine surrealista – purtroppo ne ho rimosso gli autori…): nel senso che probabilmente il “mito” come immagine dotata\produttrice di senso può nascere davvero dal lavoro della critica e restare quindi una questione di ricezione; la “forza mitologizzante” invece no: in quanto appunto legata a un’interrogazione del mondo (e della sua banalità?) piuttosto che a una sua ricreazione (anche se ammetto possa essere ugualmente difficile distinguere i due livelli, ma questo è il problema un po’ costante quando si arriva a porsi domande sulla mimesi, il suo tante volte cantato superamento, ecc. )
ho messo ancora più carne al fuoco, non credo d’essermi spiegato; grazie comunque dell’attenzione!
@ Anonimo
Giusto un paio di precisazioni.
“Fornire un senso” non vuol dire spiegare. Può essere sufficiente collegare ciò che non ha ancora un senso con qualcosa che già ce l’abbia. Raccontare è un modo (non unico ma importante) per farlo.
Quando parlo di “mondo”, non voglio dire che ogni testo che voglia essere artistico si sforza di dare un senso al mondo nella sua interezza (il che sarebbe davvero prometeico). Il senso può riguardare anche solo un dettaglio di mondo, magari importante pur se minimo, collegandolo a qualcosa a cui non si era mai pensato di collegarlo – e in questo modo dandogli (nuovo) senso, e quindi valore.
Non vedo il mito come spiegazione del mondo (né estetica né altro – anche se qualche volta lo è); perché la parola “spiegazione” sembra presupporre una consapevolezza razionale che il mito non possiede. Spiegare è uno dei modi (quello della razionalità scientifica) per dare senso alle cose; ma non l’unico.
In questo senso certamente non solo l’arte crea miti. Ma, quando è davvero tale, l’arte sembra metterci in qualche modo di fronte al processo mitopoietico, e con particolare efficacia. Mi sembra che sia anche quello che fa la critica, per quanto in modo diverso e limitatamente al campo dei testi artistici e dei loro autori. Forse la tua distinzione tra “mito” e “forza mitologizzante” può essere ricondotta a questa differenza – anche se non l’ho capita bene sino in fondo.
Il discorso è comunque più complicato, e molto, del modo in cui l’ho ridotto io qui – dove mi interessava soltanto mettere in luce questo (pur parziale) parallelismo tra arte e critica.
Grazie per la spiegazione terminologica, che almeno un po’ di cose me le chiarisce;
sullo “spiegare” è stata pura incomprensione in quanto non intendevo una direzione puramente razionale (inoltre legata a una razionalità scientifica) quanto contenente una parte di razionalità – che facesse insomma già parte di una dimensione sistemica e non fosse la relazione diretta del canto o del grido
comunque le spiegazioni che cercavo le ho avute; non sono solo sicurissimo su un punto – che riguarda il mio uso di quel “prometeico” – ma non tanto centrale; provo lo stesso a scriverne su per il gusto di insistere\sviscerare un po’ la cosa (la mia stessa idea):
dici:
“Quando parlo di “mondo”, non voglio dire che ogni testo che voglia essere artistico si sforza di dare un senso al mondo nella sua interezza (il che sarebbe davvero prometeico). Il senso può riguardare anche solo un dettaglio di mondo, magari importante pur se minimo, collegandolo a qualcosa a cui non si era mai pensato di collegarlo – e in questo modo dandogli (nuovo) senso, e quindi valore.”
il primo periodo niente da dire; la confusione l’ho sul secondo, dove però potrebbe essere di nuovo semplicemente legata a una mia errata interpretazione: e cioè che anche quel minimo dettaglio di mondo d cui fai esempio mi sembra non sia tanto considerato non sensato, quanto semplicemente dotato di un senso ancora non venuto alla luce, ma che può rivelarsi in un nuovo legame… cioè mi sembra ci sia comunque già di partenza un’aspettativa di senso; il problema mio invece riguardava oggetti di cui si sia già deciso (in qualsiasi modo) che rispondano negativamente alla possibilità di avere un proprio senso: quindi non l’inesperito, l’incompreso, ma al contrario fenomeni di “superficie”, l’errore più che il lapsus; ma molto probabilmente sto solo immaginandomi un oggetto logicamente impossibile.