3 Maggio 2010 | Tags: avanguardie, comunismo, Darmstadt, filosofia, György Lukács, ideologia, mito, politica, ragione, razionalismo, razionalismo selvaggio | Category: filosofia | Non ho mai riletto La distruzione della ragione di György Lukács. Mi toccò studiarlo per un esame universitario molti anni fa, e mi sembrò un libro vergognoso. Poiché non l’ho riletto, non voglio parlare di Lukács ma solo dell’impressione che ne trassi allora e del perché questo fatto mi colpisca ancora oggi, a distanza di tanto tempo. Quanto a Lukács, mi auguro davvero di essermi a suo tempo sbagliato, e che, a una rilettura più attenta della mia di allora, vi si possano trovare anche quei pregi che io allora non vi ho trovato.
Scritto dall’Ungheria socialista dei primi anni Cinquanta, il libro di Lukács descrive il modo in cui i filosofi occidentali hanno variamente messo in crisi (e poi distrutto, in una deriva verso il fascismo) l’idea di ragione. Quello che mi turbava nel leggerlo era che Lukács non mostrava mai (almeno ai miei occhi) il minimo dubbio sulla validità della propria concezione di ragione, che era poi quella hegeliano-marxista-leniniana di una dialettica storica inevitabilmente progressiva, destinata a culminare nella realizzazione del Comunismo.
Anch’io, all’epoca, mi reputavo comunista, ma ero orgoglioso dei miei dubbi sulla razionalità del processo storico, e delle mie incertezze su quale potesse essere il modo migliore e più razionale di costruire il Socialismo. Tanto più che Lukács sparava ad alzo zero non solo contro filosofi dichiaratamente e pacificamente irrazionalisti, ma anche contro Wittgenstein e chi ne derivava, contro la fenomenologia e gli esistenzialismi, e in generale contro posizioni che io ero abituato a considerare decisamente più razionali della sua.
Oggi credo di sapere perché le parole di Lukács mi dessero tanto fastidio. È che trovavo che quella fosse l’espressione più spavalda e prepotente di un atteggiamento fondazionalista che nella filosofia ha sempre avuto una certa diffusione, e che pretende di poter giustificare razionalmente il mondo, ovvero di poter trovare e descrivere una ragione filosofica fondamentale per cui le cose sono così e così, e non in un altro modo. (Si può immaginare quanto felice io sia stato, qualche anno dopo, il mio incontro con la filosofia di Richard Rorty, che è l’antitesi di tutto questo)
Il punto è che i razionalismi di questo tipo non si rendono conto che la ragione è semplicemente la regola di un pensiero funzionale, mentre non ha veramente un ruolo nelle questioni sostanziali. In altre parole, nella misura in cui ci proponiamo uno scopo, il pensiero razionale è lo strumento più potente che abbiamo per procedere verso la sua realizzazione; e nella misura in cui uno scopo dipende da un altro, è certamente il pensiero razionale quello che ci mette in grado di distinguere e organizzare. Ma gli scopi primari della nostra esistenza non sono razionali, e pertengono piuttosto alla regione del mito. La ragione potrà aiutarmi a trasformare il mito in mitologia, cioè esplicitazione del mito, parola del mito; ma io devo essere consapevole che anche dietro a questa trasformazione sta agendo certamente un altro mito, e che gli effetti delle mie comprensioni razionali modificano il mito sottostante sempre in maniera più rapida e incisiva di quanto possa mai recuperare quella medesima comprensione.
L’ideologia che stava alle spalle di Lukács, cioè il comunismo, ha fallito proprio perché non si è resa conto di questo, pensando di potere gestire razionalmente la società, mentre il suo agire razionale non faceva che enfatizzare il sottofondo incontrollato – e il dominio, una volta abolita la sua componente economica, veniva perpetuato in altre forme, politiche e ideologiche. L’ipertrofia della ragione le ha reso impossibile vedere i propri stessi limiti, e la dialettica hegeliana è diventata nella realtà una dialettica di forze oscure e incontrollate, rese nel loro operare potenti proprio da quello strumento, la razionalità, che le avrebbe dovute eliminare!
L’ipertrofia della ragione non ha caratterizzato soltanto le ideologie comuniste. In fondo Marx non ha fatto che sviluppare gli stessi presupposti razionalisti che stanno alla base dell’Illuminismo e dello sviluppo del capitalismo. L’economia capitalista è a sua volta fondata sul principio (capillarmente applicato dai suoi operatori) di un progetto razionale di sviluppo attraverso il controllo, cosa che presuppone, tendenzialmente, la prospettiva di un controllo totale della natura.
Naturalmente, senza un progetto razionale non c’è modo di costruire una società complessa, ma il razionalismo ipertrofico che non si accorge dei propri limiti tende a sopravvalutare il progetto rispetto alla sua verifica sul campo. In questo le società capitalistiche non sono meno ideologiche di quanto fossero a loro tempo quelle comuniste, ma il razionalismo vi si trova parcellizzato nell’azione di una miriade di soggetti, mossi dal mito soggiacente e resi potenti dallo strumento razionale.
Potremmo chiamare razionalismo selvaggio questa fiducia cieca e irrazionale nel potere totale della ragione, e in particolare della ragione scientifica – che costituisce la nuova forma di oggettivismo di cui i razionalismi economici si rivestono. E questo non perché la scienza abbia in sé qualcosa di sbagliato: anzi, nella misura in cui è applicato, il metodo sperimentale non permette che un’ipotesi possa fondare una teoria almeno finché non riceve sufficiente conferma dai fatti. È che la ragione è oggi soprattutto il mito di se stessa, un argomento sbandierabile da qualsiasi parte politica come emblema di ciò che ci salverà – e quindi incontrovertibile, incontestabile, miticamente vera.
Il razionalismo selvaggio è la maschera dei giochi del potere, dei giochi dell’inconscio. Ha dilagato anche nell’arte del Novecento, sotto forma di avanguardie, ovvero gruppi di artisti che pretendevano di sapere come dovesse essere l’arte, e che a volte utilizzavano la propria riconosciuta abilità artistica personale come prova del fatto che essi, proprio come Lukács, sapevano quale fosse la direzione indicata dalla storia. L’assurda vicenda della musica colta contemporanea è un evidente esempio di quanto il razionalismo selvaggio non sia stato che il supporto di una fazione musicale, quella di Darmstadt: tanto rivoluzionaria prima di prendere il potere quanto conservatrice e repressiva una volta che ha avuto il suo Palazzo d’Inverno.
Se la ragione usata entro i limiti della ragione ci può forse salvare, il razionalismo selvaggio, non riconoscendo i propri limiti e il proprio affondare i piedi nel mito e nell’irrazionale, ci consegna inesorabilmente ai demagoghi che hanno individuato benissimo i propri personalissimi scopi, e sfruttano molto razionalmente la potenza mitica delle televisioni per ottenere e conservare il potere. Come ci insegnò straordinariamente bene il nazismo, la ragione serve anche a pianificare la distruzione, o il dominio di qualcuno su qualcun altro. Basta che gli scopi siano sufficientemente precisi da non avere conflitti tra loro. Gli scopi di Berlusconi sono purtroppo precisissimi. Quelli degli esseri umani in generale lo sono molto meno. È per questo che lui, proprio come Lukács, sa qual è la verità.
30 Marzo 2010 | Tags: Andrea Pazienza, fumetto, politica | Category: fumetto | Andrea Pazienza è nell’aria (grazie all’infelice riedizione del suo Astarte) ed è nell’aria anche la politica (grazie all’infelice esito delle elezioni, e a tutto quello che ci sta attorno). Per questo, mi salta sotto gli occhi questo articoletto che ho scritto nel 2005 non ricordo più per chi, e la coincidenza è troppo bella per non approfittarne. Quando leggo di quella politica, buona o cattiva che fosse, mi domando davvero come abbiamo fatto ad arrivare a questa, che buona certamente non è.
Una sera di aprile
Una sera di aprile del 1977 mi trovavo in un locale alternativo di Bologna, che aveva nome La talpa, per quella che veniva chiamata allora una riunione politica. Si trattava indubbiamente di una riunione, perché il luogo riuniva numerose persone, ed era sicuramente politica perché la politica era ciò che in quei giorni ci teneva assieme. Ma quando si pensa a una riunione politica oggi si pensa a un gruppo di persone dotato di una qualche omogeneità e di un qualche fine comune che discutono una strategia di azione. Quella sera, più che altro, l’omogeneità e i fini comuni erano una meta, anziché dei presupposti, e una meta nemmeno troppo ambita.
Più che altro, potrei dire oggi, quello che ci teneva insieme, nonostante divergenze ideologiche profondissime dividessero i presenti, era la consapevolezza di far parte di un medesimo ambiente, di un medesimo ambito culturale, di essere comunque un “noi” molto forte e compatto. Allora credevamo che il nocciolo di questo “noi” stesse nella politica, ma quello che si intendeva allora per politica aveva davvero poco a che fare con quello che si intende oggi. Basti pensare allo slogan in cui ci si riconosceva, che recitava “il personale è politico”, ma che si sarebbe potuto anche declinare all’inverso: “il politico è personale”.
La serata tardava a prendere il volo. Si chiacchierava e non c’erano interventi che monopolizzassero l’attenzione. L’interesse comune si coagulò a un certo punto attorno a un mazzo di foglietti che passavano di mano in mano, suscitando grasse risate. C’erano delle vignette umoristiche, disegnate a pennarello su quei foglietti, in cui riconoscevamo facilmente la situazione bolognese di quei giorni. Erano gli originali, non delle riproduzioni, e l’autore era lì tra noi, che si godeva i commenti divertiti e i complimenti del pubblico. Io, però, non riuscii a identificarlo, e nemmeno mi rimase memoria del suo nome.
Fu solo numerosi anni dopo, sfogliando una qualche pubblicazione di quel periodo, che riconobbi chiaramente le vignette che avevo visto quella sera, e capii che, di Andrea Pazienza, avevo assistito, inconsapevole, a uno dei primi successi pubblici bolognesi. In realtà un suo successo assai maggiore stava iniziando a esplodere sulla rivista Alter Alter proprio in quei medesimi giorni di aprile, che vedevano pubblicato il primo episodio de Le straordinarie avventure di Pentothal.
Io scoprii Pentothal ben un anno dopo, mentre scontavo in ospedale i postumi di un viaggio nel deserto. Sarà forse solo cronaca il far sapere che il mio desiderio di occuparmi di fumetti in maniera più approfondita è dovuto in buona parte a quella scoperta. Ma non è solo un fatto di cronaca la ragione di questo mio innamoramento. Il fatto è che Pazienza esprimeva davvero con Pentothal l’anima creativa e contraddittoria di quello che stavamo tutti vivendo; e la esprimeva con una ricchezza, una fantasia e una precisione emotiva che erano davvero impressionanti.
Io credo che la fortuna del fumetto italiano di quegli anni, tra la fine dei Settanta e l’inizio degli Ottanta, sia stata dovuta alla presenza di un ambiente culturale giovanile diffuso e molto ben definito, di cui il movimento bolognese rappresentava probabilmente una delle realtà più significative, ma che trovava riconoscimento ovunque. Per molti giovani autori, così come per tutti i nuovi lettori di quegli anni, il fumetto rappresentava una forma espressiva ideale, perché era potente, versatile, economica, e soprattutto perché non aveva alle spalle una storia di connivenza con l’industria culturale, con il potere economico costituito: era, insomma, ai nostri occhi, un medium sufficientemente vergine, almeno in Italia, da poter essere colonizzato, e dichiarato nostro.
Questa rinascita del fumetto non era dunque dovuta né a una proposta rischiosa di autori innovativi, né alla risposta di editori astuti alle richieste del pubblico. Ovviamente, entrambe queste componenti erano davvero presenti, ma quello che esisteva prima di tutto era un ambiente culturale, di cui autori e lettori si riconoscevano come parte, un discorso, una conversazione diffusa su temi che sentivamo pregnanti – e il fumetto ne era il mezzo di espressione privilegiato.
Credo che il primo ad accorgersi di quello che stava succedendo e a fare del proprio fumetto la voce fantasmagorica di quella conversazione sia stato Filippo Scozzari. Ma poi Pazienza ha rappresentato quella voce più e meglio di chiunque altro, facendo storia e leggenda della vita di quegli anni.
Rileggendo Giorno. Un concentrato di angosce metropolitane, chi ha vissuto quegli anni non apprezza solo l’esame di storia del cinema su Apocalypse Now. Perché Pazienza non era solo un grande umorista e un disegnatore strabiliante; era anche un prodigioso narratore, capace di individuare l’anima profonda delle relazioni personali e degli eventi, e di costruire racconti apparentemente senza né capo né coda, ma in realtà così ricchi e trascinanti da lasciare attoniti.
A chi lo ricorda soprattutto come umorista regalerei Gli ultimi giorni di Pompeo, la testimonianza più drammatica di quello che succede una volta che i miti si infrangono, e il personale e il politico si separano drasticamente, e per sempre. Proprio come Pompeo, Andrea si è buttato via, un po’ per indolenza, un po’ per sbaglio, un po’ perché le epoche storiche in cui invece di sentirsi soli ci si sente in tanti finiscono, e per troppo tempo non ritornano più.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|








 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco
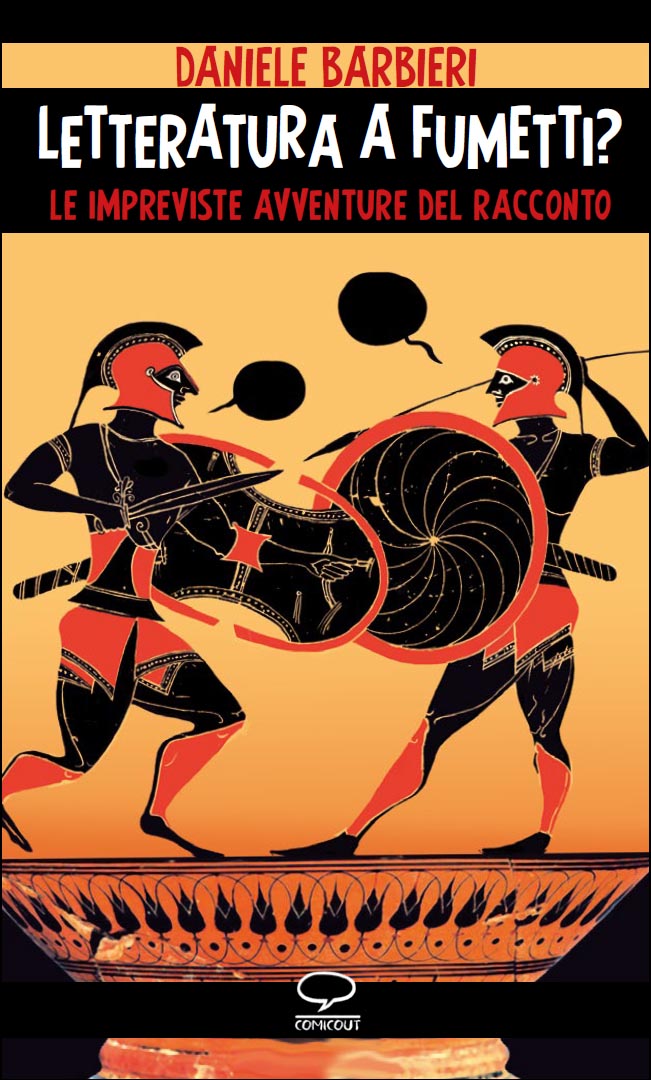




Commenti recenti