Sedere a una tavola ignota.
Dormire in un letto non mio.
Sentire la piazza già vuota
gonfiarsi in un tenero addio.
 Non so. La questione della semplicità in poesia mette a me, e non solo a me, dei problemi. Questi quattro versi di Sandro Penna, scritti in qualche momento tra il 1938 e il ’55, quando in Italia imperava la complessità semantica neodannunziana degli ermetici e già si preparava l’ipercomplessità antidannunziana della neoavanguardia, mi imbarazzano davvero. Voglio dire: perché questa quartina di banali novenari, fatti di parole del tutto normali, con rime del tutto scontate, alla fin fine mi sommuove e magari mi turba, mentre gli alti lai di una recente giovane poetessa che canta il proprio (legittimamente doloroso) cambio di sesso continuano ad apparirmi banali e noiosi?
Non so. La questione della semplicità in poesia mette a me, e non solo a me, dei problemi. Questi quattro versi di Sandro Penna, scritti in qualche momento tra il 1938 e il ’55, quando in Italia imperava la complessità semantica neodannunziana degli ermetici e già si preparava l’ipercomplessità antidannunziana della neoavanguardia, mi imbarazzano davvero. Voglio dire: perché questa quartina di banali novenari, fatti di parole del tutto normali, con rime del tutto scontate, alla fin fine mi sommuove e magari mi turba, mentre gli alti lai di una recente giovane poetessa che canta il proprio (legittimamente doloroso) cambio di sesso continuano ad apparirmi banali e noiosi?
Poesia semplice contro poesia semplice, per riprendere i termini di un tutt’altro che banale intervento di Mario De Santis uscito in questi giorni e più volte ripreso nel dibattito in rete. Dovrei dire, per semplificare, che quella di Penna mi appare poesia semplice, mentre quella della Vivinetto poesia banale, dove la differenza sta nel fatto che di semplice in Penna c’è solo – per così dire – il livello di base, e quindi si tratta, in verità, di una pura apparenza di semplicità; mentre nella Vivinetto si resta tutti lì, e dalla semplicità non si esce: c’è solo quello, nient’altro. Dirlo è facile, ma spiegare perché lo è forse un po’ meno.
Diciamo che troppo spesso, leggendo la poesia banale, succede esattamente quello che ti aspetti che succeda: escono le parole che è normale che escano, insomma. La poesia banale parla con parole non sue: sono le parole della chiacchiera, direbbe Heidegger, quelle depositate nei discorsi che si fanno continuamente. Ma non solo parole: nella poesia banale escono anche i concetti che ti aspetti che escano. Il discorso è quello preconfezionato del parlare quotidiano, del pour parler, tanto per usare un’altra espressione cara agli esistenzialisti. Nella poesia banale il discorso è preconfezionato due volte (e in verità molte di più). Non c’è mai una sorpresa: il dolore è come deve essere, il sollievo pure; l’amore, la morte, il piacere, il sesso, l’avventura… tutti sono come devono essere, come ci aspettiamo che siano.
La spocchia di un poeta complicato come Edoardo Sanguineti non gli ha impedito di definire efficacemente poetese la lingua della poesia banale. In verità, il poetese non parla, non dice. Si limita a confermare quello che ci aspettiamo. Si limita a rinchiudere un dolore (se è di un dolore che si parla) nella cornice scontata del dolore, quella che tutti con facilità riconosciamo come tale. In altre parole, si limita a nominarlo: insomma, il poeta dice “dolore”, e tutti i lettori rispondono “ah”!
Molto più difficile è spiegare perché i versi di Sandro Penna, nonostante la loro semplicità di superficie, non ricadano sotto la specie della banalità e del poetese. Meglio: non ricadevano quando sono stati scritti e continuano a non ricadervi oggi, tanti anni dopo. Potremmo dire, quanto a quando sono stati scritti, che la loro semplicità discorsiva si contrappone agli Avorio luziani che costituivano il modello di quegli anni. Ma sarebbe facile allora ribattere che la semplicità delle parole della Vivinetto si contrappone alla complessità della cosiddetta poesia di ricerca (modello, anche se molto meno, di questi anni). Evidentemente non si tratta di una ragione sufficiente.
La mia impressione è che, nella loro semplicità, le parole di Penna non siano affatto scontate. Per esempio, queste frasi così brevi si interrompono prima di poter diventare banali. Gettano l’amo della banalità, ma poi non abboccano. Ci fanno credere per un attimo alla scontatezza, ma poi non ci cadono.
A ben guardare, poi, questa colloquialità normalità innocenza quasi improvvisazione sono davvero soltanto apparenti. Guardiamo da vicino questi quattro regolari novenari, che giocano astutamente il loro appartenere metrico a uno schema popolare frustissimo, ma già ambiguamente nobilitato da Giovanni Pascoli qualche decennio prima. Si tratta di quattro versi con il medesimo andamento ritmico e la medesima struttura proposizionale, fatta di un verbo all’infinito, un complemento e un suo attributo. I versi sono a rima alternata, ma le rime alternate non si limitano al finale del verso: anche sedere si riallaccia foneticamente a sentire, e tavola a piazza, a livello di assonanze e consonanze, specie se contrapposte, negli altri due versi, a dormire con gonfiarsi (prima vocale o, e poi la r e la i) e letto con tenero (insistenza sulle e, t e o).
Eppure, questa struttura, resa ancora più regolare e quadrata attraverso queste insistenze, mostra a un certo punto un’asimmetria del tutto imprevista. Tra il primo e il secondo verso c’è un punto (come tra il secondo e il terzo), mentre tra il terzo e il quarto verso si va di seguito. Questa sorpresa (non proprio un enjambement, ma quasi) mette in movimento tutto, quasi rovinando il sistema delle simmetrie. Non è solo questione di parole e di sintassi: sedere e dormire sono due verbi che esprimono delle azioni indipendenti, ma sentire non lo è, e serve sostanzialmente a introdurre un gonfiarsi che, pur esprimendo di nuovo un’azione indipendente, è riflessivo, e quindi di colpo diverso dagli altri.
Tutto questo non è banale esibizione di controllo verbale. Esibire un controllo verbale di questo livello vuol dire far capire bene che il controllo è stato ugualmente esercitato anche sulle parole all’apparenza banali. Dimostrandosi così perfettamente consapevole di quello che sta facendo, Penna, insomma, si può davvero permettere, a questo punto, di usare le parole più banali e trite di questo mondo, senza che esse appaiano per nulla banali e trite. La sua operazione finisce per essere simile a quella (molto posteriore) della musica minimalista: nella ripetizione ossessiva ogni diversità, ogni minima discrepanza emerge enfatizzata: è proprio perché il lessico e la sintassi di Penna sono così banali, in un contesto così evidentemente controllato, che le non banalità saltano all’occhio, ci colpiscono e intrigano. Quella vaga, smagata ironia che sempre traspare attraverso le parole di Penna finisce per essere indizio di questo attentissimo controllo e del gioco consapevole sul banale; ed è attraverso di lei che le parole più usurate, proprio quelle consunte della quotidianità, possono riacquistare il peso semantico che avrebbero se non fossero consumate dalla chiacchiera, dalla banalità dei mille discorsi in cui sempre appaiono.
Non si tratta di una strategia facile. Più spesso i poeti preferiscono sancire il gap col banale rendendo più complicata la superficie del componimento. Quando leggete Montale non ricavate mai l’impressione di una poesia facile. Ma certamente la banalità si può nascondere, in altro modo, che non ci riguarda qui, anche nella poesia complicata.
I mille imitatori della semplicità di Sandro Penna vedono insomma le sue parole semplici e la sua semplice sintassi, ma non colgono il suo controllo né la sua vaghissima ironia. Per questo finiscono per risultare alla lettura semplicemente banali. Ha ragione De Santis a riconoscere alle traduzioni una certa responsabilità in questa caduta: non è davvero facile riportare in un’altra lingua la sottilissima deformità che rende affascinante il discorso di Penna! E così sarà per i tanti grandi poeti di altre lingue, ridotti in italiano alla lettera di quello che dicono. Riducete Penna alla lettera di quello che dice e avrete qualcosa di simile ai versi della Vivinetto: un ininteressante resoconto di privati turbamenti, buono giusto per spiare dal buco della serratura l’intimità di qualcun altro, che magari gode pure della propria esibizione. Certo, in tutto questo niente di male, eticamente: sono fatti di chi guarda e di chi si fa guardare. Ma che non mi si parli di poesia, please.
__________________________________
Sul tema della semplicità e complessità in poesia ho scritto anche altri post in questo blog: Del diritto della poesia a essere incomprensibile, Del cambio di paradigma, dei primi anni Sessanta, e della questione dell’io (una polemica con Marco Giovenale in due puntate, che prosegue qui: Del cambio di paradigma, della questione dell’io, dell’oscurità in poesia, dove va letta anche la fondamentale discussione in fondo), La letteralità impossibile. Risposta ad Andrea Inglese.
Sul libro della Vivinetto, vedi anche la recensione di Simone Burratti, su La Balena Bianca.








 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco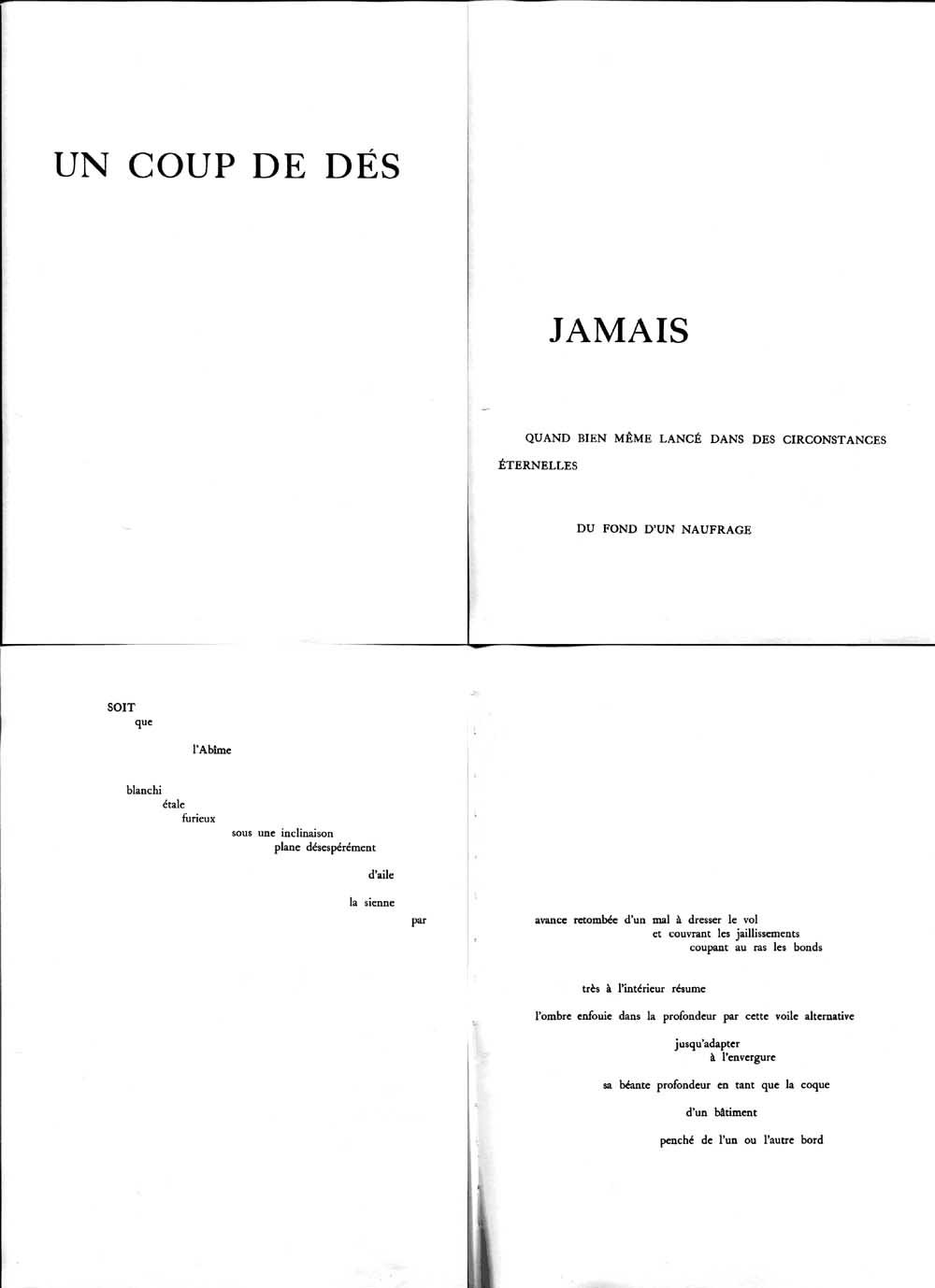






Commenti recenti