 Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte. Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte.
La prima volta riprendevo uno spunto di Paolo Giovannetti che esprimeva (tra altre interessanti considerazioni) una qualche stanchezza per una poesia che abbia sempre bisogno del supporto della critica (che interpreti e spieghi) per arrivare al suo pubblico. Mi è venuto da dire che non è così dappertutto. Non, per esempio, nel mondo di lingua spagnola, specie in America Latina, dove ci sono addirittura paesi, come il Nicaragua, in cui la poesia ha più lettori del romanzo. Mi verrebbe semmai da dire che l’Italia, con altri paesi europei, rimane vittima dell’osservazione di Adorno, per cui non potrebbe più esistere un’arte innocente, e non tanto perché c’è stata Auschwitz (come in una sua prima affermazione) quanto perché è la stessa struttura della produzione estetica di massa a renderla impossibile. Proprio per questo l’arte (tra cui evidentemente la poesia) sarebbe condannata a riflettere su di sé (una volta persa l’innocenza) per non diventare inautentica, falsa coscienza, credendo vanamente di poter recuperare un’irrecuperabile innocenza.
Riprendendo poi Paolo Zublena, che aveva contrapposto soggetto e soggettività, dicevo che l’opposizione andrebbe secondo me formulata piuttosto nei termini lacaniani, secondo cui intanto il soggetto è semplicemente il soggetto dell’inconscio, e quindi qualcosa che vive già in una dimensione pubblica, sociale (trovando la sua differenza specifica non in una identità autocosciente, ma semplicemente nel diverso modo in cui in ciascuno si organizzano specificamente delle istanze collettive). In secondo luogo, sempre per Lacan, l’io (il moi) è invece una sovrastruttura alienata, della quale, comunque, non si può fare a meno – e al massimo si può riconoscere la sua natura alienata.
Ma se l’io, pur alienato e sovrastrutturale, c’è, perché inibire alla poesia la facoltà di esprimerlo (fatto salvo che esprime sempre e comunque il soggetto – ma questo in sé non produce lirica)?
D’altra parte io stesso non ne posso più di una poesia che necessiti della critica per essere compresa, e mi piacerebbe tanto poter essere innocentemente lirici. Ma poi, quando guardo i prodotti che cercano di essere davvero tali, in verità mi sento raggelare, tanta è la falsa coscienza (di solito involontaria) che si aggira in loro. Da questa ambivalenza, come si esce? Oppure, da questa ambivalenza è possibile uscire?
Nel secondo intervento citavo inizialmente Alfredo Giuliani (lo cito un po’ troppo spesso, anche in queste pagine) che, nell’Introduzione alla edizione 1965 de I Novissimi, definiva la riduzione dell’io come “l’ultima occasione storica di esprimermi soggettivamente” – un’espressioni in cui vanno notati sia l’io che il soggettivamente, i quali fanno evidentemente riferimento a due entità differenti.
A questo punto, visto che qualcuno aveva parlato di musica, mi è venuta alla mente l’estetica di Eduard Hanslick, ovvero quell’estetica musicale sviluppata a fine Ottocento che ha fatto piazza pulita dell’idea romantica della musica come espressione delle emozioni e dei sentimenti dell’io, sostenendo non tanto che la musica non possa esprimere emozioni e sentimenti, quanto che non ha nessuna necessità di farlo, e può essere interessante anche senza esprimere alcunché. Non è un formalismo, come pure molti l’hanno interpretato, perché, anche se l’espressione non è più il cuore del problema, alla musica viene riconosciuta la possibilità di provocare in chi l’ascolta emozioni e sentimenti (indipendentemente dal fatto che sia o meno espressione delle emozioni del suo autore). L’accento, insomma, si sposta sulla ricezione e sugli effetti di senso prodotti dal testo musicale.
L’estetica di Hanslick è stata importante al punto da generare la pittura astratta, poiché Wassily Kandinsky ne era un appassionato lettore, ed è dall’idea di un’arte non figurativa (come la musica) in grado di produrre reazioni estetiche nel suo fruitore che può nascere quella di una pittura non figurativa che funzioni al medesimo modo. Nel mondo della poesia italiana sembra che, almeno sino agli anni Sessanta, non venga in mente a nessuno che la poesia potrebbe non essere letta come espressione del proprio autore; e anche dopo quella data le contrapposizioni sono ambigue. Per esempio la stessa espressione di Giuliani riportata qualche riga sopra sembra tradire una necessità di – comunque – esprimersi soggettivamente, per quanto con forme nuove e meno fruste.
Con un bel cambio di prospettiva, potremmo assumere oggi radicalmente la posizione di Hanslick e sostenere che la relazione tra testo poetico e soggettività (che in gioco sia il soggetto – quasi collettivo – dell’inconscio, oppure l’io alienato) è del tutto irrilevante, perché l’io è in poesia comunque un effetto testuale, la cui presenza è giustificata o meno dalla coerenza con il resto del discorso. In altre parole, l’io potrà essere assente o viceversa dominante, purché questo sia coerente con il resto della costruzione, e il testo produca su di me lettore qualche effetto emotivo interessante (dove emotivo va inteso nel senso più ampio possibile, che non esclude affatto l’emotività di natura intellettuale; e però nemmeno, d’altra parte, quella più istintiva e animale).
Se assumiamo questa posizione che privilegia l’effetto sul lettore, tutta la problematica della riduzione dell’io, o dell’espressione della soggettività appare ridursi sin quasi a scomparire, e con essa scompare anche il dilemma (l’ambivalenza) di cui parlavo alla fine del mio primo intervento. Questo ad Albinea non sono arrivato a dirlo, come non sono arrivato a dire le conclusioni a cui giungerò di qui in poi. Insomma, in questa prospettiva, soggettività o oggettività, espansione lirica o riduzione dell’io appaiono semplicemente come strumenti retorici per produrre effetti di senso (o effetti emotivi, il che non è molto diverso), strumenti a disposizione del poeta per la propria operazione di costruzione.
Attenzione! Questo non comporta che il testo poetico non possa più essere un testo spontaneo, dovendo piuttosto essere sempre progettato a tavolino con grande consapevolezza degli effetti di senso. A parte che l’idea stessa di spontaneità è un’espressione del pregiudizio romantico secondo cui la poesia sarebbe espressione dell’io – e perdere spontaneità sarebbe ridurla a calcolo. La dimensione progettuale, calcolata, non è in verità né implicata né esclusa da una visione della poesia che privilegi l’effetto sul lettore. Il poeta potrebbe anche aver scritto di getto, cercando di affiatarsi con lo Zeitgeist, e limitando l’intervento ragionato a qualche limatura successiva: questo, a priori, non renderebbe la sua poesia più soggettiva (e nemmeno più oggettiva, peraltro). Oppure potrebbe aver progettato tutto, come dichiarò Edgar Allan Poe (il più romantico dei Romantici) a proposito del suo poemetto The Raven.
Questa conclusione non coincide con quella del post di lunedì scorso, ma è comunque coerente o compatibile con quella. Là si riconosceva che la sensazione di presenza del noi (o di riduzione dell’io) è un effetto della qualità poetica, e non una sua causa o ragion d’essere. Qui si sostiene che si tratta di un effetto di senso del testo, non la testimonianza di un atteggiamento emotivo dell’autore. Certo, di per sé, la sensazione, prodotta dal testo, di presenza del noi (o di riduzione dell’io) non basta a garantirne la qualità; mentre una buona qualità del testo poetico, anche quando basata sulla costruzione di un effetto di presenza dell’io, richiama comunque la presenza del noi – perché trascende la dimensione semplicemente individuale.
Mi viene da dire, insomma, che il dibattito sulla riduzione dell’io, e sulla lirica e il suo eventuale oltrepassamento o negazione, è in verità basato su un equivoco tardoromantico, quello che Giuliani perdura parlando di “esprimersi soggettivamente”. Se l’io che si esprime attraverso un componimento poetico viene considerato soltanto come un effetto di senso testuale (e non come rappresentazione o testimonianza del poeta), che bisogno c’è di discuterne la legittimità? Sarà legittimo se retoricamente funziona; e sarà legittima la sua assenza se funziona quella.
Mi domando come ho potuto non accorgermene prima. In altri campi sostengo questa tesi da anni. Sembra che in poesia il dibattito dominante mi abbia accecato, mi abbia condotto nel suo alveo senza lasciarmi alternative se non quelle previste dei termini stessi del dibattito: ma sono i presupposti di questi termini ad essere sbagliati, e il dibattito stesso di conseguenza non lascia uscite.
Tornando alla falsa coscienza che emergerebbe da tanta (non tutta) poesia “innocente” o “ingenua”, certo anche quella è un effetto di senso, non c’è dubbio, e pure un pessimo effetto di senso. È naturale perciò che mi faccia raggelare.
 Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io. Il discorso è incominciato qui, e proseguito qui, ma le domande non sono finite. Se assumiamo il soggetto come costruito dall’ambiente, e l’io come sovrastruttura alienata, nonché la scoperta di tutto ciò in un percorso filosofico che va da Peirce e Nietzsche, attraverso Freud, sino a Lacan e oltre, ci apparirà ancora più strano che la poesia della modernità, dall’Ottocento in poi, si sia caratterizzata attraverso un crescente dominio proprio dell’io.
Non è solo il Romanticismo a esaltare l’io. Lo stesso imporsi del verso libero è dovuto alla richiesta di un’espressione meno vincolata da regole, e in grado di utilizzare più liberamente il ritmo come elemento espressivo, anziché come gabbia di riferimento, ovvero metrica, come era stato nella tradizione. Di nuovo, l’espressione riguarda la possibilità dell’io di manifestarsi, come fa notare Guido Mazzoni a pagina 212 del suo Sulla poesia moderna (Il Mulino, 2005) (più ampiamente, della posizione di Mazzoni in merito ho parlato qui):
L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi.
L’obiezione di Mazzoni investe assai più della “maggior parte delle poesie moderne”. Se assumiamo che “l’indecifrabilità” sia davvero “il primo segno della chiusura egocentrica”, anche buona parte della cosiddetta poesia di ricerca, compresa la Neoavanguardia e l’oggettivissimo Balestrini, finiranno a far la parte del narcisismo. Non vedo bene che cosa davvero ne possa restare fuori.
D’altra parte, uno degli aspetti che caratterizzano la modernità in generale, almeno in Occidente, è proprio la crescita del senso dell’io, narcisismo incluso. Una buona obiezione consisterebbe allora nel far notare che una poesia che esprima il proprio tempo non può esimersi dall’esprimere l’io, narcisismo alienato (alla Lacan) incluso. La (parziale) contro-obiezione sarebbe allora: d’accordo, la poesia dovrebbe sì esprimere l’io e il narcisismo, ma dal punto di vista di una consapevolezza del suo stato alienato. In alternativa, la poesia può anche esprimere altro dall’io, ma stando bene attenta a non reintrodurre attraverso le forme dell’espressione quello che tiene sotto controllo nelle forme del contenuto.
Non so. Ho l’impressione che da questa strettoia non si esca, e che il vicolo sia cieco. D’altra parte è lo stesso Lacan a definire sì l’io come un’alienazione, ma ammettendo insieme il fatto che si tratta di un’alienazione necessaria; ovvero che della sovrastruttura dell’io non possiamo in realtà fare a meno. E se non ne possiamo fare a meno nella vita, come potremmo farne a meno in poesia? Tanto più quando la poesia deve esprimere una realtà, la nostra, in cui l’io narcisistico è forte.
Proviamo allora a ribaltare i termini, e a pensare che quello che conta non sia tanto togliere di mezzo l’io, ma metterci dentro la comunità, rappresentare, o meglio esprimere la comunità. Uno dei ruoli della metrica nella poesia tradizionale era proprio quello di rappresentare la comunità, attraverso delle convenzioni diffuse di cantabilità, o attraverso l’implicita ritualità che la metrica tradizionale comporta. Peccato che la riproposizione della metrica tradizionale non funzionerebbe, oggi – se non dove la cantabilità è cruciale, ovvero ai confini della poesia, o appena fuori, cioè nella canzone musicale! Non funzionerebbe perché oggi quella metrica non ci rappresenta più, se non in casi molto particolari, o come parodia.
In questa prospettiva, non si tratterebbe più di ridurre l’io, tanto per citare il solito Giuliani, quanto di espandere il noi. La riduzione dell’io può essere una conseguenza di questa espansione del noi, ma può anche non esserlo, e l’io può benissimo far parte del noi. Insomma, non dobbiamo concentrarci sull’esclusione dell’io; perché non è quello il punto cruciale. Se l’attenzione è sul noi, l’io risulterà comunque inquadrato criticamente.
Ma che cosa vuol dire espandere il noi, o porre l’attenzione sul noi, in poesia? Una strategia a basso costo si chiama poesia civile: il noi ne è l’oggetto esplicito del discorso. Si tratta di una strategia a basso costo perché è anche, di per sé, a basso rendimento. Quello che rende affascinante i versi di Fortini, o quelli di Pasolini, non è il fatto che parlino di temi politici, ma il modo in cui lo fanno – e, per esempio, la particolare attenzione alla problematica metrica, alla ricerca di una strategia di identificazione con il collettivo. La maggior parte della poesia civile che si scrive oggi serve sostanzialmente a lavare la coscienza dei suoi autori: al di là del tema sociale, il narcisismo e i luoghi comuni la attraversano continuamente.
Rendere la poesia oscura, di difficile lettura, è un modo per nascondere il narcisismo e i luoghi comuni che a un occhio più attento non risultano affatto nascosti. Certo, così come non tutta la poesia civile è paccottiglia, nemmeno tutta la poesia oscura e difficile lo è; ma almeno la prima ha un noi come riferimento, ma la seconda? (giusto per dare qualche riferimento, nella poesia oscura e difficile non metterei nessuno del gruppo dei Novissimi, né ci metterei Adriano Spatola o Corrado Costa, ma ci starebbero benissimo vari epigoni della neo-avanguardia – come peraltro gran parte dell’ermetismo) In ogni caso, l’oscurità non è in sé un peccato mortale: solleva, però, dei legittimi sospetti. La poesia ha diritto di essere incomprensibile, anche se non è proprio opportuno che lo sia.
Forse abbiamo di nuovo bisogno di un ribaltamento di prospettiva. Vedendo le cose in un altro modo, forse quando la poesia funziona, quando è buona, quando possiamo definirla bella, è proprio quando è riuscita ad attingere alla dimensione del noi, comunque abbia trattato l’io. Se la poesia è buona, è perché ci possiamo identificare in lei; è perché esprime qualcosa che riguarda tutti, che siamo uno per uno (in quelli che ci paiono i nostri privati sentimenti) o che siamo tutti assieme.
In questo ribaltamento di prospettiva, allora non ha più senso cercare la ricetta per espandere il noi. Il noi si espande quando la poesia è buona, e non c’è una ricetta per questo. Ci sono corsi di scrittura, suggerimenti d’azione (tra cui l’aver letto tanta poesia di altri), dibattiti anche feroci: tutte cose utili, ma nessuna determinante.
Se questo è vero (e il se è d’obbligo), allora non serve la riduzione dell’io come programma, non serve la poesia civile come tema esplicito, non serve il sovvertimento della sintassi come tecnica. Sono possibilità che alla poesia restano (cioè non vanno escluse) ma è inutile utilizzarle programmaticamente, cioè come elementi della propria poetica di autore. La lezione di Peirce e Nietsche, Freud e Lacan, è recepita dalla poesia quando la sentiamo come collettivamente importante, non quando percepiamo l’espressione appassionata dell’io – la quale ci potrà anche essere, ma non è di per sé quello che conta. Non ha senso essere contro la lirica, ma nemmeno essere per la lirica; che una poesia sia lirica o meno è irrilevante per il giudizio se sia o meno una buona poesia. In questo senso siamo oltre la lirica.
Quanto ai confini del noi, io sto con Gregory Bateson (altro nome da aggiungere alla lista di cui sopra): non solo la comunità in cui viviamo è noi, non solo l’umanità, non solo la natura vivente.
 Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi. Nel post di lunedì scorso parlavo della visione del soggetto come costruzione di segni, un interno che in realtà è un esterno, nonché dell’io, o autocoscienza, come una sovrastruttura di questo soggetto, in cerca di un’impossibile auto-coerenza. Citavo al proposito Peirce e Lacan, ma poi potrei citare anche altri, più vicini a noi.
Questa visione del soggetto e dell’io si oppone, evidentemente, a quella antica e a quella cartesiana, che, in vario modo, contrappongono una res extensa, il mondo, la natura, a una res cogitans, l’autocoscienza, la mente. Questa dicotomia non esiste: la boutade di Rimbaud, “Io è un altro”, è preoccupantemente vera. Essere alienati, per Lacan, è non rendersene conto, e pensare di possedere davvero un’arena interna di cui si è padroni.
Ora la domanda è: la poesia può, o magari deve, recepire questa posizione rispetto all’io? Che senso ha parlare di lirica, cioè di espressione dell’io, se l’io è un’illusione? E chi ancora scrive lirica sta davvero sbagliando tutto? Oppure in che senso ha ancora senso scrivere lirica? Quando Alfredo Giuliani parlava di riduzione dell’io (come “l’ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente”) stava parlando di questo?
Proseguendo con le perplessità. La posizione di Peirce e Lacan non è storica. Il soggetto è sempre stato una costruzione, anche al tempo di Saffo. Questo vuol dire che la lirica greca è uno sbaglio? Presumibilmente no. Saffo scriveva, ovviamente, basandosi sulle convinzioni del suo tempo. Ma per noi, oggi, che lo sappiamo, allora la lirica è uno sbaglio? E se un poeta non ha studiato filosofia, e non sospetta nulla di tutto questo, continuando a crogiolarsi nella dominante vulgata cartesiana, è già solo per questo un cattivo poeta? Presumibilmente no, ma forse sarà un poeta un po’ anacronistico, o forse ci lascerà la facoltà di interpretarlo come se scrivesse da dentro l’illusione, come se potessimo ancora crederci davvero.
E cosa vuol dire, oggi, scrivere poesia essendo consapevoli della relatività del soggetto, e della superficialità alienata dell’io? C’è una forma specifica di questa post-lirica?
Aggiungiamo che, se l’io è un’illusione, allora si tratta di un’illusione progressivamente sempre più dominante in Occidente, di cui tutti in misura maggiore o minore, siamo vittime, anche quando dell’illusione siamo consapevoli. Una poesia che agisca dentro l’illusione, rendendone conto, ma senza consapevolezza del suo essere tale, sarà accettabile? Oltre certi limiti è certamente anacronistica, come dicevamo sopra (il che non significa, di per sé, che sia cattiva poesia); ma parlare dell’io è comunque anacronistico? Forse se la poesia ci permette di essere letta come se (nei termini di cui sopra) allora l’anacronismo scompare, o almeno si riduce?
Certo, gran parte della lirica del passato appare, se vista con questi occhi, ingenua. Ma tale, se ci leviamo il paraocchi dell’adorazione feticistica del passato, ci appare anche la statuaria della Grecia antica. Ma questo non toglie nulla alla grandezza di Fidia, che va comunque valutato pensando al suo tempo, e non si può trasfondere così com’è nel nostro. Ne era ben consapevole persino Antonio Canova, le cui capacità tecniche sono paragonabili a quelle di Fidia, e che viveva in un’epoca in cui riproporre il classicismo aveva senso; ma Canova sapeva benissimo che una bella statua neoclassica andava comunque interpretata in un modo differente da una bella statua classica – e che parte della differenza stava proprio nella perdita irreparabile di un’ingenuità.
Sul soggetto, oggi, non siamo più ingenui. Possiamo perdonare i poeti che continuano ad esserlo? E se possiamo, in che misura li possiamo perdonare? Certamente non del tutto. L’ignoranza, almeno in qualche misura, va pagata.
(altre riflessioni, di tono un po’ diverso, ma sullo stesso tema, si trovano qui)
 Ho partecipato, la scorsa settimana (2-4 ottobre) a un convegno su Charles Sanders Peirce, a Bologna, tenuto in occasione dei cento anni dalla morte. Peirce è stato un filosofo straordinario, non solo perché ha fondato la semiotica nei saggi intorno al 1868 (quando non aveva ancora trent’anni), e il pragmatismo (poi da lui ribattezzato pragmaticismo perché non gli piaceva la piega che aveva preso nella vulgata e in William James). Nei saggi di Peirce la semiotica nasce con una vena profondamente anticartesiana, in cui non solo perde ogni senso la distinzione tradizionale tra mente e natura (interno ed esterno della coscienza definita dal cogito), ma la mente stessa diventa un concetto naturale, costruita da un sistema di segni che è già nel mondo. Ho partecipato, la scorsa settimana (2-4 ottobre) a un convegno su Charles Sanders Peirce, a Bologna, tenuto in occasione dei cento anni dalla morte. Peirce è stato un filosofo straordinario, non solo perché ha fondato la semiotica nei saggi intorno al 1868 (quando non aveva ancora trent’anni), e il pragmatismo (poi da lui ribattezzato pragmaticismo perché non gli piaceva la piega che aveva preso nella vulgata e in William James). Nei saggi di Peirce la semiotica nasce con una vena profondamente anticartesiana, in cui non solo perde ogni senso la distinzione tradizionale tra mente e natura (interno ed esterno della coscienza definita dal cogito), ma la mente stessa diventa un concetto naturale, costruita da un sistema di segni che è già nel mondo.
Recentemente ho letto molto Lacan, scoprendovi con sorpresa un sacco di nozioni familiari, anche se spesso chiamate con nomi non familiari. Andando a cercare, su questa base, tracce di Peirce in Lacan, con mia iniziale sorpresa ne ho trovate parecchie, di cui molte assolutamente esplicite, a partire dal Seminario del ’61-62. Facendo un po’ di conti, anche a partire dagli anni di pubblicazione dei Collected Papers, si può ipotizzare che Lacan abbia letto Peirce nei tardi anni Cinquanta, quando già diversi elementi essenziali della sua teoria erano assestati, ma altri ancora dovevano venire.
La teoria del soggetto diviso, dell’io (moi) come fenomeno di superficie, e dell’inconscio strutturato come linguaggio erano già state sviluppate prima dell’incontro con Peirce, ma nel momento in cui l’incontro avviene Lacan trova in Peirce tutte le premesse che gli mancavano, essendosi basato sino ad allora sulla semiologia saussuriana e sul suo sviluppo strutturalista. La famosa formulazione “Il significante è ciò che rappresenta il soggetto per un altro significante” è chiaramente un calco dalla definizione peirceana di segno, e rimane oscura sino a quando non si prova a costruirla graficamente in maniera analoga a come normalmente si costruisce la fuga degli interpretanti in Peirce.
Ecco qui a destra il diagramma per Peirce: 
Un representamen (cioè un segno) rimanda al suo oggetto solo attraverso la mediazione di un interpretante, il quale si trova a sua volta nella posizione del representamen iniziale e ha bisogno di un nuovo interpretante, per il quale vale la medesima necessità. Si genera in questo modo una fuga degli interpretanti, virtualmente infinita, ma che ha di fatto termine solo nella prassi (nel formarsi di un abito, ovvero di una disposizione al comportamento, dirà Peirce).
Ora, sostituiamo in questo diagramma i termini lacaniani a quelli peirceani, e scriviamo significante là dove c’è scritto representamen o interpretante, e scriviamo soggetto là dove c’è scritto oggetto. Così come in Peirce abbiamo l’immagine di un oggetto a cui di fatto la significazione non arriva, perché è sempre mediata dal passaggio a un altro interpretante, allo stesso modo avremmo in Lacan l’immagine di un soggetto a cui non si arriva (a cui l’analista non arriva) perché qualsiasi significante gli possa rimandare va comunque interpretato alla luce di un altro significante, e così via. Di fatto, il soggetto lacaniano è tutto costruito, per la sua determinante parte simbolica, da questa fuga dei significanti, e per Lacan il soggetto è l’inconscio, mentre l’autocoscienza è un ulteriore sovrastruttura, peraltro illusoria. Il reale lacaniano appare inoltre molto vicino al ground peirceano (per non dire di altro, su cui non scriverò qui).
Lacan è erede di una tradizione fenomenologica (quella husserliana-heideggeriana) diversa da quella peirceana, in cui il soggetto non si trova così dissolto. Lacan cresce tuttavia in una cornice anche hegeliana, in cui invece l’idea di un soggetto come epifenomeno è già presente. Anche Peirce ha un retaggio hegeliano, e sviluppa una propria fenomenologia (che lui chiamerà faneroscopia). Con presupposti simili, Lacan sviluppa quindi originalmente una serie di concetti che sono convergenti con quelli peirceani, sino a quando non incontra una fenomenologia diversa da quelle europee, in cui il soggetto è già implicitamente dissolto, e sono presenti da lungo tempo diverse delle sue scoperte (non tutte, certo).
Questo è parte di quello che ho raccontato al convegno di Bologna, con altre osservazioni sul Faust di Goethe (che su questo blog erano già comparse qui, e poi di nuovo qui, questa volta sviluppate in un discorso sulla poesia) e ancora altre su Gregory Bateson, che mostrano a loro volta come nemmeno l’idea peirceana che la semiosi sia già presente in natura sia una posizione metafisica, bensì a sua volta fenomenologica. Insomma, una fenomenologia senza soggetto, inquietante e affascinante.
Riprendiamo il discorso dal post precedente su Facebook e il Web 2.0.
Che tipo di ritualità possiamo dunque ritrovare in Facebook, che, come gli altri network del Web, è un luogo di azioni non compresenti (al contrario di una cerimonia), asincrone (cioè non sincronizzate nel gesto, come è invece la fruizione televisiva), e non basate su un ritmo (come è invece la fruizione di musica e poesia – cosa che ci permette di entrare in sintonia con gli altri anche senza compresenza e simultaneità)?
Le azioni che si compiono sui social network sono fondamentalmente azioni di scrittura e di lettura, dove quello che si scrive e/o si legge sono testi verbali, oppure testi di altro tipo (visivi, audiovisivi, sonori) commentati da testi verbali. La parola scritta vi ha dunque in ogni caso un ruolo cruciale.
Scrivere e leggere non sono però normalmente azioni rituali: si scrive e si legge, di solito, con finalità comunicative specifiche, con destinatari specifici, che hanno scritto o mi leggeranno autonomamente, a loro volta con finalità comunicative specifiche. Tuttavia, quando si scrive nelle reti sociali non ci si rivolge a qualcuno specifico, bensì alla comunità di tutti gli amici, i quali, a loro volta, stanno facendo la medesima cosa. Quando l’azione di scrivere, cioè, è comune a tutti, ed è l’azione stessa che fonda la comunità e che la fa esistere, allora questa azione può essere rituale.
Questa azione non è coordinata né per simultaneità né per gestualità compresente né per ritmo, ma è ugualmente coordinata. Il mio gesto, che costruisce insieme la mia ipseità e quella di altri, è il medesimo gesto di tutti gli altri, un gesto che molti stanno compiendo in questo medesimo momento come me, e tutti hanno compiuto o compiranno in tempi brevi. La collettività dei miei amici, inoltre, non è isolata; è fittamente intersecata con quella degli amici dei miei amici, e alla lunga con tutte, cioè con la collettività della rete sociale nel suo complesso.
Proprio come il luogo della fiction (il racconto dei romanzi, per esempio), anche il virtuale è disincarnato, estraneo al corpo e alle sue peculiarità. L’identità, a differenza dell’ipseità, continua a richiedere un corpo materiale e un agire materiale: è il corpo stesso con il suo agire e la sua unicità a garantire l’identità. Nelle nostre società (reali), l’unicità legata al corpo viene garantita dal nome proprio – ma nelle reti sociali sembra facile assumere identità fittizie, con nomi altrettanto fittizi. Non c’è il corpo a garantire l’unicità. Eppure sembra che ormai questo tipo di finzione sia un caso raro su Facebook, dove la stragrande maggioranza degli utenti possiede un nome vero e un’identità unica. Il nome, la foto, diventano simulacri del corpo stesso, a garanzia dell’identità materiale che sostiene la costruzione sociale dell’ipseità.
A ben guardare, tuttavia, nella dimensione rituale di Facebook il corpo non è affatto estromesso. L’azione di scrivere, che la fonda, è un’azione materiale, che si fa con le mani, con gli occhi, con il nostro corpo. Inoltre, quando io scrivo, in una comunità, e non mi limito a guardare da fuori quello che succede senza parteciparvi, allora anche l’atto di leggere può ugualmente assumere caratteristiche rituali, ugualmente fisiche. Al di fuori di questi casi, il leggere può essere visto come un semplice atto di acquisizione cognitiva; ma se si trova combinato con lo scrivere all’interno di una comunità che legge e scrive, allora anch’esso diventa rituale come lo scrivere.
Nelle reti sociali, dunque, l’atto di scrivere e leggere è l’atto legato all’identità e, insieme, alla costruzione rituale della rete, mentre ciò che si legge e si scrive costruisce la nostra ipseità e l’ipseità della rete stessa.
C’è dunque una grande differenza tra questo tipo di ritualità e quella che caratterizza la fruizione televisiva, simbolo stesso della società di massa. La ritualità cattolica della televisione è basata sulla presenza di un celebrante che dà significato al rito attraverso le proprie parole e i propri gesti: i concelebranti/fruitori non possono che sintonizzarsi con il rito, oppure abbandonarlo. La ritualità delle reti sociali non ha invece un celebrante centrale, e non ha significati precostituiti da trasmettere attraverso il rito; anzi, l’evento cruciale del rito richiede che il fruitore produca i propri contenuti, e li offra in dono alla collettività, dalla quale ne riceverà altri, coordinati con i suoi.
Insomma, se per esistere devo parlare, devo anche inventarmi qualcosa da dire. Partecipare al rito, scrivendo, è ciò che mi fa esistere; ma è quello che dico che mi dà forma. E tuttavia, esistere è più cruciale e più basilare dell’avere forma. Il rito fonda il mito, e non viceversa, benché la distanza tra loro sia ridottissima. Quanto ai contenuti, dunque, basterà purtroppo adeguarsi più o meno a quelli degli altri: anche così infatti la nostra mitologia personale, la nostra ipseità, corrisponderà di più a quella collettiva, a quell’infinito libro sacro che tutti gli uomini scrivono e leggono e cercano di capire, e nel quale sono scritti anch’essi, come ebbe a dire Jorge Luis Borges parlando del Don Chisciotte e di altri testi paradossali.
Le considerazioni su Facebook e sull’identità narrativa che ho esposto nel post della scorsa settimana (Di Facebook e di Bauman, e dell’identità narrativa), ricollegandomi a un altro post uscito in gennaio (Dei paradossi, dei sogni e di Facebook), hanno alcune inevitabili e interessanti conseguenze.
Possiamo partire da qui: se il modo in cui gli altri ci raccontano è così fondamentale per la costruzione del soggetto, cioè della nostra stessa identità (nella forma, appunto, dell’ipseità, o identità narrativa), allora le modalità di costruzione dell’ipseità sono sostanzialmente le stesse della costruzione delle mitologie. E lo sono tanto di più in un contesto come quello di Facebook (e delle reti sociali in genere), in cui la dimensione narrativa (cioè verbale) è dominante, proprio come nella costruzione della mitologia.
La mitologia è una cosa diversa dal mito. Seguo in questo alcune intuizioni molto suggestive che ho trovato in Raimon Panikkar (Mito, fede ed ermeneutica. Il triplice velo della realtà, Jaka Book 2000). Il mito è un sistema di assunzioni molto profonde, presente nella nostra identità personale e collettiva, che non è esprimibile direttamente, e che governa le nostre credenze e attitudini. Il mito riesce talvolta a essere espresso (e, di conseguenza, in parte controllato) sotto forma di mitologie, ovvero, letteralmente, parola del mito, o pensiero del mito.
La costruzione di racconti mitologici ci permette di avere una qualche consapevolezza del mito, e di avere l’impressione di controllarlo (la versione pessimista è poi che, quando questo succede, il mito si è di fatto già spostato, è già cambiato, e continua a influire di noi in un altro modo – ma non di questo voglio parlare qui). Questo vale sia per le grandi mitologie culturali (come quelle che si espongono nella tradizione greca antica) sia nelle mitologie personali di cui si nutre la nostra ipseità. L’intero edificio terapeutico della psicoanalisi si basa sull’assunto che riuscire a portare al livello del racconto le istanze profonde sia il punto di partenza del percorso verso una guarigione.
Con questo non si vuol dire, ovviamente, che Facebook sia terapeutico. Il processo di narrativizzazione all’interno di una terapia analitica è controllato (ed è solo il punto di partenza della terapia, in cui entrano in gioco anche molti altri fattori), mentre quello che accade nei social network è, semmai, sociale, cioè dipende da quello che è nell’aria al momento tra tutti coloro che partecipano (buono o cattivo che sia per i singoli partecipanti).
Ho parlato in un altro post (Dell’audiovisivo e di Youtube) di come il Web tenda, nel suo complesso, a narrativizzare, trasformando gli eventi in documenti (cioè in oggetti comunicativi). Nel momento, per esempio, in cui un programma televisivo venga fruito su Youtube (o in generale attraverso un link nel Web), perde infatti gran parte della sua carica mitica (che agisce, attraverso un meccanismo di fruizione rituale, a livello profondo), per diventare semplice mitologia, cioè racconto del mito, un oggetto comunicativo che può essere oggetto di commenti e discussione.
In generale, infatti, il Web (specie nella versione 2.0) sembra essere un grande de-mitizzatore, proprio perché mina la radice rituale della fruizione di eventi come quelli audiovisivi, riducendoli a oggetti: io non sono più, sul Web, uno dei tanti che sta seguendo in maniera coordinata la trasmissione televisiva, senza possibilità immediata di commento o di intervento, proprio come nel corso di una Messa (a cui si partecipa, o in caso di dissenso al massimo se ne esce). Su Youtube ho, piuttosto, scelto di vedere l’audiovisivo, su suggerimento di altri, attraverso dei commenti che ho già letto, o sto persino leggendo in contemporanea, e con la possibilità di intervenire io stesso alla discussione collettiva.
Ora, questa visione del Web come luogo della consapevolezza e della coscienza narrativa (e di conseguenza, potenzialmente, luogo della discussione e della democrazia) è convincente sì, ma solo fino a un certo punto. Non si danno, antropologicamente, comunità senza riti che ne procurino la coesione, permettendone l’esistenza. Se le reti sociali come Youtube e Facebook distruggono dei riti, è plausibile che ne istituiscano altri, instaurando dei miti profondi, che non è detto che si manifestino chiaramente, o che magari si manifestano solo come confuse mitologie.
Che tipo di ritualità possiamo dunque ritrovare in Facebook, che, come gli altri network del Web, è un luogo di azioni non compresenti (al contrario di una cerimonia), asincrone (cioè non sincronizzate nel gesto, come è invece la fruizione televisiva), e non basate su un ritmo (come è invece la fruizione di musica e poesia – cosa che ci permette di entrare in sintonia con gli altri anche senza compresenza e simultaneità)?
Qualunque sia questo aspetto rituale, esso comporterà comunque una differenza fondamentale rispetto al rito della fruizione televisiva – nel quale, appunto, l’aspetto compartecipativo si limita alla fruizione stessa: una grande partecipazione collettiva a un evento le cui regole e i cui significati sono sostanzialmente dettati dall’alto, proprio come nelle cerimonie della religione cattolica. O si aderisce, e in qualche modo implicitamente si aderisce ritualmente ai contenuti (anche quando ci sentiamo razionalmente in dissenso), oppure se ne esce, si spegne la TV, non si partecipa. Nei social network, qualche regola del gioco è certamente dettata dall’alto (pur avendo bisogno di essere confermata dalla partecipazione degli utenti), ma i significati certamente no.
(segue, presto, anzi, qui)
(Queste riflessioni, così come quelle che sono contenute negli altri post cui si fa qui riferimento, sono state sviluppate per un intervento che terrò a metà maggio a un convegno a Siviglia. Il convegno, organizzato dalla rivista latinoamericana di semiotica deSignis e dalla Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede di Siviglia, si intitola Nuevas Identidades Culturales y Mediaciones Digitales)
Sembra che l’articolo di Zigmunt Bauman uscito su Repubblica e riportato da Arianna Editrice (“Il trionfo dell’esibizionismo nell’era dei social network“) abbia suscitato un piccolo vespaio di discussione. Ne ho avuto notizia attraverso un post piuttosto critico di Giovanni Boccia Artieri (“Bauman e la società confessionale. Limiti del pensiero moderno sui social network“), il quale rimanda a sua volta al dibattito presente nella pagina di Facebook che ha portato alla sua attenzione il tutto (vedi il profilo Facebook di Salvo Mizzi). Tanto per mettere ancora un po’ di carne al fuoco, c’è anche la segnalazione di Alex Giordano in un commento al post di Boccia, che ci rimanda a un suo post dove riporta un articolo di Luciano Floridi dal titolo “La costruzione dell’identità personale in rete”.
È tutto piuttosto interessante, in particolare per me che in questi giorni sto lavorando proprio su temi vicini a questi. Nemmeno a me il discorso di Bauman risulta del tutto chiaro. Capisco la distinzione che lui fa tra rete e comunità, e capisco anche che lui possa sostenere che i social network siano reti, e non comunità. La capisco ma non la condivido, perché ritengo anch’io, con Boccia Artieri, che Facebook possa anche sostenere la formazione di comunità nel senso di Bauman, e che, inoltre, la nozione stessa di comunità possa modificarsi. Le parole di Bauman sono le seguenti:
Appartenere a una comunità costituisce una condizione molto più sicura e affidabile, benché indubbiamente più limitante e più vincolante, che avere una rete. La comunità è qualcosa che ci osserva da presso e ci lascia poco margine di manovra: può metterci al bando e mandarci in esilio, ma non ammette dimissioni volontarie. Invece la rete può essere poco o per nulla interessata alla nostra ottemperanza alle sue norme (sempre che una rete abbia norme alle quali ottemperare, il che assai spesso non è), e quindi ci lascia molto più agio e soprattutto non ci penalizza se ne usciamo. Però sulla comunità si può contare come su un amico vero, quello che “si riconosce nel momento del bisogno”.
Vorrei però partire, in realtà da un punto diverso, cioè dalla questione dell’identità, che viene sollevata nell’articolo di Floridi. Floridi distingue tre tipi di identità, l’identità ontologica, cioè come siamo di fatto, l’identità epistemologica, cioè come crediamo di essere, e l’identità sociale, cioè l’irruzione del contesto sociale a strutturare la nostra identità. Floridi dice:
Il Sé sociale è il “sito” attraverso cui i media interattivi, come Facebook, hanno il più profondo impatto sulle nostre identità. Cambia le condizioni sociali in cui ti trovi, modifica la rete di relazioni e i flussi di informazioni che gradisci, rimodella la natura e lo scopo dei vincoli e delle azioni che determinano la rappresentazione di te stesso al mondo e il tuo sé sociale sarà radicalmente rinnovato, alimentando la propria concezione di sé, che finisce per formare la tua identità personale.
Io condivido la direzione in cui va Floridi, ma credo che si possa osare di più. Il sè ontologico, per esempio, è una pura ipotesi regolatrice, un’inconoscibile cosa in sé. Certo che, per qualsiasi momento della nostra vita (perché un momento dopo è già cambiato) possiamo sensatamente assumere che esista una struttura che sia la nostra, che sia noi stessi insomma. Ma ciò che ne conosciamo è inevitabilmente la sua rappresentazione a noi stessi, ovvero già un sé epistemologico. Per questo, solo del sé epistemologico ha senso parlare.
In secondo luogo, la mia identità epistemologica si può costruire solo attraverso il contatto con il mondo, e in particolare con quella enorme fetta di mondo che sono gli altri; insomma, l’identità epistemologica nel momento in cui esiste è già un’identità sociale. Era già Nietzsche a farci capire che il nostro stesso io è una costruzione culturale, basata sul linguaggio (magari nel senso ampio dei sistemi semiotici in genere, e non solo in quello ristretto del sistema delle parole); Lacan e Ricoeur non fanno che raffinare e specificare la sua scoperta. In particolare, trovo molto rilevante per il nostro discorso la nozione di identità narrativa (o ipseità) proposta da Ricoeur (in Tempo e racconto). L’identità narrativa è il modo in cui noi ci raccontiamo a noi stessi. In pratica è la componente verbale-narrativa dell’identità epistemologica. Ma il modo in cui noi ci raccontiamo a noi stessi dipende prima di tutto da come ci raccontano gli altri, perché è attraverso i racconti degli altri su di noi (e le reazioni degli altri ai nostri racconti) che ci possiamo costruire il nostro racconto di noi. Questo è cruciale nella prima infanzia, per la formazione del soggetto; e continua a essere cruciale anche poi (anche se da adulti i nostri racconti interiori già costituiti sono più forti e resistenti), per il mantenimento del soggetto.
Io credo che Facebook (e simili) abbia avuto tanto successo perché ci fornisce un’enorme possibilità in più di definire la nostra identità narrativa, attraverso i racconti degli altri e le reazioni degli altri ai nostri racconti.
Naturalmente anche questo si presta a delle aberrazioni. L’utente di Facebook che si vanta di riuscire a farsi anche 500 nuovi amici al giorno non è ancora uscito dal paradigma della TV, e ritiene che il proprio valore si misuri in termini di share. Naturalmente questo vale un po’ anche per tutti, non c’è dubbio; e questo giustifica il fatto che si possa pensare che i social network siano il luogo dell’estimità (in quanto contrapposta all’intimità, come propone Tisseron). Naturalmente, in una società in cui il valore sta nella pubblica fama, siamo tutti alla ricerca del nostro quarto d’ora di notorietà, anche a costo di raccontare i nostri segreti.
Tuttavia, non mi sembra questo il punto (e anche qui mi pare di essere in linea con le conclusioni di Boccia Artieri, quando avvicina le esternazioni degli adolescenti alla loro difesa, comunque presente, dalle irruzioni dei genitori). Semmai, maggiore è il numero di persone che ci corrisponde narrativamente, e più articolata potrà essere la nostra identità narrativa. Un punto in cui Bauman ha ragione è nel vedere la privacy (anche) come una prigione, da cui è necessario uscire: certo, se vogliamo che qualcuno ci racconti, dobbiamo fornirgli degli elementi, e quindi esternarci, abbandonare almeno un poco la nostra intimità.
Se 150 può essere davvero il numero massimo delle persone vicine (anch’io dubito che si possa andare oltre), non si vede perché i racconti delle persone lontane non possano avere a loro volta valore. Anzi, la possibilità di essere raccontato pure da qualcuno che non sceglierei come amico vero mi costringe a confrontarmi con rappresentazioni impreviste di me (e magari pure sgradevoli). Questo alla breve forse mi indebolisce, perché mi destruttura; ma alla lunga o mi rende un indifferente, oppure mi rafforza – perché mi dà ulteriore consapevolezza sul mio io.
Se la situazione dei giovani coreani è davvero quella descritta da Bauman, abbiamo ragione di preoccuparci. Non però perché usano i social network, ma perché non usano altro. Quando dico che l’identità narrativa è una parte dell’identità epistemologica faccio riferimento anche al fatto che la nostra interazione con il mondo e con gli altri non è solo in termini narrativi (cioè verbali), mentre su Facebook lo è (e non mi dite che ci sono anche le immagini e i video! non è certo questo il punto). Vivere di solo Facebook è come vivere di soli libri e giornali, in una grotta chiusa al mondo. Gli scambi narrativi sono cruciali per ciascuno di noi, ma non sono la totalità di ciò che costruisce la nostra identità.
Quanto alla fascinazione per la tecnica, di cui qualcuno parla, mi sembra piuttosto marginale. C’è stato semmai, per un po’, il fascino della novità. Ma quello da solo basta a far partire le cose, certo non a farle durare, tantomeno a garantire un successo come quello dei social network.
Piuttosto, in un’era ancora dominata dalla TV e da una cultura di massa dalla quale ci sentiamo raccontati tutti allo stesso modo, avere l’impressione di poterci raccontare a tante persone e farci raccontare da tante voci diverse è probabilmente uno stimolo straordinario. Il villaggio è diventato globale, ma senza la TV, anzi, contro di lei.
P.S. Prosegue, qui.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|
 Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte.
Nel frattempo c’è stato Ex.it Materiali fuori contesto, ad Albinea, e questo porta nuova acqua al discorso dei post precedenti (sono gli ultimi tre – oltre a questo – sotto il tag identità). Nel corso del dibattito sugli spunti critici sono intervenuto due volte.
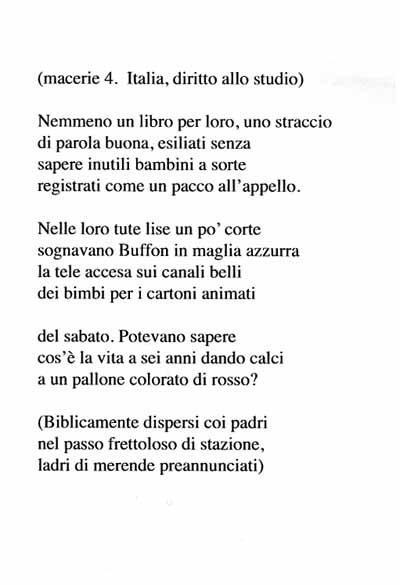












 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco





Commenti recenti