 Ho appena partecipato a questo incontro interessante, organizzato da Bologna in Lettere, dove si è discusso sulla poesia contemporanea, e anch’io ho detto la mia. Me ne esco con un problema, legato a quello che ho detto in quella sede, ma più specificamente declinato sulle mie personali scelte di poetica. La mia riflessione si ricollega a quanto dice Biagio Cepollaro in un breve video che è stato mostrato in apertura dell’incontro, e che vi invito a guardare prima di continuare a leggere (sono solo 5 minuti).
Ho appena partecipato a questo incontro interessante, organizzato da Bologna in Lettere, dove si è discusso sulla poesia contemporanea, e anch’io ho detto la mia. Me ne esco con un problema, legato a quello che ho detto in quella sede, ma più specificamente declinato sulle mie personali scelte di poetica. La mia riflessione si ricollega a quanto dice Biagio Cepollaro in un breve video che è stato mostrato in apertura dell’incontro, e che vi invito a guardare prima di continuare a leggere (sono solo 5 minuti).
Cepollaro ricorda quanto importante continui a essere l’opposizione adorniana tra arte conciliata e non conciliata, o pacificata e non pacificata (o anche, direi io, sempre riprendendo la terminologia di Adorno, tra un’arte che si rende conto di avere perso l’innocenza e un’arte che non se ne rende conto), e di come, sino agli anni Novanta, questo sia stato inteso dalla poesia italiana in termini di deriva del linguaggio e della sintassi, allontanamento da una naturale comprensibilità del discorso poetico. Sino a quando, dice ancora Cepollaro, questa strategia ha incominciato a ripetersi, a sclerotizzarsi, e c’è stato un diffuso rifiuto nei suoi confronti.
A partire da queste premesse, che condivido, il problema cui io, come autore, come poeta, mi trovo davanti è comunque quello di produrre un’arte non pacificata, consapevole della perdita della propria innocenza. Solo che non posso più utilizzare la formula della dissoluzione della sintassi, perché non funziona più – se mai ha funzionato in quanto tale. Oggi è invecchiata e a sua volta inserita nel meccanismo dell’industria culturale, almeno per quel poco che può succedere per il mondo un po’ estraniato e marginale della poesia.
Anzi, visto da oggi, io vedo quella strategia come una scorciatoia un po’ troppo comoda per arrivare al regno dell’arte non pacificata. Col che non intendo squalificare in sé il lavoro della neo-avanguardia, che ha comunque prodotto un certo numero di poeti di altissimo livello, e non solo nel gruppo ristretto dei Novissimi, ma cautelarmi rispetto alla loro maniera e soprattutto rispetto al loro epigonismo.
Tenderei ad annettere a questo insieme, ovvero a quello della scorciatoia, non solo le strategie di sovvertimento sintattico, ma anche quelle sostanzialmente neo-dadaiste di presentazione di objet trouvé, o di searched objects (leggasi googlism), in cui il distacco emotivo del poeta è messo in evidenza dal lavoro su materiali chiaramente esterni, chiaramente oggettivi, spesso utilizzati senza una particolare elaborazione – che correrebbe il rischio di inserire una marca di soggettività nel gioco – un po’ secondo il principio del collage.
Sto parlando in termini di poetica personale, non di estetica normativa. Cioè non escludo che queste strade possano ancora portare a risultati interessanti, e sono pronto ad accoglierli felicemente appena li incontro. Solo che, in primis, in linea di massima tendo a non incontrarli, cioè faccio fatica a trovarne, e, in secundis, non mi interessa personalmente percorrerle come autore. Da questo punto di vista, potrei dire, ho già dato, ho già fatto: sono cresciuto all’interno di quella temperie culturale, e tutta la mia produzione giovanile ne risente pesantemente.
Credo, oggi, che il lettore abbia diritto di avere un accesso immediato a quello che legge, ovvero che il componimento gli fornisca almeno un aggancio, un sospetto di comprensione alla prima lettura, che poi magari si rivelerà parziale, incompleto, o addirittura erroneo a una lettura più approfondita, ma che gli permetta sin dall’inizio un accesso ritmico, un ingresso in sintonia con il testo e le sue letture. In assenza di questa ricompensa immediata, per quale motivo il lettore dovrebbe impegnarsi, andare a cercare ulteriori ragioni di interesse, che si trovano soltanto con un vero e proprio lavoro di tipo critico, per quanto personale? L’impegno interpretativo è un investimento, che vale la pena di fare se il testo promette un’adeguata ricompensa, ovvero se abbiamo ragione di pensare che, oltrepassando l’ostica apparenza di prima lettura, troveremo un universo di affascinanti nessi significanti, con correlata emozione estetica. Ma se il testo non promette, oppure – peggio – se promette e poi non mantiene, perché dovremmo investire in termini di impegno e fatica interpretativa?
In tempi di vincente ideologia, come sono stati i decenni tra i Cinquanta e gli Ottanta del secolo scorso, questa disposizione all’impegno da parte del pubblico era più diffusa, perché più diffusa era l’idea che si dovesse investire intellettualmente per ottenere un risultato in termini di comprensione. Ma poi è stato il fallimento stesso di questo programma, che ha coinciso con il tramonto delle ideologie, che ha deluso il pubblico. Poetiche della complicazione sintattica o della citazione neo-dadaista, come furono quelle della neo-avanguardia, potevano funzionare in un contesto in cui l’impegno intellettuale era moneta corrente; ma funzionano molto meno quando questa stessa moneta è arrivata a svalutarsi pesantemente.
Queste strategie erano dunque scorciatoie per ottenere un’arte non pacificata, che funzionavano in quelle condizioni culturali. Oggi quelle condizioni non ci sono più, e la scorciatoia mi nausea un po’. La rispetto negli autori che l’hanno utilizzata in quegli anni in cui aveva senso utilizzarla. Ne diffido acutamente in chi continua a utilizzarla oggi.
Eccomi quindi di fronte al problema, che dovrebbe essere, io credo, il problema di chiunque scriva poesia oggi, anche se poi, la mia soluzione è semplicemente la mia, senza pretese di generalizzazione. Ma il problema, che è lo stesso per tutti, che uno se ne renda conto o no, è: come costruire un’arte non pacificata, senza utilizzare la scorciatoia asintattica o neodadaista? Come fornire un aggancio di comprensibilità al lettore senza rientrare nelle banalità di una tradizione, la quale non era banale in sé quando veniva prodotta, ma lo sarebbe oggi se riproposta nei medesimi termini?
Comprensibilità per il lettore non vuol dire soltanto che il lettore possa più o meno seguire la sequenza sintattica, ma che riceva anche la sensazione di essere di fronte a un testo poetico.
Un esempio di strategia alternativa (e un po’ meno scorciatoia) è quello dei poeti cosiddetti neo-metrici. In vari modi, con molte differenze tra loro, autori come Valduga, Frasca, Nove, costruiscono la poeticità con un esplicito riferimento al metro tradizionale, ma si mostrano non pacificati associando a questo recupero del metro tematiche e/o sintassi tutt’altro che tradizionali, in modo che il conseguente straniamento costruisca un effetto complessivo paradossale e un po’ provocatorio. Strategia interessante, che dà anche dei buoni risultati, ma che si lega comunque alla presenza di uno spirito dichiaratamente intellettualistico, quale quello che accompagna inevitabilmente le parodie. Restano escluse, da questa scelta, molte possibilità di registro, tra cui anche varie che interessano a me.
Altri poeti ancora si rifanno alla metrica tradizionale, in particolare all’endecasillabo, con spirito meno provocatorio, ma ugualmente utilizzandolo in maniera non convenzionale, come una sorta di macchina ossessiva e senza uscita. E’ il caso, per esempio, di Piersanti e di Fedele (ne parlo ampiamente nel saggio “Il vincolo e il rito”, sulla metrica della recente poesia italiana, uscito su L’Ulisse n.16 – anche più direttamente accessibile su Academia.edu). Pur apprezzando molto certi loro lavori, personalmente provo una certa paura nei confronti dell’endecasillabo, un verso troppo bello e troppo tradizionale per utilizzarlo senza un controllo continuo e faticoso, una continua attenzione al non renderlo tramite di forme antiquate e pacificate, nel senso adorniano di Cepollaro. Proprio per questo, io ho fatto sì una scelta metrica, ma studiata appositamente per non cadere inavvertitamente nelle maglie dell’endecasillabo, pur potendolo utilizzare trasversalmente, ma solo con studiata consapevolezza.
Il rapporto con la poeticità può riguardare temi, ricorrenza di formule, costruzioni ritmiche a qualsiasi livello (prosodico, fonetico, sintattico, lessicale, narrativo…). Il problema è che non se ne può fare a meno, se si vuole che il proprio testo possa essere riconosciuto come poetico, e possa entrare nel dialogo con altri testi poetici. D’altra parte, queste stesse forme portano con sé il rischio di un ritorno all’ingenuo, al pacificato, all’illusione dell’innocenza. La via per farne uso senza cadere nella trappola è stretta, e le scorciatoie non funzionano più.
Personalmente, ho fatto una scelta metrica, come riferimento di fondo; ma mi sono costruito un metro che potesse suonare non familiare a un orecchio italiano, un esadecasillabo che non è un doppio ottonario, ma che porta un accento obbligato sulla settima sillaba, oltre che, ovviamente, sulla quindicesima. Si costruisce in questo modo una regolarità prosodica che può essere recepita come tale, senza portare relazioni dirette con le sonorità dei versi tradizionali italiani. Il verso può essere usato sia come struttura chiusa e ossessivamente ripetuta, sia come struttura aperta con enjambement anche estremi, alla Rosselli, sia alternando i due modelli, a seconda delle necessità espressive, come una struttura musicale.
Su questa base, il discorso cerca di essere rigorosamente sintattico (anche se con possibilità occasionali di non chiusura di periodi, specie se lunghi e complessi), ma distaccato. Il lessico cerca di essere basso, colloquiale, o di innalzarsi verso lessici specialistici se necessario, ma evitando quelli poetichesi, a meno che una qualche formula tradizionalmente poetica non voglia diventare cuore stesso del discorso, e allora il distacco va manifestato straniandola, ripetendola, rendendola cellula di un’ossessione ritmica che la snatura. Questo permette di fare uso anche delle parole vietate e persino delle rime in cuore-fiore-amore-dolore.
L’esercizio sta in un periglioso equilibrio tra l’abbandono emotivo e il controllo intellettuale, tra il gioco stilistico e la partecipazione appassionata e profonda. Un’arte non pacificata, io credo, non è un’arte che evita le forme pacificate, standard, stereotipate, anche esaurite, ma che le usa mostrandole al contempo come tali, e sapendone estrarre quella cellula di vita vera che comunque ancora rimane in loro, come in ciascuno di noi, per quanto pervertito sia dalla vita nell’universo delle comunicazioni di massa di una società capitalistica avanzata.
Insomma, nella dicotomia adorniana tra Schoenberg e Strawinsky, là dove Adorno vedeva in Schoenberg il progressista, colui che si mantiene al di fuori della corruzione dell’industria culturale, e in Strawinsky un peccatore corrotto e contaminato, io vedo piuttosto nel primo un (comunque affascinante) aristocratico innamorato del passato e della tradizione, che cerca a tutti i costi le vie per innovarla conservandone l’essenza (quale Adorno stesso era, in fin dei conti), e nel secondo colui che ha davvero saputo costruire un’arte non pacificata, sporcandosi le mani con tutto quello con cui se le poteva sporcare, ma rimanendo sempre originale e in fin dei conti non compromesso, giocoso e appassionato.



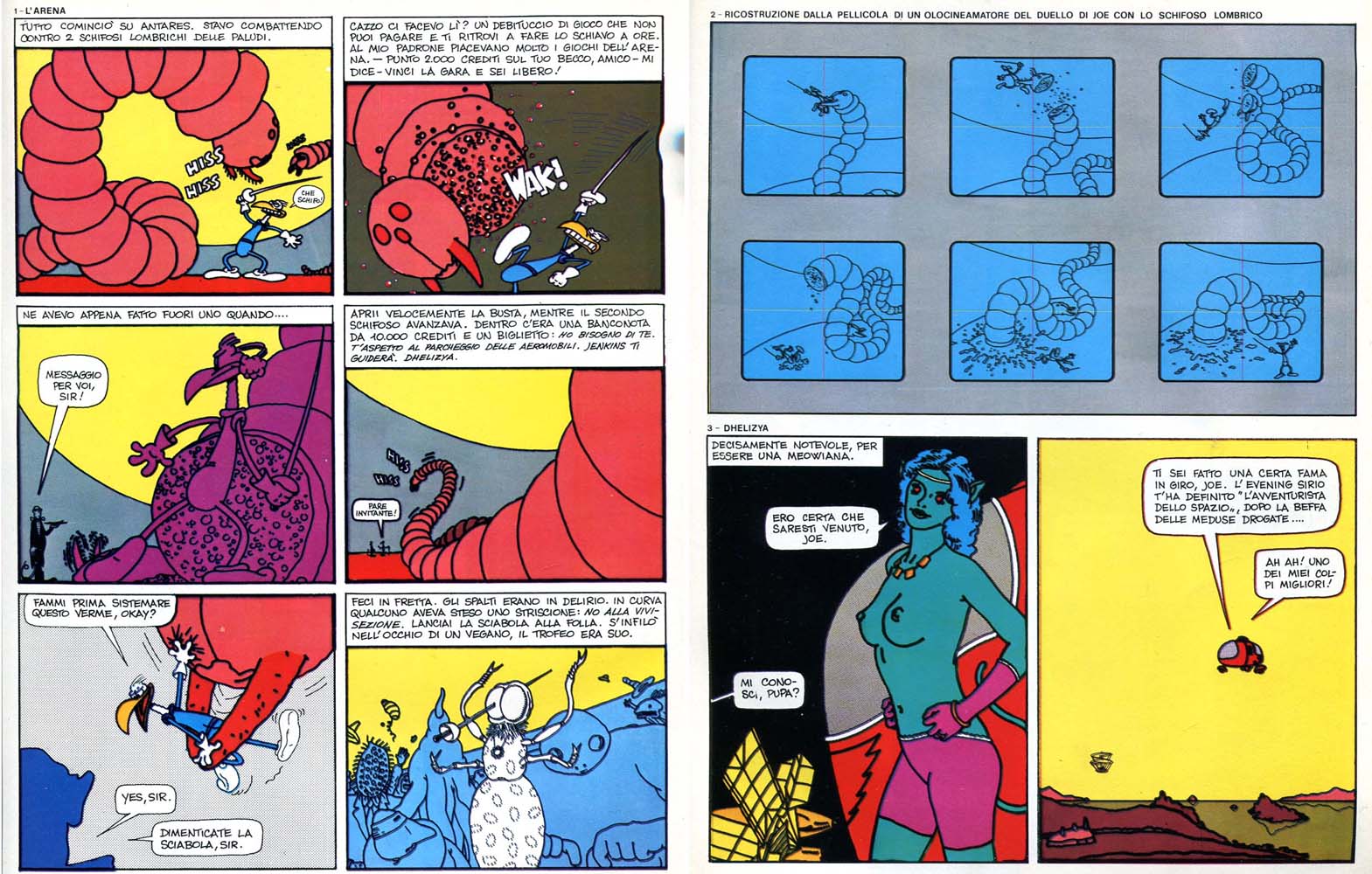
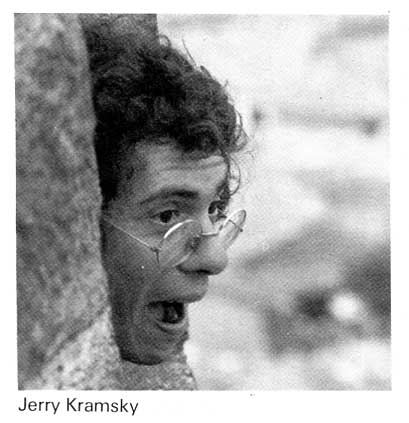


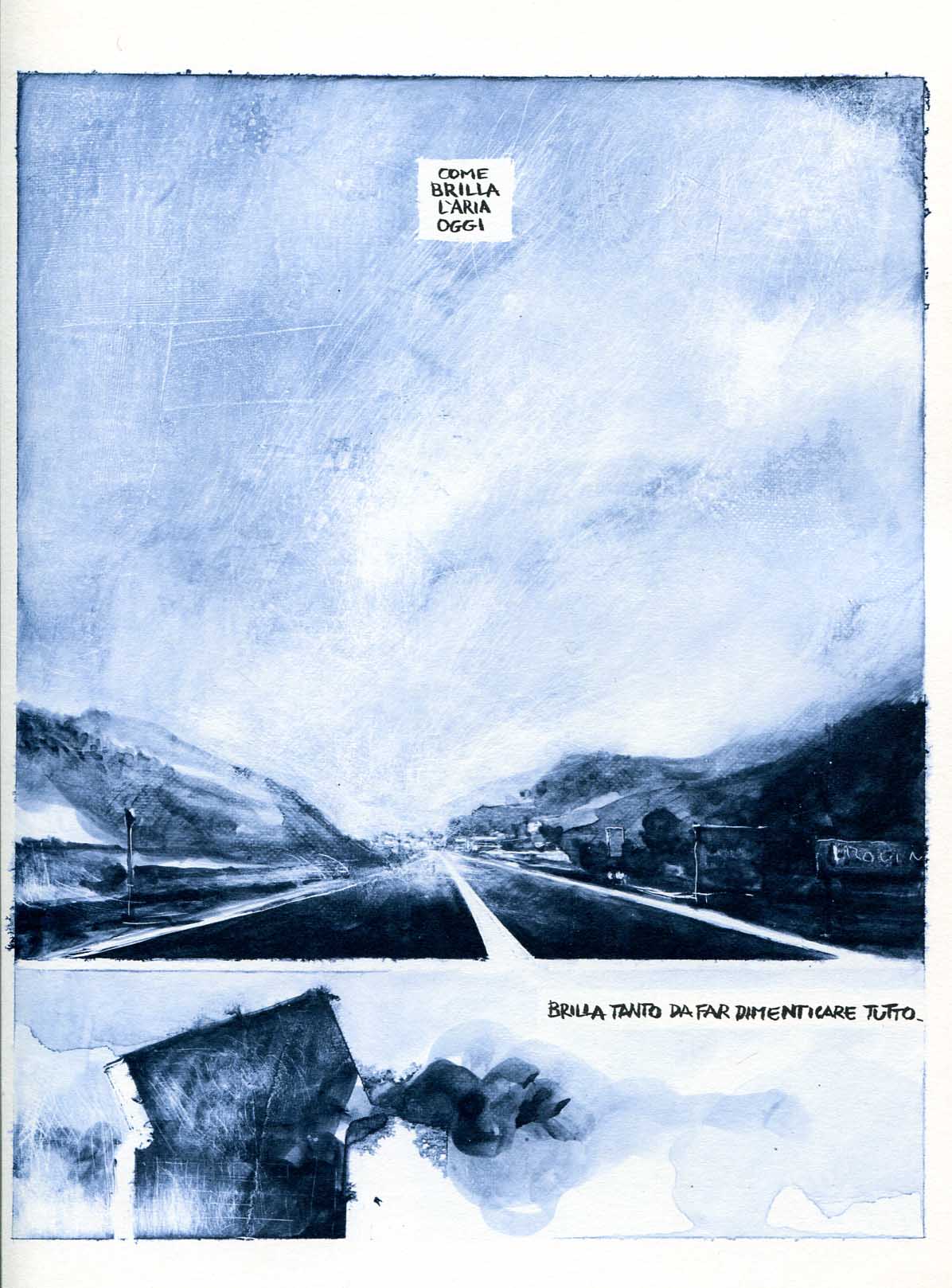
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco
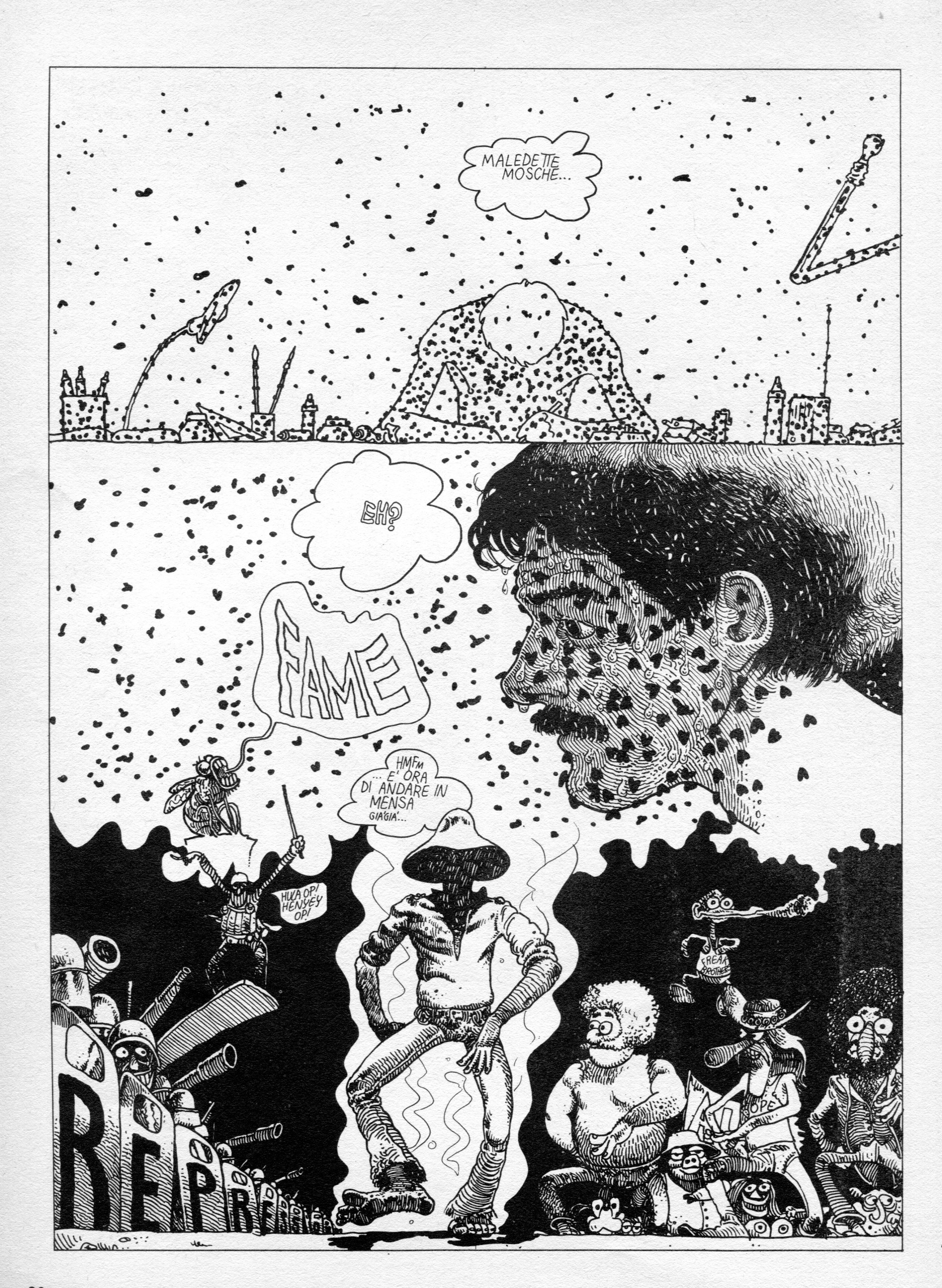



Commenti recenti