Della poesia fatta a macchina, e anche di Sergio Rotino
di Daniele Barbieri
A home transformed by the lightning
the balanced alcoves smother
this insatiable earth of a planet, Earth.
They attacked it with mechanical horns
because they love you, love, in fire and wind.
You say, what is the time waiting for in its spring?
I tell you it is waiting for your branch that flows,
because you are a sweet-smelling diamond architecture
that does not know why it grows.
È attraverso una segnalazione di Enzo Campi su Facebook che arrivo a questo articolo di Salvatore Luiso, “La poesia che (non) si doveva scrivere”. L’articolo inizia citando una (discreta, anche apprezzabile) poesia in lingua inglese (qui sopra), rivelando poi che non è stata scritta da nessuno, bensì composta da un algoritmo, un’Intelligenza Artificiale insomma, intorno al 2010. Ora cito io dal medesimo articolo (più veloce, onesto, e comodo che riassumere – per vedere il contesto vale il link sopra) che sviluppa il discorso a situazioni ancora più recenti:
Venendo a qualcosa più vicino a noi, Galileo.net ha pubblicato un articolo molto interessante sul lavoro di Jack Hopkins, fondatore della Spherical Defence Labs LLC di Londra ed ex ricercatore presso il laboratorio di Informatica di Cambridge. Hopkins sta sviluppando alcuni algoritmi per “insegnare” ad una rete neurale artificiale a comporre poesie paragonabili a quelle dei poeti umani. Il suo sistema è molto più “professionale”: sono stati caricati nel programma ben 7,56 milioni di parole ricavate da libri di poesie del ventesimo secolo. Questa IA, inoltre, avrebbe una speciale memoria sia a breve che a lungo termine, “esercitandola” alle emozioni. Il risultato è che il nuovo sistema riesce a scrivere poesie in diverse forme ritmiche, adoperando soluzioni formali e strutture retoriche, persino la rima.
L’IA di Hopkins è in grado di scrivere poesie su molte tematiche: proponendogli una poesia sull’estate, il sistema troverà tutti i termini che richiamano la stagione più calda e ci comporrà una lirica. Nel 70% dei casi in cui l’IA ha composto una poesia “sensata”, gli esseri umani non sono stati in grado di distinguere fra queste poesie e quelle composte da autori umani, trovando spesso le prime addirittura più belle, dunque emozionanti.
Ci sono alcune precisazioni da fare. Quando si dice “in cui l’IA ha composto una poesia sensata” si implica che c’è stato qualcuno, presumibilmente umano, che l’ha giudicata sensata. Quindi è stata compiuta una scelta sui risultati della produzione automatica. Di questa scelta ignoriamo i criteri, ma potrebbe anche trattarsi di criteri minimali di coerenza semantica – non di qualità estetica. Il problema sollevato da questa storia non cambia però di molto: comunque, un algoritmo ha generato poesie (non tutte, non sempre – ma quale umano lo fa?) che alcuni lettori hanno apprezzato (e tra questi, in qualche misura, anch’io).
Ora, il problema non è – come sembra credere Luiso, o anche Hopkins – se i computer davvero comprendano o sentano emozioni (o possano essere “esercitati” alle emozioni). Il computer non ha fatto che seguire regole che derivano dalla combinazione frequente di parole frequenti. Se invece di sottoporgli un corpus di poesie, gli avessimo sottoposto un corpus di ricette culinarie, il computer avrebbe prodotto ricette culinarie. Non lo avrebbe fatto, presumibilmente, con altrettanto successo: una ricetta culinaria deve certamente parte del suo successo al modo in cui viene scritta, ma se poi la ricetta, al momento di metterla in pratica, non funziona, la correttezza linguistica si rivela insufficiente, e il criterio dominante rimane un altro.
Una poesia non è però una comunicazione pratica con diretto effetto sul mondo, e la sua valutazione dipende unicamente da come è scritta. In più, proprio per questo, il lavoro che su di lei compie chi la sta leggendo è assai più importante che in qualsiasi altro tipo di comunicazione verbale. Potremmo dire che una poesia è un oggetto di proiezione, una specie di macchia di Rorschach su cui ogni lettore proietta ciò che può proiettare (senza che questo, evidentemente, si traduca in un giudizio sulla sua psiche); e la qualità di un componimento poetico è la qualità delle proiezioni che permette o suscita. Questo meccanismo può funzionare così bene da produrre un attaccamento anche molto forte da parte del lettore (e io stesso, come lettore di certe poesie, non faccio certo eccezione).
Ma questo meccanismo permette anche che, attraverso identificazioni potenzialmente molto diverse tra loro, lettori diversi si trovino accordati sul medesimo andamento, sul medesimo ritmo poetico (che è anche, ma non solo, quello prosodico-rimico: ci sono un sacco di altri ritmi in gioco in un testo poetico!). In questo modo, la situazione di fruizione collettiva prende la forma di una situazione rituale: benché lo facciamo in momenti diversi del tempo (e dello spazio) tutti noi lettori stiamo seguendo lo stesso andamento ritmico, stiamo vivendo un’esperienza accordata – come quella del ballo, o dell’ascolto musicale. Se la poesia prodotta dal computer, per ragioni qualsiasi, produce nei suoi lettori questa esperienza, allora è una poesia che in qualche modo funziona, ed è comunque una poesia di valore: anche se siamo ingannati, si tratta di un inganno positivo, fruttuoso; abbiamo davanti comunque un oggetto interessante.
La questione che questa storia pone non riguarda tanto, a mio parere, la supposta umanità del computer e la sua capacità di provare emozioni (semmai solleverebbe il problema di cosa sia l’umanesimo, ma sarebbe troppa carne al fuoco per questo post). Io la vedo diversamente: se la poesia composta a macchina può essere preferibile, più interessante, di poesie composte da umani veri, perché non domandarci come lavorano gli umani veri?
Cosa vuol dire essere un poeta? (Non faccio questa domanda da fuori: sono anch’io, comunque, un poeta.) Vuol dire cercare di rientrare, da autori, in un universo di testi di cui siamo stati in precedenza, e ancora siamo, lettori. Non c’è altro modo: se la poesia non ci ha affascinato come lettori, non potremo mai sentire il desiderio di riprodurre direttamente quella fascinazione – nemmeno se il nostro corpus di letture fosse quello banalmente scolastico. Se così fosse scriveremmo poesie altrettanto limitate, ma staremmo comunque riproducendo il meccanismo.
Per riconoscere come poesia quello che scriviamo (e se non lo riconosciamo noi certo non possiamo pretendere che lo riconoscano altri) quello che scriviamo dovrà…
Segue qui, su Nazione Indiana.






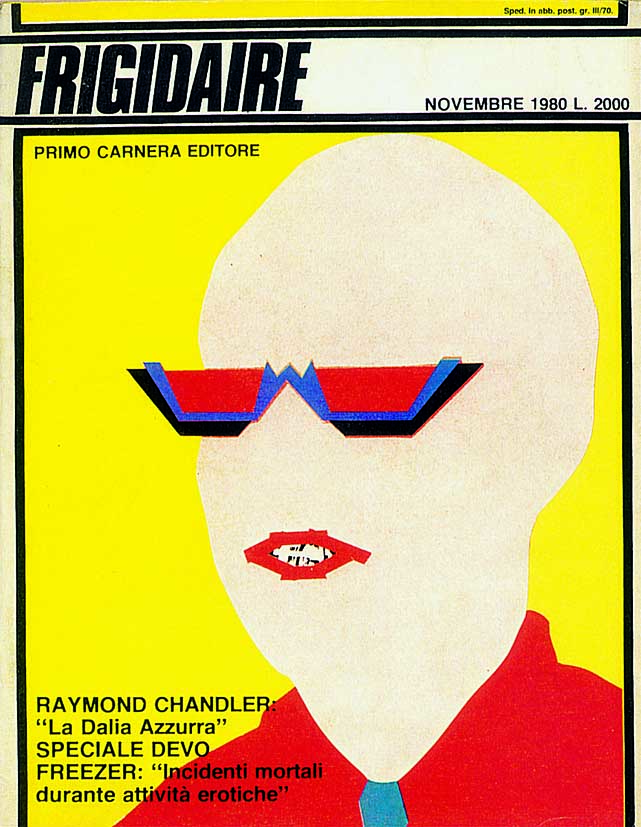

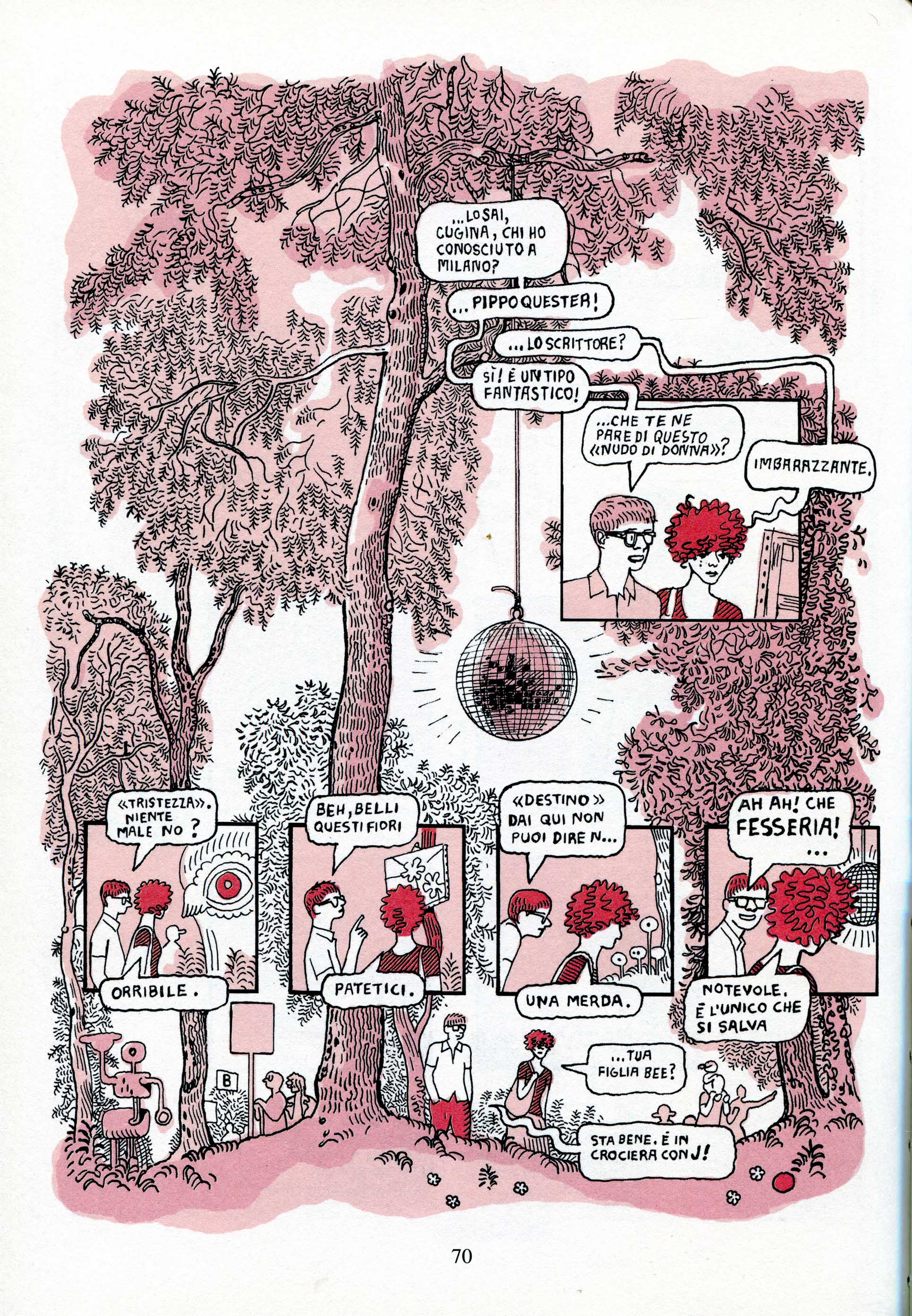



 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






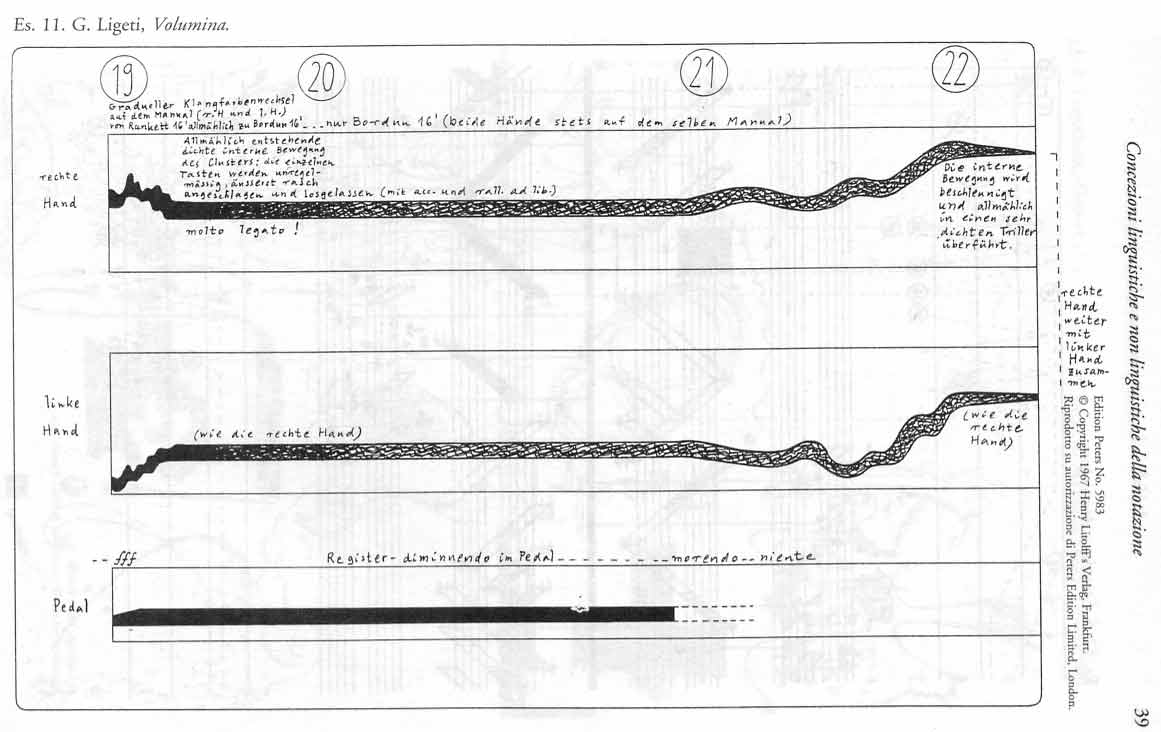

Commenti recenti