 Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva.
Quanto dura di solito un prodotto letterario? Idealmente, secoli, cioè sino a quando la lingua in cui è scritto resta leggibile a qualcuno. Commercialmente, qualche mese, cioè il tempo necessario perché venga sostituito sugli scaffali delle librerie da altri prodotti analoghi più recenti. Se il prodotto letterario è di carattere poetico, la durata ideale è la medesima, mentre quella commerciale media non esiste: il più delle volte, infatti, sugli scaffali delle librerie la raccolta di poesie nemmeno ci arriva.
Poi, certo, ogni autore sogna di sfornare il classico, quell’opera che resta sugli scaffali a lungo, al limite per sempre. E questo ci rivela che esiste (almeno) un terzo criterio di durata, che dipende da quanto (e sino a quando) il testo in oggetto esprime qualcosa di cruciale per un numero rilevante di lettori. Non è un criterio generalista né generalizzabile, ma è nondimeno un criterio influente; forse quello, sulla società letteraria, più influente di tutti: le opere che saranno ricordate sono quelle che soddisfano questo terzo criterio, infatti. E, proprio per questo, in fin dei conti questo terzo criterio si trova alla base di ogni presentazione critica di un testo poetico: deprivata di qualsiasi possibilità di successo commerciale, la poesia vive di approvazioni personali e profonde, sogna di incarnare lo spirito del tempo, e che quello spirito possa essere ritrovato a lungo…
Da questo punto di vista, per quanto poco un testo poetico duri, almeno un decennio o due gli spettano di diritto. Per quanto effimero possa essere il suo senso, non decadrà secondo il criterio delle librerie, bensì, semmai, secondo quello del gusto – il quale ha comunque tempi un po’ più rilassati. Proprio per questo motivo, io rivendico il diritto, in quanto critico, di considerare come novità tutti i testi poetici usciti negli ultimi dieci-quindici anni, e di proporli eventualmente qui – magari alternati, se capita, con dei veri classici o anche con dei sospetti classici (i quali potrebbero essere anche più giovani, benché in odore di durata).
Anche La divisione della gioia, di Italo Testa (Transeuropa 2010), come ogni altro testo poetico, ambisce a entrare tra i cosiddetti classici; ma lo fa, mi sembra, anche in un altro senso, quello, per intenderci, per cui esiste una differenza lessicale tra classicità e classicismo. Nel caso di Testa, parlare di classicismo non vuole scomodare l’antichità classica, e nemmeno altri classicismi più recenti, come quello ermetista. Nondimeno, è inevitabile, leggendo la scrittura calibrata, elegante, appassionata, spesso avvincente, di Testa, che si sentano gli echi di una serie di classici del Novecento, da Montale a Sereni a Fortini, a Eliot e all’ultimo Porta, persino al Pavese di Lavorare stanca. È una poesia, potremmo dire, riflettutamente sentimentale, appassionatamente riflessiva, attenta sia alla costruzione metrica che a evitare gli eccessi intellettualistici dei neo-metricisti. Si parla di una storia d’amore, di sesso, di passione e di difficoltà di rapporto; si racconta molto, e anche bene, sempre a cavallo tra il distacco e la partecipazione. C’è una bella storia, con un bel linguaggio, un bel ritmo poetico…
Ma si ha come l’impressione che questa limpidezza sia troppo intenzionalmente classica; e mentre tutti quesi echi costituiscono indubbiamente un pregio per i versi di Testa, ne sono insieme anche il limite. Questa ricchezza, e il bel racconto che la accompagna, finiscono per appartenere, ai miei occhi, a un’altra epoca, un’epoca classica, che non è la mia; e il mio apprezzamento, che durante la lettura c’è, indubbiamente, e ed è anche frequente, a volte persino forte, finisce per essere arginato dalla sensazione di trovarmi altrove – negli anni, insomma, poeticamente meravigliosi, di Montale, Sereni, Fortini…
Non è un peccato subire degli influssi, certamente. Senza influssi non c’è poesia, né nessun’altra creazione artistica. Non è un peccato nemmeno lasciarli vedere. Ma quando la sensazione mi arriva così forte, come lettore io perdo il contatto diretto col testo, o col discorso che gli sta dietro; e vivo la sensazione di non essere io, oggi, il destinatario di quelle parole, bensì un lettore mitico di qualche anno fa. D’altra parte, proprio come ogni autore segue dei miti, allo stesso modo anche ogni lettore lo fa. Io non posso certo escludere che La divisione della gioia possa entrare nel novero dei classici, nel giro di qualche anno (non mancano di sicuro, a quest’opera, le qualità tecniche per meritarlo), ma questo non potrà accadere per mano di lettori che non si possano del tutto riconoscere come i suoi.
Da: La divisione della gioia (sezione II)
I. UN LUOGO QUALUNQUE
o sulle poltrone in prima fila,
davanti a un sipario grigio
segui in allerta la scena vuota,
come una macchia nera in un quadro
lo spazio deserto ti incornicia:è stato sulle scale, il gradino
lucidato dai passi anonimi,
l’ombra obliqua che taglia lo stipite:oppure è quando senza preavviso
il chiavistello con uno scatto
scuote l’uomo che dietro la porta
a torso nudo liscia il lenzuolo,quando la sedia accostata al muro
ha mosso un’ombra dentro la stanza
e i panni inerti sul ripiano
hanno mandato un lampo nel buio:o è stato mentre risalivi
fino al nostro primo appartamento,
la mano appoggiata al corrimano,appena il vento ha mosso le tende
contro le assi del pavimento
e hai visto le crepe nella brocca,
ti sei voltata contro il bianco
squarcio del lino sulla parete:o è stata la mia sete a disfarti,
lo sguardo osceno che getto al mondo
sulle braccia sode di una donna
in vestaglia, di primo mattino,
con la brama del volto coperto,
del taglio aperto lungo le natiche,e ogni volta che le spalle forti,
ossute, come un quadrante bianco
tornavano a imprigionarmi
nel tempo del corpo sconosciuto,
in un interno spoglio e taciuto:o è stato in una casa a due piani
sopra la croce di Sant’Andrea,
mentre anch’io nella marea
del desiderio cadevo vinto,
ansimando per la prima volta
preso tra i rami del suo ailanto,o quando da dentro chiudevamo
le tende, a telefono spento
per sentire sul binario il treno,
senza più un gesto o un pensiero vero,
se da allora il passaggio è precluso
e non posso tornare a ciò che ero:ma forse anch’io un giorno ho pensato
presto le macchine partiranno,
la casa sarà per noi sbarrata
e io sotto un lampione astioso
sfoglierò altre pagine, altri libri,o camminerò lungo un parco
e nemmeno la notte potrà
nascondermi, se guarderai sotto
le tue finestre sulla panchina,o se appoggiata a uno schienale,
nuda, alle undici di mattina
ti toccherai furtiva, e senza
più ben sapere chi siamo stati,
quando la lampada ci cadeva
a lato, e il letto si spostava
dal muro, e l’acqua non bastava:così, se tutte le cose restano
su se stesse, come le colonne
contente di sopportare il peso,
di opporsi alla gravità che incombe
dalle architravi, dai porticati,o i ciottoli sparsi sulle piazze,
i coppi scuri, incatramati
tra i lucernai aperti ai venti,
i fori da cui la luce piove,e poi le griglie sui marciapiedi
impassibili a prender nota
della curvatura delle gambe,
del lino che corre tra le cosce,come tutta stia nel suo contegno,
e accolga indifferente la luce
nella presa rapace dell’ombra
che cade sulle facciate calme,
sull’intonaco che irride i nostri
sforzi di camminare eretti,
restare fermi a un davanzale,o i tentativi di imitare
la fissità del cielo, di statue
mute che si tengono i gomiti
nell’aria domenicale, oppure
sotto due fila di luci in fuga
posano gli occhi su una tazza
con i polsi, le labbra serrate,
le dita richiuse con fermezza:anche così si annega l’ansia
nello specchio marmoreo di un tavolo,
anche quando la vita si piega
tra le imposte, sull’impiantito
verde, o dietro la ghigliottina
che separa il tempo dalla stanza:nemmeno così sarà redento
questo agitarsi, questo andare
esposti a ogni buffo di vento,o nella luce artificiale
di un neon credere che la notte
non sia notte, il verde non scintilli
immune da ogni nostro sguardo,
le merci esposte nel silenzio
di una vetrina siano lo sfondo
del nostro tranquillo sovrastare,
del dominio saldo della specie:e quando nelle insegne luminose
che ritmano i grani dell’asfalto
hai visto il segno certo, il richiamo
ribattuto da ogni nostro passo,o in una vetrina, controluce
hai scorto sul ripiano le pose,
le ossa spigolose del suo corpo
segnarti senza più un riparo,come il giorno che stesa sul letto
ti sei girata, tranquilla, e hai visto
le grate che spartivano il vetro,
e alzandoti di scatto hai detto
che non sarebbe successo niente,
che tutto era ancora intatto
e mentre ti guardavo in silenzio
sei sparita nell’angolo cieco:allora ho visto che nulla torna,
che la fragilità ci insidia
dall’interno, dentro le giunture,
s’insinua nelle vene, riveste
la piega opaca dei discorsi,allora, chiamandoti in disparte
a fianco del letto avrei atteso,
la pelle a toccare il marmo freddo,
che tutto fosse tornato a posto,
il braccio nascosto tra le gambe,
la luce sulle mie cosce nude,
la mano a coprirti il pube:








 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco




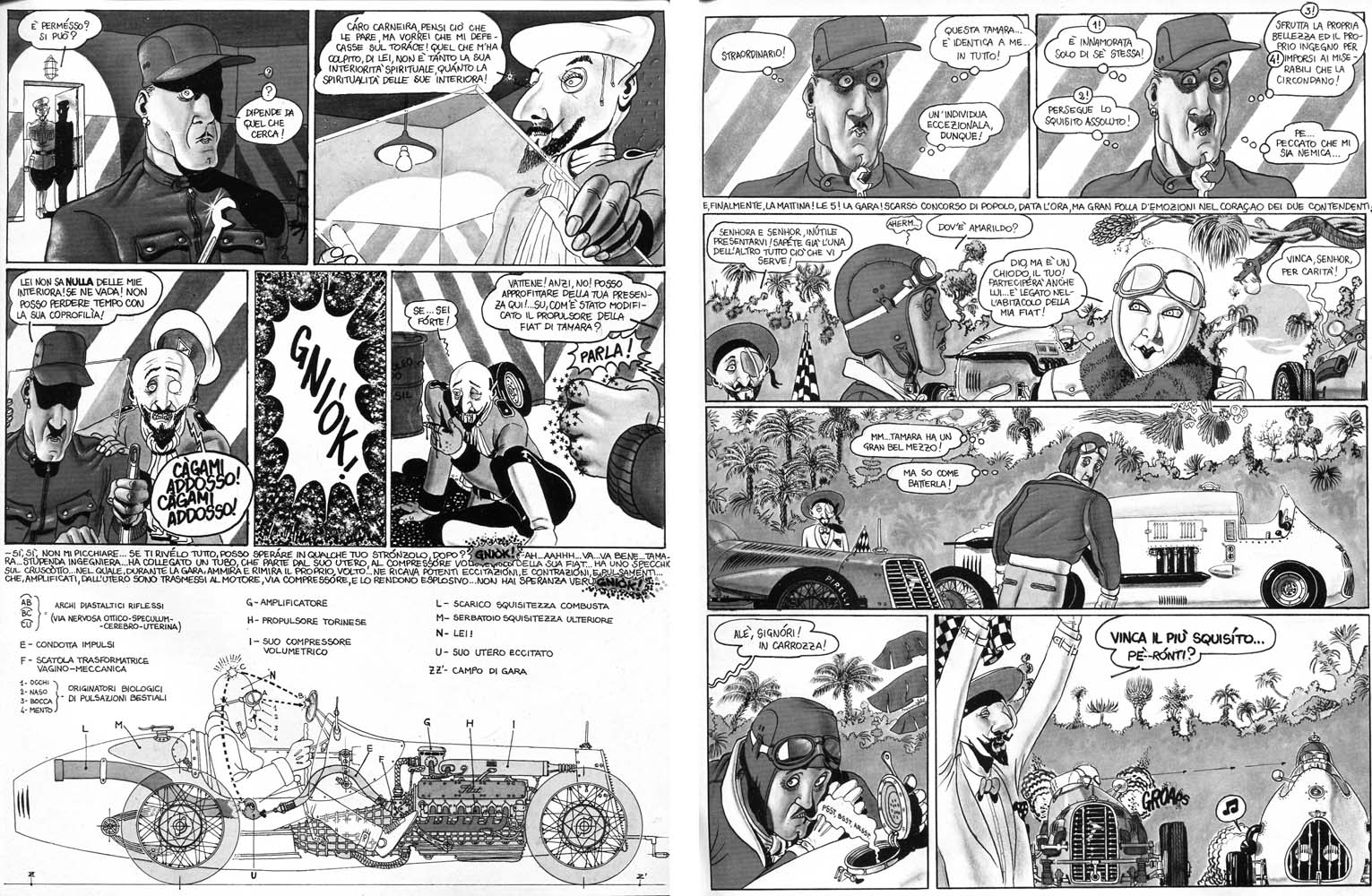



Commenti recenti