Narratori senza parole
Il Sole 24 Ore, 26 settembre 1999
Raccontare senza parole. E’ la sfida del mimo, e fu quella del cinema muto. E’ stata, in qualche epoca, la sfida della pittura: ma in pittura ci si limitava a mettere in figura una storia già nota, evocata nella sua interezza dalla messa in scena di una sua situazione cruciale – nell’ambiguità, talvolta, che si trattasse della storia di Giuditta e Oloferne, o di quella di Salomè e Giovanni Battista…
Il racconto è così legato alla parola, che ci sono lingue in cui “dire” e “raccontare” vengono espressi dalla stessa parola, come l’inglese “to tell”. E pure in italiano un racconto è certamente, in assenza di ulteriori specificazioni, un racconto a parole.
Nella nostra tradizione, almeno fino a un secolo fa, è solo con il teatro che è possibile raccontare in una forma che non sia semplicemente verbale. Il teatro da sempre, potremmo dire, mette in scena un racconto: lo fa avvenire davanti ai nostri occhi, seleziona frammenti di realtà, li artefà e li rimonta in modo che lo spettatore veda chiaramente la sequenza degli eventi che costituisce il racconto, anche senza l’accompagnamento della voce del narratore.
La parola ha un ruolo importante nel teatro, ma rispetto al racconto puramente verbale il salto è enorme; perché il ruolo della parola nel teatro si riduce dall’essere fondamentale al semplice essere utile. E la mimica, la scenografia, il movimento reale, assumono valenza narrativa, rendendo possibile alla fine, quando l’evoluzione tecnologica ne fornirà gli strumenti materiali, l’ipotesi di un arte che racconti integralmente senza fare alcun uso della parola.
Visto all’indietro, con gli occhi di oggi, il cinema muto appare singolarmente e talora grottescamente espressivo. L’immagine deve rendere chiaro quello che nella vita normale (e nelle abitudine dei lettori di sempre e dei cinespettatori di oggi) viene solitamente reso con qualche parola: sensazioni, sentimenti, emozioni…
Ma se il cinema è nato muto, per ragioni squisitamente tecniche, il fumetto è nato con le parole. Convenzionalmente, si usa considerare data di nascita del fumetto quella della comparsa della prima tavola di Yellow Kid in cui compare un balloon, un fumetto appunto, corredato del suo contenuto di parole. Non si considerano fumetti, convenzionalmente, le storie illustrate esistenti in precedenza, né quelle per bambini dell’Ottocento, né quelle edificanti e popolari diffusissime nell’Europa dal sedicesimo al diciottesimo secolo. C’è di buono, in questa data convenzionale, che essa individua grosso modo anche la data di inizio di un’industria culturale, che rende il fenomeno “comics” assai diverso da quanto di anche simile esistesse prima. E questi precedenti, non frequentissimi e talvolta davvero senza parole, sono dimenticati molto più del cinema muto.
Per questo, realizzare oggi dei fumetti senza parole appare come un’operazione inusuale e difficile, con pochi precedenti. Ricordiamo le strisce storiche di Ferd’nand del danese Mik, e di Little King (Piccolo Re) di Otto Soglow; ma si trattava di strisce umoristiche, che presentavano e risolvevano una situazione nelle quattro vignette di un’apparizione quotidiana. Non c’era davvero racconto, non c’era azione.
Più prossimo a noi è il fumetto giapponese Gon, di Masashi Tanaka, storie di un piccolo e fortissimo dinosauro alle prese con un mondo che ignora (e poi subisce) la sua forza. E più prossima ancora è una collana inaugurata qualche mese fa dalla casa editrice Phoenix di Bologna, dal significativo titolo No words.
Sono tre i volumi usciti sino ad oggi, di cui almeno due di deciso rilievo. Si tratta di Pastil, di Francesca Ghermandi, e di ¡Infierno!, di Tito Faraci e Silvia Ziche. Due storie molto diverse, accomunate dal tema surreale.
In Pastil, una bambina dalla testa piatta come una pastiglia continua a svegliarsi in tante variazioni del medesimo incubo, vola all’interno di una cassetta del pronto soccorso, ora fuggendo ora arrivando in situazioni da cui è necessario risvegliarsi. ¡Infierno! racconta invece del destino post-mortem di un boss mafioso, che, ovunque vada, riesce in breve tempo a rivolgere la situazione a suo vantaggio. Una parodia che si risolve in un continuo incubo la prima, un incubo che si risolve in parodia la seconda.
In entrambe le storie, a ben guardare, ritroviamo gli aspetti che abbiamo visto caratterizzare il cinema muto: poiché non si possono utilizzare le parole, i sentimenti vanno resi evidenti, vanno sottolineati con l’eccesso dell’espressione. Ma il fumetto, con tutta la sua storia di parodia e caricatura, convive tranquillamente con questa esasperazione, e le storie di No words non fanno eccezione. Quello che crea differenza, e stranezza, nel cinema, è del tutto naturale in un medium differente, e con una storia differente alle spalle, come il fumetto.
Ma qualcosa di diverso c’è comunque, rispetto a un normale fumetto che faccia uso di dialoghi e didascalie. La parola – è facile osservarlo, in generale – influisce profondamente sui ritmi del fumetto: rallenta la lettura, dando più tempo alle singole vignette, e quando compare in didascalia accelera il racconto, esprimendo con poche parole quello che potrebbe richiedere anche parecchie vignette. La sua assenza è dunque cruciale nelle storie di No words. Nella diversità che comunque manifestano tra loro, la diversità ritmica rispetto a qualsiasi altra storia a fumetti è comune e evidente. Molti lettori, solitamente appoggiati alle parole (dialoghi e didascalie) si troveranno qui costretti – magari davvero per la prima volta – a guardare le figure, a compiere un’opera di decodificazione grafica a scopo narrativo.
Una volta tanto, per quanto strano possa apparire dirlo, le immagini del fumetto non sono trasparenti. L’assenza della parola costringe il lettore ad attraversarle senza la consueta stampella. E il discorso narrativo vi si costruisce forse con qualche leggera difficoltà, ma con un grande godimento visivo e con un notevole effetto didattico. Cosa che, in una società popolata da analfabeti dell’immagine e in cui la comunicazione passa in larga misura attraverso figure, basterebbe da sola a dar valore a questi testi.
Ma si tratta, per quanto singolari, anche di storie, con tutta la fascinazione del racconto, dello sviluppo narrativo. Restituito in qualche modo con la forza delle cose che si vedono per la prima volta, come la teoria – di nuovo di origine teatrale – dello straniamento ci ha da tempo insegnato.
Francesca Ghermandi
Pastil
Tito Faraci, Silvia Ziche
¡Infierno!
Phoenix, Bologna
pp. 48, £. 7.900
Per un sorriso di paura
Il Sole 24 Ore, 26 giugno 1994
C’era una volta il fumetto per bambini, un mondo magico del quale il sanguinario e l’orribile, il temerario e il sadico, lungi dall’essere banditi, rappresentavano il condimento principale. Per chi da adulto non ha rinunciato al desiderio di sorridere della paura, Francesca Ghermandi propone delle storie per immagini di altissima qualità e di raffinata invenzione grafica. Storie per adulti, dotate della stessa giocosa perfidia di quelle per bambini. Negli ultimi mesi sono due le pubblicazioni che si devono alla sua mano e alla sua inventiva: Joe Indiana. Il segno dei cinque, pubblicato dalle edizioni Comic Art di Roma, e Hiawata Pete, della Granata Press di Bologna.
Joe Indiana è una detective story dai toni burlescamente grandguignoleschi, di cui è protagonista un topo (assistito da un porcello), in una vicenda di mani mozzate e società segrete, che si intreccia tra piscine comunali, laboratori di chirurghi criminali, scenografie abbandonate del film di Peter Pan, abitazioni di mucche impazzite, spettacoli di magia… La città è diventata un intrico di viuzze e scale piastrellate, dove i giardini sono fatti di palme di plastica in cima ai palazzi, e gli spazi più ampi stanno dentro le case invece che fuori. La Ghermandi ha un talento particolare per la resa degli spazi, che continuano ad apparire instabili e grotteschi come in un film espressionista.
Hiawata Pete è una raccolta di strisce umoristiche ambientate in un futuro che ha molte caratteristiche del presente, in cui le figure della pubblicità escono dai televisori per inseguire gli spettatori, e c’è chi pretende di inventare automobili ecologiche che funzionano ad acqua di mare. Ma la mortadella vi è considerata una droga pericolosa, e farne spaccio è un reato grave, attorno al quale si intrecciano interessi criminali, che non esitano a farsi paravento con la predicazione visionaria di un ispirato che predica la grassezza. Un fumetto demenziale, lo si sarebbe definito qualche anno fa, godibilissimo per assurdità e cattiveria, pieno di miti rivisitati e luoghi comuni buttati per aria, disegnato come si vorrebbe ce ne fossero di più.
Lo stile grafico di Francesca Ghermandi costituisce un vero caso interessante. Ci troviamo tantissimi tra gli stilemi e le convenzioni del fumetto comico di animali (quello alla Disney, tanto per intenderci), ma è evidente, d’altro canto, l’estrema particolarità e personalità del suo modo di usare le modulazioni della linea nera e le sue curve, per ottenere alterazioni della forma a scopo espressivo. Mani e piedi sempre troppo grandi, colli troppo lunghi o inesistenti, una profusione di espressioni del viso degne del migliore cartone animato americano. L’amore per le inquadrature diagonali, dall’alto e dal basso, per i primissimi piani espressivi (del tutto inconsueti nel genere comico di animali), per l’abbondanza di dettagli (contraria alla regola della massima concisione per ottenere il massimo dell’effetto umoristico) rendono lo stile della Ghermandi un vero evento nuovo, un unicum nell’intero panorama del fumetto, italiano o estero che sia.
 Francesca Ghermandi, Cronache dalla palude, pag. 16 Cronache dalla palude è un non-horror che fa il verso al fumetto autobiografico, mescolando la realtà e i deliri autobiografici di Silvia, una fumettista brutta e complessata, che vive una vita grottesca in un mondo assai più grottesco di lei. Naturalmente, tutta l’autobiografia è immaginata, e non ci sono relazioni tra la protagonista e l’autrice – se non quelle, forse, inevitabili in qualsiasi storia, e che permettevano a Flaubert di dire: “Madame Bovary c’est moi”.
Dunque, se il fumetto d’autore oggi è pervaso dall’autobiografia, vera o finzionale che sia, la Ghermandi ce ne mette in scena questa parodia assurda, un vero delirio di personaggi, di cui spesso non si capisce quanto siano reali e quanto inventati da Silvia. Non che importi molto, in realtà. Se c’è un filo narrativo, in questa graphic novel, non è certo quello a spingere avanti il lettore. Da questo punto di vista, la Ghermandi sembra aver studiato e rielaborato a proprio modo l’idea di Daniel Clowes di un romanzo (a fumetti) fatto di strisce, o tavole, semi-autonome, come in Ice Haven, o nel recente Wilson. Qui è tutto meno regolare e strutturato che nei lavori di Clowes, e si passa spesso senza soluzione di continuità dalle storie nella storia alla storia principale (o a quello che sembra esserlo).
Insomma, un delirio, o meglio, la parodia di un delirio. Da quando ha iniziato a disegnare, la caratteristica davvero inimitabile della Ghermandi è stata quella della deformazione verso il grottesco di forme grafiche già semplificate verso l’infantile, associate al contempo a una ancora più grottesca accumulazione di figure nello spazio, come in un incubo persistente ispirato ai cartoni animati. Ora, la deformazione è arrivata a coinvolgere anche il racconto. Si ha sempre il sospetto, infatti, leggendo Cronache dalla palude, di essere sul punto di trovare il bandolo della matassa, il filo narrativo che ci condurrà fuori dal guado – e invece in questa palude narrativa si resta sino alla fine, e anche dopo la fine.
Potremmo dire che il mondo in cui Silvia vive, vero o immaginato che sia, è un mondo terribile, brutto, stupido, atroce. Se la Ghermandi sta dipingendo, attraverso questo, il nostro mondo, l’immagine che implicitamente ne dà è in egual misura terribile, brutta, stupida, atroce. Ma poiché il suo testo è anche la parodia di un fumetto autobiografico, forse questo mondo così (ridicolmente) cupo si trova solo (o principalmente) nella testa degli artisti (fumettisti, pittori, scrittori o altri che siano), destinati a vederlo così. Naturalmente anche la Ghermandi stessa appartiene, e sa di appartenere, a questa medesima categoria.
Ride di se stessa, dunque? Be’, sì, anche, di sicuro. Ma altrettanto certamente non soltanto. Comunque sia, nel leggere queste sue pagine ci sentiamo tutti turbati, oppressi, senza scampo, e insieme ferocemente ridanciani. Erano versi di De André quelli che dicevano: “Ci sarà allegria / anche in agonia / col vino forte / resterà sul viso / l’ombra di un sorriso / tra le braccia della morte”.
Cronache dalla palude è il vino forte prodotto da Francesca Ghermandi.
 Francesca Ghermandi, Cronache dalla palude, pag. 164
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|



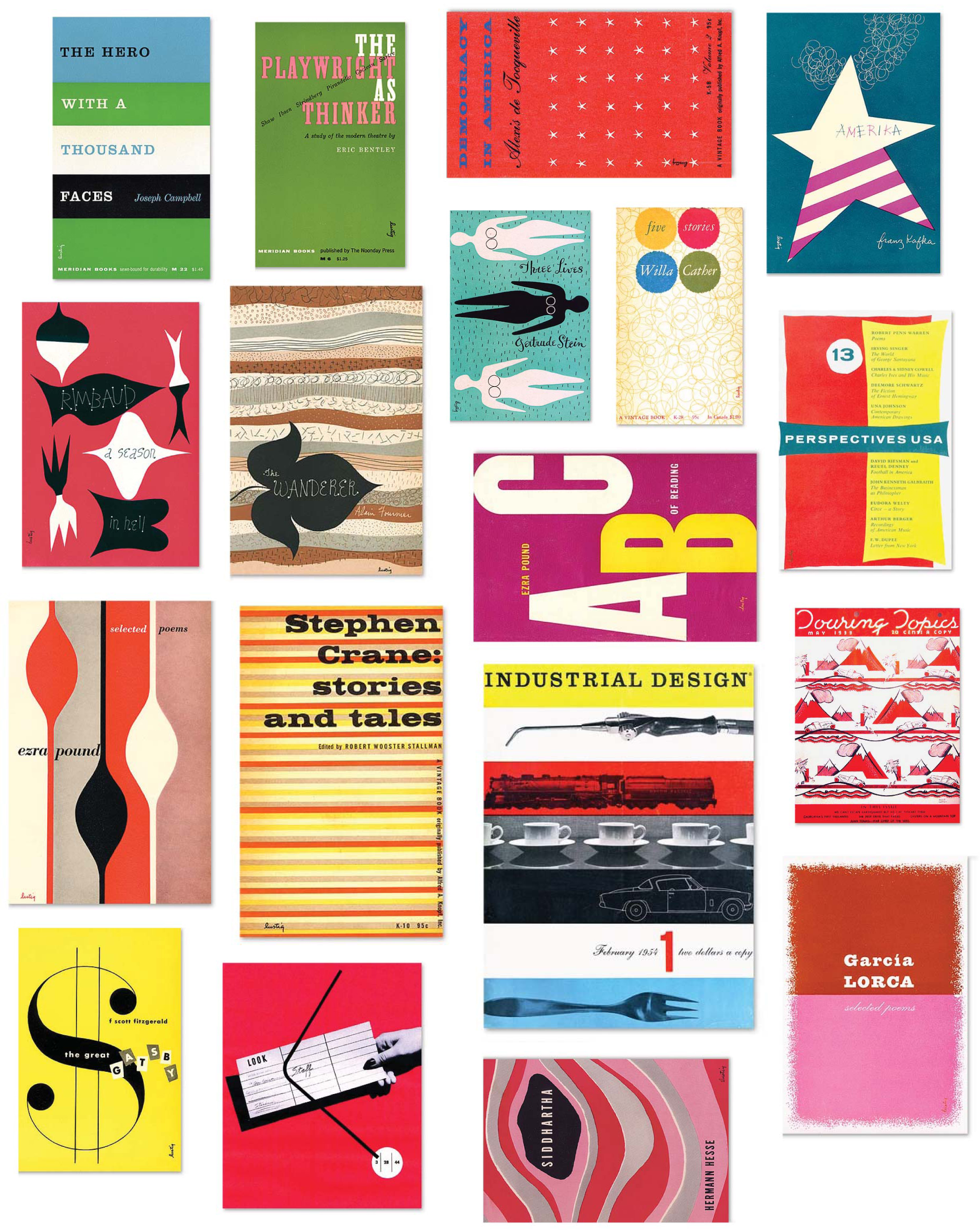







 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email





















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco





Commenti recenti