Restiamo ancora su Pollock, e – come si è detto l’altra settimana – sulla sua riformulazione della comunicazione della pittura attraverso il maggior peso attribuito al gesto piuttosto che al suo prodotto, o meglio, spingendo a interpretare il segno grafico più come indice (indizio) del gesto che come segno visivo (plastico e/o figurativo). Il lettore modello del dipinto di Pollock sarebbe dunque colui che legge l’intreccio delle linee come rinvio alla danza creativa dell’autore, un po’ come un a solo improvvisato, estremamente libero in linea di principio, ma, via via che l’operazione creativa procede, progressivamente sempre più vincolato dalle proprie scelte precedenti, in armonia e in contrappunto con i percorsi già registrati.
Nata in epoca di psicoanalisi come scienza nuova, come nuova spiegazione del mondo, la pittura di Pollock, se vista in questo modo, può essere certamente interpretata come una sorta di scrittura dell’inconscio e dei suoi ritmi, una sorta cioè di scrittura automatica, alla Breton. Quando si parla di scrittura dell’inconscio o scrittura automatica, non bisogna tuttavia pensare a una sorta di sfogo di forze brute, di pulsioni primordiali che escono e magicamente prendono forma visiva (o verbale). Indubbiamente il principio surrealista dell’automatismo può essere inteso anche così, cioè come una versione più moderna e più estrema dell’idea romantica dell’arte come espressione dell’io, una versione in cui all’io si è sostituito quello che gli sta sotto, in una ricerca di autenticità ed espressività ultima – nell’ipotesi, di matrice rivoluzionaria, che quello che gli sta sotto sia comunque eversivo, antiborghese, antinormale, unheimlich.
Eppure questa ipotesi, per quanto fascinosa essa sia, si trova falsificata dai fatti. L’automatismo surrealista ha dato vita certamente a molti testi interessanti, che rimangono tali anche a distanza di anni; ma ha prodotto pure una quantità di testi noiosi, banali e per niente rivoluzionari, segno o che il processo automatista non è sufficiente in sé a tirar fuori l’essenza sovversiva dell’inconscio, oppure che l’inconscio è in sé assai meno sovversivo di quanto si possa pensare.
La mia sensazione è che il principio surrealista dimentichi almeno una metà dei fattori in gioco, e che sia davvero in questo senso una propaggine (certamente un po’ deviante) dell’idea romantica dell’arte come espressione – non dell’io ma di quello che gli sta dietro: sempre di espressione, però, si tratta. Quello che Romantici e Surrealisti sembrano dimenticare è che un prodotto artistico è inevitabilmente un prodotto comunicativo, e che quindi mette in gioco (almeno) due parti; e la parte che riceve (cioè il fruitore) non è meno importante della parte che produce.
Un’opera che si vuole artistica che non riesca a trovare il proprio fruitore è infatti un’opera fallita (chiamatela – come si usa – brutta, noiosa, priva di interesse). Poco importa che essa intenda esprimere un inconscio sovversivo: alla fine dei conti non c’è niente di meno sovversivo del non sapere uscire da se stessi, del non sapere risvegliare l’interesse di qualcun altro.
Se non si arriva a produrre un qualche tipo di accordo, di consonanza, tra l’opera e il suo fruitore, un accordo o consonanza che renda possibile da parte di quest’ultimo un interesse e un conseguente lavoro di interpretazione, l’opera rimane muta e inutile (brutta, noiosa, priva di interesse…). E allora il punto non è se l’automatismo in sé come metodo funzioni, bensì semmai, visto che a volte funziona, perché succeda questo, e che cosa distingua un automatismo dall’altro, l’automatismo che produce opere interessanti da quello che produce banalità.
La risposta facile a questa domanda è che l’autore dell’opera apprezzabile, in qualche modo, abbia barato. In altre parole che abbia coscientemente e volontariamente utilizzato strutture comunicative tradizionali in modo da rendere più facilmente trasmissibile il suo discorso. In questa prospettiva il fruitore troverebbe l’accordo con il testo attraverso la familiarità di tali strutture, e sarebbe questo a permettere all’opera di esistere davvero, di vivere la sua vita comunicativa, permettendo a qualche fruitore di entrare in consonanza con lei, e di apprezzarla.
È probabile che molte opere surrealiste siano davvero costruite in questo modo, mediando l’automatismo attraverso un progetto che, in quanto tale, non ha nulla di automatico; e non ci sarebbe niente di male in questo. Si tratta certamente di un tradimento del principio surrealista, ma a noi fruitori interessa il risultato, e non la coerenza con un principio (discutibile) di poetica. L’arte si è sempre basata su strutture comunicative condivise, e non potrebbe essere altrimenti: che l’automatismo surrealista non sia che una rivoluzione parziale, molto meno influente di quanto pretenderebbe di essere, non è cosa che debba stupire, anche al di là delle dichiarazioni programmatiche delle avanguardie, le quali tipicamente esagerano – enfatizzando il fulcro dell’area di rottura con la tradizione – per ragioni di propaganda e autoaffermazione.
Eppure i dipinti di cui parliamo non sembrano situarsi nell’ambito di questa risposta facile. O ipotizziamo infatti in Jackson Pollock la presenza di una razionalità progettuale a monte, di una lucidità straordinaria, capace di guidare consapevolmente l’espressione del suo inconscio attraverso le strette di qualche principio compositivo assestato e riconosciuto, oppure la soluzione del controllo volontario per lui non regge. E non regge proprio perché parte del fascino dei dipinti di Pollock sta nella sensazione che il progetto a monte non ci sia affatto, e che la costruzione dell’accordo con il fruitore (con me che guardo) non si basi su quello. Se si fosse basato su quello, inoltre, cioè se il lavoro di Pollock fosse stato quello di un montaggio consapevole e progettuale di pulsioni inconsapevoli, non si spiegherebbe la sua sopravvenuta incapacità di produrre – per cui da un certo momento in poi l’autore smette di dipingere, portando a motivazione di questo il fatto che non troverebbe più il ritmo, non sentirebbe più la musica interiore che prima lo faceva danzare.
C’è allora un’altra soluzione al nostro problema, forse meno gratificante per Breton e compagnia, ma – mi pare – più ampiamente esplicativa. L’inconscio, io credo, non è affatto un blob destrutturato e potenzialmente sovversivo. Se lo intendiamo nel senso più della prima che della seconda topica freudiana (cioè come un magazzino profondo di esperienze, sia fattive (operative) che narrative, sia naturali che culturali, e non soltanto come il rifugio profondo del rimosso) l’inconscio conterrà anche le strutture, le forme, i ritmi, della natura come delle produzioni culturali e artistiche, e un automatismo autentico porterà alla luce inevitabilmente pure quelli.
Per questo poi molti testi automatici sono, alla fin fine, semplicemente banali: nell’ipotesi che l’automatismo porti a galla alla cieca dei brandelli di quello che si trova sotto, non è affatto detto che questi brandelli debbano essere sovversivi. Se l’inconscio è un magazzino generale dove si pesca a caso, se ne può portare a galla tanto la pulsione di morte quanto i ritmi di Carosello; ovvero tanto il diverso quanto l’uguale a quello che gli sta sopra. L’idea dell’arte intesa fondamentalmente come espressione di questo pre-io è sbagliata tanto quanto l’idea dell’arte come espressione dell’io: la banalità rimane in agguato nell’uno non meno che nell’altro caso.
Magari un filtro cosciente anche nel lavoro di Pollock c’è, come è auspicabile che ci sia: un’attenzione, cioè, a limitare l’emersione o l’espressione delle istanze più banali, troppo facili, troppo ovvie; quelle che renderebbero l’opera ininteressante, noiosa. A Pollock, come ai testi surrealisti riusciti, va riconosciuta questa capacità consapevole; la quale non è, però, in sé ancora un progetto, e non basta, da sé, ad assicurare la qualità del risultato. Sono tanti al mondo i filtratori attenti e responsabili della propria produzione che hanno finito per non rilasciare nulla nel corso della loro vita, perché tutto quello che usciva da loro appariva a loro stessi banale!
Io credo piuttosto che il genio automatista di Pollock stia nel fatto di avere interiorizzato profondamente, di avere reso inconsce, anche le regole, le buone forme, permettendo loro di uscire allo scoperto già amalgamate con il resto. Il contributo formale, cioè – filtraggio delle banalità a parte – non è qualcosa che venga esercitato razionalmente e coscientemente: è insito, piuttosto, nell’espressione stessa.
Quando uno strumentista musicale improvvisa, non si trova da solo: ha il feedback di un pubblico, e un immenso sistema di regole interiorizzate che lo guidano. Il solista di scarsa qualità non è meno in contatto con il proprio inconscio di quanto non lo sia – poniamo – John Coltrane: è il suo inconscio che è meno ricco, meno strutturato, più povero; o almeno è meno ricca la parte che riesce a esprimersi.
L’automatismo della produzione di Pollock richiede una ricchezza interiore straordinaria, e una straordinaria familiarità con le strutture culturali del visivo, comprese quelle tradizionali. Quello che emoziona, nel guardare un suo dipinto, è la continua comparazione tra il risultato formale, di grande equilibrio, e la danza convulsa, protratta, dionisiaca, che l’ha prodotto, e che si trova registrata nei percorsi del colore. Pollock ci conquista perché produce in noi l’idea che la mediazione razionale, costruttiva, progettuale, tra l’opera e noi sia ridotta al minimo, e il suo è davvero un automatismo; ma questo automatismo ha come prodotto un universo ricchissimo.
Pollock, nel dipingere i suoi quadri, ha insomma danzato con noi; e noi nel guardarli danziamo con lui, accorgendoci di quale straordinario danzatore fosse, di quanto ricca fosse la sua interiorità, e di conseguenza di quanto ricca sia la nostra, visto che siamo capaci di seguirlo. Nell’accordo che l’opera di Pollock in questo modo produce, noi riconosciamo (per tramite collettivo) la nostra stessa ricchezza profonda. L’automatismo di Pollock funziona perché rende non tanto il suo specifico inconscio, ma il nostro, e il mio, quello insomma che ci costruisce, nella nostra cultura, come persone, come soggetti, o anche solo come parte di un tutto collettivo.








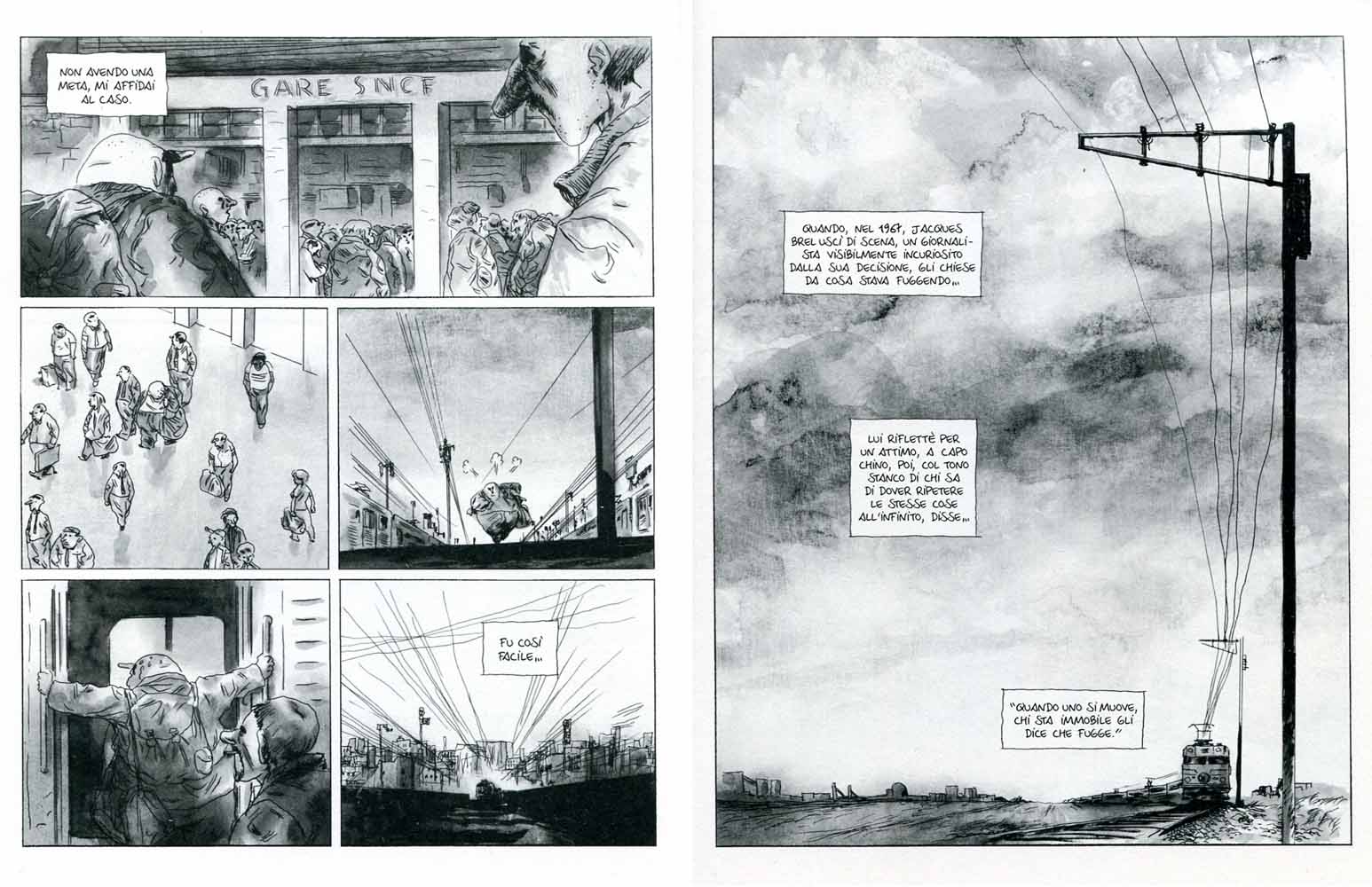
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email




















 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






Commenti recenti