L’articolo è qui, sul blog di Bilbolbul, curato da Lo Spazio Bianco.
|
|
||
|
Ho promesso, qualche mese fa, che avrei cercato di trovare se non la chiave, perlomeno una chiave per capire che cosa mi renda così inquieto leggendo i libri di Maunele Fior. Ora che Cinquemila chilometri al secondo ha vinto ad Angoulême, mi sembra di non potere più posticipare questa ricerca. Mi sono messo così a pensare. Mi sono riletto il volume. Mi è ripiaciuto moltissimo, forse ancora più che alla prima lettura. Ma la chiave è rimasta nascosta. Certo, posso dire che è una bella storia, raccontata molto bene e anche molto ben disegnata. Posso dire che i colori di Fior sono ammalianti, ed è molto bello anche l’uso che viene fatto delle varianti tonali per gruppi di pagine, quasi a esprimere degli stati d’animo dominanti. Posso dire che quel modo di trattare l’esotismo è profondo, e che la sensazione di Svezia e la sensazione di Egitto sono tutte e due intense, proprio nella loro diversità; è quasi come se ci stessimo vivendo anche noi. Non c’è niente di cartolinesco, niente di oleografico. Fior è davvero bravo anche in questo. Insomma, che Fior è bravo si vede, si capisce continuamente: dai disegni, dai dialoghi, dal modo di condurre la storia complessiva… Ma perché mi inquieta? Come fa a prendermi così visceralmente? Mentre brancolavo alla cieca alla ricerca dell’invisibile chiave, ho avuto un piccolo flash, e mi sono venute alla mente queste parole, lette tanto tempo fa: “C’è nella vita un tempo in cui essa rallenta vistosamente, come se esitasse a proseguire o volesse mutare direzione.” È l’inizio di “Grigia” il primo dei tre racconti che compongono Tre donne, di Robert Musil. Tre donne è un libro che ho amato molto, negli anni dell’università. Proprio per questo lo regalai come dono di commiato a una donna (il regalo era mio, ma il commiato era stato suo), e smisi di averlo in casa. Qualche anno dopo lo ricomperai in tedesco, nell’illusione che la mia conoscenza della lingua di Musil (che già mi permetteva di leggere con fatica le favole dei fratelli Grimm) fosse sufficiente ad affrontarlo. Ma dopo avere speso due giorni per leggere le prime tre pagine, capii che al mio tedesco mancava ancora parecchia strada (una strada che in verità non ho mai più percorso). Ma quell’esercizio mi aveva lasciato stampato nella memoria quell’inizio folgorante: “Es gibt im Leben eine Zeit, wo es sich auffallend verlangsamt, als zögerte es weiterzugehn oder wollte seine Richtung ändern. Es mag sein, daß einem in dieser Zeit leichter ein Unglück zustößt.” Che cosa ha a che fare Musil con Cinquemila chilometri al secondo? Non lo so, in verità. Non so nemmeno se Fior abbia letto Musil, anche se sospetto di sì. So però che il romanzo di Fior è focalizzato su alcuni momenti della vita dei suoi protagonisti, e per ciascuno di quei momenti potrebbero valere le parole di Musil. Sono quei momenti di debolezza in cui le costruzioni mentali che tutti noi ci facciamo per portare avanti alla meno peggio la nostra vita si indeboliscono e diventano trasparenti, lasciando vedere quello che c’è dietro. Sono quei momenti in cui la sfortuna potrebbe accanirsi contro di noi, come accade nel racconto di Musil ma non in quello di Fior. Ma sono comunque quei momenti in cui le persone si rivelano non solo nella loro superficie, ma quasi come se la loro pelle fosse diventata trasparente. Non è un modo occasionale di procedere per Fior: La signorina Else e Rosso Oltremare sono costruiti al medesimo modo. Fior evidentemente sa disegnare e sa scrivere molto bene, ma il fascino delle sue storie deriva dal suo saper guardare le persone e le cose, in superficie come in profondità. E magari – chissà – dall’aver letto appassionatamente Musil, oltre a Schnitzler. Sembra quasi un’assonometria, o prospettiva parallela, questa veduta del grande tempio Arunachaleswarar di Tiruvannamalai, presa dall’alto della montagna-che-è-Shiva Arunachala, la montagna dell’alba. Questa foto potrebbe essere il pendant di questa, presa da più in alto, nella direzione opposta, questa qui sopra tutta città, quella tutta campi. Ma questa foto mi piace anche perché il tempio e la città sembrano come emergere dagli alberi, in questa posizione irreale – quasi che il mondo fosse in salita. E poi ancora perché, in questa foto, la confusione tipica dell’India rivela un’attenta costruzione razionale di fondo, proprio come mi era già capitato di osservare in quest’altro post. Secondo me non è mica un caso che questo paese abbia inventato i nostri numeri e continui a sfornare grandi matematici (per non dire del software che utilizzamo, che è in larga misura scritto in India). Qui persino la religione ha a che fare con la logica: solo se ci si ferma alla superficie non se ne vede che l’effervescente (e affascinante) mitologia. Quando si scava sotto, si trovano pagine del Vedanta e dei suoi commentari che rivelano strane somiglianze con il teorema di Gödel e con i paradossi di Russell: fantastici apparati razionali che hanno come scopo di mostrare i limiti della razionalità. Ho partecipato, negli ultimi anni, a diversi convegni dove si è parlato del tema del significato della musica, ho scritto articoli e curato libri dove se ne parla. Continuo a pensare che il tema sia importante e che la musica possa avere un significato nel senso in cui ce l’hanno altre forme espressive. Mi ritrovo però progressivamente più scettico sul fatto che alla musica si debba comunque trovare un significato. Naturalmente, un brano musicale può avere un significato perché, molto banalmente, qualsiasi cosa prodotta dall’uomo lo può avere. Come detta un vecchio e sempre valido adagio di un grande guru della comunicazione (Paul Watzlawick), non possiamo non comunicare. Questo vuol dire che anche in un brano di musica possiamo trovare intenzioni comunicative, ed è pure giusto attivarci per farlo. Tuttavia, la mia impressione è che non sia questo il modo corrente in cui noi ascoltiamo musica, o perlomeno che il nostro modo di ascoltare musica non si esaurisca affatto in questo. Anche se la musica colta occidentale si è evoluta negli ultimi secoli in modo da costituire una forma di discorso (richiedendo dunque una ricezione che mette in gioco questioni di significato), la musica che l’ha preceduta, e quella di altre culture che si è evoluta indipendentemente dalla nostra, non ha necessariamente seguito la medesima strada. Inoltre, anche nella musica colta occidentale restano in gioco una quantità di componenti che non chiamano in gioco necessariamente la dimensione del significato. Intendere la musica come portatrice di significato rappresenta indubbiamente un grande vantaggio per la critica, la quale, esprimendosi attraverso parole, vive per sua natura nella dimensione del significato. Valutare la musica nei termini di quello che “ci vuol dire”, e valorizzarla in relazione ai valori che essa trasmetterebbe, è una mossa che permette alla critica di svilupparsi al meglio, riducendo l’ascolto musicale alla percezione di quei valori e del modo in cui verrebbero trasmessi. D’altra parte, una musica che debba convivere con una critica di questo tipo trarrà vantaggio dall’apparire maggiormente discorsiva, maggiormente propensa a trasmettere valori. Devo puntualizzare che sto parlando di musica pura, strumentale. Se c’è di mezzo la parola, o una dimensione scenica, l’universo del significato è già legittimamente entrato in gioco in altro modo, e l’invito a leggere la musica in questa medesima dimensione è naturalmente molto più forte e giustificato. Pure qui, va detto, la questione non si esaurirebbe con questo – ma non ne voglio parlare in questa sede. Per entrare più nello specifico della questione, sulla musica pura, un aspetto che, a mio parere, per esempio, caratterizza il jazz, è quello di aver coniugato la tradizione occidentale colta della musica-come-discorso con altre componenti di origine popolare ed etnica, che si sono evolute al di fuori di questo ambito. Quando ascolto John Coltrane, la qualità del suo fraseggiare, delle sue invenzioni melodiche e del modo in cui porta avanti le proprie sequenze di note sono tutti elementi di carattere “discorsivo” che indubbiamente fanno parte del piacere che la sua musica mi procura. Il suo modo di passare da dimensioni liriche a dimensioni rabbiose, trasognate, appassionate, frenetiche, distese e così via, fa parte di quello che Coltrane mi trasmette, e non c’è dubbio che io ami la sua musica anche per quello. Ma tutto questo non mi spiega come mai io possa restare attaccato alla voce del suo sax anche dopo aver sentito per caso due sole note, e ancora prima che qualcosa mi si illumini in testa, quasi esclamando “Coltrane!” – perché quel qualcosa che mi si illumina è l’effetto e non la causa del piacere improvviso. Certo, persino quelle due note di sax afferrate per caso possono essere interpretate come portatrici di significato. Ci sono belle pagine di Davide Sparti (Il corpo sonoro, 2007) sulla capacità di Coltrane di ricreare l’emotività della voce umana attraverso il semplice modo di emettere il suono attraverso l’ancia nel tubo del sax. Seguendo questa intuizione, pure quelle due note sarebbero portatrici di significato. Dovremmo allora dire che l’intonazione di Coltrane rimanda a quella della voce, e ai significati che le associamo normalmente? Forse sì. Eppure, quando si dice che io assomiglio a mio fratello non si vuol dire che io ho senso in quanto assomiglio a lui, e rimando semanticamente a lui e di conseguenza ai suoi significati. Se io assomiglio a mio fratello non sono un segno di lui più di quanto lui non sia un segno di me. Allo stesso modo, le due note di Coltrane non rimandano alla voce umana più di quanto essa non rimandi a loro. Dovremmo allora dire che sia le note che la voce portano senso allo stesso modo, in maniera parallela, e che la somiglianza è un semplice suggerimento di trovare nelle note quello che troviamo nella voce. Ma se dal modo di intonare le note passiamo alla melodia, dove finisce la somiglianza? A un’altra melodia, che ripropone il medesimo problema un po’ più in là? O magari all’andamento del mio corpo, come tende a fare una certa musicologia recente? Tuttavia, se metto in gioco l’andamento del corpo, devo davvero continuare a parlare di rimando semiotico, o non sarà piuttosto altro, quello che è in gioco? Prima di rimandare all’andamento del mio corpo, la mia sensazione è che la musica di Coltrane lo produca, lo provochi. Prima di un meccanismo di rimando segnico sembra entrare in gioco un meccanismo di sintonizzazione, di compartecipazione, di “fare insieme la stessa cosa”. Persino nell’effetto delle due note e della voce, di cui parlavamo sopra, potrebbe giocare allora questa stessa sintonizzazione, il porsi nel medesimo mood. Certo, c’è comunque di mezzo il riconoscimento: se non riconosco qualcosa come note o voce, o come melodia, non avverrà nessuna sintonizzazione. E se lo riconosco, l’ho già riconosciuto come qualcosa, e l’ho già fatto rientrare in un universo di senso. La mia sensazione è però che la dimensione del significato a cui la musica non può non essere ricondotta si esaurisca qui (mentre quella a cui può essere ricondotta non si esaurisce né qui né mai). In altre parole, la prima funzione del mio godimento nei confronti della musica di Coltrane (e di tanta altra musica di cui godo, ovviamente) starebbe nella sintonizzazione che essa produce in me, e nel percorso su cui, attraverso questa sintonizzazione, io vengo condotto. Se rifletto su questo percorso, poi, la dimensione del significato può incominciare a dispiegarsi, e da questo momento senza fine. Ma se io non sono un critico musicale, quanto ho bisogno di riflettere sul percorso? Lo vivo, piuttosto, e basta. Mi lascio percorrere, piuttosto, e basta. Approfitto di questa occasione per vivere, attraverso questo percorso, delle esperienze altrimenti ben più pericolose. Nel percorso posso trovare, certamente, degli effetti di senso – ma io ci sono già dentro, nel percorso, ancora prima di trovarli. Non è il ritmo, non è il timbro o la melodia a produrre questi effetti, non sono quelle componenti della musica che la critica tradizionale definisce “sensuali” – anche se certamente ritmo, timbro e melodia giocano la loro parte. Ho parlato di Coltrane perché la sua musica, il suo jazz, riesce a essere insieme trascinante e intellettuale. Certo, nella musica di Pierre Boulez la componente intellettuale, discorsiva, ha un ruolo di base più importante, ma proprio perché è musica, e non prosa critica, pure con i pezzi di Boulez, quando li si sa ascoltare, si può essere travolti, trascinati, ci si può ritrovare immersi. Senza immersione, e sintonizzazione, non c’è godimento estetico, né in musica né altrove. Immersione e sintonizzazione sono due tipi di azione. La comprensione è spesso di grande importanza per l’azione, ma è una cosa diversa, che non può essere confusa con lei. Confondere l’agire con il comprendere ci porta a confondere la fruizione con la critica.
Un post di Caro su The Hooded Utilitarian mi riporta agli occhi l’arte di Saul Steinberg, ricordando quella che lui (ma solo lui, Caro) definisce una graphic novel ante litteram (del 1954): il volume The Passport. Che The Passport fosse una graphic novel è naturalmente solo una boutade da appassionato, ma la passione per il lavoro di Steinberg è un fatto del tutto comprensibile, indipendentemente dalla decisione (discussa nel post) se si tratti di fumetti oppure no – un tema su cui non mi pronuncerò qui.
Io ho incrociato Steinberg su un numero di Linus degli anni Settanta, o forse ancora prima. Ne ricordo una vignetta spettacolosa in cui il personaggio seduto dietro a una scrivania parlava a quello seduto di fronte a lui, e il fiume di incomprensibili parole che costituiva il suo discorso era contenuto in un grande e arzigogolato balloon che formava chiaramente un enorme NO. Al di là dell’efficacia della gag, c’era qualcos’altro che indubbiamente m’intrigava in quel disegno, e che ritrovo pienamente negli esempi portati dal post di Caro (al quale rimando per vederne molti di più di quelli riportati qui – ancora di più se ne possono vedere, ovviamente, su Google images). Con poche eccezioni, tutto il lavoro di Steinberg è basato sull’uso di un pennino sottile, dalla punta dura che consente poca modulazione della linea, e su un’estrema economia di segni. In qualche caso, come quello riportato in alto, questa estrema economia diventa quasi il tema, e l’effetto insieme lirico e ironico di questa immagine è tutto basato su una grande assenza evocata dalle poche presenze – o da un grande nero (il buio della notte) rappresentato dalla pagina bianca. In altri casi, come quello che segue, si arriva al virtuosismo di eseguire immagini figurative abbastanza complesse attraverso l’uso di una sola linea continua: e l’ironia di Steinberg ci rivela di colpo dimensioni percettive di cui non siamo consapevoli, e, insieme, strane relazioni tra le cose.
Non è tutto qui. Con le sue linee striminzite, Steinberg ha costruito uno stile molto ben riconoscibile, talmente personale da essere continuamente quasi una specie di firma. Non a caso, poi, la sua firma vera e propria quasi non si distingue dagli scarabocchi con cui, di tanto in tanto, imita la scrittura. Questo segno così personale è una sorta di “io” grafico; attraverso il segno così riconoscibile, è come se per ogni immagine che ci presenta, Steinberg stesse (sommessamente) dicendo “io la vedo così”, “ecco la mia visione delle cose”. Questa forte soggettivizzazione toglie immediatamente alle sue vignette qualsiasi pretesa di rappresentare il mondo com’è, e ci invita subito a cogliere il punto ironico e/o lirico del suo discorso. Nell’immagine che segue, la complessità della parte in basso la rende subito sfondo, mentre l’attenzione si concentra su quella in alto, che contiene il cuore del discorso – compreso il delizioso dettaglio della luna, che si trova inquadrata nel finestrino, come se appartenesse solo al mondo di chi dorme, e non al paesaggio sottostante.
La forte caratterizzazione dei pochi segni permette a Steinberg di ottenere l’immediata concentrazione dell’attenzione dello spettatore su quello che gli interessa comunicare. Ed è in questo modo che diventa possibile trasmettere anche qualcosa di molto sottile, di leggero e impalpabile: qualcosa che magari fa appena sorridere il lettore, magari con un’ombra di tenerezza, magari con un sospetto di crudeltà. L’ultima vignetta qui sotto la dedico agli amici del blog Sinsemia, che si occupa di comunicazione visiva. Come a volte succede con le vignette di Steinberg, ho dovuto avanzare dei dubbi sulla mia prima interpretazione. A prima vista, mi è sembrato che la vignetta giocasse sulla scarsa capacità di progettare ( e quindi di pensare – think) del personaggio, proprio mentre scrive la parola think. Poi mi sono accorto che quello che lui sta scrivendo si può leggere anche come “thin k”, cioè “k sottile”, dove “sottile” è scritto in bold. La seconda lettura non esclude la prima, né viceversa. Su cosa gioca Steinberg?
Non so se la foto è bella, ma il soggetto era davvero straordinario, e del tutto integrato nell’ambiente urbano/naturale di Fort Kochin, nel Kerala, in un viale di alberi giganteschi, nel bel mezzo di un paese immerso in una sorta di giungla addomesticata, eppure grande, grandissimo, praticamente una città. Il camion abbandonato sulla pubblica strada, che da noi sarebbe presto additato a vergogna e rimosso, qui si trasforma naturalmente in una singolarissima e affascinante aiuola, del tutto in sintonia con l’ambiente circostante. Ancora un anno o due e poi della struttura metallica non si vedrà più niente. Mi vengono in mente i racconti (inventati) di Guido Gozzano di fronte alle rovine di Goa ricoperte dalla giungla. Bellissimo e struggente, da un lato. Sottilmente inquietante dall’altro. È una natura amica questa, che si prende beffa della nostra superba tecnologia, oppure è un’amara metafora del destino della nostra civiltà?
Mi accorgo di essere piuttosto sensibile, in questi giorni, al tema dell’autoriferimento paradossale, quello del Don Chisciotte di Borges che legge le proprie avventure scritte da Cervantes. È il tema tradizionale della mise en abîme, del precipizio ottico scatenato dagli specchi contrapposti, quella cosa che ci fa domandare, come suggerisce Borges, se non siamo pure noi stessi una delle finzioni nel gioco. Oppure – quasi al contrario – forse è quel tema che dovrebbe essere preso (magari proprio per il medesimo farci sorgere quella domanda) come un chiaro indizio di finzione – perché solo nei mondi riflessi o di finzione ci si domanda se ci troviamo nel reale. Questo succede, io credo, perché il reale su cui ci poniamo domande è a sua volta il frutto di un’astrazione, e in particolare il frutto di un’astrazione linguistica, facilmente allargata poi anche a tipi di narrazione e di discorso di carattere maggiormente visivo. Come dire che la domanda di Borges ha senso perché quando ragioniamo del reale in quei termini, il reale stesso è diventato un’astrazione; è diventato cioè la nostra concettualizzazione del mondo della nostra esperienza. Ed è questo che fa sì che abbiano senso teorie logiche come quella cosiddetta dei Mondi Possibili (base delle versioni moderne della logica modale). Quando smettiamo di ragionare, il problema scompare. Tutte le arti di carattere narrativo hanno la possibilità di giocare su questo paradosso, e tuttavia esso è estraneo, per esempio, alla musica pura e alla pittura astratta; è cioè estraneo a quelle situazioni che ci chiedono più di metterci in sintonia che di comprendere concettualmente. Perché allora il tema di Borges mi affascina tanto? Probabilmente è proprio il fascino del paradosso, ovvero di quelle situazioni estreme in cui la ragione si ingarbuglia da sola, e non è in grado di dire con certezza se Epimenide il cretese (che afferma che tutti i cretesi mentono sempre) stia mentendo o no: se dice la verità, poiché è un cretese pure lui, allora sta mentendo; e solo se sta mentendo allora può dire la verità. Nella vita quotidiana non ci domanderemmo mai se non ci sia qualcuno che ci sta leggendo, o che ci sta sognando. Siamo troppo impegnati nel fare e nel sentire, nell’andare a tempo col mondo. Ed è quella la realtà Ma quando la vita quotidiana viene vissuta attraverso il Web, magari scrivendo un blog, o stando attaccati a Facebook, il problema se ci sia qualcuno che ci sta leggendo non è più così peregrino. Anzi, è il problema cruciale, la condizione sine qua non per esistere. Se nessuno ci legge, nel Web non esistiamo. Parafrasando l’arcivescovo Berkeley, essere è essere letti (e di conseguenza percepiti). Potremmo dire che la vita nel Web è una sorta di letteratura condivisa e interattiva, di cui siamo protagonisti e lettori, e, proprio come Don Chisciotte, esistiamo quando qualcun altro scrive di noi e lo possiamo leggere. Tutto questo è importante e insieme anche irrilevante, perché di nuovo un tale gioco irreale di specchi che riflettono specchi di noi stessi e degli altri ci appare davvero reale non quando siamo in grado di dire di essere reali perché altri ci leggono, ma quando di fatto pure nel Web (magari proprio perché qualcuno ci sta leggendo) ci sentiamo vivere, quando abbiamo la sensazione di essere a tempo, di nuotare nel flusso, di vibrare col ritmo di fondo. Sarebbe fantastico poter vivere solo di queste sensazioni, indipendentemente dalle loro ragioni. Se non fosse che, come in una Matrix non cinematografica, queste sensazioni possono essere controllate, e davvero possiamo ritrovarci a essere scritti del tutto da qualcun altro. È proprio in questo caso che la nostra concezione razionale della realtà (con tutti i paradossi cui va soggetta) finisce per essere l’unico paletto sufficientemente solido, quello a cui dobbiamo la nostra sopravvivenza nel mondo, anche se (forse) non il nostro piacere. Chi non ha ancora capito questo continua a pensare che sia meglio sognare con l’uomo del destino del momento piuttosto che vedere l’abisso di squallore in cui quel medesimo uomo ci ha gettato, e quanto quel mondo favoleggiato da lui sia lontano da quello che la nostra ragione ritiene reale. La comunicazione del Web crea indubbiamente un sacco di problemi al nostro senso di realtà, eppure la sua natura scritta la rende comunque molto più prossima alle valutazioni razionali di quanto non accada, per esempio, con la TV. Per quanto Facebook ci possa alienare, insomma, ci manterrà sempre più a contatto dei paradossi di Borges di quanto non faccia l’alienazione televisiva. Orà dirò una cosa che va presa con le pinze, perché i controesempi sono tanti, e la realtà è più complessa, e le singole persone possono essere spesso sia qualcosa sia il suo contrario; eppure, in linea di massima, la mia sensazione è che o si vota l’uomo del destino o si è utenti attivi del Web; o si è sognatori catodici oppure si scrive e si discute. I paradossi mi piacciono, ma solo se potessi essere al sicuro da tutti i Berlusconi del mondo mi potrei abbandonare alla loro (razionalissima) assurdità. Magari mi intrigano così tanto in questi giorni proprio perché, in maniera (razionalmente) contorta, evocano questo sogno, quello di una realtà a cui potersi lasciare un po’ andare, senza doverci domandare chi ci stia leggendo ora, ma anche senza il rischio di nani maligni a controllarla. Le straordinarie copertine realizzate da Dave McKean per diverse serie di comic book americani mostrano bene che cosa ne sia dello strumento fotografico nell’epoca di Photoshop. Credo che a nessuno verrebbe infatti in mente di considerare i dettagli palesemente di origine fotografica che appaiono in molte di quelle immagini come testimonianze di una qualche realtà, di una qualche oggettività che da qualche parte in qualche tempo ha avuto luogo. Eppure, d’altra parte, non ha neanche molto senso considerare quei dettagli come banali scorciatoie produttive, perché si fa prima a utilizzare un brandello di fotografia che non a disegnare quel particolare con un qualche tipo di tecnica manuale. McKean fornisce continuamente prove troppo evidenti della consapevolezza con cui gioca i propri elementi costruttivi per non dargli credito anche su questo. Il punto infatti è proprio che, a questi dettagli, qualcosa del valore di testimonianza del reale comunque resta, ed è anche su questo residuo di realismo che l’autore gioca per costruire il proprio effetto comunicativo. La copertina di The Dreaming che apre questo post è probabilmente realizzata del tutto con frammenti fotografici – a parte i caratteri della testata, anche se la loro fattura li potrebbe comunque far scambiare per tali. Nel complesso, per la qualità delle sfumature e della grana dei materiali riprodotti, l’immagine potrebbe anche essere davvero una singola fotografia – se non fosse che la sua collocazione (copertina di un albo a fumetti) e l’improbabilità del suo soggetto ce lo fanno escludere. Ma l’allusione al reale che questa non-fotografia compie è comunque importante. Ciò che essa rappresenta è infatti a sua volta una rappresentazione: una complessa scultura in marmo o avorio da cui emerge, o meglio, da cui sembra stare uscendo una figura umana. Questa figura è, verso il basso (la parte più arretrata del gesto di emersione, ancora vicina al blocco scultureo), certamente di marmo o avorio, e continua a esserlo nelle braccia e nel tronco – mentre nel viso, che è la parte più avanzata, più vicina a noi, qualcosa è decisamente differente. Al di fuori di questo viso, infatti, tutto è riconducibile abbastanza tranquillamente a delle convenzioni iconografiche note, e solo l’immersione delle braccia nel reticolo delle piccole figure può apparire non canonica. Il viso, invece, è decisamente non canonico: se questo è un angelo, o un Cristo (come potrebbe suggerire la forma del drappo che gli copre i fianchi), la calvizie e il labbro leporino sono immediatamente inquietanti, un improvviso tocco di eccessivo realismo. E quando si osserva questo, ci si prende anche immediatamente conto che la grana della materia delle guance, del mento e di tutta la parte inferiore del viso non è quella di una statua, bensì proprio quella della pelle vera, così come vero è il naso, e quel riflesso dell’occhio lucido che emerge dall’ombra. La figura grande procede quindi verso di noi, come liberandosi dall’universo della rappresentazione per fare il suo ingresso in quello reale; ed è insieme una figura sinistra, ambigua. Nel contesto complessivo di finzione, l’apparenza fotografica crea un effetto di realtà, così che questo Cristo demoniaco sembra davvero colto nell’atto di acquisire carne, uscendo dalla propria materia statuaria di origine, e venendo verso di noi – creatura da incubo che esce dal sogno per entrare nel reale… Anche l’altra copertina, in basso, realizzata per The Sandman, gioca sull’effetto fotografico, però quasi in direzione opposta. La parte fotografica è una cornice di legno, anzi, una serie di cornici concentriche. Ciò che la cornice inquadra è ovviamente un disegno (o un dipinto); salvo che la cornice è rotta, e attraverso lo squarcio si capisce che ciò che credevamo disegnato è invece il mondo reale, che la cornice si limita a inquadrare. Pur non smettendo di apparire come una cornice, la cornice si rivela ora una sorta di finestra, e la sua realtà (testimoniata dalla sua riproduzione fotografica) si trasmette a ciò che essa inquadra, nonostante si tratti chiaramente di un prodotto della mano. Anche per questi esempi sarebbe pertinente la citazione di Borges con cui abbiamo aperto il post di lunedì scorso. Per McKean il dettaglio fotografico è l’effetto di realtà che confonde le acque, permette ai diversi livelli di interagire, mescola il Don Chisciotte letto con quello che lo legge. Ma se in Frank Miller tutto questo serviva per dichiarare ad alta voce: “Attenti, questo è spettacolo”, nelle copertine di Dave McKean il rimando al sogno è sufficiente a tematizzarle. È come se McKean ci avesse ripetuto, copertina dopo copertina, declinato in tanti modi diversi, lo stesso motto shakespeariano pronunciato dalla voce di Prospero: “We are such stuff / As dreams are made on”, ovvero “siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni”. Questa mucca presa sulla spiaggia di Mamallapuram sembra davvero camminare sul profilo del mondo contro un cielo uniforme e grigio, o contro un muro di nebbia. La verità si può vedere nella foto qui sotto (da cui si capisce anche che ho barato un pochino). Certo, quello non è il cielo, ma l’acqua di una pozza. Eppure il cielo vero non è meno grigio, e la mucca cammina lo stesso in una dimensione metafisica, sul profilo di una qualche terra, che si interrompe, per poi riprendere nella sua realtà un poco più in là, e infine perdere concretezza del tutto verso il fondo. C’è un grande senso di quiete, non disturbato ma persino confermato dall’irruzione del quotidiano all’estrema sinistra, nel cartellone del ristorante e nell’asta diagonale del lampione. Tutto è orizzontale, e procede da sinistra verso destra (le barche amarrate, la mucca e il vitello in alto a destra, l’insegna del ristorante, persino le due barche in mare sullo sfondo), ma senza fretta. Pure l’orizzonte lievemente inclinato ci rimanda a destra. La ruota delle cose gira, il mondo scorre. Noi lo osserviamo da turisti, seduti sotto la tettoia del ristorante. Dalla foto non si capisce, ma sta piovendo un’acqua finissima… Mi guardo intorno, anzi sarebbe meglio dire mi leggo intorno. Leggo su questo schermo blog di diversi tipi, di diversi argomenti. Nei blog dove si ragiona di poesia mi colpiscono in questi giorni tre post differenti, ma che girano attorno a un tema solo, o forse (meglio) a temi diversi con una radice unificante; uno è quello di Paolo Zublena su punto critico, Esiste (ancora) la poesia in prosa?, un altro è quello di Massimiliano Manganelli su Absoluteville, La poesia contro il romanzo, e il terzo, ancora su Absoluteville, solo in apparenza di tema differente, è quello di Rosaria Lo Russo, Scrivere sotto dittatura; tutti con i relativi commenti. Il tema unificante a cui girano attorno è che cosa sia questa roba che chiamiamo poesia, e in particolare che cosa sia rispetto a quell’altra roba che, per contrasto, si chiama prosa, ed è soprattutto, nel mondo di oggi, romanzo. Non è, io credo, una questione di vincoli maggiori o minori; semmai di quali vincoli. Un commentatore del post di Zublena (Gianluca Garrapa) suggerisce di assumere una regola arbitraria, tipo i 140 caratteri di Twitter “come fosse una regola (quasi oulipo) di versificazione e stare quindi nella ‘poesia’ in una più ampia, però, struttura narrativa_di_prosa. come se insomma ‘macroscopicamente’ fosse prosa e ‘microscopicamente’ poesia”. Mi pare una proposta che può essere magari interessante per fare degli esperimenti (tipo Oulipo, appunto), ma che con la poesia non ha niente a che spartire, in sé (anche se ci si può porre come sfida di scrivere poesia sottostando pure a un vincolo come quello). Mi sento semmai più in sintonia con Rosaria Lo Russo, che parla di dettatura (o dittatura) del corpo ispirato. Forse la Lo Russo pone troppo l’accento sul corpo (ma lo scrive in un post, non in un trattato, e non si può sottilizzare troppo in poche righe), perché la poesia, da diversi secoli a questa parte, non è solo vocalità. Però io trovo che sostanzialmente abbia ragione, e che nella poesia sia presente una dinamica fisica, o fisiologica, di carattere principalmente vocale-sonoro, ma anche secondariamente (a mio parere) grafico-visivo, che non si può eliminare, se non uscendo dai suoi confini. Lo dice bene Paul Valery, citato da un altro commentatore del post di Zublena (Luigi Bosco): “L’essenza della prosa è di perire, – cioè di essere «compresa», – cioè di essere dissolta, distrutta in modo irreparabile, del tutto sostituita dall’immagine o dall’impulso che essa significa secondo la convenzione del linguaggio. Infatti la prosa sottintende sempre l’universo dell’esperienza e degli atti, – universo nel quale, – o grazie al quale, – le nostre percezioni e le nostre azioni o emozioni devono alla fine corrispondersi o rispondersi in un solo modo, – uniformemente. L’universo pratico si riduce a un insieme di scopi. Ottenuto tale scopo, la parola muore”. Come dire che, nella prosa, la parola si esaurisce nella trasmissione del proprio significato, e si legge unicamente per capire: tutto il resto, compreso tutto il sentire emotivo che eventualmente ne deriva, passa completamente da lì, dalla comprensione della sequenza di parole. Viceversa, nella poesia la parola resiste alla comprensione del suo significato, e il suo suono traccia altre relazioni, che si accompagnano a quelle del significato, e non si esauriscono in quelle. La comprensione (anche profonda) del significato di una poesia è ben lontana dall’esaurirla. Con forme differenti, la poesia condivide con la musica l’irriducibilità al senso – pur essendogli più vicina di quanto non gli sia la musica, per la sua natura ovviamente verbale. Qualche giorno fa scrivevo (qui) che “la poesia è un meccanismo che mette in relazione il nostro sentire personale, privato, intimo, con quello collettivo e sociale, fatto di tradizione e di regole e di consuetudini e di stratificazioni”. Potrei aggiungere, esagerando e semplificando, che il sentire personale è legato al senso, al significato, mentre quello collettivo è legato agli aspetti ritmici e sonori. Starei esagerando e semplificando perché le relazioni sono molto più complesse di così, ma non starei mancando del tutto il bersaglio. In altri termini, potrei anche dire che la poesia è un meccanismo che mette in relazione il significato verbale con altre reti di relazioni, non necessariamente riducibili, nemmeno in ultima istanza, al significato verbale stesso. Se tale riduzione fosse possibile, una buona interpretazione di un testo poetico lo esaurirebbe (come sembra aver ipotizzato qualcuno in epoca neoavanguardista, secondo il racconto, ancora su punto critico, di Antonio Loreto). In verità, anche Valery sta esagerando e semplificando. Persino la prosa non si esaurisce del tutto nel suo significato, anche se certo il valore sonoro (o visivo) delle parole è estremamente minore di quello della poesia. Proprio per questo è virtualmente possibile costruire della prosa che conservi i valori della poesia di non riducibilità al significato. Ma non ha tutti i torti Zublena a ritenere la poesia in prosa un’operazione che ha avuto valore storico, un valore oggi del tutto superato (i grassetti della citazione sono miei):
In questo predominio dell’industria editoriale, la prosa – cioè il romanzo – è diventato davvero pienamente quello che descriveva Valery, cioè qualcosa il cui linguaggio si risolve nel proprio significato: in altre parole, la trama, il plot, la struttura del raccontato. Per Massimiliano Manganelli, su Absoluteville, proprio grazie alla sua marginalità, la poesia “è diventata il terreno più fertile della scrittura letteraria, quello dove si consumano gli esperimenti, dove l’invenzione conta ancora qualcosa, contro l’infinita ripetizione del romanzo”. Alla luce delle sconsolate parole di Zublena, questa fertilità sembrerebbe tuttavia dovuta proprio a quella “indifferente libertà” lasciatale dal mercato. Nell’un caso come nell’altro, non è però chiaro perché il mercato abbia scelto il romanzo. Non dobbiamo dimenticare che il mercato non ha affatto demonizzato, per esempio, la musica, che è l’altro polo che influisce sulla poesia. In altri termini, il mercato ha puntato da un lato su una parola narrativa che si esaurisce nel racconto, e dall’altro su una struttura ritmico-sonora che si tiene ben lontana dal senso (basti pensare alla banalità media o irrilevanza dei testi delle canzoni, quando ci sono). La poesia, dal canto suo, ha percorso i sentieri aspri delle avanguardie, e si è adornianamente tirata fuori da quella dialettica, enfatizzando l’inevitabile complessità che deriva dal mettere assieme i due campi, quando si cerca di giocare insieme all’interno e all’esterno del senso. La separazione tra mercato e poesia è stata dunque per molti versi consensuale. Il problema, a questo punto, è concretizzare davvero la non coincidenza tra la cultura e il mercato culturale. Non possiamo lamentarci che la poesia non venda. Dovremmo lamentarci piuttosto che il vendere sia l’unico criterio di valore riconosciuto pubblicamente, e agire di conseguenza. Dovremmo perciò renderci conto che la pubblicazione a stampa non può più essere il discrimine tra poeti da considerare criticamente e poeti da ignorare. La pubblicazione è comunque qualcosa che si paga, vuoi che la paghi il mercato, l’editore o l’autore stesso. Se non crediamo nel valore del mercato dobbiamo coerentemente squalificare anche il valore della pubblicazione a stampa. In altre parole, sarebbe ora che chi si occupa di critica poetica si accorgesse che l’universo del Web ospita la poesia di oggi e di domani. Naturalmente è molto più scomodo analizzare un campo così vasto, non previamente scremato dalle scelte degli editori. Ma non ci sono alternative, oggi, io credo. Se il criterio seguito da Cucchi e Giovanardi per la loro nota antologia mondadoriana (di prendere in considerazione soltanto autori pubblicati, e da editori veri) era discutibile nel 1996, e pericoloso nel 2004 (le date delle due edizioni dell’opera), credo che sarebbe semplicemente sbagliato, o falso, oggi. P.S. Sto partecipando al Premio Turoldo.
 Jorge Luis Borges, da "Magie parziali del Don Chisciotte", Altre inquisizioni, Feltrinelli 1963, traduzione di Francesco Testori Montalto Le parole di Borges hanno per oggetto testi classici, o speculazioni filosofiche. Le conclusioni a cui arriva restano comunque affascinanti. Questo è un saggio vero, non una delle sue Finzioni. Con Borges, si fatica a distinguere il reale dall’immaginato, e alla fine ci si rende conto che spesso non è una distinzione pertinente. Siamo anche noi il sogno di qualcuno, come Don Chisciotte era il sogno di Cervantes? Che cosa c’entra Frank Miller con le fascinose ma astratte elucubrazioni del maestro argentino? Miller impara dai giapponesi, già nei primi anni Ottanta, a costruire la pagina in maniera diversa, a giocare con lo spazio della pagina nella sua interezza, considerando il margine delle vignette un elemento opzionale, da utilizzare o meno a seconda del caso. Il margine delle vignette ha, in generale, una funzione di cornice, e serve quindi, tra le altre cose, a distinguere lo spazio del mondo della finzione (il mondo raccontato) da quello del mondo reale (la pagina materiale, lo spazio bianco che allude allo scorrere della lettura e al passaggio dell’occhio del lettore a un altro quadro). Lasciare l’immagine al vivo, limitata solo dal taglio materiale della pagina, significa eliminare una cornice, cioè un elemento di distanza. Naturalmente rimane un’altra cornice ineliminabile, che è quella della pagina stessa – ma il taglio della pagina è un vincolo materiale, non un prodotto del disegno, proprio come il bordo della finestra che inquadra un pezzo di mondo. L’immagine al vivo rimane finzionale, ma il suo impatto è molto più forte, perché si avvicina di colpo al nostro mondo reale – lo sfiora, pur senza poterlo raggiungere. Se poi sai giocare bene anche sull’inquadratura, ecco che Batman sta davvero di colpo piombando su di noi. Ma cosa sono dunque quei riquadri appoggiati sull’ìmmagine? Altre vignette, certo. Eppure se ci stanno sopra essi non appartengono al medesimo mondo: sono come cartoline appoggiate sopra a un manifesto. Nel mondo reale le immagini non si possono giustapporre in questo modo. Solo le immagini lo possono fare tra loro – e il fatto di trovarsi sopra indica che sono posteriori (non si infila un manifesto sotto a delle cartoline, di solito, ma viceversa). Mentre l’immagine al vivo si accosta mostruosamente al mondo reale, la sovrapposizione di altre immagini la rigetta verso il finzionale, il rappresentato. Ma non dimentichiamo che la lettura di un fumetto va fatta in sequenza: prima dunque l’immagine grande è quasi-reale, poi diventa lo sfondo di altre immagini. La correttezza di questa modalità di lettura è confermata anche dalla posizione relativa delle vignette, e dall’andamento narrativo che ne consegue. Si può leggere tutto questo però anche in un altro modo, cambiando un poco il punto di vista. Se l’immagine grande era quasi-reale, le vignette piccole si trovano ora ancora più vicine a noi – e poco importa che la realtà dell’immagine grande sia nel frattempo retrocessa, perché essa ormai si trova nel passato, e noi stiamo già leggendo le vignette piccole sovrastanti. È così che gioca Miller, illusione dopo illusione; e quando un’illusione si disvela, noi siamo già dentro la prossima, e poco ci importa della precedente. E poi, soprattutto, poco ci importa perché quello che ci importa è soltanto l’impatto emotivo: questa insomma è fiction, questo è mito. Quello che Borges non arriva a dire (ma consegue dalle sue parole) è che l’ipotesi di essere a nostra volta personaggi della lettura di qualcuno ci rende parte di uno spettacolo, di un mito, di una fiction, in cui valiamo per quello che possiamo comunicare nella trama complessiva, non per quello che siamo. Se siamo i personaggi di un racconto, il senso della nostra vita, dell’intero nostro mondo, è quello di costruire un’esperienza significativa per chi ci legge, per chi lo legge. Guarda caso, le vignette inserite sulla pagina di Miller sono schermi televisivi, con il relativo sonoro. Tutto The Dark Knight è intessuto di sequenze televisive. Le immagini più reali del quasi-reale che sta sotto di loro rappresentano dunque non una realtà bensì una rappresentazione – magari fedele, come può anche essere la TV, però una rappresentazione. Nel momento di massima vicinanza al mondo reale incontriamo quindi di nuovo una rappresentazione. Non so se Miller abbia mai letto Borges, ma gran parte della sua notevolissima capacità narrativa sta proprio nell’aver capito che la fiction ci può apparire tanto più reale quanto più assomiglia a quella confusione di livelli tra il reale e il rappresentato che è il nostro mondo dominato dai media e dalle loro rappresentazioni. In un mondo in cui la rappresentazione (televisiva, cinematografica, raccontata dai giornali ecc.) può essere per noi più reale del reale, la realtà è per noi una dialettica complessa tra i tanti modi di viverla e rappresentarla. Il Cervantes di Borges riduceva il mondo a spettacolo per la lettura di uno dei suoi personaggi, insinuando in noi il dubbio sulla nostra stessa realtà. Frank Miller non fa che riconoscere che il nostro mondo è ormai di quel medesimo tipo, e gli specchi della costruzione in abisso sono i diretti responsabili della costruzione del reale – non dei semplici riproduttori. Su questa dialettica senza scampo Silvio Berlusconi ha costruito il suo impero di finzione, e i suoi personaggi siamo noi. Per la lettura di chi? Kanyakumari, punta estrema sud dell’India, la punta dei tre mari. Questa foto mi piace per quel gruppo di donne in rosso (con l’uomo in bianco), vivace e mosso, e con un atteggiamento molto presente, che si staglia su questa geometria immobile o ricorsiva del mare sotto l’orizzonte, della terra con i suoi muretti merlati, del palo un po’ storto. Ci sono due colori dominanti e immobili: l’azzurro del cielo-mare, l’ocra delle cose solide. Cielo e mare sono orizzontali; la terra è caratterizzata da questa lunga diagonale che va verso l’orizzonte, a metà della quale c’è il gruppo di persone. Sono attive e ben presenti. Stanno certamente parlando tra loro. Ma l’atteggiamento prevalente è il guardare, guardare oltre il muretto, guardare nell’oceano. Quella macchia rossa e contrastata è ciò che crea un ponte tra la terra e il mare. Se non ci fossero loro sarebbe tutto vuoto – interessante lo stesso, magari, ma vuoto. Questo post vuole essere la continuazione del post precedente, ma ora parlerò di fumetti. Voglio scrivere di Jiro Taniguchi e del suo ultimo libro pubblicato in Italia: Quartieri lontani (Coconino Press, 2010 – l’originale giapponese è del 1998, ma Coconino l’aveva già stampato in due parti, nel 2002 e 2003, con il titolo In una lontana città). Due parole sul suo tema le devo spendere, per permettere un minimo di orientamento a chi ancora non lo ha letto. Un uomo di 48 anni si trova – come in una sorta di sogno incredibilmente realistico – a rivivere i propri 14 anni, ma con la consapevolezza dell’adulto. Ritornare a scuola, rivedere i propri genitori, proprio nel periodo in cui il padre è andato via, rivivere i rapporti con i compagni di scuola, il primo innamoramento… Però niente è come prima, perché prima di tutto lui, nel corpo del quattordicenne, è un adulto gettato nel passato, che cerca di nascondere agli altri le proprie conoscenze sul loro futuro, non sempre riuscendoci del tutto. L’idea di base forse non è originale, ma, come sempre, Taniguchi è un maestro a svilupparla e a portarla sino alle ultime conseguenze. Il risultato è così un racconto sospeso tra la sensazione del già visto e la tormentosa inquietudine del non capire come possa andare a finire: guarda casa, le stesse sensazioni del protagonista della storia! Taniguchi ha un disegno lineare e chiaro, piuttosto statico, ma questa semplicità si rivela poi adatta a meglio trasmettere le emozioni dei volti e dei corpi, sempre molto vere. E, insieme, c’è una sapiente costruzione dell’insieme, con un gioco di accostamenti/contrapposizioni tra la costruzione ortogonale della pagina, creata dalla serie delle vignette rettangolari, e lo sviluppo delle linee delle figure in esse contenute, che sono spesso anch’esse ortogonali, ma a volte organizzate sugli assi diagonali. Questa piccola vivacità costruttiva è sufficiente a dare vita alle pagine di Taniguchi, anche nel loro insieme – mentre al tempo stesso raccontano con espressività quello che sta succedendo. Se stessimo parlando di uno scrittore, staremmo lodando la raffinatezza del linguaggio verbale e insieme la sua capacità di usarlo efficacemente per raccontare le emozioni – due qualità diverse, e non sempre compresenti. In un disegnatore di fumetti il corrispondente è ovviamente il rapporto tra il tratto grafico e la composizione, oltre che il modo di farne uso. La strategia di semplificazione visiva agisce, in Taniguchi, anche al livello narrativo. La storia è semplice, assai lineare: tutto gira attorno a pochissimi elementi. Ma proprio come con la linearità del disegno, la linearità del racconto finisce per mettere fortemente in luce gli elementi chiave. Pagina dopo pagina, l’assurdità di quello che capita al protagonista svanisce anche per il lettore, e la vita del quattordicenne di 48 anni procede nella sua normalità, nelle sue piccole sorprese, nei suoi grandi timori. Ho letto le 414 pagine di Quartieri lontani tutto di un fiato. Ci vogliono un paio di ore. L’immersione che mi ha prodotto non era così dissimile – come ho già detto – da quella del suo protagonista. In più di un momento della lettura mi sono sentito vivamente emozionato. Certo, il romanzo di Taniguchi gioca su temi profondi: la memoria, il rimpianto, il sogno di rivivere il passato. Ma proprio perché sono temi così intensi, il rischio di essere banali è estremo. La semplicità del disegno e del racconto di Taniguchi è per forza quindi soltanto apparente. Il ritmo che qui l’autore costruisce è magari quello del sogno – ma non si ha mai l’impressione di trovarsi dentro un sogno. Tutto è reale, e anche il racconto è quello di qualcosa di reale. Forse è proprio questo straniamento a portare avanti il lettore – ma nella capacità che ha Taniguchi di farci dimenticare che stiamo leggendo una storia (e una storia di Giapponesi, tanto differenti da noi!) c’è qualcosa di davvero straordinario. Come ho detto nel post precedente, non mi interessa trovare una verità del testo, e non credo che la critica debba concentrarsi su quello. Se il messaggio di Taniguchi è efficace su di me, in questo caso è perché già lo conosco e lo condivido. Non è il messaggio la parte interessante di un testo artistico, bensì l’esperienza su cui il testo ci conduce, il percorso di scoperta o riscoperta di qualcosa, che già lo conosciamo o no. Il messaggio, in questo, farà anche la sua parte – e ci sono sicuramente testi in cui è una parte importante, e davvero impariamo qualcosa di nuovo. Ma lo impariamo solo perché il testo ci ha condotto attraverso un’esperienza coinvolgente. P.S. Giusto un’osservazione per la Coconino. Ristampare In una lontana città è certamente una buona operazione, che ha tutta la mia approvazione. E capisco anche che la concomitanza con il film di Sam Garbarsky sia una buona occasione per un’operazione commercialmente positiva (cosa da non disprezzare per un editore di questi tempi) e insieme culturalmente utile. Ma non apprezzo il fatto che da nessuna parte del volume compaia il riferimento alla precedente edizione, con il titolo mutato: la trovo anche una piccola truffa ai danni dei lettori che già possedevano In una lontana città, e che ora acquisteranno Quartieri lontani credendo che si tratti di un lavoro nuovo.
Le poesie riportate in questo post sono di Andrea Inglese, tratte da L’indomestico (2005, scaricabile per intero da qui). Le riporto non solo perché mi piacciono, ma perché mi hanno suggerito una riflessione sul senso della lettura e, soprattutto, sul senso della critica – una riflessione che prende come spunto la poesia, ma che vuole avere valore più generale, per qualsiasi oggetto di carattere estetico/artistico di cui si voglia parlare. Mi riferisco non tanto alla critica storica, non tanto a quella che tira le somme, ma piuttosto a quella che legge e propone, cercando di indurre i propri lettori a un apprezzamento (o non apprezzamento) dei testi in oggetto. Quella che deve dire (nel caso) se un testo è bello e perché. Lo può fare perché sta scrivendo una recensione, oppure perché sta cercando di spiegare (in una prospettiva più storica) le ragioni della qualità o del successo di un testo. Ora: teniamo presente che quando riteniamo che il ruolo della critica sia quello di spiegare il testo, rendendone evidenti i contenuti nascosti, stiamo già presupponendo che il testo possa essere spiegato, e che valga la pena di farlo. Se vale la pena di farlo è perché siamo convinti che il testo abbia valore, e che questo valore stia nel suo significato (e dove altrimenti?): aiutare il lettore a cogliere meglio questo significato sarebbe dunque un compito principe della critica. Non metto in dubbio, né qui né in generale, l’utilità di una spiegazione del significato dei testi. Certo non si tratterà mai di una spiegazione definitiva (un buon testo estetico non dà mai fondo alle sue possibili interpretazioni), tuttavia già fornire al lettore qualche chiave di lettura in più (magari per discuterla o addirittura – criticamente – rifiutarla) è certamente qualcosa di positivo. Il punto della mia riflessione è piuttosto se la funzione della critica debba limitarsi a questo basilare “fornire una chiave in più” alla lettura, oppure se essa possa ambire anche a qualcos’altro. Cosa potrebbe essere questo “qualcos’altro”? E pure limitandosi magari alla semplice funzione di base, in che modo essa dovrebbe essere espletata? Potrei, tanto per cominciare da una procedura molto basilare, prendere questi testi e sottoporli a parafrasi, proprio come si fa a scuola, ma temo che nel loro caso non otterrei molto. La parafrasi è utile quando la sintassi è complicata – cosa che non succede nelle poesie di Inglese. Il risultato non sarebbe molto diverso dall’originale: solo più brutto, presumibilmente. Potrei allora prendere questi testi ed esplorarli andando a fondo nella rete interna dei significati. Se io sono davvero un critico di poesia, non trascurerò, nel farlo, le dimensioni metriche e in generale ritmiche, cercando di individuare il loro specifico contributo al senso complessivo. Analizzarò i campi semantici e le ricorrenze isotopiche, magari identificando relazioni sottili e imprevedibili tra le parti. Alla fine otterrò magari anche un’interpretazione coerente, un senso complessivo sufficientemente unitario. Se lo volessi fare su questi testi, sarei perfettamente in grado di farlo. Serve lavoro, anche parecchio, ma alla fine si ottiene un oggetto critico molto soddisfacente: una specie di sostituto del testo iniziale, certo parziale, ma molto più coerente e conchiuso. È un lavoro che, da bravo semiologo, ho compiuto tantissime volte, sia su testi poetici che su tanti altri tipi di testi (in primis i testi a fumetti, ovviamente). Il problema che mi trovo di fronte in questo momento è che anche se un lavoro di questo genere mi insegna di solito moltissime cose sul testo che ho di fronte, nulla mi dice invece sul perché questo testo mi piace, e sul perché debba eventualmente piacere anche ad altri (cioè ai miei lettori, cui lo sto proponendo). Semmai questo lavoro è esso stesso una conseguenza e manifestazione del fatto che il testo mi piace, e può al contempo fornire una serie di stimoli tali per cui il testo potrà più facilmente piacere a qualcun altro (cioè ai miei lettori). Insomma, il mio lavoro non dice del testo “è bello” in maniera critica, spiegando il perché lo sia; ma si limita a suggerire che, se io, critico, vi ho individuato tanti aspetti interessanti è perché l’ho trovato, nel suo complesso, bello, e che lo stesso potrebbe dunque accadere a te, lettore. Non che questo sia poco, ovviamente; ma continuiamo a trovarci al livello della descrizione del testo, e non del perché esso sia interessante. Facendo un passo più in là, un altro strumento di cui si può fare uso sono le considerazioni di carattere storico-critico. Non la storia vera e propria – che è un altro genere, parente ma diverso dalla critica – bensì il tentativo di trovare il senso nel testo attraverso il rapporto che esso intrattiene con testi antecendenti. Per esempio, potrei argomentare che io trovo un rapporto piuttosto stretto tra le poesie di Inglese e quella di Antonio Porta, specie le sue prime e le ultime (ovvero lasciando in subordine quelle della fase più strettamente legata al gruppo ’63). Affinché un’affermazione del genere abbia davvero valore storico andrebbe sostenuta da qualche riscontro maggiormente oggettivo. Così come la pongo io, invece, non si tratta che di un’ipotesi, avente valore più dal lato del consumo (mio) che dal lato della produzione (dell’autore). Andrea Inglese, infatti, per quanto ne so, è un francesista – per cui magari, più che Porta, andrebbe chiamato in gioco qualche autore francese, che io però non conosco o non conosco abbastanza. Nonostante questo, il riferimento a Porta non è privo di senso. Esso significa, per me, che il piacere che provo leggendo i testi di Inglese è in qualche modo simile a quello che provo leggendo i testi di Porta. Certo non si tratta che di uno spostamento: mi piace Inglese perché mi piace Porta; e Porta, a sua volta, perché mi piace? Tuttavia, per coloro tra i miei lettori che già conoscono e apprezzano Porta, lo spostamento risulta utile, e rappresenta un’indicazione piuttosto chiara: essi possono apprezzare questi testi perché già apprezzano quelli di Porta. Si tratta però, inevitabilmente, di un’indicazione parziale: Inglese non è Porta e (per fortuna) nemmeno lo copia. È un autore differente che porta una qualche somiglianza di famiglia. Ma le considerazioni storico-critiche possono costituire la base anche di un diverso tipo di apprezzamento. Per esempio, se esiste una nostra scelta di campo ideologica che riteniamo debba essere sostenuta, la collocazione del nostro testo all’interno di quel campo potrà costituire una ragione sufficiente per apprezzarlo. Nel nostro caso, per esempio, se fossimo sostenitori di una certa posizione avanguardista o delle sue conseguenze, avvicinare Inglese a Porta potrebbe essere una mossa per valorizzarlo come prosecutore di una determinata tradizione che riteniamo apprezzabile in sé. Agire in questo modo, insomma, sarebbe un po’ come dire che Inglese è dei nostri, e va apprezzato e sostenuto anche solo per questo. Più che critica, questa mi pare comunque attivismo politico. Più che apprezzamento estetico, la definirei militanza. Non è necessariamente un atteggiamento negativo, ma ha in sé poco a che fare con la critica, persino con il suo compito di base di aiutare la comprensione. Nonostante qualche piccolo passo in avanti, sostanzialmente non stiamo uscendo dal dare un senso al testo, e restiamo lontani dallo spiegare perché il testo sia di valore, perché mi piaccia e dovrebbe piacere anche ai miei lettori. Un’altra e differente soluzione mi appare più ingenua e controproducente delle precedenti: è quella che potremmo definire critica impressionista, ovvero il tentativo di rendere l’impressione che il testo produce su di me. Ma come si rende un’impressione? Be’, per esempio in versi, o attraverso una prosa letteraria… Dovrei dunque costruire un secondo testo estetico, che abbia come tema l’esperienza percettiva del primo. Il lettore che apprezzasse il mio testo dovrebbe sentirsi invitato ad apprezzare anche quello di Inglese. Naturalmente, se io fossi un grande scrittore, potrebbe anche capitarmi di produrre un testo critico assai più interessante del testo oggetto. Più frequentemente, invece, accade proprio il contrario, e la critica impressionista non invoglia affatto alla lettura. Gran parte dei commenti ai post dei blog di poesia sono di questo tipo, e lo sono perché l’autore del commento sta cercando un modo per esprimere gli elementi del proprio apprezzamento. Perché dunque (quando non vi siano presupposti ideologici di scelta di campo a sostenerlo) è così difficile spiegare le ragioni del proprio apprezzamento estetico? Dire “mi piace” è facile. Anche dire “non mi piace” è facile, però è più semplice giustificarlo. Per esempio, non mi piacciono le cose banali, che sono quelle in cui ritrovo troppo facilmente delle strutture che già conosco: per dichiarare banale un testo, dunque, non ho che da trovargli degli antecedenti sufficientemente simili. Di conseguenza, trovandomi ora nella situazione opposta, dovrei spiegare nei termini della loro non banalità il perché questi testi mi piacciono. Tuttavia, mentre dire a che cosa qualcosa somiglia può essere facile, è molto più difficile metterne in luce la diversità – tantopiù che c’è sempre qualcosa a cui un qualsiasi testo somiglia, e questo non lo rende ipso facto banale. I testi di Inglese mi ricordano quelli di Porta, ma ne sono comunque sufficientemente lontani da non apparirmi affatto banali. Se si resta fuori dalle scelte di campo ideologiche, l’apprezzamento estetico è qualcosa di sottile e personale. Questo non vuol dire che non sia condivisibile o trasmissibile, poiché – nella diversità individuale – siamo tutti comunque sufficientemente simili da poter avere a volte gli stessi gusti. Ma è comunque questione di sintonia. In altre parole, non riconosciamo che un testo è bello allo stesso modo in cui riconosciamo il suo significato; piuttosto, entriamo in sintonia con esso, e riconosciamo la nostra condizione di sintonia. Per questo, possiamo dare spiegazioni sul significato, ma non possiamo spiegare il bello. Al massimo possiamo aiutare gli altri ad entrare nella nostra medesima condizione di sintonia. Mi resta dunque ancora una possibilità, proprio assumendo questa soggettività dell’esperienza del bello. Quello che posso fare è provare a descrivere l’esperienza, ovvero semplicemente testimoniare il mio vissuto, nell’ipotesi che questo vissuto possa essere, per lo meno, contagioso, e confidando nel fatto che il mio gusto non sia troppo esclusivo. Non è un’operazione facile, perché nel corso della lettura di un testo la nostra attenzione è ovviamente concentrata sul testo stesso, e non sulla nostra esperienza.
Che cosa posso dire, dunque, in concreto, di queste poesie di Andrea Inglese? Mi colpisce, per esempio, il ritmo con cui vengono elencati i concetti, un ritmo piuttosto stringente, ossessivo, con cui mi arrivano una serie di oggetti ed eventi che sono insieme elementi di quotidianità e correlativi di inquietudine. Non ci sono metafore in questi versi, ma solo questo stillicidio di cose, di eventi, di riflessioni, il cui ricorrere cadenzato mi costringe a comparare, ad accostare, come se io stessi percorrendo gli elementi di un racconto, il quale insieme però c’è e non c’è: non succede nulla in verità, eppure le cose appaiono cariche di storia, quasi di presagi. Esco dalla lettura di ciascuno di questi testi con una sensazione inquieta, come se il mondo che mi circonda quotidianamente si fosse riempito di indizi, come se ciascuno degli oggetti mi stesse dicendo “attento, io ho un segreto”, ma poi il segreto non viene disvelato. Lo snocciolarsi degli oggetti del mondo nello snocciolarsi delle proposizioni e dei versi costruisce in me un ritmo di piccoli brividi.
Persino quando, a volte, un accenno di racconto si trova davvero, non è che poi cambi molto le cose. Mi appare quasi come un ordinamento apparente, un modo per organizzare in superficie una dinamica espositiva che rimane comunque quella dell’elenco ossessivo, quella dell’emergenza progressiva di figure inquietanti. Il racconto stesso, in fin dei conti, non è che una di queste figure, e non più importante delle altre. Mi picerebbe scoprire, ora, come fa Inglese a produrre questa sequenza di piccoli brividi. A partire dalle mie sensazioni dovrei dunque analizzare il linguaggio, il metro, le figure, e il modo in cui tutto questo viene messo in successione. Ne otterrei, auspicabilmente, non un’interpretazione critica del testo, non cioè la mia versione della sua verità, ma semplicemente un’ipotesi sul suo funzionamento retorico, cioè sul modo in cui riesce a essere così efficace – efficace su di me, ovviamente, ma forse anche su altri lettori.
La chiamiamo ancora “critica” un’operazione di questo tipo? Io sono convinto di sì. Ma bisogna capire che c’è differenza tra pensare i testi come portatori di una qualche verità, e pensarli piuttosto come meccanismi estetici, o retorici, dove anche la loro eventuale verità non è che un elemento tra gli altri per costruirne l’efficacia. Due consideraioni conclusive: Se, dalla posizione da cui è stata presa questa foto, ci si volta e si attraversa lo spazio mostrato da quest’altra foto, uscendo fuori dal Pudhu Mandapam, questo è quello che si vede. Questa grande statua coloratissima del Toro Nandi è ovviamente rivolta verso il tempio di Shiva che si trova, dopo il Pudhu Mandapam, alle mie spalle. Il Toro Nandi è, per la tradizione shivaita, il proto-asceta, il primo adoratore di Shiva perso nella contemplazione del dio, nell’unione mistica dell’advaita. Eppure, come si può facilmente vedere da questa immagine, si tratta di una figura festosa, quasi allegra – specie se comparata all’immagine che tipicamente abbiamo in Occidente dell’ascesi mistica, fatta di santi emaciati se non flagellati in un contesto decisamente drammatico (anche se più che di santi dovremmo parlare di solito di santini, e il dramma è quello per noi ormai reso ridicolo da secoli di insulsa insistenza ecclesiastica sugli aspetti più spettacolari di qualcosa che dovrebbe piuttosto essere vissuto in maniera esclusivamente interiore). Qui di drammatico mi pare che ci sia molto poco. Di questa foto a me piace il contrasto tra tre elementi così differenti: gli austeri cinquecenteschi propilei del tempio sullo sfondo, il coloratissimo asceta con la lingua fuori, e il traffico quotidiano circostante. Ciascuno di questi elementi, poi, ostenta da sé la propria specifica complessità. Siamo in India, insomma – e comprendiamo quel che possiamo. Volevo scrivere un post sulla poesia; volevo scrive un post su una poesia. Credevo di averla, la poesia su cui scrivere. Poi l’ho riletta, e non era adatta. Ci sono poesie che, quando le togli dal contesto in cui sono state pubblicate, si disfano, non reggono l’isolamento, perdono senso e valore. Questo non significa che siano cattive poesie, ma solo che, come tutta la poesia, sono delicate; sono come un cibo dal sapore così delicato che, se lo combini o lo accosti male non lo senti più, e diventa insignificante, e ti domandi perché te l’abbiano proposto. Così sono andato alla ricerca di poesie un poco più robuste, che almeno potessero reggere l’isolamento dell’autonoma citazione, l’essere messi lì, come testi davvero autonomi, davvero autoconclusivi, così come siamo abituati dai tempi della scuola a considerare le poesie – le quali, certo, testi autoconclusivi lo sono, ma insieme anche no, perché a scuola ogni poesia ci viene propinata insieme con un sacco di informazione e di critica, che la rendono niente affatto autonoma, niente affatto autoconclusiva. Non è certo come leggere una raccolta, un vero libro di poesie (la poesia a scuola è sempre travisata, tradita) ma è comunque qualcosa, una preparazione, un riferimento, un riassunto del contesto che ci fa da sfondo. Che cos’è che rende una poesia sufficientemente robusta (almeno in questo senso) da essere riportata da sola, da essere citata come testo autonomo? Naturalmente non il fatto di essere migliore e certamente non quello di essere peggiore. Forse una certa capacità di crearsi da sola il contesto, e quindi, di conseguenza, una certa forza, un qualche impeto – anche magari a costo di un poco di retorica: per avere forza, un testo deve presentare degli elementi che siano riconoscibili con qualche facilità, e gli elementi riconoscibili sono ovviamente elementi noti. Se non lo fossero, richiederebbero molto più tempo ed energia (e contestualizzazione) per essere compresi; il che non andrebbe necessariamente a scapito della qualità, ma certamente della forza, e dell’autonomia di presentazione. Ho trovato quello che cercavo, dopo qualche tentativo, in un volume di Giovanna Sicari: Epoca Immobile (Jaca Book 2004). Ce n’erano parecchie, lì dentro, di poesie che facevano al caso mio, e ne ho scelte due. Ecco la prima:
La componente retorica è piuttosto evidente: è il tema dell’identificazione dell’io poetico con un escluso, un calpestato, qualcuno che ha ragioni evidenti per star male, un correlativo oggettivo del proprio dolore. A questo va aggiunto un elemento formale meno immediatamente riconoscibile, ma non meno efficace. La prima parte della poesia è costituita da un unico lungo crescendo, in cui, verso dopo verso, aumenta la concitazione e la frequenza degli enjambement – secondo un modello classico stranoto, quello del sonetto di Foscolo A Zacinto. E sarà un caso, ma anche qui, proprio come là, il crescendo dura esattamente undici versi. Non è invece certamente un caso (non perché la Sicari abbia voluto rifarglisi esplicitamente, ma di sicuro ce l’aveva nelle orecchie) che la poesia prosegua con quella chiusa, dove il tono diventa esplicativo e rassegnato; e non è un caso che il primo verso della chiusa sia un endecasillabo, che riprende per un attimo proprio il tono del foscoliano “Tu non altro che il canto avrai del figlio”. Quando si usa il verso libero, l’improvvisa irruzione di uno schema metrico tradizionale (come l’endecasillabo) segna sempre un momento di rilievo, attraverso l’emersione inaspettata di un’eco della tradizione. Potrei continuare, ora, a elencare gli elementi retorici, le riprese da una qualche tradizione. C’è il modo in cui l’immagine della fascetta sul braccio si propone all’inizio del crescendo, e poi si ripropone alla fine, con ben altra densità di significato, ora – anche qui secondo un modello di cui si potrebbero trovare tanti antecendenti. C’è la struttura tripartita della chiusa, sancita da tre “da”, con una classica progressione (in senso musicale), a cui corrisponde, dal punto di vista del senso, un nuovo breve crescendo – che culmina in un tragico ossimoro, quel pomeriggio di luce che potrebbe essere splendido se non fosse infame, perché infame è la vita che lo rende tale. Spiegare una poesia è, inevitabilmente, riportarla al già noto; è quello che il lettore consapevole fa, nell’atto stesso di leggerla. Non si legge poesia né nulla, senza compiere questa operazione. Ma la ragione per cui un componimento poetico ci colpisce non è l’aderenza a una qualche tradizione. Dovremmo dire, semmai, che il componimento ci colpisce e, insieme, aderisce a una qualche tradizione; e attraverso questa coincidenza quella stessa tradizione improvvisamente ritorna viva, e improvvisamente ritorna a rappresentarci, a essere parte attiva di noi. Spiegare le poesie può essere utile, ma se il lettore non ne coglie autonomamente il lampo, la vita, il grido di esistenza, se non sente di colpo la corrispondenza con il proprio stesso sentire, qualsiasi spiegazione è del tutto inutile. La poesia è un meccanismo che mette in relazione il nostro sentire personale, privato, intimo, con quello collettivo e sociale, fatto di tradizione e di regole e di consuetudini e di stratificazioni: solo se riusciamo a sentire entrambe le cose, la poesia funziona (e che oggi, nonostante tutto, la forma dominante di poesia sia ancora la lirica è probabilmente legato al fatto che il nostro sentire personale, privato, intimo, resta legato all’idea di un io ugualmente privato e intimo – ma non è sempre stato così, né è detto che lo debba essere in futuro). Le spiegazioni ci aiutano a imboccare la strada buona, ma se poi non arriviamo a questo sentire unificante, le spiegazioni sono state inutili. La seconda poesia della Sicari è quella che riporto qui sotto, meno drammatica, meno immediatamente riconducibile a strutture note (che però, a saperle ascoltare, ci sono ugualmente). La metto qui, senza commenti. Ho già parlato abbastanza.
Mi sento in dovere di parlare di Giacomo Nanni e mi accorgo che non mi è facile. È bravo, sì, ma non trovo la chiave. Forse è soltanto troppo minimale per me. Non chiedo alle storie di avere una morale, e nemmeno una conclusione. Ma, le sue, non so come prenderle. Potrei dire: semplici spezzoni di vita, cronachette. Ma se così fosse, che interesse avrebbero? Quasi nessuna quotidianità è di per sé più interessante della mia, che già lo è poco. È difficile raccontare la quotidianità perché è difficile selezionarne i luoghi interessanti, e ancora più difficile ricavarne una sequenza interessante. Giacomo Nanni ci riesce? Nelle Cronachette, in effetti sì. Ma in questa Vera storia di Lara Canepa? Non c’è troppa carne al fuoco? Elvis non morto e il figlio nato/non nato, e i sogni inquietanti? Il disegno è volutamente minimale, e questo non è certo un difetto, in sé. Però non aiuta ad andare oltre, e ci rende del tutto prigionieri della storia. Scrivo, questa volta, non per proporre una soluzione, ma per sollecitare dei suggerimenti. C’è qualcuno che vuole provare a suggerirmi che cosa trova in questo libro, e come potrei tornare a leggerlo con meno difficoltà? (Non mi si dica di leggermi le recensioni. Ne ho lette diverse, giustamente lusinghiere e assolutamente evasive nel merito; per il mio problema, inutili). Poiché la persona inquadrata nella foto sono io, e ancora non ho il dono dell’ubiquità (né amo gli autoscatti), è ovvio che questa foto non è stata scattata da me. Ci trovavamo poco lontano da Aleppey (o Alappuzha) nel Kerala. Avevamo preso una barca senza motore, per girare i canali in silenzio. A un certo punto il nostro conduttore ci ha proposto di fermarci per un te. Siamo scesi, e non ci hanno messo di fronte a un tavolino, ma davanti a questa meravigliosa distesa di verde, come se fosse ovvio che eravamo capaci di apprezzarne la bellezza. Ma lo eravamo davvero, e quando il tè è arrivato ci ha fatto appena sorridere il fatto che i nostri ospiti si rendessero conto che non avevamo dove appoggiarlo. Si è rimediato con un’altra sedia. Guardare davanti a noi era così coinvolgente che tutto il resto rimaneva in secondo piano. L’augurio da fare oggi, all’inizio dell’anno, sarebbe che guardare davanti a noi potesse essere ugualmente ispirante. Non viviamo nel paese giusto né nel periodo giusto, ma il primo dell’anno è fatto per illudersi felicemente. Proprio come lo stare seduti su quella sedia.
Chris Ware da McSweeney's Quaterly Concern 2004, pagg. 1 e 2 Ogni volta che torno a guardare questa breve storia a fumetti realizzata da Chris Ware faccio delle piccole scoperte, che mi aiutano a capire i motivi sia della qualità del suo lavoro che quelli dell’effetto gelato che mi trasmette. Le ossessioni produttive di Ware stanno un po’ diventando oggetto delle mie ossessioni, come si può già vedere in questi post. In quello più recente mi ero soffermato sulla struttura complessiva della pagina e sulla costruzione di un effetto quasi mondrianiano attraverso la distribuzione delle vignette e delle linee bianche che le separano. Ora, tornando a osservare queste pagine mi cade l’occhio su un gioco di diagonali, contenuto nelle vignette, che costruisce un interessante contrasto con l’architettura ortogonale complessiva. Se guardiamo le due doppie pagine, possiamo osservare che ciascuna è organizzata attorno a una vignetta centrale, che rappresenta la stanza vuota della protagonista. Le due vignette sono quasi uguali (le riporto qui a fianco), differendo solo nella collocazione temporale diurna o notturna (e nella presenza/assenza di un pezzo di corrimano). Sono caratterizzate entrambe dalla presenza di una linea spezzata che va dal basso a sinistra verso l’alto a destra e separa il pavimento nero dal resto dell’immagine. Si noti che gli angoli di questa spezzata sono tutti uguali, secondo una regola di costruzione assonometrica (e dunque non prospettica), che però non comprenderebbe la diagonale delle scale. Ma pure la seconda spezzata, che separa, in alto, il soffitto dalle pareti, mostra le medesime angolazioni, anche se invertite in due linee diagonali su tre. Qui, tuttavia, non c’è nessuna regola di costruzione assonometrica che imponga questa scelta, che è dunque interamente arbitraria. Infine, se si traccia il prolungamento della prima diagonale a sinistra, questo va a cadere esattamente sulla diagonale del soffitto in alto a destra, rivelando l’accuratezza della costruzione. E si tratta di una costruzione importante: questa immagine si trova al centro delle due doppie pagine, perché la stanza rappresentata è a sua volta al centro del racconto, e ricorre ossessivamente nella sequenza narrativa. Ma non ricorre solo l’immagine della stanza. È la linea spezzata stessa che la caratterizza a ricorrere, in tutto o in parte, con l’ossessione di quegli angoli sempre uguali. La ritroviamo persino nell’inclinazione della testa della protagonista appoggiata sul cuscino quando è a letto, e nei profili dei tetti delle case nelle immagini in esterno. Già l’abbandono della prospettiva a vantaggio dell’assonometria rende freddo e geometrico l’universo di Ware, eliminando concettualmente la presenza di un punto di vista umano – ma poi, questa ricorrenza esasperata delle medesime angolazioni sembra riportare tutto quello che viene mostrato e raccontato a questa medesima logica inumana. Mi sono divertito qui a fianco a togliere dalle doppie pagine le vignette che non riguardano la situazione stanza. Ci si accorge bene, da queste immagini, che persino la distribuzione delle vignette che hanno per oggetto la stanza da letto segue un’organizzazione diagonale, più accennata nella prima doppia pagina e più spiccata nella seconda. Ma ci si accorge anche – eliminando le altre vignette – che c’è una logica moltro stringente nei colori: ai grigi della stanza si aggiungono un azzurro e un ocra (rosso). Se ora torniamo alle pagine vere riportate in alto, ci possiamo accorgere che le vignette qui mancanti sono costruite esattamente su questa coppia di colori, con appena un po’ di verde quando sono in scena i genitori. Insomma, nella monotonia della vita della protagonista, anche la ricorrenza inesorabile dei colori contribuisce a costruire l’impressione che non ci sia via di fuga, se non nella rassegnazione. L’ossessività della costruzione rinvia alla natura ossessiva e ricorsiva del vivere – o almeno alla visione che ne vuole esprimere Ware: gli stessi angoli, gli stessi colori dappertutto, senza scampo. No, non è della mostra di Roma che voglio parlare. Però proprio a causa di quella ho preso in mano la mia vecchia copia di Pertini, Primo Carnera Editore, supplemento di Frigidaire del 1983. Mi ricordavo che non solo a suo tempo mi aveva fatto morire dal ridere (cosa normale da parte di Pazienza) ma che mi aveva anche colpito l’amore e il rispetto manifestati dall’autore nei confronti di Sandro Pertini. Non certo perché Pertini non se li meritasse (caso politico più unico che raro), ma perché mi colpiva allora e continua a colpirmi oggi un’esempio di satira in cui il protagonista non viene massacrato, ma anzi ne esce con simpatia. Per questo, mi sono riletto le pagine di Pazienza, e mi sono reso conto che il vero oggetto della satira non è Pertini ma lui stesso. Non vera satira, dunque, perché su se stessi si può giocare, ma non è possibile massacrarsi. Paz si mette nei panni dell’imbecille, che, con tutta la sua buona volontà, non riesce che a combinare guai. Se di Pert si può vedere parodia, sarà al massimo perché è troppo buono, troppo intelligente, troppo tollerante delle scempiaggini del suo luogotenente. Le storie sono, a loro volta, una più scema dell’altra. Pazienza sembra prendere in giro se stesso anche come autore. Ma è una continua strizzata d’occhio al lettore, a cui si chiede di stare al gioco. Se saremo disposti a starci, ci sganasceremo dalle risate. La comicità vive di meccanismi complicati. Esistono stupidità geniali e altre semplicemente stupide. Sono diverse per un soffio. Pazienza l’aveva quel soffio. L’aveva davvero! |
||
|
Copyright © 2025 Guardare e leggere - All Rights Reserved Powered by WordPress & Atahualpa |
||









 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email













































 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco

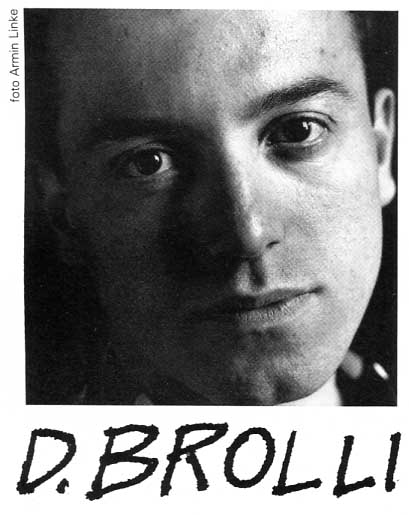






Commenti recenti