Il futuro del fumetto a fumetti
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2000
Nel 1993, stagione ancora dorata per il fumetto americano, usciva negli Stati Uniti un libro destinato a lasciare il segno. Si trattava di un libro a fumetti, come tanti altri; a differenza dagli altri non era però fiction, ma un libro di teoria: un trattato a fumetti sul linguaggio del fumetto. Understanding Comics, di Scott McCloud, non era un manuale, e nemmeno un volume divulgativo. Si trattava di un’autentica riflessione teorica sulle caratteristiche e le possibilità espressive del linguaggio dei comics, espressa con gli strumenti di quello stesso linguaggio, destinato a una lettura attenta e meditativa, e in cui si esprimevano tesi stimolanti e originali, interessanti anche quando non del tutto condivisibili.
Accanto all’interesse per il discorso tenuto da McCloud vi era comunque ciò che rendeva questo libro unico, ovvero il fatto di essere esso stesso realizzato a fumetti. Non era una semplificazione: al contrario, per me come per tutti coloro che sono abituati a trasmettere o ricevere teoria attraverso la parola, l’esposizione a fumetti rendeva tutto più complicato. Anche per questo bisogna sottolineare l’invenzione da parte di McCloud di uno specifico stile espositivo, in cui l’argomentazione riguadagna attraverso l’uso delle immagini quello che lo stesso uso delle immagini fa perdere a un genere tradizionalmente verbale come il trattato teorico. Impossibile è dar conto in queste poche righe della quantità di microinvenzioni retoriche e stilistiche a cui McCloud è riuscito a dar sostanza grafica e grafico-verbale nel suo libro. Nel suo complesso, potremmo dire che Understanding Comics inaugura un genere linguistico, talmente particolare da non avere antecedenti diretti; e così difficile da frequentare, almeno dal punto di vista della produzione, che sino a poco tempo fa non c’erano stati nemmeno susseguenti.
Dopo sette anni di silenzio teorico, Scott McCloud ha dato oggi un seguito alla sua prima fatica. Si chiama Reinventing Comics, e ha, anch’esso, il fumetto come oggetto e come strumento linguistico. In questo volume però l’attenzione di McCloud non è più rivolta al linguaggio, ma a un insieme di questioni che, complessivamente o singolarmente, hanno a che fare con il futuro di questa forma espressiva.
Dal punto di vista stilistico, Reinventing Comics è forse ancora più originale ed efficace dell’altro, segno che l’autore non sta più inventando il proprio linguaggio, ma assestandone le possibilità ed esplorandone nuove soluzioni. E’ però dei suoi contenuti che possiamo più efficacemente parlare qui.
Nella prefazione, anch’essa a fumetti, McCloud individua una rosa di 12 temi chiave per il futuro del fumetto: fumetto come letteratura, fumetto come forma d’arte, diritti degli autori, innovazione nell’industria, percezione da parte del pubblico, valutazione da parte dell’istituzione, equilibrio tra i sessi, rappresentazione delle minoranze, differenziazione dei generi, produzione con strumenti digitali, diffusione con strumenti digitali, fumetti digitali. Ai primi nove temi, di carattere più culturale e sociale, sono dedicati i capitoli della prima parte; agli ultimi tre, che delineano il rapporto tra comics e computer, è dedicata la seconda parte, praticamente metà del volume.
Questo squilibrio non impedisce all’autore di presentare argomenti brillanti per spiegare perché i fumetti, a dispetto delle loro potenzialità, vengono utilizzati soprattutto per produrre fumetti di supereroi per lettori adolescenti. L’analisi delle modalità di vendita dei fumetti e della struttura del mercato mostra con grande evidenza come in queste condizioni il genere che vende di più, cioè quello superomistico, finisca per diventare necessariamente l’unico che si vende, togliendo completamente visibilità e possibilità di diffusione a generi meno vendibili, ma non per questo commercialmente impossibili.
I problemi, rispetto alle posizioni di McCloud, iniziano nella seconda parte. Una delle finalità del libro è infatti di mostrare come la tecnologia digitale e in particolare la diffusione dell’informazione tramite Internet siano candidati ideali per contribuire (talora in maniera decisiva) a risolvere i problemi di qualità, diffusione e considerazione pubblica del fumetto. Non c’è dubbio che McCloud abbia ragione quando mostra come il computer possa aiutare il fumetto tradizionale, anche semplicemente utilizzato come strumento grafico al pari del pennino e del pennello, benché con mille possibilità in più.
Più discutibile è invece la sua proposta di usare Internet per togliere di mezzo la grande editoria e permettere un rapporto diretto tra l’autore e il suo pubblico. Benché l’idea di fondo sia positiva e condivisibile, la possibilità reale di un’operazione di questo genere richiede un prezzo da pagare, e non si tratta di un prezzo da poco. La scomparsa del supporto cartaceo, sostituito dallo schermo del computer, non pone infatti solo i problemi tecnici di cui McCloud dimostra di essere ben consapevole (risoluzione, dimensioni, tempi di accesso, modalità di pagamento ecc.), ma anche dei problemi comunicativi che invece egli sembra ignorare.
Non è vero, infatti, che i fumetti siano “semplicemente” una sequenza di combinazioni di immagini e parole, indipendente dal supporto. Le possibilità che McCloud elenca con entusiasmo verso la fine del libro (pagine grandi a volontà, linee di sequenzialità diverse dal consueto, libertà assoluta nella dimensione delle vignette ecc.) sono in realtà altrettanti motivi di crisi per il linguaggio del fumetto, che si è formato godendo non meno che patendo dei limiti della carta stampata. Senza contare il fatto che una forma espressiva deve sempre fare i conti con le potenzialità tecniche dello strumento di cui fa uso: e il computer ne possiede tali e tante che il fumetto, per quanto “migliorato”, vi farebbe certamente la parte del parente povero, perdendo l’appeal che i limiti della pubblicazione su carta gli forniscono.
(Understanding Comics è stato tradotto con il titolo Capire il fumetto. L’arte invisibile, Vittorio Pavesio Production, 1996. Scott McCloud è raggiungibile su Internet al sito scottmccloud.com)
Scott McCloud, Reinventing Comics, DC Comics, New York, 2000, pp. 252, $19.95
Nei territori semisommersi dell’arte ‘sequenziale’
Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2000
Ho insistito spesso, nei miei interventi su queste pagine, e probabilmente nella maggior parte di loro, su una vena del fumetto che, pur confrontandosi – necessariamente – con l’editoria e il mercato, nasce non da considerazioni di editoria e di mercato, bensì, nella più classica tradizione di quello che in Occidente viene considerato arte, da un bisogno espressivo da parte del proprio autore, un bisogno di raccontare, e, nel caso specifico, di raccontare per immagini.
Una vena piccola, all’interno di un ambiente, quello del fumetto, che è già ristretto di suo. Una vena che costringe gli autori che ne fanno parte a cercare il successo in altre parti del mondo, o a vivere una vita economicamente incerta, perché anche quando questo successo arriva, esso non ha niente a che fare con quello delle star di qualsiasi altra forma espressiva. E se questo può confermare lo stereotipo dell’artista geniale e mal compreso, che il riconoscimento di questo stereotipo valga almeno come indicazione che qui si sta davvero creando qualcosa di interessante, che lotta con mille difficoltà per farsi riconoscere e apprezzare!
Un piccolo ma ben organizzato contributo a far conoscere questo mondo semisommerso ci arriva da un’iniziativa che ha sede presso la Festa Nazionale dell’Unità di Bologna. Si chiama “Territori del racconto a fumetti”, e si compone di una mostra, di una serie di workshop per giovani autori, di una serie di incontri serali per il pubblico, di un libro di interviste agli autori presenti in mostra. Gli organizzatori sono Stefano Ricci, Giovanna Anceschi e Igort. Di loro, i primi due sono anche i curatori della rivista Mano, che conduce con competenza e impegno da alcuni anni un discorso sulla manualità del disegno e della grafica, e di cui il volume-catalogo con le interviste agli autori rappresenta il numero 5.
“Territori” mette in mostra ben 450 tavole di otto autori, provenienti da tutto il mondo: Francesco Altan (Italia), Baru (Francia), Charles Burns, David Mazzucchelli, Adrian Tomine (USA), José Muñoz e Carlo Sampayo (Argentina), Jiro Taniguchi (Giappone). Molto vi sarebbe da dire su ciascuno di loro, e per quanto si possa riassumere, comunque più di quanto potrebbe contenere questo spazio. In comune, piuttosto, questi autori hanno la concezione del fumetto come un mezzo espressivo per costruire testi a più livelli di lettura. C’è chi gioca più sulla provocazione (come Altan, Baru, Burns, Muñoz e Sampayo) e chi più sul personale e biografico (come Mazzucchelli, Tomine e Taniguchi), ma quale che sia l’approccio esteriore il discorso che vi sta dietro è sempre sfumato e multiforme. Del lavoro di ciascuno la mostra ha selezionato aspetti in cui il territorio appare come qualcosa di più di un semplice sfondo, e in cui l’appartenenza a un luogo è un tema centrale.
Non si tratta però di semplici disegnatori. A parte Sampayo, che non disegna affatto, ma scrive le storie insieme con Muñoz (e romanzi per conto proprio), gli altri sono autori di fumetti in senso pieno, autori cioè per cui il disegno è funzionale a un discorso narrativo, per arrivare a produrre quella che Will Eisner ha battezzato sequential art, arte della sequenza, racconto per immagini (e parole). Quello che conta, in essa, non è l’immagine come risultato, ma il testo a fumetti nel suo complesso, nel suo equilibrio globale di narrazione mostrata, di figure che ricevono senso dal loro stesso costruire e dar senso a una storia.
Per comunicare al pubblico (numeroso ogni sera) questa natura solo apparentemente composita del testo a fumetti, “Territori” ha organizzato una serie di incontri con autori ed editori. Ma soprattutto per trasmettere ai giovani autori l’esperienza di autori già affermati, sono stati tenuti ben dodici workshop di tre giorni ciascuno. Oltre a Baru, Muñoz, Sampayo, Taniguchi e Tomine, presenti in mostra, hanno lavorato con un appassionato gruppo di allievi David B., Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Ben Katchor, Lorenzo Mattotti, e anche Igort e Ricci, organizzatori e autori essi stessi.
I giovani che hanno partecipato hanno trovato una situazione che non si incontra né nelle scuole di fumetto né nelle Accademie più illuminate. Non tanto di problemi tecnici si è infatti parlato, quanto dell’esperienza stessa dell’inventare e costruire, del gestire una materia composita, che richiede una competenza altrettanto composita, che è sia grafica che narrativa, e richiede di saper disegnare e di saper scrivere; ma soprattutto impone che nel risultato, nel prodotto finale, questa origine composita non si noti più – non più di quanto, vedendo un film, si possa pensare che è fatto di fotografie e di parole montate. Il confronto, a quanto pare, ha affascinato tanto gli allievi quanto i docenti, contribuendo a creare – ci auguriamo – quell’ambiente di influssi e di scambi di cui la cultura si nutre, e di cui il fumetto (fatto troppo spesso di individui isolati, cresciuti da soli ispirandosi a maestri che non hanno mai conosciuto) avrebbe un grande bisogno.
Il volume, che ha lo stesso titolo della mostra, ed esce come numero 5 di Mano, ci porta, con le sue otto sentite conversazioni, un po’ del profumo che si deve essere respirato in questi incontri. Non vane istruzioni per essere creativi, ma esperienze di persone che hanno creato.
Territori del racconto a fumetti
Mostra, incontri, workshop e volume
Festa Nazionale dell’Unità di Bologna
Sino al 18 settembre
Luce sul Sol Levante
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2000
E’ davvero difficile dare nelle poche righe di un articolo di quotidiano un’idea di che cosa siano il fumetto e il cinema d’animazione giapponese. La difficoltà – per fare un paragone con qualcosa di certamente più noto al lettore – sarebbe analoga a quella di cercare di descrivere in quelle stesse poche righe il cinema americano, trovando una cifra comune a Welles, Allen, Wilder, Altman e ai mille nomi meno noti di un secolo di produzioni. Perché se c’è qualcosa che i due mondi del fumetto e del cinema d’animazione giapponesi hanno in comune con quello del cinema americano è l’enorme quantità di materiale prodotto e in continua produzione, e l’enorme differenza di qualità al loro interno.
Si producono e si leggono più fumetti nel solo Giappone che nel resto del mondo. Si producono e fruiscono più cartoni animati in Giappone che in qualsiasi altro paese. Al punto che, per quanto rilevanti, le esportazioni di questi prodotti rendono ai loro editori assai meno dei consumi all’interno dello stesso Giappone.
E’ dunque naturale che di questa produzione sterminata, creata per un pubblico assetato di narrazioni per immagini, quello che arriva in Occidente non possa che essere una minima parte, della cui scelta non sempre la qualità è il discriminante principale.
E la qualità non è tipicamente neppure la ragione del successo di un prodotto, seppure certamente un qualche tipo di qualità non possa che essere riconosciuta in un prodotto che goda di grande successo. Quale che essa sia, nel nostro caso, è innegabile che, per una via o per un’altra, tubo catodico o carta stampata, l’immaginario giapponese si sia introdotto pesantemente in quello giovanile italiano, dagli anni Settanta in poi.
Come questo sia avvenuto ce lo racconta un ponderoso volume di Marco Pellitteri, dal titolo emblematico: Mazinga nostalgia. Quasi 500 pagine di analisi delle mitologie massmediatiche italiane prima e dopo l’avvento degli anime, i cartoni animati giapponesi, con una minuziosa ricostruzione del modo in cui questi sono entrati nelle televisioni italiane, ne sono stati anche malmenati e censurati, e hanno conquistato il loro pubblico.
L’aspetto più interessante del libro di Pellitteri, che è comunque in generale assai notevole per la precisione e la documentazione (nonché la facilità di lettura), è la rivendicazione dell’autonomia e dell’originalità stilistica delle produzioni giapponesi. L’autore è appassionato nel sostenere – e con argomenti del tutto validi – che il giornalismo e la stampa italiana hanno fatto di tutto per diffondere l’idea che il cinema d’animazione giapponese sia solo una squallida e malriuscita imitazione di quello americano, dimenticando o volutamente tralasciando di considerare i suoi caratteri innovativi. L’animazione giapponese non sarebbe dunque un’animazione più legnosa e povera, ma il prodotto di un diverso sistema di rappresentazione del movimento e del mondo. E il paragone, semmai andasse fatto, non dovrebbe essere tra l’animazione televisiva giapponese e quella cinematografica americana, bensì tra pari – per scoprire che il cinema d’animazione giapponese ha prodotti che ben difficilmente si potrebbero giudicare inferiori a quelli di Walt Disney, mentre nelle produzioni televisive seriali molto spesso le produzioni americane non sono affatto né tecnicamente migliori né particolarmente più educative.
Quello che Pellitteri non fa è di valutare le differenze di qualità all’interno della stessa produzione giapponese. Nella sua prospettiva questa assenza è del tutto giustificata, perché il suo proposito è quello di documentare una porzione dell’immaginario giovanile, e non di tranciare giudizi su cosa sia destinato a restare e cosa no. Ma quando gli stessi prodotti di cui lui parla vengono visti da qualcuno che appartiene a una generazione più vecchia, che non ha vissuto l’invasione giapponese come formativa, queste valutazioni sono inevitabili.
Non mi dispiace affatto, allora, cercare di separare il grano dal loglio, persino quando, dopo la lettura di questo libro, il loglio non mi appare più pernicioso come prima. E rivendico le mie preferenze di educato occidentale, che mi portano a valutare certe storie, personaggi e autori come affascinanti, e altri come educatamente tollerabili.
Tra gli affascinanti – ed è giocoforza limitarsi a quello che l’editoria italiana ha tradotto recentemente – vanno sicuramente le produzioni di Osamu Tezuka, il riconosciuto padre del fumetto e del cinema d’animazione nipponici. Di Tezuka si parla talvolta come del Disney giapponese, ma, qualità a parte, il paragone è fuorviante, se non altro perché i grandi temi politici e ideali che Disney ha sempre escluso dalle sue produzioni sono invece continuamente al centro di quelle di Tezuka, sia nei suoi lavori per bambini che in quelli per adulti.
Rivolto agli adulti per complessità e tematiche (ma certamente assai leggibile anche dai più giovani) è il Budda, in corso di pubblicazione da parte delle edizioni Hazard di Milano. Una storia monumentale: quattordici volumi di oltre duecento pagine ciascuno, che iniziano raccontando di eventi che precedettero la nascita di Siddarta, e proseguono con la sua giovinezza di principe e la sua vita. Come già avevo avuto modo di commentare a proposito de La storia dei tre Adolf, pubblicato da Hazard nel 1998 (vedi Il sole 24 ore, 31.1.1999), il lettore non abituato a questo modo di raccontare potrà talora trovare irritante la presenza di raffigurazioni e situazioni umoristiche in contesti decisamente drammatici. Ma se si arriva ad accettare questo effetto della differenza culturale, ci si accorge passo passo, leggendo le pagine di Tezuka, di essere condotti per mano da un narratore di grandissimo livello, capace di commuoverci talvolta persino mentre pensiamo che quella battuta (per noi) di cattivo gusto se la poteva forse risparmiare…
Gen di Hiroshima, di Keiji Nakazawa, è invece il regalo che fa l’editrice Planet Manga (Panini-Marvel) ai lettori italiani. Una storia pluripremiata, la cui lettura dovrebbe, a mio parere, essere resa obbligatoria nelle scuole dalle medie in poi. Gen è un ragazzino che vive a Hiroshima nel 1945, e vive prima la realtà triste di un paese non libero, dove essere figlio di una persona che non riesce a tacere quello che pensa può essere un grosso problema. E poi, in questa realtà difficile, ma tutto sommato quotidiana, irrompe il 6 agosto, e tutto diventa un inferno.
Hiroshima vista da dentro, insomma, dal mondo degli affetti personali e delle necessità di sopravvivenza di un bambino. Una storia a fumetti che racconta, con la sensibilità e la precisione che vorremmo trovare più spesso nella letteratura ufficiale, uno dei temi ricorrenti dell’immaginario giapponese: quello della catastrofe. Dedicato a chi continua a diffidare dei racconti per immagini del Sol Levante.
Marco Pellitteri
Mazinga nostalgia. Storia, valori e linguaggi della Goldrake-generation.
Castelvecchi 2000. Pp.480, £. 24.000
Osamu Tezuka
Budda
Hazard Edizioni, 1999-2000. Ogni vol. pp. 222, £. 15.000
Keiji Nakazawa
Gen di Hiroshima, vol.1
Planet Manga 1999. Pp. 296, £. 25.000
L’orrore quotidiano genera mostri di carta
Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2000
C’era una volta The Vault of Horror. Insieme con Tales from the Crypt, infiammava l’immaginazione dei giovani americani degli anni Cinquanta. Sin quando il dottor Fredric Wertham, con il suo libro Seduction of the innocents, rese colpevole fin quasi Mickey Mouse di corrompere i giovani, e l’America si chiuse nel proibizionismo culturale.
L’editore di quelle indimenticate riviste si chiamava “EC”, una sigla che stava per Educational Comics. Potrà sembrare una presa in giro, ma non lo era: le storie orrorifiche che apparivano su quelle riviste erano davvero istruttive, realizzate dagli autori migliori di quegli anni, di una qualità narrativa e di un impegno etico che non sarebbero ritornate nel fumetto americano per almeno trent’anni.
Il loro emulo degli anni Sessanta, Creepy (assai più noto in Italia con il nome di Zio Tibia), nato quando l’ondata della caccia alle streghe iniziava a scemare, non era lontanamente all’altezza. La moralità delle storie del decennio precedente era diventata moralismo; gli effetti splatter, che certo non erano mancati neanche allora, erano più frequenti e più gratuiti; gli autori delle storie, per quanto non disprezzabili, facevano quello che potevano.
E’ singolare come nel mondo del comic book americano, il genere horror sia stato più volte quello più progressivo e socialmente impegnato. Certo abbondano le produzioni di qualità più bassa, ma dalla prima metà degli anni Ottanta una parte notevole di tutto ciò che di davvero interessante si è potuto leggere in America appartiene più o meno strettamente a questo genere.
Potrei incominciare un piccolo elenco, tutt’altro – naturalmente – che esaustivo (anche perché mi limiterò a una sola casa editrice, per quanto la più importante nel campo, la DC Comics), con Swamp Thing. Creato nel 1971 da Len Wein e Berni Wrightson, Swamp Thing è in larga misura inizialmente un figliolo di Creepy. Per poco più di un decennio vive la vita letterariamente noiosa del mostro buono e ingiustamente cacciato da tutti, sinché, nel 1983, le sceneggiature vengono date in mano ad Alan Moore, un inglese di grandi promesse. Oggi Moore è uno degli sceneggiatori più quotati del mondo, e tra quelli che hanno prodotto i risultati letterari più interessanti, ma allora era solo un giovane in cui qualcuno aveva fiducia.
La fiducia era ben riposta. Per quattro anni, Moore condusse la vita di Swamp Thing, in maniera irreversibile, verso il ruolo di testimone di tutti gli orrori d’America, da quelli reali a quelli che infestano l’immaginario collettivo – non meno rilevanti per questo. Il genere horror rivelava davvero con queste storie la sua natura originaria: quella di dar luce e forma ai nostri incubi. E le storie di Moore riuscivano così bene perché questi incubi sembravano veramente calati nel nostro quotidiano.
Durante il suo percorso di sceneggiatore di Swamp Thing, Moore creò un personaggio collaterale, John Constantine, una specie di stregone inglese con l’impermeabile alla Humphrey Bogart, l’eterna sigaretta in bocca, e un sarcasmo devastante sulle labbra, unite a un’assai sincera comprensione delle disgrazie cui si trovava di fronte. Nel 1988 Constantine ebbe la sua testata. Hellblazer, affidata inizialmente a un altro inglese, Jamie Delano.
Hellblazer è rapidamente diventata il modello di gran parte del fumetto d’orrore americano da quel momento ad oggi: un misto di vita quotidiana, con i suoi piccoli problemi di amicizie ed amori, salute e lavoro, e di irruzioni di presenze irreali. E’ ovviamente il contrasto a rendere interessante questo modo di presentare le cose, ma anche la chiara percezione che ogni mostruosità irreale è la metafora di una mostruosità assai più reale. The Preacher, il Predicatore, di Garth Ennis, è forse il fumetto che ha portato agli estremi questo contrasto, con una linea di violenza non sempre facile da tollerare, ma spesso riscattata dalla capacità narrativa.
Il mondo fantastico di Swamp Thing ha dato origine anche a un’altra linea di tendenza, in cui l’horror si è lentamente disciolto in mistery o fantasy. The Sandman è stato sceneggiato da Neil Gaiman dal 1989 al 1996, ed è finito quando il suo autore se ne è stancato, nonostante le proteste del pubblico. Il signore dei sogni, Morfeo, vi è talora protagonista talora personaggio collaterale di una serie di incubi, sospesi tra l’orrore vero e proprio e la semplice meraviglia. Anche qui la quotidianità di un universo fantastico si scontra con un’altra quotidianità, la nostra, e con eventi cruciali. Qualcuno l’ha definita la serie a fumetti più poetica mai realizzata. E tutti i suoi lettori hanno sperato che Gaiman cambiasse idea, quando annunciò che smetteva. L’editore ha cercato di rimediare inaugurando un’altra serie, The Dreaming, che con qualche onore porta avanti il medesimo universo fantastico – sempre più lontano dall’horror.
Mentre in casa Hellblazer e Preacher ha recentemente fatto ritorno lo splatter. E le storie si sono fatte ancora più dure. Un sintomo di qualcosa? Non oso interpretare…
Tre illustratori per Dante
Il Sole 24 Ore, 21 novembre 1999
Come illustrare la Divina Commedia senza restare bloccati dall’incontro con gli spettri di Gustave Doré, di William Blake, di Botticelli? Per non dire che dei più grandi, inevitabilmente evocati quando si tenta l’operazione di fare illustrare il racconto più immaginifico e terribile della nostra letteratura. Ci hanno provato le Edizioni (e Galleria) Nuages di Milano, proponendo ciascuna delle tre cantiche a un autore diverso. Deciderà la storia se i nomi di questi illustratori resisteranno al tempo come quelli nominati più sopra. Per ora possiamo limitarci a dire che sono tra i migliori disponibili nel mondo.
Ai tre volumi corrispondono tre esposizioni. Quella di Milton Glaser, autore delle illustrazioni del Purgatorio, si è tenuta dal 29 ottobre al 13 novembre. Quella di Lorenzo Mattotti, autore delle illustrazioni per l‘Inferno, si è aperta il 16 novembre e si chiuderà il 5 dicembre. Quella di Moebius, illustratore del Paradiso, si svolgerà dal 9 al 24 dicembre.
Si tratta di tre proposte illustrative molto diverse tra loro, e anche il confronto è stimolante.
L’Inferno di Mattotti è all’insegna dell’angoscia e del terrore. I colori sono saturi e contrastati e le luci radenti rivelano le forme in un’oscurità rossastra. Le forme sono spesso piegate, contorte. Le figure imponenti e incombenti. Più che il dolore, è la paura a percorrere queste immagini, a volte giocate sulla complessità, e a volte su un’estrema semplificazione: la figura bianca del Caronte “con gli occhi di bragia” si inarca su una forma nera ogivale sospesa su un’acqua di un azzurro irreale, contro uno sfondo rossastro. E’ solo la presenza e il gesto di Caronte a rendere comprensibili le forme che lo contornano. I suoi occhi, per quanto piccoli, sono il fulcro dell’intera immagine.
Anche il Purgatorio di Glaser insegue una semplificazione formale, ma lo spirito è del tutto diverso. Le forme (spesso pure silhouette) e i colori hanno tutti un aspetto allegorico, sembrano sempre rinviare a qualcos’altro. Il tempo vi appare come sospeso; le situazioni narrative suggerite e denegate; gli oggetti carichi di evocazioni. Le immagini a volte si ripetono, variate per colori e rilevanza dei dettagli, così che una stessa situazione narrativa si ritrova talora illustrata due volte. E’ lo stesso Glaser, nella sua breve introduzione al proprio lavoro, a raccontare come questa duplicità, inizialmente suggeritagli dal percorso tecnico con cui ha realizzato le immagini, poteva bene accostarsi allo spirito stesso del Purgatorio, “dove il tempo è interminabile”.
Moebius è forse quello che resta più fedele al proprio modello fumettistico. Il Paradiso appare costellato di nubi e figure umane che paiono torri. Sarà per identità nazionale, o per un comune spirito visionario, le immagini di Moebius sono quelle che più ricordano la figurazione di Doré. Lunghe figure isolate; volti che guardano verso l’alto, o verso il basso… Ma Moebius non può fare a meno di adornare queste figure con gli spettri formali del proprio immaginario: vestiti e copricapi singolari, colori caldi e sfumati; eventi fermati in un gesto che, per quanto evidentemente pacato, consono al luogo, accenna a un divenire che l’immagine nel suo complesso sembrerebbe escludere.
La Divina Commedia ci ritorna, attraverso l’entusiasmo visivo dei suoi tre illustratori, avvicinata, attualizzata. Le angosce, le allegorie, le illuminazioni di Dante continuano ad affascinarci perché sono, evidentemente, le stesse nostre angosce, allegorie, illuminazioni – quando solo si attraversa quel medioevo che tutti e tre gli autori hanno scelto assai coerentemente di dimenticare. Non è perché Dante è vissuto allora che la sua opera continua ad ammaliarci.
Le tre esposizioni saranno riunite in una sola mostra presso la Torre Avogadro di Lumezzane (Brescia) dal 19 febbraio al 16 aprile 2000. I volumi di Glaser e Mattotti si trovano già in libreria; quello di Moebius è imminente.
Dante Alighieri, La Divina Commedia
L’Inferno di Lorenzo Mattotti
Il Purgatorio di Milton Glaser
Il Paradiso di Moebius
Edizioni Nuages, Milano, ogni vol. £.58.000
La galleria ha sede in via Santo Spirito 5, Milano
 Vanna Vinci, “La Casati. La musa egoista”, Rizzoli Lizard 2013, pp. 26-27 Della Marchesa Luisa Casati, famosa per la sua bizzarria, ricchezza e originalità, Vanna Vinci ci dipinge questo ritratto narrativo dall’aria un po’ familiare, un po’ ironica, senza perdere del tutto l’alone di favola che ha sempre circondato la divina Marchesa. Dopo i tanti ritratti pittorici che la Marchesa si è meritata in vita, simbolo sfavillante di un’epoca in cui il simbolismo era tutto, ecco un ritratto a fumetti, meno icastico, forse, meno favoloso, e magari, se la Marchesa lo potesse vedere, meno a lei gradito.
Ma il racconto a fumetti è sì un racconto per immagini, come i dipinti di Boldini o della Brooks, però un racconto stereoscopico, sviluppato, fatto non di intuizione simultanea bensì di pennellate successive. Per cui il fascino ammaliante e un po’ artificioso della Marchesa può ben affiancarsi qui alla sua immagine più personale, con le sue debolezze ironicamente (ma affettuosamente e delicatamente) narrate. O sarà l’aria di famiglia che la Marchesa finisce per avere con altri precedenti personaggi femminili della Vinci, persino con la perfida Bambina Filosofica, che potrebbe esserne la sorella (minore) più smagata e concreta.
Ma quest’aria di famiglia non fa male alla Casati. In fondo l’autrice del libro l’ha scelta perché potrebbe essere benissimo uno dei suoi personaggi; e non ha fatto molta fatica a farla rientrare nel proprio mondo. Decadenza e sarcasmo, occultismo ed eleganza, esibizionismo e timidezza: alla fine, questa biografia sotto forma di graphic novel si legge con una leggera malinconia, quasi un’allegria triste, quasi fosse l’angoscia felice che si può sopravvivere ai propri tempi, diventare un fossile vivente, ridotto in miseria, dimenticato da tutti, e nonostante questo ribadire ancora fieramente la verità della propria scelta – ed essere ricordati anche per questo.
 Changiz Jalayer – (dalla serie “Music without sound”) Ho ricevuto questa foto dall’Iran da un mio ex allievo ISIA che ora vive e lavora a Teheran, la sua città; come fotografo, ovviamente. La trovo così bella e inquietante che (una volta ottenuto il suo permesso) l’ho voluta mettere qui e le voglio dedicare qualche riga di commento.
Ovviamente al fascino della foto contribuisce anche il fatto che provenga dall’Iran. Non sarebbe la stessa cosa se sapessimo che è stata scattata in Italia. Tutto quello che sappiamo sulla grande e antichissima cultura iraniano-persiana, tutto quello che sappiamo sulla condizione non facilissima in cui vivono le donne nel paese, e magari anche un sacco di reminiscenze dai racconti di Marjane Satrapi, entra in gioco qui.
Il punto di prima attenzione è ovviamente il volto della donna, quasi illeggibile, nascosto da questa elegantissima decorazione floreale. È un’identità che viene insieme negata nei suoi dettagli naturali e fortemente affermata attraverso la scelta del tipo di velo. La donna nasconde la sua apparenza e ostenta la sua essenza.
L’arabesco floreale è un modo violento per alludere alla stessa cosa cui allude il gesto deciso con cui le mani tengono il violino e l’archetto, ma è anche un’allusione implicita agli arabeschi musicali che lo strumento è in grado di produrre, proprio attraverso quelle mani. La donna si nasconde ma la violinista si mostra, si manifesta, si ostenta.
A questo punto, il vestito nero su fondo nero finisce per diventare ciò che non importa, ciò che è destinato a mettere in risalto quello che importa: cioè le mani decise, lo strumento, lo sguardo negato eppure come incollato su di noi – ed è davvero difficile distogliere il nostro sguardo da quello che si intuisce dietro i merletti floreali. Di luce ce n’è appena quanto basta per dare realtà, consistenza, volume alla figura: senza l’alone luminoso sullo sfondo e senza il riflesso sul vestito, le parti luminose uscirebbero direttamente dal nulla – e non è questo l’effetto che si sta cercando.
Per tutto questo, questa immagine è comunque una foto sottilmente e inquietantemente erotica. Già è erotica la musica, di per sé; ma qui, quello sguardo suggerito, quelle labbra che si intuiscono, quel braccio nudo e quel piede ancora più nudo in basso sono davvero conturbanti. Poco importa che quella mano e quel piede, a uno sguardo ravvicinato, non appaiano “belli” secondo i criteri vigenti in Occidente. È la forza con cui si impongono, è il mistero che suggeriscono a insinuare in chi guarda l’idea di una femminilità profonda.
Brrrr! Non so se è freddo o caldo a corrermi per la schiena. Spero proprio che Changiz possa fare una splendida carriera. Mi sembra che se la meriti.
 Manu Larcenet, “Blast. II”, Coconino 2013, pp.142-143 È uscito per Coconino il secondo episodio di Blast. Del primo ho parlato in termini entusiastici qui. Del secondo volume dovrei parlare in termini altrettanto entusiastici, ma preferisco rinviare a quello che ho già scritto allora.
Voglio aggiungere solo due cose.
La prima, breve, è che ho la sensazione di trovarmi di fronte a un’opera memorabile, di quelle che lasciano il segno nella storia del fumetto. Ma di questo riparliamo tra una ventina d’anni.
La seconda, un po’ più lunga, è che su questo episodio l’ombra di Simenon si è fatta molto più lieve. Si fatica persino a ricordare che il protagonista sta raccontando una storia che dovrebbe portare a un omicidio. Ma la storia, nel frattempo, è così coinvolgente di per sé che il lettore (cioè io, e magari pure voi) ci si tuffa dentro e ci nuota con grande piacere. La cosa strana, però, è che questo succede nonostante la tensione verso la rivelazione finale si sia molto allentata rispetto al primo episodio: là tutto ci spingeva a leggere gli eventi come premessa al misterioso omicidio; qua l’omicidio è decisamente sul fondo, e stanno in primo piano degli eventi che non sembrano delineare una storia con un qualche fine riconoscibile. Il protagonista, si direbbe, vive, e basta; ed è il suo particolarissimo approccio al mondo a fare la parte del leone, nel gusto del racconto.
È assai probabile che in un prossimo episodio la tensione verso il sapere come è accaduto l’omicidio torni a essere centrale; ma per adesso va benissimo così, con questa fascinosa semidigressione, e questo gusto (anche del protagonista) di raccontare, raccontare, raccontare semplicemente il proprio vissuto.
Da non perdere (a partire dal primo volume, ovviamente).
 Saulne, “Non costa niente”, Coconino 2013, pp. 34-35 È un romanzo estremo Non costa niente, scritto e disegnato da Saulne (Sylvain Limousi), presumibilmente autobiografico. Un giovane francese, in procinto di ricevere una grossa eredità, decide di restare a Shanghai, in attesa del denaro. Decide di non farsi prestare soldi, e di vivere con quel poco che gli resta di liquido, sin quando il notaio non si deciderà a renderlo ricco. Ma la cosa va per le lunghe, e il nostro protagonista esperimenta la fame e la vita a contatto con la gente normale di Shanghai, quel mondo che i suoi conoscenti francesi in loco disdegnano di conoscere.
Si potrebbe interpretare questo libro anche come un esempio di graphic journalism, vista l’attenzione che Saulne riserva ai dettagli della vita e della psicologia dei cinesi di Shanghai, però, in verità – e soprattutto da un certo punto del libro in poi – l’attenzione alla propria vicenda e alle conseguenze della denutrizione diventa dominante, sino a modificare la percezione (e, sulla pagina, la rappresentazione) dei colori: tutto diventa in bianco e nero (persino la carta su cui sono stampate queste pagine si ingrigisce) eccetto i cartigli gialli dei pensieri, e gli occasionali alimenti scorti dal protagonista, sempre coloratissimi, in quanto unico oggetto di attenzione veramente rimasto.
Non ho capito bene se, nel suo complesso, il libro di Saulne mi sia davvero piaciuto oppure no. Da un lato, queste storie autobiografiche solipsistiche si trovano ormai sulla linea della mia capacità di sopportarle – quasi che per reagire alla dimensione iperbolica e semplicistica del fumetto di supereroi, o agli infantilismi più o meno marcati del fumetto di avventura, si possano raccontare solo storie di depressioni personali.
Dall’altro, nonostante questo, Saulne ha una tecnica narrativa originale, un disegno interessante, e ci racconta Shanghai molto molto da vicino, il che non è poco, con gli occhi di un occidentale che cerca di immedesimarsi per quanto può. In questo senso, persino la sua temporanea, ma momentaneamente irrimediabile, povertà rappresenta implicitamente un avvicinamento alla condizione di vita del cinese medio, una volontà di immedesimazione portata all’estremo – che sfugge però al controllo e diventa il metro di tutto.
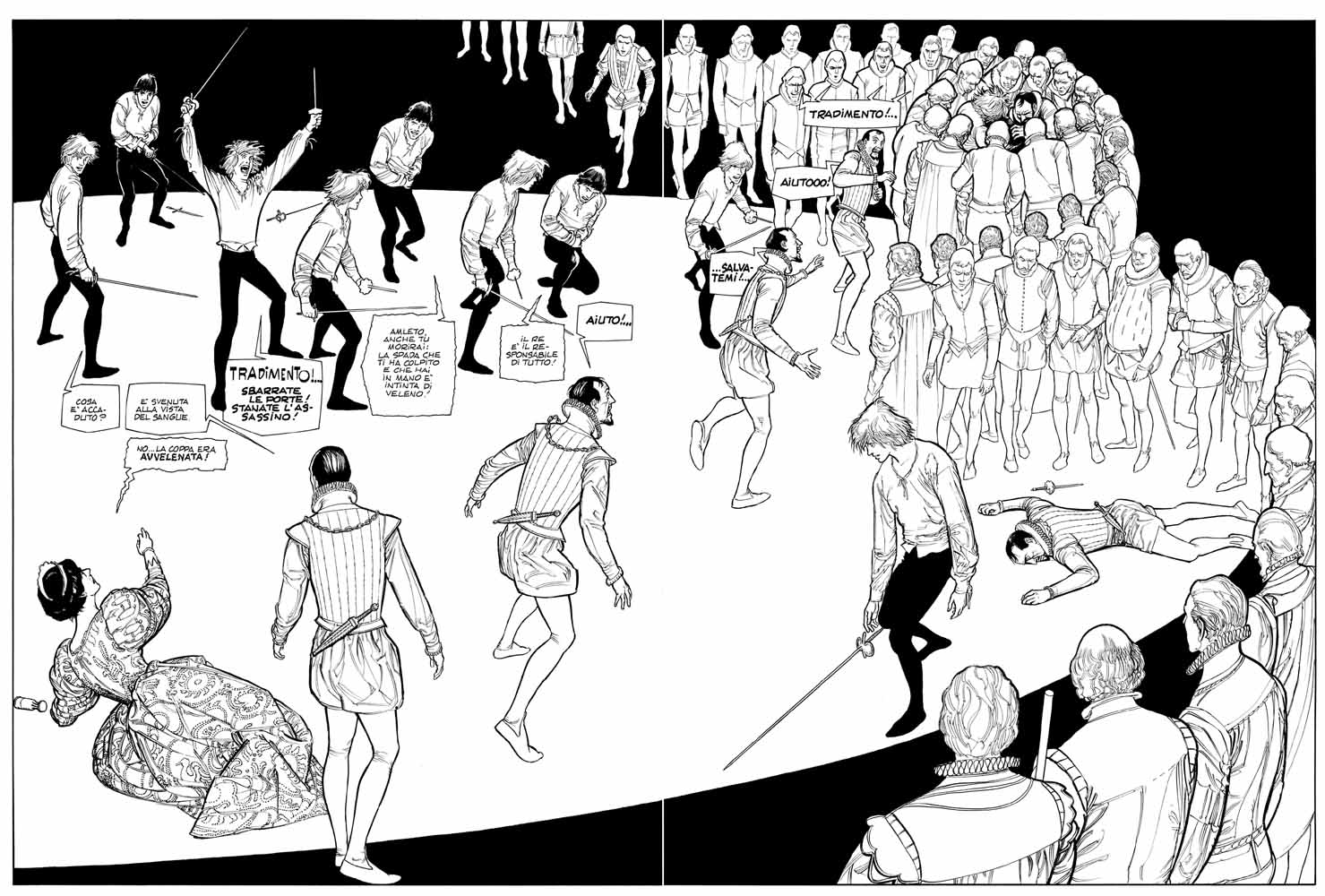 Gianni De Luca, Amleto, tavv 45-46 Rileggendomi le riduzioni shakespeariane di De Luca, mi è venuto da fare un paragone. Come tutti i paragoni, anche questo regge sino a un certo punto; tuttavia, almeno sino a quel punto aiuta a capire qualcosa, a cogliere qualche idea, che poi andrà sviluppata per conto proprio, anche al di là del paragone stesso.
Il paragone è quello col melodramma, ovvero con la riduzione per musica che si fa, ed è più volte stata fatta, da un dramma teatrale per il teatro di prosa a un dramma per musica. Pensate, tanto per restare in tema shakespeariano, all’Otello, e alla sua riduzione verdiana, per esempio.
Che cosa si fa, quando si trasforma un dramma per renderlo adatto alla musica? Prima di tutto si taglia, si taglia moltissimo; e poi si riscrive, affinché le parole siano più adatte al nuovo contesto. Quello che deve restare è una versione essenziale della storia originale, sufficientemente riconoscibile nella sua concisione. Certo, il libretto perde moltissimo dei contenuti della versione originale; ma il libretto non è un testo definitivo, bensì un semplice supporto per un’opera che sarà prima di tutto un’opera musicale. Quello che si perde in termini di azione e dialoghi viene recuperato in termini musicali, se il musicista è sufficientemente bravo. E così, ci sono splendidi melodrammi tratti da drammi mediocri, così come mediocri melodrammi tratti da drammi splendidi, ma anche mediocrità da ambo i lati, oppure capolavori, come nel caso dei due Otello.
Nel caso delle riduzioni shakespeariane di De Luca….
Prosegue su Conversazioni sul Fumetto.
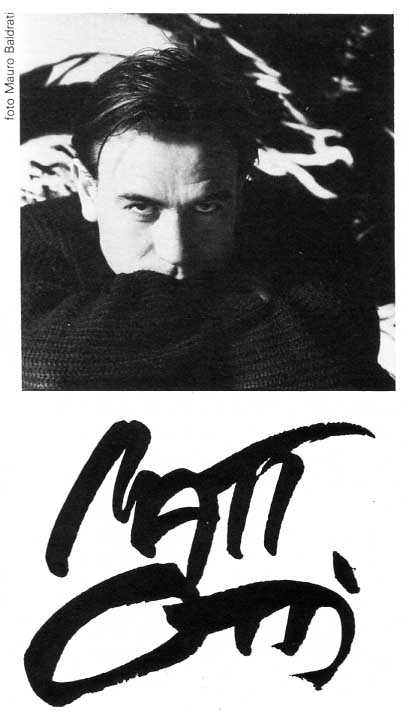 Lorenzo Mattotti 1988 Sono affascinato dal fumetto soprattutto per la sua complessità, come mezzo per la complessità. Per il rapporto tra tre aspetti: le immagini, il ritmo, la sceneggiatura. Quello che più mi interessa è metterle insieme, organizzarle. C’è il problema dell’immagine, della sceneggiatura… le immagini sono fatte di segni, molto spesso sono fatte di colori, la pagina ha una struttura portante, ci sono delle componenti di ritmo… Ogni elemento è necessario alla riuscita di una storia ed è in rapporto stretto con gli altri, per cui deve esistere equilibrio e contemporaneamente tensione. Ora sto parlando semplicemente del mezzo, del rapporto tra la lingua e l’immagine, tra i silenzi e l’immagine solo disegnata che crea tensione, una tensione che esiste tuttavia soltanto se è stata preceduta da un parlato. E queste sono le componenti del ritmo. Poi c’è la struttura della pagina, formata dalle varie vignette, che sono corpi singoli e sono nello stesso tempo in relazione tra loro e con le pagine precedenti. Le vignette sono poi contemporaneamente segno e colore, due elementi anche questi in rapporto tra loro e tra vignetta e vignetta, nell’arco di tutta la storia.
Sicuramente, tra tutto quello che ho fatto, dall’illustrazione alla pittura al cartone animato, il fumetto è il linguaggio che amo di più. Nel cartone animato c’è il movimento, il rapporto col cinema… Ma è quasi tutto detto. Nel fumetto invece c’è un’organizzazione finalizzata a creare qualcosa che in effetti non è detto a priori. Il tempo e il passaggio del tempo hanno un altro valore. Anche nelle immagini più astratte io parto sempre da un’idea narrativa. Anche nelle illustrazioni, per la moda e per la pubblicità, mi piace molto essere narratore. E mi piace raccontare cose molto leggere, impalpabili, anche i silenzi, qualcosa che nel fumetto diventa più difficile esprimere che con altri linguaggi.
***
Il fumetto deve essere una cosa estremamente diretta. Bisogna trovare la tensione giusta, quella che coinvolge il lettore. Se l’immagine, la storia, la forza dell’immagine non riescono a catalizzarlo, allora deve esserci un ritmo naturale, nel quale si entra senza sforzo e affascinati. Non è come nel cinema, in cui sei in una stanza buia, con il volume alto, la grande immagine. Già anche con la televisione sei molto distratto, ma il fumetto ha un rapporto con la concentrazione che è più simile a quello del libro. Il fumetto deve avere un ritmo e delle immagini forti, che catturano subito. Tutto sta sempre sulle righe, nel fumetto.
A volte lo paragono al melodramma: lì i testi sono completamente privi di consistenza, non esistono, però il rapporto con la musica fa sì che se tu ascolti un melodramma seguendo i testi, grazie alla musica essi assumono immediatamente un altro valore. È la musica che li fa volare, per cui ti trovi completamente coinvolto, subito colpito da questo fatto. Penso che si possa tracciare un parallelo tra l’innaturalità che deve avere il fumetto e la struttura dell’opera lirica. Anche nel fumetto puoi inserire dei testi estremamente retorici, forti, che estratti da quel contesto letterariamente non reggono. Però una volta che sono accompagnati alle immagini, ecco che volano anche loro. È comunque importante raccontare delle storie delicate, quasi inesistenti. Non puoi pretendere di concepire le immagini in maniera cinematografica, come fai con la cinepresa, come Andy Warhol che registra un uomo che dorme per otto ore. Nel cinema questo può avere il suo fascino, ma nel fumetto non ti è consentito. Lo puoi fare forzando molto.
***
Una delle più grosse tensioni della mia storia ha riguardato proprio il dover raccontare la realtà e contemporaneamente il disegno, l’immagine. Facevo Incidenti e mi sarebbe piaciuto fare del cinema, volevo catturare con una cinepresa quello che avevo attorno e cercavo di raccontarlo nel fumetto. È stato lì però che ho capito che dovevo accettare la “falsità” del disegno, l’artificiosità completa. E infatti la storia è scoppiata: a un certo punto sono entrati i Sidra, personaggi del tutto irreali. Non potevo andare avanti altre cinquanta pagine tenendo duro con quel rapporto con la realtà, la storia non reggeva, non aveva forza. All’interno dell’artificiosità, invece, a un certo punto si può riuscire a far entrare il lettore in campi o momenti impalpabili, di pure sensazioni. Questo mi interessa molto, e l’ho poi tentato anche con Fuochi, ma diventa possibile far provare, far respirare al lettore l’aria, il colore, il vento, solo dopo che l’hai catturato.
Tutto deve essere quindi sopra le righe. Tutto deve essere vissuto in maniera diretta. Io sento che il racconto funziona se riesco a viverlo in maniera diretta, a costo che le cose possano apparire semplicistiche, semplificate all’osso. A livello personale, penso che le cose funzionino quando le affronto direttamente… la paura, l’amore, la felicità… quando è appagato il mio rapporto con la fisicità dei sentimenti.
Si tratta certo di sentimenti diversi tra loro, ma hanno in comune il fatto di essere fisici. Hanno tutti un rapporto con il sentire. Io sono molto emotivo, molto passionale con il mio lavoro. Non sono concettuale in questo senso, devo sentire il disegno, le emozioni. E cose come la malinconia, la paura, il correre, il rapporto con la natura, se da una parte sono “i grandi temi”, dall’altra sono probabilmente molto romantici, molto emotivi, legati molto alla fisicità. La fisicità che viene fuori anche nei mezzi che uso, mezzi con i quali ho un rapporto molto stretto. Anche quando uso dei materiali leggeri, non particolarmente spessi o pastosi, dalle matite ai pastelli a olio, c’è un rapporto di fatica o di piacere nella stesura dei colori, un gusto per la stratificazione, per il graffio, per l’impasto creato attraverso numerosi passaggi. E quando lavoro con il pennino capisco che le cose migliori vengono fuori quando io sento il pennino: è cioè importante per me il rapporto di sensibilità con la linea e con quello che si sta creando. Il rapporto fisico con la punta, che è estremamente sensibile, diventa un tramite, un prolungamento delle mie emozioni. La mano è in rapporto diretto con il mio sentire e qualsiasi emozione varia il segno. Questo è un rapporto fisico, dove la mia emozione sulla carta mi affascina e mi influenza. È tutto molto legato al corpo, alla mia pelle. Il pennarello, ad esempio, crea tra me e il lavoro un rapporto “di mestiere”, non è proprio una sensazione artigianale, ma in ogni caso sento il distacco. Mentre quando uso la matita e realizzo una storia che già conosco – e quindi può essere mestiere – sento di più il senso del lavoro. Il retino è come il pennarello: mi affascina e alcune volte lo uso, ma non è richiesta una partecipazione fisica, soltanto pazienza e precisione. Mentre la mia precisione è più legata alla rappresentazione esatta del mio sentire e dei miei sentimenti.
***
Il bianco e nero rappresenta un problema, forse per un mio eccesso di controllo. Il bianco mi piace perché è puro. Vorrei lavorare soltanto con il pennino. Mi imbarazza invece il rapporto tra pennino e pennello, perché è difficile contenere le proporzioni e l’equilibrio tra queste due tonalità. Mi piace molto il pennello, così come forse mi piace troppo il nero. Lo uso poco proprio per contenermi, perché quando comincio a usarlo non smetterei più e tendenzialmente farei tutto sul nero, lavorerei sulle penombre totali. Un po’ come Muñoz.
Il nero è estremamente prepotente. In Fuochi a un certo punto ho cominciato a sentire il fascino delle penombre, e ci sono delle vignette in cui sono arrivato a dei punti “limite”, non sapevo nemmeno che risultati di stampa avrei potuto avere. Ma ero così affascinato dalle differenze nell’oscurità che non riuscivo a fermarmi. Lo stesso problema ce l’ho quando comincio ad adoperare il nero. Se mai affronterò una storia in bianco e nero, so che dovrò passare almeno un mese a combatterci.
***
Per quello che riguarda i miei temi, mi interessa la scommessa di riuscire a raccontare delle cose che con il fumetto sono difficili da raccontare, cose che forse appartengono ad altri territori espressivi. Ad esempio, la contemplazione… il cambiamento delle nuvole, l’aria, il colore, sono cose che non generano azione, ma piuttosto degli itinerari interiori. L’idea di riuscire a raccontare queste cose mi affascina, perché non mi interessa il fumetto come serialità, ma il fumetto come scommessa. C’è gente che dice che è impossibile raccontare certe cose; io dico: “Proviamoci. Proviamo a vedere se si può raccontare, se ci si riesce”. Non ho pregiudizi per il mezzo. Lo uso nella sua specificità, senza però limitare la gamma dei temi possibili. Questo non implica la distruzione, non sono per la distruzione del fumetto, ma voglio cercare di lavorare nell’ambito di zone non ancora investigate, zone che molti ritengono inagibili.
È importante insomma vedere se è possibile espandere il campo, prima di dire che non lo è. Certe volte mi sono ritrovato in vicoli ciechi, da cui si entra nella concettualità esasperata, oppure totalmente nella pittura. In Fuochi credo si senta questa tensione enorme tra pittura, intimo, narrazione, eccetera. L’importante è trovare un equilibrio, grazie al quale nulla si distrugge, ma tutto convive al meglio. Capitava che quando c’erano dei sentimenti di un certo tipo da esprimere, mi scattavano fuori le immagini di pittori che io amo e che per me hanno parlato nella mia lingua. Veniva perciò automatico e naturale coglierli, seguire la loro lezione. Certo, esiste anche un mio distacco di lettore, una consapevolezza riguardo alle mie fonti di ispirazione, però devo sentire di essermene completamente appropriato per essere in grado di utilizzarle.
 Valvoforme valvocolori .
.
Questo è l’estratto dell’intervista a Lorenzo Mattotti contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline sono apparse nei giorni precedenti. Qui un’introduzione a Valvoline.
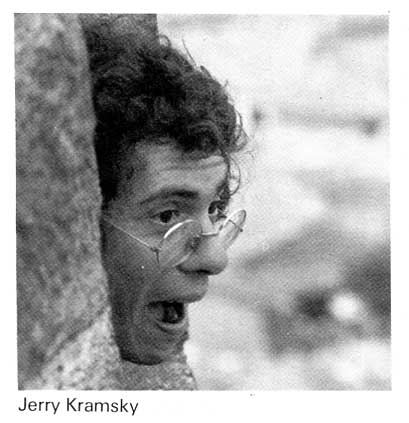 Jerry Kramsky 1988 La mia origine come sceneggiatore è piuttosto casuale. Ho cominciato a scuola a fare sceneggiature per fumetti conoscendo Lorenzo (Mattotti) e scoprendo questa passione in comune. Io, a dire il vero, venivo esclusivamente da Topolino e Jacovitti, e tramite lui ho incominciato a conoscere Asterix, e Linus.
Quelli erano gli anni, penso, in cui uscivano più novità. Avevamo incominciato a guardare anche dei giornali semialternativi: c’era Outside, che non credo sia durato più di un anno, che pubblicava certe storie di fantascienza di Crepax, L’astronave fantasma, e pubblicava anche qualcosa di Druillet. È stato così, adagio adagio, che ci si è interessati a questi autori, che per noi davvero venivano da un altro mondo, e facevano un altro tipo di fumetto, un fumetto che io non avevo nemmeno mai pensato potesse esistere. Era quello il momento – anche come età, credo, sui sedici-diciotto anni – in cui si sentivano gli echi dei vari movimenti, delle manifestazioni, cose che succedevano anche a scuola, cose che ci apparivano come alternative alla nostra realtà quotidiana.
Si era intorno al ’68, ’69…, fino al ’71-’72. Noi abitavamo in un paesetto, per cui le cose arrivavano sempre un anno dopo. Per me poi, che oltretutto non abitavo neanche a Como, e stavo proprio in un paese piccolo piccolo, nella periferia, si apriva proprio un altro mondo. Io avevo visto solo l’oratorio e… non so… i piccoli atti di teppismo paesano. Como mi sembrava una metropoli. Così, c’era attorno a noi tutto questo insieme, questo coinvolgimento a tanti livelli… Insomma, non ho mai pensato al fumetto, e tanto meno alla sceneggiatura, come lavoro. Era più che altro una voglia, un fare qualcosa. Ancora più casuale è stato il mio dirigermi verso la sceneggiatura, perché anch’io facevo disegni, schizzavo qualcosa. Lorenzo e io arrivavamo prima a scuola e incominciavamo a fare lo schizzetto sulla lavagna; e vedendo queste cose scoprivamo che avevamo voglia di farne altre. Dopo di che, strada facendo, ci siamo divisi i compiti, perché lui era più bravo, e allora si guadagnava sul campo il diritto a fare la parte delle immagini.
***
In me c’è Pogo e Krazy Kat, due classici. Mi piaceva moltissimo anche Spirit. E il conoscerli è stato proprio uno sbloccarmi, aprirmi, farmi vedere che potevano esistere altre cose al di là di quelle poche che conoscevo.
E poi ci sono i Moomin. Hanno un po’ un aggancio casalingo, loro. Un altro è Bodé, che però è venuto dopo, quando avevamo già incominciato a produrre qualcosa, e incominciavamo già a svezzarci un po’ di più. E Bodé era più pop, nel senso musicale del termine, più psichedelico se vuoi.
***
Al di fuori del fumetto… c’era, c’è sempre stata, una vaga influenza un po’ da Kerouak, anche se mai molto approfondita, ma che era sintomatica del momento, del tipo di cose che mi arrivavano, come anche quel guardare un po’ all’America; più tramite la musica in effetti, ma comunque come a qualcosa che fosse in un certo senso un faro, una luce guida, qualcosa che fosse avanti. Quello che di alternativo piaceva di più arrivava da lì. Ma questo succedeva solo all’inizio.
Poi, una delle prime cose che mi ha molto influenzato, come spirito, anche se probabilmente non tanto come stile, è stata la fantascienza, quella del tipo più assurdo, quella un po’ sul surreale, come Robert Sheckley o altri che basavano le loro storie sull’esasperazione, sul portare al paradosso delle situazioni molto normali. Mi affascinavano molto quelle situazioni in cui vedevo delle normalità portate alla pazzia.
Anche queste sono però in realtà influenze iniziali, come era stato l’impatto visivo con i lavori di Druillet, molto forti ma destinati un po’ a diluirsi nel tempo. È come con una torta con troppi sapori: dopo un po’ che la mangi incominci a preferire la torta margherita, a sentire anche le sfumature di quest’ultima.
Più avanti, chi ho trovato molto coinvolgente è stato Queneau, con Zazie nel metro, ma anche nelle sue altre cose… e anche Buzzati, una riscoperta dell’Italia. Un’altra cosa che ho sempre cercato infatti, tutto sommato, mi sembra che sia un poco quel suo sottofondo di favola, o anche un po’ di ingenuità.
***
Nel mio fare – adesso forse più coscientemente di prima, ma lo ritrovo in me fin dall’inizio – mi sono sempre molto appassionato alla mia attività; e questo mi ha procurato anche qualche svantaggio, perché in questo modo si ha meno controllo, si può esagerare; ma non sono mai riuscito a fare una cosa solo perché dovevo farla. Ho sempre dovuto crederci molto. Ho sempre dovuto appassionarmi. Quello che provo adesso quando lavoro – e sono contento quando ci riesco – è il lasciarmi andare all’amore verso quello che sto facendo, al trovare il tipo di atmosfera, la storia, la battuta o il dialogo, la parola su cui magari perdo mezz’ora per sentire qual è la variante che mi procuri la sensazione, o qual è il suono che mi convinca di più. Voglio avere ancora questo tipo di sentimento, ma voglio riuscire poi anche a osservarlo con distacco; voglio riuscire a buttare giù lo schizzo della sceneggiatura, del dialogo, con questo grande sentimento, e subito dopo riuscire a guardarlo come se io entrassi in quella stanza e mi dessero in mano il foglio e me lo facessero leggere. Non sempre ci riesco. Non so bene quanto ci riesco. A volte mi sembra di riuscirci, perché quello che trovo… non proprio più difficile, ma più importante per me, quando produco, è cercare appunto di non innamorarmi troppo di una frase o di un periodo o di qualcosa che sta succedendo.
***
La parola lavoro, la parola anche sceneggiatura in se stessa, mi inibiscono abbastanza, perché non riesco a entrare in quello che io immagino che sia il personaggio dello sceneggiatore, nel quale io non mi ritrovo assolutamente. Un altro fatto, collegato a questo, è che lavorando su fumetti di questo tipo, che sconfinano un po’ nella cultura – un’altra parola che uso sempre un po’… che credo di non saper neanche usare bene – a volte non ne sento dentro di me le giustificazioni, nella mia preparazione, in quello che io so, appunto nella mia cultura. Non mi sento molto preparato, professionalmente, in un certo senso, né molto studioso e a conoscenza di un panorama letterario, o di un panorama artistico molto vasto, e quindi mi sembrerebbe di imbrogliare facendo finta di mettere cose di questo genere in quello che sto facendo, perché non sono vere; possono ugualmente esserci, ci sarà probabilmente qualcosa, ma si tratta di cose molto istintive. Cose che poi cerco, col distacco di cui parlavo prima, di vedere e di aggiustare al meglio. Ma per me è ancora qualcosa di molto molto dilettante. Ho provato per certi periodi a fare lo sceneggiatore proprio come mestiere, e avrei anche potuto continuare, secondo me, perché le occasioni c’erano; era anche un momento più facile. Però a quel punto subentrava la non voglia: era il fatto di doverlo fare per lavoro, di dover fare delle cose che ne coinvolgevano anche altre in cui non credevo fino in fondo.
***
Mi ritrovo poi sempre il gusto, più che dello sceneggiatore, del lettore. A me piace, quando rivedo le mie cose, vederle con lo spirito di uno che le sta leggendo, più che di quello che le ha fatte, e questo nel fumetto è abbastanza fattibile, perché il fumetto è principalmente immagine, per cui anche se una tavola, una sequenza è stata realizzata con nessun cambiamento da quello che io avevo scritto, ha un’angolazione, una luce, è comunque qualcosa di molto diverso.
Il metodo di lavoro che io prediligo è quello del discutere la trama, il soggetto più o meno a grandi linee, poi una volta stabilita bene la sequenza, i tempi, le immagini da privilegiare, riprendere in mano la storia con i disegni già finiti, e lì inserire i dialoghi. Magari prima avendo deciso che in un certo punto è meglio la didascalia, in un altro è meglio il balloon, cioè studiando il ritmo che si vuol dare all’insieme.
***
Un’altro discorso che mi piace, quando mi sembra di capire qualcosa di quel poco che ho fatto, è quello dei compromessi. All’inizio Lorenzo e io facevamo pagine di trenta vignette e storie di settanta pagine, e andava così solo perché ci si stancava, se no sarebbero state di centocinquanta. Cioè, grande libertà. E più avanti invece ti accorgi che tante volte se sai usare i compromessi a cui devi sottostare – perché magari hai solo quello spazio a disposizione – alla fine questi ti servono di più. I limiti ti danno più metodo, ti danno una struttura. Da lì cominci a capire che le cose devono avere sotto una struttura che le deve sostenere. Ecco, in questo mi è molto stato di aiuto Queneau, anche nei suoi articoli, nelle sue teorizzazioni, nelle polemiche che aveva con i surrealisti, sul lasciarsi andare oppure nell’avere il canone classico sotto.
***
Una cosa che vedo in me è una mia crescita lenta – una crescita che trovo molto lenta rispetto a quello che potrebbe essere. Affrontando le cose in maniera così giocosa, magari imparo il meccanismo giusto, quello che mi serve, in quattro anni invece che in tre mesi.
 Valvoforme valvocolori .
.
Questo è l’estratto dell’intervista a Jerry Kramsky contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. L’intervista a Lorenzo Mattotti seguirà domani. Qui un’introduzione a Valvoline.
 Charles Burns 1988 Ho iniziato a disegnare fumetti giovanissimo. Prima ancora di imparare a leggere, guardavo fumetti come Tin Tin di Hergé, e Mickey Mouse, e anche Pogo di Walt Kelly. Il fatto è che a mio padre piacevano i fumetti e ne possedeva molti libri, e io avevo perciò anche da giovanissimo la possibilità di leggerli. In America, quando ero piccolo, i fumetti erano considerati una pessima cosa, erano visti come spazzatura, immondizia; e io sono stato in effetti molto fortunato ad avere una famiglia a cui non interessava il fatto che potesse trattarsi di immondizia.
In seguito sono andato a scuola d’arte, e lì ho studiato disegno e pittura e scultura, cose che non sono necessariamente collegate al malconsiderato fumetto. Eppure, a un certo momento della mia vita ho sentito che quello che mi interessava era proprio il suo modo di espressione: mi colpiva il fatto che i fumetti fossero un medium molto accessibile, estremamente poco costoso; non come le belle arti, non come la pittura o la scultura, rispetto alle quali è necessario essere molto ricchi o raffinati per comprendere e per comperare. Bastano pochi soldi per accedere ai fumetti.
Oltre ad Herge, del quale apprezzavo la chiarezza della linea e la chiarezza delle storie – storie molto forti e semplici, ma splendide – sono stato lettore di tutti i vari comic book americani, come i super eroi, Batman, Superman, Spiderman, e così via. Conoscevo anche alcuni buoni fumettisti dei giornali, come Al Capp, che faceva Li’l Abner, Walt Kelly con Pogo, e Chester Gould, che faceva Dick Tracy. Più avanti, quando ho incominciato a crescere, all’epoca dei tredici o quattordici anni, ho conosciuto i fumetti underground, e quella è stata una vera rivelazione: artisti come Robert Crumb, e altri ancora, erano davvero potenti, perché mentre la maggior parte dei fumetti erano per ragazzini e ragazzine, quelli erano per la prima volta fumetti per adulti, che parlavano di cose da adulti.
***
Ho incominciato a interessarmi alla qualità grafica dei miei fumetti molto presto, quando ero ancora molto giovane. Mi interessava disegnare immagini di forte attrazione, mentre mi interessava molto meno raccontare. A un certo punto, tuttavia, circa otto o dieci anni fa, mi sono reso conto che avrei potuto comunicare meglio se avessi potuto disporre della combinazione di una storia – una storia molto forte – e di una grafica altrettanto forte. Penso di essere migliore come artista che come scrittore, ma penso anche che la combinazione di scrittura e immagine crei un tipo di espressione forte, la più forte di cui mi senta capace. Mi sono anche reso conto, a un certo punto della mia vita, che volevo raccontare storie molto chiare e pulite, chiare da un punto di vista grafico, e chiare nella sceneggiatura; e ho cercato da allora di evitare le oscurità inutili, ho cercato di creare le più semplici e chiare presentazioni possibili.
***
Io voglio raccontare storie forti, e per qualche ragione gravito nei mondi delle storie di horror. Quando racconto una storia molto forte qualche volta la trovo troppo seria, e dopo un poco mi rendo conto che è necessario un po’ di umorismo per renderla più appetibile, più accettabile. Penso che humor e horror vadano molto bene assieme; in America il nome è “black humor”, umorismo nero, ed è un buon appellativo. Ci sono molti fumetti di horror in America e sembrano tutti seguire una formula molto semplice, banale; come fa anche il cinema horror americano, nel quale esiste una formula semplicissima per spaventare il pubblico. Per parte mia, io ho cercato di non fare riferimento a queste formule; ho cercato di creare un nuovo stile di horror.
***
E’ comunque piuttosto ovvio, guardando alla maggior parte delle mie storie, che io sono influenzato dalla fiction di genere in generale, e quando si dice fiction di genere si intende, oltre allo horror, anche fantascienza, poliziesco. A dir la verità sono molti quelli che mi hanno domandato se io sia un accanito lettore di romanzi di fantascienza, e la risposta è no. In genere trovo la fantascienza molto noiosa; non mi interessa molto. Quello che mi piace è il romanzo poliziesco americano duro, tradizionale, quello che viene da Raymond Chandler. Tuttavia, non lavoro in senso stretto con questa tradizione; si fa uso delle strutture ma non si rimane nella tradizione. Preferisco usare cose più bizzarre, che parlino degli aspetti strani della cultura americana. In fin dei conti, io uso la struttura del romanzo poliziesco come un metodo per scoprire certi aspetti della cultura americana a cui sono interessato. Uso il mio detective, El Borbah, per esempio, come colui che scopre i fatti, scopre la storia che a me interessa scoprire, qualsiasi siano le strane circostanze che la circondano.
Sono anche piuttosto influenzato dal cinema, specialmente da quello cattivo, dal cinema americano di pessimo livello. Mi è stato già domandato come mai io sia tanto attratto dai film di fantascienza e di horror, quelli peggiori. Non mi è facile spiegare quello che vi trovo. Quando guardo film veramente brutti, da pochi soldi, degli anni quaranta, dei cinquanta o dei sessanta, proprio per il fatto che sono stati realizzati con così poca spesa, pochi mezzi, pessimi attori e pessime sceneggiature, emerge da tutti questi fattori una certa verità, una certa onestà, e questa onestà è difficile da spiegare; ma qualche volta penso che quei film siano più onesti e più trasparenti di quanto non lo siano film più costosi e raffinati, perché in fin dei conti parlano in un linguaggio molto comune, un linguaggio veramente non raffinato. Questi film esistono solo per sfruttare la situazione, esistono solo per ragioni di denaro, e quindi ogni strana verità vi può emergere.
***
I supereroi, e i comic book in generale sono un fenomeno americano, e sono qualcosa a cui io non posso sfuggire. Sono qualcosa insieme con cui io sono cresciuto, e li capisco molto bene; ma continuo a pensare che siano una creazione per ragazzi, per ragazzi dai cinque ai quattordici anni. Ci sono persone che non crescono mai, non superano mai quell’età; a loro i supereroi piacciono sempre. C’è un problema in America, che deriva dal fatto che le persone che crescono leggendo supereroi finiscono poi a disegnare e a scrivere storie di supereroi. Non arrivano loro influenze dal mondo dell’arte, non arriva nessuna influenza al di là di quella dei fumetti di supereroi, e così essi finiscono per produrre brutte versioni di brutti fumetti; producono immondizia in cima all’immondizia. Non creano nulla di nuovo. Imparano, per esempio, a disegnare dai fumetti, e non imparano dalla vita o dalla propria esperienza. Per questo considero i supereroi come responsabili di una situazione pessima, perché non vi è nessuna possibilità di crescita, non vi è luogo ove si possa crescere.
***
Da giovane reagivo contro la pop art perché assomigliava ai fumetti. La pop art assomiglia ai fumetti dei comic book per il suo legame con la narrazione e per il suo umorismo. Ora la apprezzo per queste stesse ragioni: penso che essa sia davvero in buona parte così perché ha distrutto alcune nozioni sulla serietà delle belle arti, e ha dimostrato che si può ricavare arte partendo dall’immondizia. C’è bellezza nel mondo commerciale, c’è qualcosa di interessante in ogni parte del nostro ambiente, se si possiede un occhio buono. Penso che la pop art abbia avuto ragione a distruggere la santità delle belle arti, a distruggere l’atteggiamento che mette le belle arti sul trono.
***
Sono stato in Italia due anni e non parlavo bene italiano. La situazione era sempre quella in cui i componenti del gruppo Valvoline parlavano un ottimo inglese, mentre io parlavo pochissimo o niente italiano. Perciò, ovviamente, per la partecipazione ad un gruppo di artisti, la cosa si presentava piuttosto difficile. Ma penso che più importante sia stato il fatto che potevo finalmente condividere le mie idee su fumetti e grafica con gli altri del gruppo, e loro mi potevano mostrare da vicino quello che facevano e quello a cui erano interessati. La mia partecipazione interiore a Valvoline è stata decisamente positiva e coinvolgente; può sembrare stupido ma la sensazione globale era molto forte.
Mentre ero in Italia mi veniva domandato “Perché non crei un fumetto, una storia sulla tua esperienza in Italia?”, e sebbene fossi molto impressionato dall’Italia, e ne apprezzassi moltissimo la cultura, rimane il fatto che io mi sento comunque troppo strettamente legato alla cultura americana: sono sempre stato americano, che mi piaccia o no. Qualche volta non mi piace, per ragioni politiche molto ovvie, come Ronald Reagan. D’altra parte, i due anni che ho passato in Italia hanno reso la mia visione dell’America molto più forte. Mi hanno messo infatti in grado di guardare la cultura americana da un diverso punto di vista e di capire che è ancora più strana e oscura e brutta di quanto avessi capito prima. In un certo senso la cultura americana è molto forte, ma penso che resti comunque vero che è molto strana, e molto difficile.
Lo horror è il mezzo di espressione che mi piace usare per esprimere la mia visione di questa cultura, la mia visione del lato oscuro dell’America. Come ho già detto, penso anche che ci dovrebbe essere sempre dello humor nello horror, ci dovrebbe essere sempre humor nel lato oscuro; mi sembra cioè, in definitiva, che il modo migliore per esprimere il mio punto di vista sulla cultura americana sia attraverso horror e humor.
 Valvoforme valvocolori .
.
Questo è l’estratto dell’intervista a Charles Burns contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste Jerry Kramsky e Lorenzo Mattotti seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.
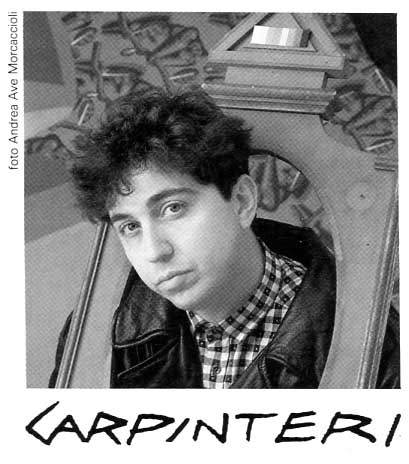 Giorgio Carpinteri 1988 Penso che la ragione per cui ho incominciato a disegnare fumetti sia sostanzialmente generazionale. Come accade frequentemente, la scelta iniziale è legata al caso; ho iniziato a disegnare i miei primi fumetti a undici anni, se non prima, per gioco… Mi piacevano i fumetti, era l’unico tipo di letteratura che da bambino leggevo, e quindi è evidente che per me la comunicazione passasse attraverso un fumetto, una storia, una fiaba, e non attraverso il cinema o la pittura. In poche parole il fumetto coniugava perfettamente le esigenze di un bambino: aveva storia, narrazione e disegno: la capacità di esprimersi attraverso personaggi e atmosfere disegnate.
Poi questa idea di fumetto, questa passione per il fumetto si è sviluppata attraverso diverse fasi. Prima disegnavo perché era il mezzo più espressivo e mi divertiva semplicemente farlo; in seguito il divertimento ha continuato a essere una costante, ma gli elementi che mettevo in gioco col passare degli anni erano evidentemente sempre più ricchi, diversi, e cambiavano secondo la mia età, le mie letture, quello che vedevo intorno a me, e anche secondo la storia stessa del fumetto. Ho passato fasi in cui io stesso sottovalutavo il fumetto, lo consideravo un’arte di serie B. Oggi, dopo un periodo di allontanamento in cui ho lavorato per la televisione, penso che il fumetto sia un’arte favolosa, perfetta, ricchissima, ancora da sfruttare. E quell’intuizione casuale che ebbi da bambino la confermo oggi; anzi sono pronto a ritornare a disegnare fumetti, convinto che siano un campo di ricerca espressiva, di letteratura visiva e non, capace di competere con qualsiasi altro tipo di espressione artistica.
***
Ad un certo momento il mio stile è cambiato, diventando quello che mi ha fatto più conoscere dal pubblico, diventando più geometrico e meccanomorfo. Le ragioni di questo cambiamento sono di ordine espressivo. Era molto più utile per me avere un controllo totale su quello che mettevo in scena. Un’esigenza di ricostruzione del mondo che si soddisfaceva attraverso forme meccaniche, con un alfabeto mentale, umano, prevalentemente razionale, che è quello delle forme geometriche, che consentono il controllo di traiettorie, gesti e movimenti. Il mio procedere meccanomorfo nel ricostruire la realtà attraverso un atomo uguale e immutabile (sia per il mondo animale che per quello vegetale e minerale), questo modo di ricostruire con lo stesso materiale il mio teatrino, tutto di cartapesta, è un metodo che mi è servito ad esercitare più controllo sul mio lavoro. Così come alcuni dei più prestigiosi autori di fumetti italiani si sono conquistati il proprio controllo espressivo appropriandosi della tecnica di autori classici del fumetto americano quali Milton Caniff, io ho soddisfatto la stessa esigenza guardando anche alle esperienze artistiche europee del dopo-Cezanne.
***
Una storia a fumetti nasce da un’intuizione. L’intuizione è un sogno che diventerà sceneggiatura e regia. La prima è la ricostruzione razionale del sogno e il suo inevitabile ampliamento. È la necessità di dare un senso e una scansione logica a quello che si è immaginato.
La seconda è la sua realizzazione visiva: la scelta delle inquadrature, dei colori, del ritmo, ma anche delle tecniche con cui costruire l’immagine.
Il prodotto dell’incontro di questi due elementi è la singola immagine e la somma delle singole immagini: cioè la storia a fumetti. L’armonia e l’equilibrio che legano questi elementi (il contenuto e la forma) determinano lo stile e la riuscita del lavoro.
C’è qualcosa di significativo in ogni intuizione, anche in un’intuizione che prende le mosse per partorire un fumetto. Non vedo nessuna differenza insomma tra un buon libro e un buon fumetto e un buon film e un buon quadro.
***
Il pattern è già di per sé un elemento neutro che si offre come ripetizione di un’immagine, comunque piatto, di sfondo. E quindi narrativamente all’interno di un fumetto deve e può essere usato qualora la narrazione lo consenta per esprimere nel modo più evidente questo suo carattere di neutralità, questo suo carattere di piattezza. In Lichtenstein, per esempio, il pattern era usato come brutalmente preso dal fumetto, cioè era un retino, puntinato o a linee parallele, e lui non osava mutarlo, non aveva nessun senso mutarlo per lui; Lichtenstein ricercava la neutralità, l’astrattezza appunto da macchina, da stampa, e la ritrovava perfetta, la traduceva perfetta sulla tela. A lui non interessava operare una modifica su un pattern di stampa; lo prendeva come significante di per sé. Io se uso il pattern all’interno di una storia lo faccio esclusivamente per fini narrativi.
*****
Il fumetto e la televisione sono due media completamente diversi; anche se la pratica del fumetto è in questo caso un buon punto di partenza per avvicinarsi alla televisione. Apparentemente, lo storyboard di una sigla grafica è un fumetto muto, ma in questo caso il movimento delle sequenze è progettato per diventare reale, non per rimanere virtuale. Il movimento è infatti l’elemento aggiuntivo rispetto al fumetto che determina un radicale mutamento delle regole espressive. La televisione è un fiume di immagini che scorrono, davanti ai nostri occhi senza sosta. Questo flusso di immagini procede per sostituzione. Ogni immagine soppianta la precedente rendendo impossibile il confronto contemporaneo di due singoli fotogrammi. In televisione quindi una buona immagine non è da considerarsi tale se non è realizzata tenendo conto che si tratta di una delle venticinque immagini (fotogrammi) che compongono un secondo.
Naturalmente anche il rapporto immagine-contenuto è diverso, non avendo la sigla televisiva altro scopo se non quello di introdurre il programma o rubrica nel modo più spettacolare e appropriato, fornendo inoltre i titoli di testa. Ciononostante, nelle mie sigle non rinuncio ad elementi narrativi, come ad esempio il mago di Sotto le stelle, il quale nel corso della sigla trasformava stereotipi della stagione invernale in stereotipi della stagione estiva; una sorta di Mandrake dello stereotipo.
Un’altra differenza rispetto al fumetto consiste nell’uso di mezzi tecnologici, e non poveri e artigianali. La conoscenza dello strumento elettronico è fondamentale sia per l’ideazione che per la perfetta realizzazione dell’idea. A volte penso che i veri artisti siano gli ingegneri che ideano e rendono possibili le nuove funzioni del computer.
In televisione infine, al contrario che nel fumetto, non è possibile attuare la realizzazione del prodotto esclusivamente in prima persona. E si impone quindi un metodo di pensiero, prima che di lavoro, tale che trasformi le idee in informazioni inequivocabili, che possano cioè essere trasmesse agli operatori e da questi perfettamente rispettate.
***
Il meccanomorfo, una volta servitomi ad acquistare padronanza di linguaggio, rischiava, col proprio ingombrante significato, di precludermi nuove e più ampie possibilità espressive. L’avere accettato la coesistenza nel mio lavoro sia del controllabile che dell’incontrollabile (come con alcune tecniche coloristiche) è ora fonte di più fertili risultati atmosferici. In ogni caso il fumetto, comunque lo si pensi, rimane fedele alla propria caratteristica fondamentale: l’artigianale povertà di mezzi. Nonostante la diversità di riferimenti e di propositi, mi piace immaginarmi il Jack Kirby di oggi: un cocktail di spettacolarità e tenera povertà di mezzi.
***
Le mie storie, violentemente espressive? Espressive e basta. La violenza è uno dei contenuti da esprimere. Espressive è il mio ottimo, quello che ricerco. Espressività e basta.
 Valvoforme valvocolori .
.
Questo è l’estratto dell’intervista a Giorgio Carpinteri contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.
 Marcello Jori 1988 È per via dell’arte concettuale che mi sono messo a disegnare fumetti. Ho iniziato la mia carriera “ufficiale” di artista in pieno periodo di arte concettuale, e come artista concettuale sono nato. In quel momento, più che soddisfare la mia voglia di manualità e di pittura, cose che ormai non si facevano più, io progettavo i lavori. Il mio era infatti soprattutto un lavoro di progettazione, dopo il quale passavo il progetto agli artigiani, e vedevo realizzate alla fine le mie opere quasi senza toccarle. È stata così questa mancanza di sfogo della manualità a farmi venire una voglia immensa di ricominciare a disegnare e a dipingere; e il fumetto mi sembrava la strada più adatta.
Per di più, l’arte stava diventando totalmente chiusa al mondo esterno; l’artista lavorava su se stesso, lavorava sull’arte, e il lavoro era diventato talmente poco comunicativo che un’altra cosa che mi mancava era proprio la comunicazione, il contatto con il grosso pubblico, il contatto con quel mondo dell’immagine che entrava nelle edicole, dell’immagine che veniva riprodotta: insomma tutto quello che era negato più che mai in quel momento all’artista figurativo. È quindi questo uno dei motivi che mi ha spinto a fare il fumetto; un fumetto comunque, il mio, che era assai poco fumetto, che era quanto di più lontano ci fosse dal fumetto. Un fumetto molto concettuale: ho cominciato a piccoli passi, a piccole dosi. E infatti l’impatto con il pubblico è stato difficile, perché il mio lavoro era quasi offensivo. Io usavo le pagine dei giornali con un segno elementare, usavo magari un’intera pagina per fare una testa, quando invece il pubblico del fumetto allora voleva le pagine piene, voleva il fumetto classico, eccetera eccetera.
All’inizio Minus era di un bianco e nero asciuttissimo, povero povero, elementare, ed è andato poi riempiendosi di colore, e il colore ha introdotto quelle atmosfere, quel lirismo, quella poesia che il personaggio richiedeva. Il colore in Minus è fondamentale, perché è un po’ la poesia del mio fumetto, è quello che riempiva quei grandi vuoti, è quello che creava lo spettacolo in un fumetto che era eccessivamente povero. È ciò che mi permetteva di ricordare, di sognare Klee, cose che non potevo fare in pittura, perché lì non facevo il pittore. Il colore di Minus è influenzato dal colore dell’arte, è influenzato da Klee, da Steinberg, da tutti questi personaggi che stavano altrove e non nel fumetto.
Curiosamente poi, nel momento in cui io passo a Valvoline – e questo è l’unico legame che c’è tra la mia figura di artista e la mia figura di disegnatore di fumetti – nel momento in cui io torno a fare l’artista, cioè ritorno a usare i colori, ad usare le mani, a sfogare la mia manualità, a fare il pittore, ecco che in quel momento incomincio a fare veramente il fumetto fumetto, il vero fumetto; la mia sensibilità ormai gratificata nel mondo dell’arte non aveva infatti più bisogno di fare Minus e di sognare.
E così a questo punto mi è venuta una grande voglia di sottostare a quelle che erano le vere leggi del fumetto, naturalmente da alieno quale ero io, senza in realtà adattarmi perfettamente alle sue regole, ma proprio divertendomi a sbagliare, a finire in altre zone, ad arrivarci anche lentamente, senza copiare nessuno, così come avevo fatto prima con Minus. Il sistema che ho adottato: non guardare nessuno per essere sicuro di arrivare a un prodotto completamente originale, e quindi non guardare neanche come si indica il movimento, come si sintetizzano le cose, niente. Era stato proprio partendo da zero che avevo tentato di ricostruire il mondo con Minus, dove tutto doveva corrispondersi: gli alberi, le case dovevano essere alla Minus. E poi sono ripartito da zero di nuovo nel momento in cui ho incontrato questo gruppo di persone, prima Carpinteri, e poi gli altri amici di Valvoline; ed è stato lì che ho avuto uno dei più grossi impatti emotivi che mi sia mai capitato di avere.
***
Io sono sempre stato un solitario, come artista e anche come fumettista fino a Minus. Ma nel momento in cui tornavo alla pittura da una parte e arrivavo al fumetto vero dall’altra, scoprivo di trovare più energia cosiddetta artistica in questi fumetti che in qualsiasi pittore che in quel momento ci fosse in circolazione. Ho avuto proprio un colpo di fulmine per il lavoro di Carpinteri, di Igort e degli altri. Ed ecco che ci siamo aggregati, senza capire bene il perché all’inizio, perché io in fondo non avevo niente del loro segno. Avevo però una mentalità che poteva combinare con la loro, e trovavo in loro per la prima volta un modo di affrontare il fumetto da artisti, con quella libertà e quella sorpresa, quel mistero che normalmente era solo nell’arte, e non era mai stato nel fumetto in genere. E loro trovavano in me delle attrattive che non trovavano negli altri autori di fumetti. Ed era anche un momento in cui la sperimentazione era forte, e l’entusiasmo era enorme. E tutto questo curiosamente accadeva proprio nel momento in cui riesplodeva la pittura, in cui riesplodeva nell’arte la grande carica emotiva.
All’inizio della mia storia con Valvoline c’è quindi questa voglia di lavorare insieme, e ci sono le mie esperienze con Carpinteri, dove io portavo la mia mentalità, la mia follia, il mio squilibrio da una parte, e lui il suo segno dall’altra. E lavorando insieme arrivavamo a fumetti che non erano mai rigorosamente fumetti, che erano profondamente sperimentali e che continuavano a irritare il pubblico, ma che avevano dentro delle tracce di futuro, di un lavoro interessante.
***
Per arrivare a lavorare con gli altri, per realizzare questa voglia di far fumetto vero, mi sono così convinto a ripartire da zero, a cambiare completamente quello che avevo fatto fino a quel momento, a fare l’opposto di quello che avevo fatto in altri momenti; ma a fare l’opposto anche – almeno a prima vista – dello stile che avevano i miei amici. Ho visto infatti che si stava formando un gruppo molto compatto, compatto anche nello stile, e proprio in quella compattezza, e in quella precisione di stile e impatto notevole vedevo anche la possibilità della fine del gruppo, vedevo il pericolo, la troppa riconoscibilità. E quindi il mio compito, la mia voglia è stata quella di essere il diverso nel gruppo, l’elemento più imprendibile, che avesse la caratteristica della durata nel tempo, che fosse meno consumabile.
Così mi sono quasi violentato. Con quale segno è più difficile fare ricerca, fare avanguardia? Con il realismo. Io sono andato all’opposto di quello che stavano facendo loro. Ho voluto brutalizzare proprio il gruppo, in questo senso, e ho scelto di essere realista fino in fondo, al massimo livello. Sono partito quindi dalla fotografia, per essere al massimo del realismo, per liberarmene poi col passare del tempo. All’inizio il contatto con la fotografia è stato strettissimo, e poi più sono andato avanti e più ho cercato di allontanarmene, arrivando infine ad atmosfere che non sono più legate alla fotografia, ma arrivando ciononostante a uno stile così preciso che anche quando la fotografia non c’è, sembra reale e fotografico quasi allo stesso modo.
Poi, dentro il realismo e oltre il realismo, con la mia prima storia sono andato ancora più a fondo, partendo da quanto di più sgradevole si potesse immaginare in quel momento. Qual era la cosa che interessava in quel momento di meno in assoluto? I contadini, il mondo contadino. Il realismo e il mondo contadino insieme creavano in fondo quanto di meno prevedibile in quel momento si potesse immaginare, e che meno aveva a che fare col lavoro dei miei amici.
***
Mi è difficile parlare del mondo rappresentato nei miei fumetti. Perché io ho sempre lavorato in una condizione di leggera incoscienza, da una parte lucido e preciso, razionale, e dall’altra uno stato di follia e di non lucidità e di non razionalità voluta, che mi serve a creare le storie. È questo che mi fa nascere le idee. Nelle prime storie che pubblicavo su Frigidaire la storia era irreale, addirittura c’era il contratto con l’aldilà: in una di queste storie il protagonista costruisce un fucile e degli occhiali che per la prima volta vedono l’anima, e dopo aver abbattuto un personaggio, indossa gli occhiali, vede l’anima, innesca un secondo colpo e uccide anche quella. Poi arriva a capire di essere mandato da Dio, di non avere nessuna colpa perché il mondo altro, l’aldilà è talmente zeppo di anime che non ne può più contenere; e quindi la prossima guerra necessiterebbe di armi nuove che eliminino anche quelle. Da una parte un realismo totale quindi, e dall’altra una profondissima irrealtà, ma cercando sempre un equilibrio, cercando di agganciare sempre l’attenzione del pubblico con il vero, perché se ti spingi troppo oltre in questo gioco puoi far svanire ogni interesse per la storia.
 Valvoforme valvocolori .
.
Questo è l’estratto dell’intervista a Marcello Jori contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.
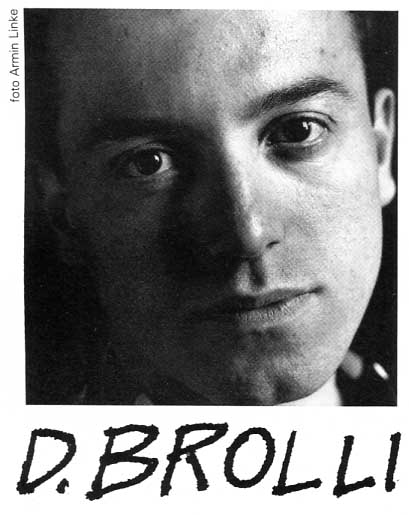 Daniele Brolli 1988 Sono stato per anni un lettore accanito di fumetti. Rispetto a letture d’altro tipo non ho una formazione classica, se non in senso scolastico. Ci sono stati i libri di Salgari, i romanzi di fantascienza, i romanzi gialli, la letteratura di genere e i fumetti. Poi, da un certo periodo in avanti sono comparsi vari interessi per la letteratura d’autore, che mi hanno spinto a scrivere in un certo modo, e mentre prima quello che facevo era solo una riscrittura, la bottega, il senso dell’imitazione, la copia e l’apprendistato, da quel momento in poi è diventato davvero un’invenzione.
Comunque, ritornando ai fumetti, sono stato di preferenza un accanito lettore di Topolino, fino all’abbandono. Già all’inizio, inconsciamente – non per conoscenza vera e propria – tendevo a leggere solo la produzione americana, piuttosto che quella italiana. E poi leggevo tutti i supereroi, non uno escluso, con sogni di superomismo.
Detestavo Linus; e le strip, le ho sempre detestate. Questo accadeva fin verso i sedici anni. Leggevo con molta diffidenza queste cose; però poteva capitarmi di leggere Eureka, o Il Mago, in particolare Roy Crane e Jacovitti. E infatti è tramite Il Mago che ho incominciato a leggere il fumetto d’autore, intendendolo davvero come fumetto d’autore.
Ho incominciato a disegnare a sedici anni, mentre avevo incominciato a scrivere a nove. Ed è stato in quel periodo che ho capito che i fumetti si potevano fare. La radice di tutto stava nella mia passione per il cinema: per esempio la scrittura era per me come una cosa già fatta, che io provavo a fare senza capire bene com’era fatta, e tutto era troppo oscuro per me; invece nel cinema rintracciavo subito il momento, per esempio, di uno stacco nel montaggio. Una volta che avevo scoperto che il cinema non mostrava le cose così com’erano allora in quel momento, vedevo tutto, mentre con la scrittura, anche se capivo, mi era molto più difficile farlo. Il fumetto rappresentava quindi in quel momento una certa possibilità di avvicinarmi a quello che vedevo fatto nel cinema – a quella caratteristica di montaggio, di creazione di mondo. Scoprivo che disegnando potevo riuscire a ricostruire quell’effetto.
E poi, sia per quanto riguarda il disegno che per la scrittura, era una questione di piacere personale. A nove anni scrivevo romanzetti illustrandoli – il che ancora non aveva niente a che fare col disegno vero e proprio del fumetto. E fornivo da leggere le mie cose a tutti i miei compagni di classe… C’era quindi anche questo stimolo della curiosità degli altri che leggevano le mie cose. Una volta che fai una cosa del genere poi – è un meccanismo infantile – ti imitano tutti; e cominciavano a girare un sacco di cose.
Questo è stato il modo in cui mi sono avvicinato al fumetto. Sono sempre stato comunque un fruitore smodato di tutte le cose che mi piacciono, per cui ne ho lette tantissime. Ho già citato qualcosa, ma c’è anche Raymond, c’è Mandrake; ci sono poco i supereroi della DC: mi piacevano meno. Quelli della Marvel li leggevo tutti. Superman non lo sopportavo: lo leggevo perché il mio consumo di fumetti era proprio smodato, ma non lo sopportavo, insieme all’Uomo Atomo, a Flash.
***
In molti miei fumetti ci sono quasi due narrazioni diverse che corrono parallele, una verbale e una visiva, che si contrappongono, e sono pochi quelli in cui la parola è dentro l’immagine, nel senso in cui è normalmente dentro l’immagine nei fumetti, cioè come balloon. Di solito tra le due c’è un rapporto di complementarità e giustapposizione. È così perché spesso trovo insufficiente lo spazio. E allora è questo il metodo per creare una terza via di narrazione. Da una parte ho le immagini che procedono; ma voglio anche poter dire tutto quello che in queste immagini non c’è. Voglio cioè provocare la sensazione come in una fotografia, o come in un’inquadratura: l’inquadratura cinematografica simula il fatto che attorno non ci sia nulla, mentre la fotografia è arrivata a un punto – probabilmente è un fatto storico, di evoluzione dell’arte – in cui tutti sanno che quell’immagine sta per tutto quello che c’è attorno, che non c’è nell’immagine. Ecco, io volevo riunire tutte e due le cose nel fumetto, la parte della narrazione, per cui quella storia ha un rapporto diretto con te perché è tutto quello che c’è da vedere in quel mondo lì – e questo la rende plausibile, perché tutto quello che devi vedere è lì – e l’altra parte dove allo stesso tempo voglio dare la sensazione che c’è tanto altro che tu non stai vedendo, che è altrettanto plausibile, ed è forse importante quasi allo stesso modo per la storia, ma è anche emblematico; e allora questo non lo ottieni costruendo una narrazione troppo realistica, come è quella del balloon, ma attraverso una narrazione più straniante, portando fuori le parole. E allo stesso modo con le parole puoi suggerire tutto quello che non c’è, puoi suggerire qualcosa che banalmente diventa atmosfera, ma è anche un intreccio di situazioni, significati.
Puoi costruire un intero mondo semplicemente creando la sensazione dello spazio vuoto, che non c’è. Per esempio, se tu costruisci troppo realisticamente la sequenza del fumetto, perdi gli spazi bianchi tra le inquadrature, tra disegno e disegno. Invece la maggior parte della storia sta lì dentro, nello spazio bianco; perché se si concepisce la realtà come un arco di punti, per esempio centomila, un romanzo ne può prendere… cinquantamila, poniamo, un film può prenderne diecimila, ma in un fumetto hai una sintesi incredibile, e tutta la storia sta allora in quelle parti bianche che dividono le vignette. Sono quelle che devi potenziare, perchè la capacità di costruire la storia sta proprio lì. E devi costruire un mondo, devi costruire la sensazione che sia qualcosa di articolato, non qualcosa come quello che accade nella produzione di serie. La produzione di serie funziona cancellando quel tipo di cose, appiattendo; invece tu le devi amplificare, ed è con questo che procuri una sensazione più profonda, più duratura.
***
Mi piacerebbe avere una libreria di cose fatte da me tutte nei diversi generi. Per esempio quando ho fatto Alan Hassad volevo fare il melò rosa, e poi l’horror un po’ grottesco con Mortimer Caidin, poi la storia hollywoodiana che sarà Mucho Mas con Fara, e la storia col pupazzo che era Chez Mixioll disegnata da me direttamente. Mi piacerebbe avere un libro di ogni genere, avere fatto un passo dentro ognuna di queste strade, insomma, piuttosto che averne percorsa una fino in fondo. Se ne devo percorrere una fino in fondo è quella che riguarda me e basta. Mi piacerebbe essere una mayor insomma, mi piacerebbe avere una intera casa di produzione hollywoodiana. Mi piace Spielberg per questo, non tanto perché mi piacciano i suoi film, ma perchè mi piace quest’idea di disperdersi… Più sincronica che diacronica. In realtà si esiste in senso diacronico, ci si sviluppa; il tempo si addensa, e questo mi piace. Ma è qualcosa che è già in me, non ho bisogno di sforzarmi. Invece mi piace questa idea di sincronicità del mondo, questo allargarsi, piuttosto che alzarsi.
***
Una delle scoperte brutte della mia infanzia è stato il fatto che il mio rapporto con gli oggetti si trasformava. A un certo punto è stato evidente quale era la loro dimensione. Io non passavo più sotto i tavoli, non avevo più lo stesso rapporto. Si ha un rapporto diverso con lo spazio, con lo spazio della casa.
C’era un’altra cosa, che era, per esempio, addormentarsi sui braccioli delle poltrone, oppure i cuscini sotto il sedere per arrivare al piano del tavolino…
Per quanto mi riguarda, c’è stata una trasformazione improvvisa dal sentire le cose fatte così, fatte per essere grandi, per avere un rapporto benigno, materno, con me, alla dimensione invece del tutto estranea, quella che si lascia dominare – ma che non mi piaceva e non so ancora se mi piace – degli oggetti che son fatti per essere impugnati, per essere usati. Questo è il presente; adesso quelli sono diventati oggetti: io mi sento uguale dentro, come se il tempo non passasse, mentre invece il mio corpo si modifica. E allora mi piace nei fumetti costruire gli oggetti come se fossero delle presenze. Se è umano tutto questo allora sono umane anche loro, e questo mi piace. E poi esiste anche una cultura della fantascienza, in cui l’oggetto si anima davvero, vive: è tutta la fantascienza del periodo d’oro, per esempio, con l’esperienza della possibilità di rendere gli oggetti qualcosa di più che oggetti. Come coi robot, per esempio: per me non c’è differenza tra la poltrona e il robot, o le case che parlano.
I miei interni sono interni che ricordano, perché gli oggetti hanno memoria. Questa è una cosa che mi costringo a dire ma preferirei non dirla; tra poco me ne sarò dimenticato.
A me piacciono le cose già usate, ma che sono ancora nuove. Io leggo i libri tenendoli quasi chiusi, per non rovinarli. E la notizia che vanno in polvere mi ha distrutto. Penso che farò tanti pacchi di plastica, perché questa è una cosa insopportabile. Ma non sopporterei che i libri fossero freddi, che fossero delle cose fuori da me; devono cioè avere questo aspetto usato, ma nuovo. E allora mi corrispondono, altrimenti no. Sarebbero cose che non avrebbero nessun rapporto con quello che faccio io. I libri sono dei parenti, insomma.
Non immagino una produzione di serie dei miei oggetti. Mi fa orrore. Li faccio solo perché so che non verranno mai realizzati, perché se no ci si espone troppo.
***
Sì, potrei riconoscere nell’idea di memoria il punto centrale della mia poetica, ma una memoria che è anche futura. Per me la vera memoria è quella che determina il presente. È quel tempo che ricorda il passato e anticipa di un attimo il futuro, in cui c’è tutto. Io ho un’adesione completa a una teoria “scemo-filosofica” di Vonnegut, a cui io credo lui creda seriamente quanto credo io; che è quella dell’universo, del tempo, non come qualcosa che va, che passa, ma come di una lunga pellicola, in cui tutti i fotogrammi sono segnati per sempre. Un pellicola che non ha inizio e non ha termine, ma in cui ogni fotogramma è identificabile, in maniera precisa; e non è qualcosa che viene distrutto, che va in polvere, ma è qualcosa che ha ancora il suo momento; è ancora lì, e noi siamo ancora qui, in questa pellicola. Ci sono poi tanti altri momenti che vengono dopo e tanti altri momenti che vengono prima. E c’è qualcuno, qualcosa, qualche meccanismo che la fa girare, per cui gira. Quello che è passato rimane indietro, ma sai com’è, se uno lavora alla moviola poi… Può anche fare l’avanzamento veloce… Sì, sì, è la memoria il centro, in questo senso, l’essere il punto di riferimento di tanti altri punti di riferimento che esistono, sia al passato che al futuro. Esiste solo il presente in questa teoria, un presente totale.
 Valvoforme valvocolori .
.
Questo è l’estratto dell’intervista a Daniele Brolli contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.
 Igort 1988 Il metodo che seguo nel mio lavoro è, in generale, abbastanza codificato. Ho come dei percorsi obbligati: non seguo sempre gli stessi, ma si creano in genere delle strade che attraverso e che ripercorro. Uso sempre prendere appunti, molti appunti rispetto a personaggi e situazioni, e i personaggi non nascono mai isolati, ma come parte di un contesto più generale. A partire da questo, poi, il mio metodo tende a fare fluire le cose in maniera abbastanza naturale: si potrebbe dire che tutto il lavoro, come nello Zen, è più un lavoro di preparazione che un lavoro finalizzato all’esecuzione. Quello che mi prende più tempo è il trovare la lunghezza d’onda secondo la quale poi le cose mi vengono naturali.
Parto da un’idea anche vaga, un tipo di situazione, una lunghezza d’onda o un taglio, un modo anche tendente all’astratto di concepire situazioni. Per esempio, ho cercato in passato per mesi dei romanzi, un certo tipo di letteratura – quella che mi interessava di più era americana – che potesse contenere delle componenti di crudezza, qualcosa che di per sé è difficile da definire. All’interno di questa letteratura mi interessava un gioco sulla mitica del crudo, sulla descrizione di una violenza anziché sulla violenza vera e propria. Si trattava di un’intuizione, qualcosa che io stavo inseguendo e che mi interessava, una strada che mi serviva.
Leggo quello che leggo sempre in relazione a ciò che voglio fare; la mia impostazione di lettore tende ad avere la dimensione del furto. Fa parte del mio metodo il non avere mai delle cose aperte o chiuse. Quando sto realizzando una storia non sto solo lavorando a quella storia; ho un continuum, un flusso continuo, lavoro sempre, come Muñoz e Sampayo. Tra le due scelte, tra quella hollywoodiana e quella di Bazin, ho scelto quella di Bazin: cinema come vita, quindi arte come vita; per me lavorare significa che qualsiasi cosa io legga in qualsiasi momento, o qualsiasi cosa pensi, che io sia in dormiveglia o appena salito in studio per lavorare, qualsiasi cosa rimane comunque per me all’interno di un flusso continuo di pensiero, che è sempre finalizzato alla costruzione di un mondo, il mio mondo.
Penso che quello di ispirazione sia un concetto astratto. A me l’ispirazione interessa relativamente poco, perché è come qualcosa che ti piomba addosso – mentre quello che a me interessa è un lavoro di metodo, un lavoro in cui l’ispirazione è solo una parte, è un flash, una marcia in più di un lavoro continuo che consiste principalmente di concentrazione: è come l’ebbrezza di correre, e poi a un certo punto c’è lo scatto e le gambe vanno più veloci; non ti annoi quando corri, sei coinvolto dalla corsa. Per me è lo stesso: io sono astratto completamente quando lavoro. Raggiungo degli stati di concentrazione solida, e poi provo un’enorme difficoltà a riatterrare e occuparmi di altre cose.
***
Lo straniamento è legato a un rapporto abbastanza particolare che ho coi personaggi. Ci sono autori, per esempio, che lavorano con un’idea di partecipazione nei confronti dei personaggi, e altri che lavorano invece con uno stile di odio nei loro confronti, il che significa tutto sommato ancora coinvolgimento. A me interessa invece la possibilità di creare una dimensione che stia tra il raccontare delle passioni molto forti sottovoce e il raccontare usando accorgimenti particolari: raccontare, per esempio, come un personaggio venga sconvolto da una bufera di sentimenti, per mezzo di un barometro che segna la quantità e la qualità di variazioni nel fisico di questo personaggio.
Il rapporto con i personaggi è sempre un rapporto molto complesso, molto difficile, di amore e di odio, ma è tuttavia fondamentalmente un rapporto strumentale. I miei personaggi sono uno strumento per esprimere qualcosa che va oltre il personaggio stesso, un humus, una cifra di umanità, che va espresso non parlando e definendola, non facendo la didascalia dell’umanità, ma tentando di evocare una serie di situazioni che ti conducano a leggerla a partire dal personaggio stesso.
***
Il mio lavoro non è, come potrebbe sembrare da queste dichiarazioni, esistenzialista. Il mio è un lavoro che fa i conti con caratteristiche proprie del linguaggio; mi interessa cioè lavorare sul progetto, inteso come contaminazione possibile e possibile apertura tra elementi che di per sé appaiono a un primo sguardo contraddittori tra loro: i Giapponesi, re dell’elettronica, imperatori di quanto c’è di più imitativo, tecnologico o imprenditoriale – dal punto di vista della aggressività, della asetticità – comprendono poi nella loro stessa disciplina, nella loro cultura, elementi decisamente antitetici rispetto a quelli, elementi di religione; lo Zen deriva dallo Chan giapponese, ma è chiaramente una disciplina spirituale. Quello che ho fatto, mettendoci un pizzico di nonchalance, è stato di portare il tango in Giappone, finendo poi per scoprire da Muñoz che in Argentina arrivano veramente delle orchestre giapponesi, e avere da Sampayo la conferma che queste orchestre lavorano suonando tanghi e cantando in spagnolo, seguendo di fatto dei principi apparentemente caldissimi. Mi piace insomma lavorare per contrasti, utilizzare e unire delle strutture diversissime – come parlare del dolore sorridendo.
Questi aspetti determinano poi l’esistenza di un’altra prospettiva, che è quella del melodramma. All’interno dei miei personaggi ci sono molto spesso storie di grandi passioni, di passioni devastanti, che aprono, squartano il personaggio, non possono essere contenute in un cuore così piccolo, in un cuore di carta come quello di un personaggio. La mia freddezza, anche quando utilizzo la prima persona, nel parlare di queste cose, il fare uso di elementi narrativi estranei, stranianti, mi portano a considerare con un po’ di ironia questi personaggi, queste grandi passioni, questi grandi dolori. È da questo che mi viene la propensione nei confronti del melodramma: a me piacciono anche le cartoline di queste passioni sconvolgenti.
Non mi piace invece la caricatura. Io credo che l’uomo sia anche cartolina; sto molto attento, quando mi documento, a non tradire mai la prima impressione, la freschezza, la facciata delle cose. Anche questo fa parte dell’uomo, e ne è una componente estremamente vera. Credo che all’interno di ciascuno di noi ci sia fondamentalmente un grande interesse nei confronti della prima impressione. E sto attento a utilizzarla anche come chiave per poter entrare in un universo più complesso.
***
Una caratteristica del metodo che mi sono imposto quando ero più giovane – un metodo molto teutonico, rigido, estremamente quadrato – era quella di cercare di capire quale fosse la lunghezza del mio respiro, quale fosse biologicamente la mia possibilità. Io credo di usare il pennino in un certo modo, di fare le cose asimmetriche perché la mia parte sinistra è diversa dalla mia parte destra, perché il mio corpo biologicamente reagisce all’universo in una maniera differente nella mia parte sinistra dalla mia parte destra. E questo si ripercuote nei miei disegni: io teorizzo un disegno mancino, asimmetrico, teorizzo una musica mancina. Non sono però, di fatto, mancino; o, almeno, ho sempre pensato di non esserlo.
***
Per quello che riguarda il mio uso dei colori, credo che c’entri il moderno. Penso che il moderno sia una delle cose di cui mi sono innamorato di più; con un concetto di eleganza, quindi, nel quale quello che si rappresenta non è soltanto un contenuto estetico, ma anche una ricchezza interiore. Il moderno ha anticipato per me qualcosa di quello che sarebbe accaduto poi in Giappone, cioè – non so – una bellezza ghiacciata, nella quale era già contenuta una carica di esistenzialismo congelato – mentre d’altra parte il moderno è tutto un gioco di contrappunti, un gioco di elementi che tra di loro contrastano.
Michelangelo, per esempio, non è elegante; Michelangelo è potente. Quando vidi Berni Wrightson dissi “Questo è Michelangelo elegante”, perché era potente e delicato. Questa capacità così ricca che Berni Wrightson contiene è contenuta anche nel moderno: è freddo e contemporaneamente esistenziale; è il frutto di un distillato che contiene due odori che sono in apparenza contrastanti tra loro, mentre in realtà sono solo elementi sovrapposti; hai una parete rocciosa, la apri e trovi una cosa nuova, come con una noce di cocco. Dentro il nero c’è il bianco. I miei colori tendono a un equilibrio di questo tipo.
Tutte le mie storie nascono da particolari situazioni, e alcune situazioni nascono dall’evocazione di alcuni colori associati, che mi muovono corde interiori. Il rosso carminio e il blu elettrico, se la percentuale del rosso è superiore a quella del blu, per me è antipatia. Questo ha probabilmente qualcosa a che fare con la mia infanzia. Io tendo a sfruttare le mie sensazioni, aprendo il più possibile, entrando in una dimensione quasi catalettica, un territorio neutro, di pace, all’interno del quale penetro tramite la memoria di tipo creativo, artistico. Non saprei ricordare esattamente l’avvenimento a partire dal quale mi sono poi diventati antipatici il rosso e il blu in quella percentuale, né lo voglio fare; non mi interessa farlo. Quello che mi interessa è giocare con questo tipo di situazioni limite: credo che quando riesco a cogliere il cuore di questa mia situazione riesco a evocare veramente l’antipatia, riesco a suscitarla.
Penso insomma che quando fai un lavoro che comincia a toccare delle corde di te, se riesci a esprimerti direttamente – e per questo mi interessa la freschezza – allora veramente riesci a comunicare cose che sono grandi, molto grandi. Il limite di alcuni autori considerati ottimi disegnatori, virtuosi, è il fatto che sono disegnatori, anche se ottimi. Mentre invece un autore come Loustal, che è un disegnatore naif, molto limitato, ha lavorato da subito sulla capacità di esprimere delle situazioni, delle sensazioni, e non di descriverle. E questo gli ha dato la forza di essere un grande autore, non solo un disegnatore.
***
Per quello che riguarda le altre mie attività le cose non stanno diversamente. In musica, per esempio, la parte musicale ridiventa narrativa, nel senso che utilizzo, insieme alle parole, anche i rumori, mischiandoli alla musica, determinando situazioni che ricollegano a una memoria cinematografica. Se tu senti determinati rumori, che sono tipici del cinema, li ricolleghi subito a determinate situazioni visive, perché nella tua mente si sono depositate in quel modo. Un elemento, una chiave comune per tutta la mia produzione è insomma l’evocazione, la capacità di utilizzare delle componenti evocative.
Rispetto alle scenografie, il lavoro è quello di evocare situazioni, per esempio con accostamenti di colori: il colore funziona in maniera astratta, una maniera che è figlia di un atteggiamento disinvolto nei confronti della cultura. L’evocazione è una grande scoperta. Per me è fondamentale. Io penso che la forza di moltissimi artisti sia quella di lavorare non sulla didascalia ma sulla possibilità di alludere. Io sono contro la descrizione e per l’allusione.
 Valvoforme valvocolori .
.
Questo è l’estratto dell’intervista a Igort contenuto nel volume Valvoforme valvocolori. Era il 1988. Le interviste agli altri autori di Valvoline seguiranno nei prossimi giorni. Qui un’introduzione a Valvoline.
 Marco Galli, “Oceania Boulevard”, Coconino 2013 Confesso che non conoscevo Marco Galli. I suoi due libri precedenti mi erano proprio sfuggiti. Questo, però, ha colpito nel segno, molto intensamente.
È una storia un po’ assurda, vagamente da Pasto nudo di Burroughs, che non evita qualche riferimento qua e là all’Alack Sinner di Muñoz e Sampayo, e che riesce a costruire un senso malsano di mistero crescente in maniera non così lontana dal Pennac del vecchio Paradiso degli orchi, ma senza il riscatto morale e in fin dei conti ottimistico di Malaussène & c.
Qui di morale e di ottimistico non sembra rimasto proprio nulla, a parte forse l’apparente mitezza del protagonista. I temi sono quelli dell’hard boiled socialmente impegnato alla Muñoz e Sampayo, con l’approfondimento psicologico dei personaggi… ma tutto è deragliato verso l’assurdo, lo splatter, l’inquietante, a partire dal suicidio iniziale di un venditore televisivo d’arte, che si butta dal trentesimo piano e fa veramente splat, inondando di sangue e frammenti di corpo gli esterrefatti passanti.
Bello questo ritmo costante, apparentemente uguale, delle ricorrenti due vignette per pagina su sfondo nero, accompagnate (ma non sempre) da un racconto esterno oggettivo, secco. Un ritmo sempre uguale su cui si appoggia benissimo il lento ma inesorabile crescendo narrativo, a mano a mano che le indagini avanzano e gli eventi si sviluppano, prendendo pieghe sempre meno prevedibili – mentre la realtà stessa sembra deragliare progressivamente e inevitabilmente, e tutto si rivela diverso da quello che sembrava.
Lungo questo passo così coinvolgente si posizionano poi una serie indimenticabile di cammei di personaggi, dai colleghi poliziotti agli artisti interrogati dall’investigatore (e altri ancora), presi con poche immagini e poche parole, sempre devastanti.
Mi sembra che Marco Galli dimostri una grandissima capacità di sintesi e di ritmo, e allo stesso tempo un’eccellente qualità descrittiva. Ecco qualcosa che al fumetto è possibile molto più che al romanzo: là dove al romanzo per descrivere con precisione sono necessarie molte parole, che magari (se scritte con competenza) non rallentano il ritmo espositivo, ma rallentano per forza quello narrativo, il ritmo dello svilupparsi degli eventi, al fumetto è possibile, grazie all’immagine, e al disegno, descrivere senza fermare l’azione, descrivere nell’azione. Quando si guarda, si vede tutto, l’evoluzione narrativa e l’aspetto di ambiente e personaggi. Ottimo ancora, persino in questo, il segno grafico sottile e lineare di Galli, forte della sua stessa innaturalità.
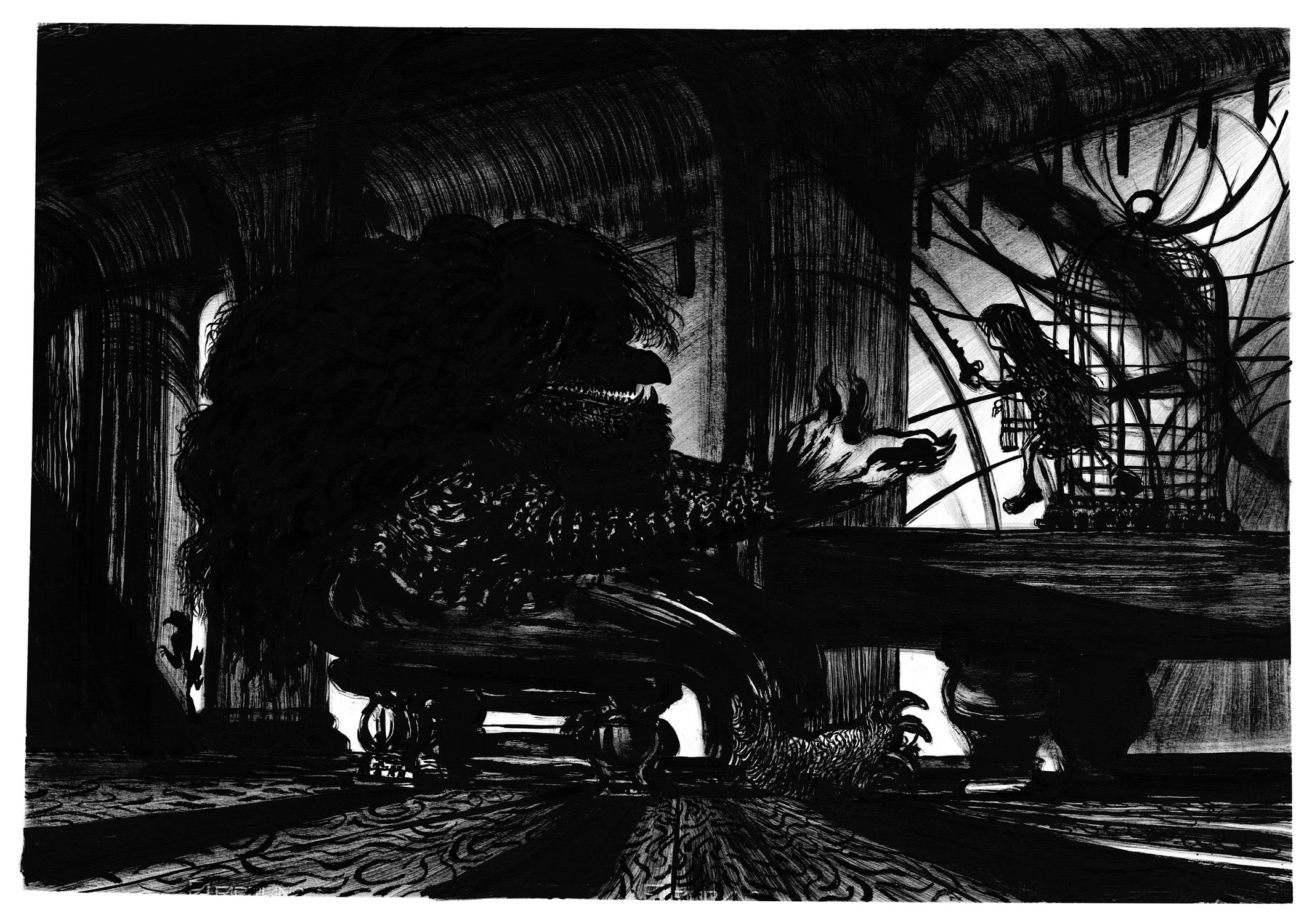 Lorenzo Mattotti, Oltremai (42) Devo aggiungere ancora qualche osservazione a quello che ho detto su Oltremai di Lorenzo Mattotti la scorsa settimana. Si tratta del rapporto con il tema del sublime, un tema che ho sfiorato molte volte (vedi qui, e in particolare qui).
L’innamoramento settecentesco della cultura europea per la nozione di sublime è all’origine tanto del romanzo gotico e dell’horror, quanto del Romanticismo, quanto del mito funzionalista della forma pura. Stupisce un poco pensare che dietro ai lavori di Piet Mondrian e di Howard Phillips Lovecraft ci sia qualche elemento comune (poi, certo, non c’è dubbio che quell’elemento comune si è combinato e contaminato con altri elementi molto diversi tra loro, per arrivare a visioni del mondo così diverse – ma l’aspetto interessante è che l’elemento ci sia!). L’elemento comune potrebbe essere sintetizzato nella parola primitivismo. Per Mondrian si tratta di trovare la forma più semplice, più astratta di tutte, quella che i suo maestri cubisti erano già andati a cercare nell’arte (considerata primitiva) africana, e che lui cerca nei rapporti geometrici e cromatici puri. Per Lovecraft l’horror è l’irruzione nel mondo di forze primitive non controllate, superiori alle nostre possibilità di controllo.
I surrealisti cercheranno questa primitiva purezza nell’inconscio, le neo-avanguardie nella ricerca del grado zero della scrittura, certo non immemori dello sberleffo duchampiano, ambiguo tra l’assunzione di un grado zero totale di significatività artistica e la sua devastante parodia.
La concezione del sublime non è al polo opposto dell’Illuminismo, e non a caso Kant ne è pure il suo maggiore teorico. L’idea stessa che la matematica possa fornire una spiegazione ultima del mondo è un’idea che ha a che fare col sublime. Per quanto possa apparire complessa, il bello della matematica è che tutto può essere riportato a principi più semplici, a principi elementari…
Il problema forse è che, procedendo in questo modo, troppe cose sembrano dipendere da questa idea. Aggiustando un po’ il tiro, possiamo pensare che la riscoperta dello Pseudo-Longino da parte di Boileau e il successivo innamoramento della cultura inglese per le sue idee, siano a loro volta figli dello spirito del tempo; e magari le cose sarebbero andate così anche senza l’affermarsi dell’idea del sublime. Ma, come accade in questi casi, l’idea e la parola che la esprime hanno finito per fare da attrattore, da catalizzatore, per raccogliere e rilanciare quello che era già nell’aria, ma in forma più dispersa. Ed è così che ci possiamo accorgere che lo stesso tipo di tensione sta dietro al razionalismo illuminista, e a quelli che appaiono essere il suo opposto, lo spirito romantico e l’inconscio freudiano.
 Francisco Goya, El sueño de la razón produce monstruos Il famoso Capriccio di Goya, del 1797, El sueño de la razón produce monstruos viene normalmente interpretato (su conferma di altre parole del medesimo Goya) traducendolo come “Il sonno della ragione genera mostri”. Tuttavia, la parola spagnola sueño significa non solo sonno, ma anche sogno. Se seguiamo le parole dei manoscritti di Goya (“La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas.”) penseremo che è quando la ragione non veglia che nascono i mostri. Ma la sua frase originale ci autorizza anche a un’interpretazione diversa: la ragione, quando sogna, produce mostri.
Questi mostri, ancora ignoti a Goya, si possono chiamare oggi libero mercato, comunismo, nazismo, Olocausto, scientismo (che non è la scienza, ma il sogno che tutto sia interamente spiegabile attraverso la scienza). Sono il punto di contatto tra Mondrian e Lovecraft, ciascuno dei due innocente, ma rivelatore nella sua sensibilità.
E Goya ci riporta al nostro punto di partenza, Oltremai di Mattotti, essendone chiaramente un lontano ispiratore (per ammissione, tra l’altro, di Mattotti stesso). Il sublime di Oltremai è quello dei mostri ed è quello di William Turner; è quello del sonno più che del sogno della ragione. Goya poteva ancora pensare alla ragione come alla possibilità del controllo sull’irrazionale, e quindi all’arte come qualcosa che è figlia di questo controllo, esercitato sull’irrazionale fantasia. Goya poteva pensare che la ragione fosse qualcosa che ha a che fare con la classicità, e con la sua tradizionale capacità di controllo; la sua arte non è già più quella classica, ma condivide con quella il controllo, classico, sull’irrazionale.
Due secoli dopo, questi Capricci di Mattotti sembrano essere stati prodotti interamente dal sonno della ragione, attraverso un controllo che non è quello della ragione, non quello del calcolo e nemmeno quello del racconto, e quindi nemmeno quello della classicità. Sono figli dell’improvvisazione musicale e dell’improvvisazione grafica dei calligrafi cinesi e di Jackson Pollock (anche se Mattotti negherà quest’ultima associazione); cioè figli più di un’idea di Stimmung, cioè accordatura, sintonia, che di un’idea di spiegazione razionale (matematica o narrativa che sia).
In questo senso, proprio nel loro assumere i temi inquietanti delle poetiche del sublime, questi lavori si trovano sull’orlo del loro superamento. L’orrore, i mostri, sono diventati semplice inquietudine; non ci soverchiano più, ci conviviamo incertamente, pur senza pretendere di controllarli e di spiegarli. È scomparsa, o sembra scomparsa, la dialettica tra primitivo e matematico. La paura che proviamo non è terrore; l’incapacità di controllare il primitivo non ci soverchia; la semplificazione razionale è fuori gioco. Siamo al di là di Lovecraft e al di là di Mondrian: è il tema in comune all’opposizione tra loro che sta per essere messo fuori gioco.
Sarà forse perché questa dialettica tra controllo razionale e distruttività primitiva è la dialettica del soggetto individuale, pilastro della nostra cultura (ma non di tutte le altre). Sarà forse perché in questi Capricci di Mattotti è proprio il soggetto a essere scomparso…
…stavolta ho incominciato a creare immagini narrative evocandole sul momento. Questa piena libertà che mi sono preso mi obbligava paradossalmente a un’estrema concentrazione sul soggetto e sulla composizione del disegno. Tutto doveva essere contenuto, svolgersi in quell’unica tavola e possedere abbastanza forza da stimolare l’immaginazione di chi l’avrebbe guardata. Ho l’impressione che la mente, in questi casi, si metta all’ascolto di lontani echi narrativi, di storie, simboli e immagini, visti in altri periodi della mia vita. Scava nella memoria e va a pescare immagini rimaste impresse nella mia pinacoteca personale, creando strane associazioni, mescolando miti, personaggi, luoghi. È stato come se l’improvvisazione scartasse le idee di superficie, le inutili decorazioni, e puntasse direttamente all’essenza, potente, nascosta, sotterranea, della visione. Piano piano, si è concretizzato un universo fiabesco senza riferimenti precisi a storie esistenti, un racconto per immagini molto personale. Il pennello e il nero permettono questo linguaggio diretto, senza fronzoli, evocatore ma non descrittivo, misterioso, dove la luce e il buio vestono un ruolo da protagonisti. Sono disegni enigmatici anche per me, fanno parte di quell’esplorazione del “dentro” che ho intrapreso da un bel po’ di tempo ormai e che, in questo caso, si è indirizzata piuttosto verso i luoghi della fiaba, del mito, del fantastico. Ho l’impressione che le immagini si raccontino da sole, in maniera libera, indipendenti da qualsiasi frase con cui avrei potuto accompagnarle. Mi è parso che qualunque parola avessi aggiunto alla loro autonoma narrazione avrebbe solamente limitato l’evocazione affabulatoria che quelle immagini hanno in sé…
 Lorenzo Mattotti, Oltremai (1) Mi fa sorridere pensare che i tre mondi del fumetto, dell’illustrazione e della pittura rivendicheranno come propria quest’opera di Lorenzo Mattotti. Tutti e tre hanno infatti ragioni per farlo, visto che l’autore vive tutte e tre queste realtà. Però Oltremai non è facilmente descrivibile come fumetto, perché non c’è né una sequenza né una storia; non è facilmente descrivibile come illustrazione perché non illustra nulla, e non c’è nessun testo di riferimento; non è facilmente descrivibile come pittura perché supporto e strumento sono atipici, e soprattutto perché fatica a inserirsi nel discorso corrente delle arti visive. Ma “pittura” è comunque il termine più generico dei tre, e solo per questo motivo alla fin fine Oltremai sarà riconosciuta nel suo ambito.
È la terza volta che mi trovo davanti a questi lavori. La prima mi trovavo nello studio di Lorenzo, mentre ancora li stava realizzando. La seconda, era nello splendore del salone della Pinacoteca di Bologna, dove sono stati esposti tutti e 53, uno dopo l’altro in una lunga fila, sino a pochi giorni fa.
Adesso sono a casa mia, e ho davanti il libro, pubblicato da Logos di Modena, stampato e confezionato con estrema cura, che vale pienamente il suo (non indifferente) prezzo. Certo, non sono gli originali; però adesso di fronte a queste curatissime riproduzioni posso prendermi tutto il tempo che voglio, guardare, osservare, tornare indietro, confrontare, ripensarci, metterle via, ripensarci ancora, tirarle fuori, confrontare quel dettaglio con un certo dipinto che ricordavo, pensarci ancora, guardare ancora, rimandare a domani, e poi guardare ancora…
Questi disegni mi fanno un po’ paura. E non sono i mostri che vi appaiono, a spaventarmi. O almeno, non loro direttamente. Ogni tanto mi viene da pensare che questi mostri sono solo i fratelli cresciuti di quelli (selvaggi) di Maurice Sendak. Quindi non spaventano: inquietano.
Ma inquieta anche la bambina, e il bosco, e l’acqua, e il cielo, e persino il paesaggio lontano. Tutte queste cose inquietano, e questo sommarsi di inquietudini mette un po’ i brividi. Ma quello che fa paura davvero è il fatto di riconoscere in queste immagini un sacco di cose che già conosco, e queste cose, qui, non si trovano al loro posto, oppure non stanno nel rapporto corretto tra loro: insomma, sono loro e insieme non lo sono. È così anche per gli stessi mostri, la bambina, i boschi, le acque, i cieli e i paesaggi lontani; ma è così soprattutto per tutti quegli echi di forme che riconosco e che in parte sono come dovrebbero essere e in parte no.
Nelle parole che ho citato all’inizio del post (tratte dall’introduzione del volume), Mattotti spiega come ha lavorato su queste immagini. Sono tutte improvvisazioni, spesso realizzate in un’unica sessione di lavoro (sto aggiungendo qui anche qualche informazione avuta dalla sua stessa voce). Si parte da un segno qualsiasi del pennello sul cartoncino bianco (di grande formato, 100×70), e quel segno ne evoca altri, e questi a loro volta evocano figure, e l’immagine così progressivamente si compone.
Una delle cose che mi piace fare su queste immagini è seguire con l’occhio il gesto del pennello: il gesto che traccia grosse linee ondulate, il gesto che affianca sottili linee diritte, quello che lascia sequenze di macchie vagamente regolari… e poi la rottura improvvisa, quando a un tipo di gesto se ne sostituisce un altro, più netto, più violento, meno iterativo.
È come ascoltare un brano di musica. Ci sono dei temi che ritornano, dei leitmotif, cioè dei motivi portanti (il mostro, la bambina, l’oscurità, il bosco, l’acqua…), ci sono degli andamenti armonici che si susseguono (le varie tessiture, i vari andamenti del gesto…), e c’è questo loro stupefacente avvicendamento. Non c’è una storia?
In verità di storie ce ne sono tante quante sono le immagini, e hanno tutte qualche relazione tra loro; ma non c’è tra loro una continuità. Il che rende tutte queste storie molto vaghe, e non interessanti di per sé. Proprio come in un brano di musica: magari riconosci il momento di furore, o il momento di gioia, o quello di contemplazione estatica, ma non c’è modo di collegarli in un racconto. Eppure la musica funziona lo stesso.
Il fatto è che una storia è già, in sé, una spiegazione. Poter descrivere ciò che osserviamo come parti di una sequenza dotata di senso è qualcosa di confortante, che ci dà l’idea che il mondo sia, almeno in parte, spiegato; e quindi, almeno per quella parte, sotto controllo. In queste immagini, proprio come in musica, questo conforto non c’è. Queste immagini fanno paura perché non sono spiegate, non sono inseribili in un racconto. Sono come quei frammenti di sogno che non riesci a collegare alla sequenza principale, e non sei capace di dar loro un senso, una coerenza narrativa – e per questo motivo o li dimentichi subito (li rimuovi), oppure non li dimentichi mai più.
Un primo riferimento istintivo, per queste immagini di Oltremai, sono le Carceri d’invenzione di Giovanni Battista Piranesi. Certo, in Piranesi c’è molto più progetto di quanto non ci sia qui, non foss’altro per la differenza nella tecnica: l’incisione non permette di sicuro questa libertà d’improvvisazione. Tuttavia, l’oscurità, il senso di grandioso e di oppressivo, e la tessitura fitta delle linee, sono elementi comuni, che portano a un comune senso di inquietudine.
L’altro riferimento inevitabile è quello a Breton e all’automatismo surrealista. Ma in Mattotti è presente una consapevolezza che ai surrealisti era ancora sconosciuta: non si tratta di esplorare l’inconscio alla ricerca della sua forza distruttiva e rivoluzionaria. L’inconscio è forse anche distruttivo e rivoluzionario, ma è pure un sacco di altro cose, e contiene pure il proprio specifico ordine, quell’ordine che l’ordine consapevole non conosce.
L’ordine dell’inconscio è fatto di ritmi e di contrasti, di continuità e di rotture improvvise, di figure note che si rivelano improvvisamente collegate con altre figure note con cui il collegamento non ci dovrebbe essere. Non è l’inconscio di Lorenzo Mattotti quello che mi interessa, bensì piuttosto il fatto che attraverso la sua espressione il mio stesso inconscio si trova a lavorare. È questo che fa la differenza tra il lavoro di Mattotti che sfrutta il proprio inconscio e il lavoro di un Pinco Pallino qualsiasi che va dallo psicoanalista: non a caso Pinco Pallino deve pagare per trovare qualcuno che lo ascolti, mentre qui sono io, piuttosto, a pagare, per ascoltare Mattotti.
Ciò che rende interessante il lavoro di Mattotti non è quindi la scoperta del suo mondo personale interiore, che è probabilmente interessante, in sé, quanto quello di qualsiasi altro essere umano. È piuttosto la sua capacità di entrare in sintonia con qualcosa che, se fossimo junghiani, dovremmo chiamare inconscio collettivo, ma che io preferisco chiamare mito.
Il mito è ciò che non si comprende, non si racconta (quando lo si fa, si ottiene la mitologia, che è già un prodotto consapevole del mito), ma sta lì, sotto o dietro a tutti i nostri criteri di azione e valutazione del mondo. Spesso i racconti sono, appunto, mitologie, cioè parola del mito, ovvero mito spiegato, portato a coscienza. Anche i sogni, nella visione della psicoanalisi, portano a galla elementi del mito; e poi il racconto del sogno completa il quadro; e poi la spiegazione del racconto lo perfeziona ulteriormente, fornendoci l’illusione del controllo razionale.
Del mito però si possono rivelare solo brandelli. E nella misura in cui questi brandelli si rivelano è perché già non sono più centrali. Ci è comunque necessario tentare di rivelare quanto più possiamo, per poi poter raccontare, e poi spiegare, e infine illuderci di controllare. I disegni di Mattotti sono come sogni, però sogni collettivi, in cui possiamo tutti riconoscerci. Non sono i suoi sogni privati, bensì quella parte dei suoi sogni privati che coincide con i sogni privati di tutti. In loro il mito viene fuori con inquietante potenza, proprio perché non arrivano al racconto, ma danno la sensazione di essere sul punto di farlo, e ci sono, in loro, le figure e i ritmi e le armonie, ma con un ordine che non è quello del mondo esterno.
Ecco perché questi disegni mi fanno un po’ paura: perché ci cado dentro, mi ci perdo, mi tengono lì, fatico terribilmente a uscirne. Mi danno continuamente l’illusione di essere sul punto di tenerli, di capire, di raccontare, di spiegare, di controllare; e un attimo dopo l’illusione si disfa; e poi si ricrea, e poi si disfa di nuovo…
Nelle illustrazioni a colori di Mattotti, spesso quello che mi affascina sono le geometrie della costruzione, che forniscono al mondo rappresentato qualcosa come una seconda e differente dimensione di senso, e le figure di quel mondo finiscono così per essere al tempo stesso se stesse e anche qualcos’altro. Qui non ci sono geometrie, e di differenti dimensioni di senso ce ne sono ben più di due.
 Lorenzo Mattotti, Oltremai (8)
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|









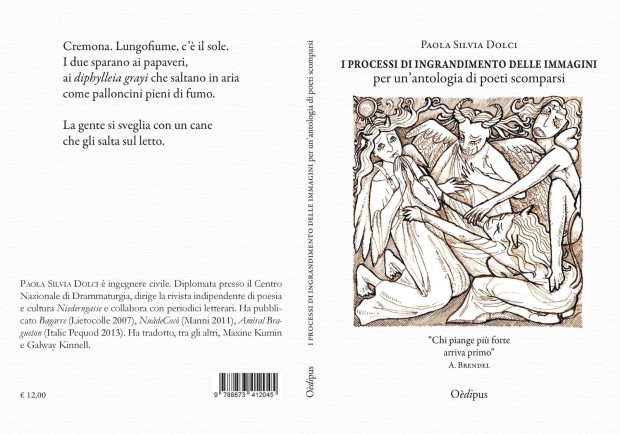


 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email



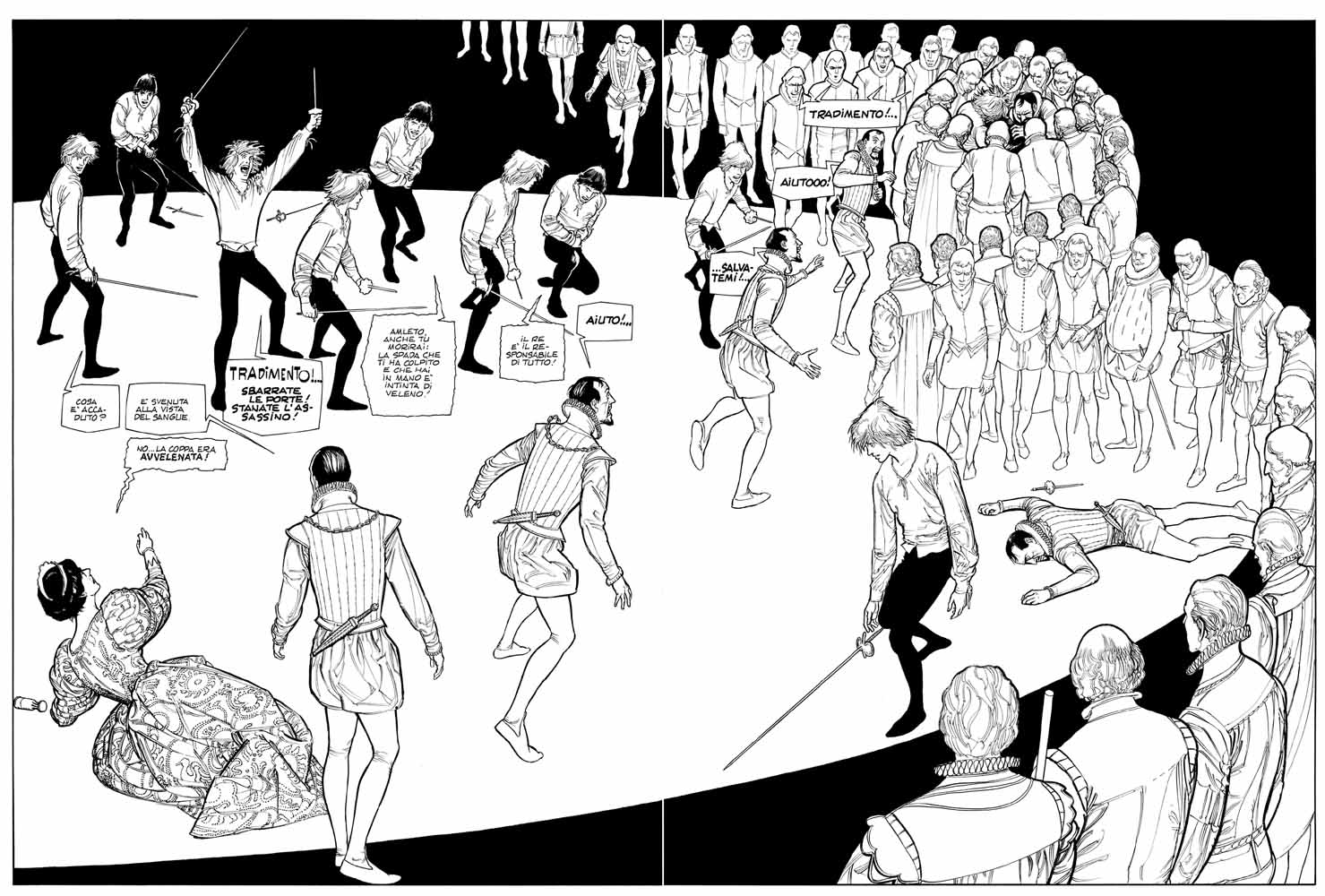
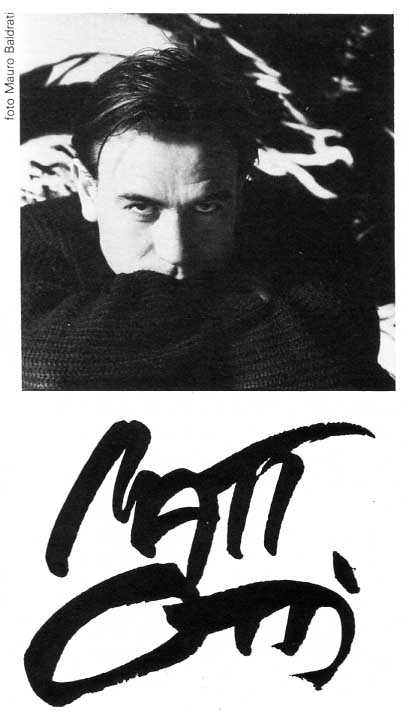

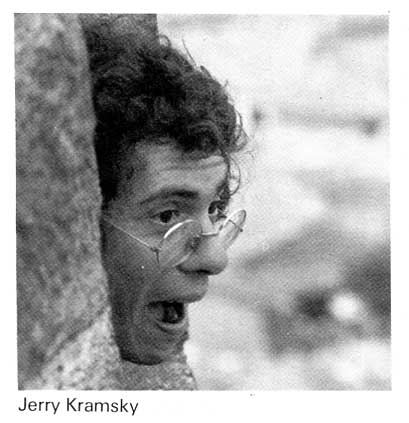

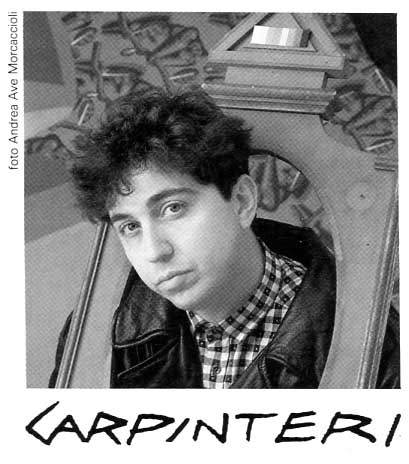

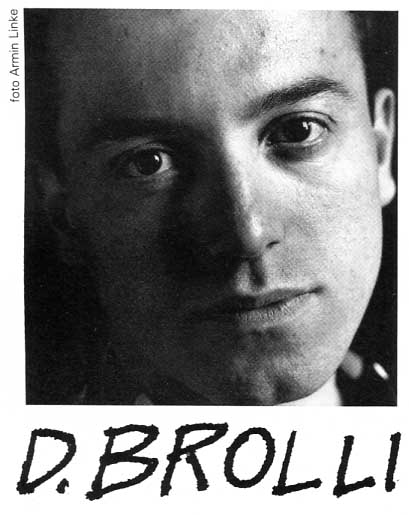


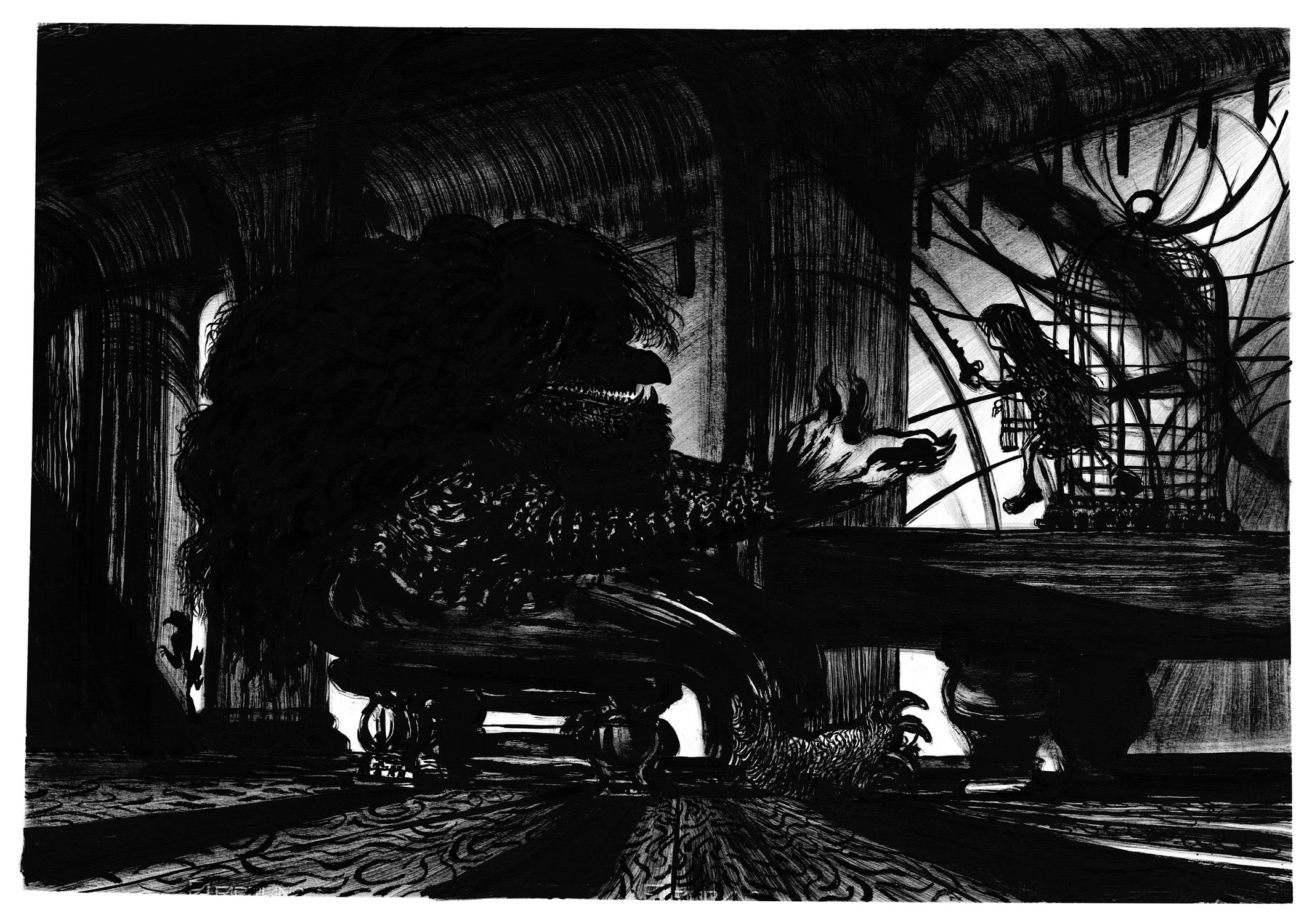























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco






Commenti recenti