 Olhao, Algarve, Porte (e qualche finestra) Prosegue il discorso della scorsa settimana, stessa città, stessa occasione.
Tra queste, sono particolarmente affascinato dalle due porte che non ci sono. Come fa una porta a essere affascinante quando non c’è? Basta che faccia notare la sua assenza, dovrebbe essere la risposta. Sì, ma c’è di più; e lo si capisce a guardare i colori di queste non-porte, rispetto a quello che hanno attorno.
Trovo bella anche quella fatta solo di assi, a sinistra nella seconda fila dal basso. Sarà grazie al muro attorno, ovviamente. Un’altra non-porta, di fatto.
Forse qualcuna ne ho ancora. Le devo cercare?
25
Así como a veces desearíamos
que Karl Marx y Arthur Rimbaud
se hubieran conocido en una mesa
de algún Café de Londres,
mientras en el agua sórdida del Támesis
– ahíta de grumos aceitosos
que flotan entre botellas y colillas
y ropa gris de gente ahogata –
espera el Barco Ebrio, ya sin anclas,
a que el fantasma que recorre Europa
suba también, para zarpar
(Karl, vestido con blue jeans marineros
se despite de Engels en el muelle
y Arthur hace lo propio con Verlaine
– los sueños insolentes ahora enfundados
en la gorra que usó él mismo en la Comuna);
así come, a estas alturas, quisiéramos
que Hegel, apeado del estrado de su cátedra,
hubiese visitado a Hölderlin un día
en su manicomio oculto de la torre
para escuchar cómo el demente
– sin reconocerlo tal vez en su delirio –
le habla de un viejo amigo de Tubinga
con quien, en mitad de una fiesta adolescente,
bailó una mañana, junto a un árbol
por ellos mismos levantado
(“Libertad”, lo llamarían),
tan fieros y felices como niños orinándose,
con el impudor de los puros, frente al rey
(en la siesta monocorde del verano,
recordando novias suavísimas de Heidelberg,
los dos compañeros se confiesan:
la razón debe pedirle a la locura
su danza irreductible, la inocencia
con que el loco Hiperión, desde su torre,
enseña al profesor que la luz blanca,
la rosa de los vientos del Espíritu,
no termina en el Estado de los Césares,
se burla de las Prusias de los káiseres);
así querría yo hoy que a William Blake
lo hubiesen dejado predicar un solo día
sobre el púlpito labrado de una iglesia
– la catedral de Westminster, por ejemplo –
en presencia de arzobispos y presbíteros
y de una moltitud de feligreses
harta, como todas, de sermones.
Imagino el viento sagrado resonando,
por primera vez, junto a los mármoles,
mientras los cuerpos, desnudados por fin
como a la hora del agua o del amor,
se erizan con el paso del Dios vivo
y tiemblan ante el olor de Cristo el Tigre
devorando las ingles de las almas,
ahora tan intactas, tan ebrias y tan vírgenes
como la de aquel niño canoso viendo ángeles
a la hora en que arde Venus sobre Lambeth
y hasta las prostitutas de Soho profetizan.
(Armando Rojas Guardia, da Poemas de Quebrada de la Virgen, 1985)
25
Così come a volte sogneremmo
che Karl Marx e Arthur Rimbaud
si fossero incontrati a un tavolino
di un qualche caffè a Londra,
mentre là nell’acqua sozza del Tamigi
– piena di grumi oleosi
che fluttuano tra bottiglie e mozziconi
e abiti grigi di gente annegata –
attende il Battello Ebbro, già senz’ancore,
che il fantasma in giro per l’Europa
salga anche lui, per salpare
(Karl, vestito con blue jeans da marinaio
sta salutando Engels là sul molo
mentre Arthur fa del proprio con Verlaine
– i suoi sogni insolenti adesso infoderati
nel berretto da lui usato alla Comune);
così come, a queste altezze, amassimo
che Hegel, disceso dal gradino della cattedra,
avesse un giorno visitato Hölderlin
nel manicomio occulto della torre
per ascoltare come il demente
– senza riconoscerlo forse nel delirio –
gli parla di un vecchio amico di Tubinga
con cui, a metà di una festa adolescente
ballò una mattina, presso un albero
fondato da essi stessi
(“Libertà”, lo chiamerebbero),
così felici e fieri come bimbi che pisciano,
con l’impudicizia dei puri, verso il re
(nella siesta monocorde dell’estate,
ricordando ragazze dolcissime di Heidelberg,
si stanno confessando i due compagni:
dalla follia la ragione deve avere
la danza irriducibile, l’innocenza
con cui il matto Hiperion, dalla sua torre,
insegna al professore che la luce,
quella rosa dei venti dello Spirito,
non finisce nello Stato dei Cesari,
si burla della Prussia dei kaiser);
così io oggi vorrei che William Blake
lo avessero lasciato predicare un giorno solo
sopra il pulpito istoriato di una chiesa
– l’abbazia di Westminster, per esempio –
in presenza di arcivescovi e presbiteri
e di una grande folla di fedeli
esausta, come tutte, di sermoni.
Immagino il vento sacro che risuona
per la sua prima volta, insieme ai marmi,
sin quando i corpi, infine denudati
come nell’ora dell’acqua o dell’amore,
si impennano col passo del Dio vivo
e tremano all’odor di Cristo il Tigre
divorando gli inguini dell’anima,
adesso così intatti, così ubriachi e vergini
come quello del bimbo canuto a veder angeli
in quell’ora in cui arde sopra Lambeth Venere
e sin le prostitute di Soho profetizzano.
Altro esempio da Armando Rojas Guardia, e altro esperimento di traduzione, dopo quello della scorsa settimana. Qui i problemi sono diversi. Si tratta di un componimento molto più lungo in versi liberi. Il principio di base della mia traduzione rimane lo stesso: cercare di rendere in italiano l’effetto che l’originale produce in me. Mi rendo conto benissimo che questo principio implica un problema: per quanto io conosca lo spagnolo, l’effetto che una poesia di tradizione spagnola produce in me è inevitabilmente diverso da quello che può produrre in un lettore che è cresciuto in quella medesima tradizione. Non è solo questione di lingua. Per quanto io conosca Garcilaso e Lope e Gongora, e Darío e Jiménez e García Lorca e Storni e Caballero Bonald e García Montero, sono cresciuto a Dante e Petrarca, e a Leopardi e Montale, e a Pasolini e Sanguineti e De Angelis. Inevitabilmente, gli echi che un lettore nato ispanico (di lingua, intendo) sentirà, saranno diversi da quelli che sentirò io – e se pure la conoscenza del passato aiuta (anzi, è indispensabile) nessuna conoscenza approfondita sostituirà la mia specificità, il mio percorso di crescita.
In misura minore, certo, questo è vero anche a livello individuale, non solo di differenza linguistica. Quello che io posso sentire in qualsiasi componimento poetico anche nella mia lingua dipende inesorabilmente dal mio percorso di formazione – il quale, certo, non è mai terminato, e continua tuttora a modificare il mio gusto, ma in cui certe acquisizioni del passato rimangono comunque determinanti. Insomma, differenza di percorso individuale, o differenza di percorso culturale che sia, la lettura che posso fare, e dunque la traduzione che posso proporre di qualsiasi componimento è inevitabilmente la mia. E solo in parte posso appellarmi al fatto che condivido molte letture formative con tanti, e che la tradizione spagnola è abbastanza vicina (ma tutt’altro che identica) a quella italiana. I livelli di libertà che avrei anche solo con l’inglese sarebbero molto superiori.
Ecco quindi, inevitabilmente, il mio Rojas Guardia, e il mio verso libero di Rojas Guardia.
E poi si fa presto a dire verso libero. Se si guarda più da vicino l’originale ci si accorge che l’effetto ritmico complessivo è dato da una alternanza (non regolare, ma dettata da ragioni di retorica) di endecasillabi (anche ipermetri o ipometri, cioè con una sillaba in più o in meno), alessandrini e altri versi comunque piuttosto musicali, con qualche rottura ritmica qua e là. Lessico e sintassi sono abbastanza piani, su un registro non particolarmente alto – forse innalzato in verità solo dal ritmo prosodico.
È questo dunque che devo rendere nella mia lingua, cercando di essere fedele al senso il più possibile, ma all’interno dei vincoli posti dalle scelte metriche, lessicali e sintattiche generali – che sono più importanti, in poesia, della corrispondenza semantica esatta.
Così, dove mi era possibile rispettare il metro dell’originale, l’ho ovviamente fatto; mentre dove questo avrebbe portato a un lessico o a una sintassi di registro troppo alto (o troppo basso), ho cercato comunque di attenermi ai modelli ritmici di verso dominanti nell’originale. La fortuna dello spagnolo è che spesso è facile rispettare queste regole, per la somiglianza tra le due lingue; ma qualche rimpianto ce l’ho lo stesso. Per esempio, non sono contento di aver dovuto trasformare la “luz blanca” del quart’ultimo verso della seconda strofa in semplice “luce”, ma non ho trovato modo per conservare la caratterizzazione “bianca” senza perdere in efficacia ritmica – e alla fine ho deciso di levarla, scommettendo sul fatto che nel gioco poetico di Hölderlin (per come viene visto da Rojas Guardia) il fatto che la luce fosse “bianca” non fosse così essenziale.
Sono molto affezionato a questi versi, specie per la terza strofa, quella in cui il bimbo canuto che vede gli angeli William Blake predica a Westminster. Trovo molto bella, anche narrativamente, quella progressione.
Torno da Romics, dove giovedì 29 abbiamo discusso di fumetto popolare, di eroi, e di autorialità. Il tema era deciso da tempo, ma l’ombra di Sergio Bonelli aleggiava inevitabilmente su di noi. Che l’eroe non sia indispensabile alla serialità lo sapevamo già, ma Camilla Patruno Marmonnier ci ha fatto toccare con mano che cosa succede in Francia, dove ci sono serie basate sugli sviluppi diversi possibili, serie basate su un gruppo con diversi personaggi e vicende parallele, serie basate sul ritornare di una situazione in epoche storiche diverse. Non sono cose che accadano solo in Francia. Anche da noi o negli Stati Uniti o altrove l’eroe è semplicemente la principale tra le opzioni per permettere la continuità.
E non è nemmeno una novità. Il mito greco (e altri miti ancora) è già implicitamente seriale. Talvolta la sequenza si basa sull’eroe (Ulisse, Ercole) talvolta su un gruppo (gli Argonauti) o una famiglia (gli Atridi, Edipo), talvolta su una situazione (la fuga di Elena e la guerra di Troia).
Parlando, dentro e fuori la sessione, con gli amici (Ivo Milazzo, Sergio Brancato, Paola Laura Gorla) ritornava poi continuamente il tema del rapporto tra autore e serialità – che, in forme di solito meno teoriche, usciva anche dai discorsi degli altri partecipanti (C.B. Cebulski, Takamasa Sakurai, Francesco Artibani, Pierdomenico Baccalario, Giacomo Bevilacqua, Giulio De Vita, Roberto Perpignani, Giovanni Ciofalo – e sto certamente dimenticando qualcuno): per esempio, un personaggio appartiene al suo autore? è giusto proseguire una serie dopo la morte dell’autore?
Non voglio riportare le opinioni di tutti (non ne sarei nemmeno capace). Solo ripetere, e magari ampliare un po’ le cose che ho detto in chiusura, stimolato da tutti i discorsi, privati e pubblici, del pomeriggio.
Ho accennato al mito greco. Di sicuro Omero, se mai è esistito, non ne è stato l’autore. Non ha inventato né storie né personaggi. È stato soltanto il più grande tra gli aedi, questi poeti da braccio che vivevano recitando pubblicamente dei versi di tradizione popolare e orale, ma anche modificandoli secondo la situazione del momento, la propria memoria, il proprio gusto e le proprie capacità. Evidentemente le capacità di Omero erano tali che i greci sentirono in seguito il bisogno di registrare le sue parole per non perderle, e adottarono la scrittura fenicia (anche) per questo.
Oltre due millenni dopo, quando la nozione di autore è già forte, un autore come Ludovico Ariosto non si fa nessun problema, nello scrivere il suo capolavoro, a riprendere non solo personaggi altrui ma addirittura nel proseguire la trama di un altro, il Luigi Pulci dell’Orlando innamorato. Nonostante questo, alla storia è passato molto più lui del suo predecessore su quegli eroi, e basta leggere l’uno e l’altro per capire il perché.
Ora, i miti greci sarebbero meravigliosi anche senza Omero, e pure lo sarebbero quelli cavallereschi, anche senza Pulci o Ariosto. Ma certo un poco l’uno e molto gli altri hanno aggiunto qualcosa, e quel qualcosa è lo specifico dell’autorialità, cioè il fatto di aggiungere al mito una riflessione personale, con la quale noi moderni amiamo confrontarci. Diciamo che il romanzo cavalleresco dell’Ariosto è il mito più il discorso, è il mito più una proposta personale di affrontarlo.
Quando nasce il fumetto, si trova in una situazione che condivide molte caratteristiche con l’oralità (ne ho parlato qui), e il suo successo si basa su una condivisione di valori e situazioni con il proprio pubblico che ha molti caratteri del mito. Naturalmente, trattandosi di un prodotto moderno, che vive la sua vita in un contesto di produzione in cui l’autore esiste in maniera inevitabile, la situazione non è certo la stessa che ai tempi di Omero. Tuttavia, per molto tempo in maniera quasi esclusiva e in vari suoi settori ancora oggi, nonostante la presenza di autori, il fumetto viene fruito da molto pubblico sostanzialmente come mito. La progressione verso l’autorialità c’è stata, nel suo secolo e passa di vita, ed era inevitabile che ci fosse, ma non ha affatto scalfito certi aspetti dello zoccolo duro della fruizione.
Non lasciamoci ingannare: le espressioni di serie e di autore non sono antonime, non definiscono due poli opposti, né per opposizione netta né su un continuum per gradi. L’autore di fatto c’è sempre, e il problema è semmai quanto egli sia presente nella ricezione del lettore. Questo vale tanto per le serie quanto per le storie autoconclusive, anche se per queste ultime è più frequente che lo si ritenga rilevante.
Non lasciamoci ingannare nemmeno da un’altra considerazione. L’industria culturale non ha il monopolio degli eroi e delle serie. Essa stessa, in un sistema commerciale, è inevitabilmente legata al gusto del pubblico. Un eroe ha successo se c’è un pubblico che lo apprezza, ovvero se muove qualcosa nell’immaginario di qualcuno, ovvero se può almeno un poco, per qualcuno, costituire una mitologia. Da questo punto di vista, l’autore di un personaggio di successo che viene fruito in maniera poco o punto autoriale è semplicemente colui che ha saputo lasciarsi attraversare meglio di altri dallo spirito del tempo (o da un qualche spirito del tempo), cogliendolo e restituendocelo.
Quando il testo viene fruito in maniera autoriale (di serie o meno che sia), l’autore aggiunge a questa capacità anche quella di trasmettere il proprio discorso, e quindi di dialogare con il suo pubblico e con gli altri autori attorno a lui.
È questo aspetto di discorso e di dialogo a essere sottolineato e spesso unicamente preso in considerazione da molta critica delle arti più riconosciute, dalla pittura al cinema al romanzo. Questa critica sbaglia anche in questi casi: un’opera d’arte firmata è sì certamente un discorso, ma non l’apprezzeremmo davvero come tale se fosse solo quello, e se non fosse pure, al tempo stesso, fortemente mitopoietica.
Aggiungiamo che, a sua volta, quello stesso dell’autore è, da qualche secolo a questa parte, un mito (moderno), il mito del genio creatore, il mito del Michelangelo ispirato, che rappresenta al meglio l’individualismo occidentale (moderno).
Tra mito dell’eroe (o di qualche altro elemento adatto alla serializzazione) e mito dell’autore, l’editore può sempre scegliere dove calcare la mano per le proprie operazioni di promozione, e a seconda del pubblico cui si rivolge enfatizzerà di più la componente mitica oppure quella di discorso.
Detto questo, non vedo quindi nulla di sbagliato nel fatto che un personaggio di successo possa essere proseguito da altri. Molto spesso i risultati sono peggiori, certo, perché il genio è raro, e la serie vivacchia sul prestigio acquisito in passato piuttosto che sul valore presente: Asterix senza Goscinny è una tristezza, né Sagendorf né Zaboly né nessun altro hanno saputo rendere a Popeye la dolce e incantevole demenzialità di Segar; rabbrividisco al pensiero di cosa possa accadere ai Peanuts, caduti in mani che non sono quelle di Schulz. E tuttavia, l’Asterix del dopo Goscinny non ci impedisce di preferire e leggere quello originale, e magari contribuisce a tener viva la memoria e il mito (a sua volta) del primo grande suo autore.
Aggiungiamo poi che qualche volta è pure successo di trovare prosecutori più bravi dei creatori iniziali: Lucky Luke è stato inventato da Morris anche per i testi, ma se Morris non avesse conosciuto Goscinny passandogli poi la mano per quel ruolo, oggi probabilmente non continueremmo a leggerlo. Spirou è stato creato da Rob-Vel nel 1938, ma è stato il suo successore Franquin (dal 1946) a incantare i francesi. Adoriamo il Paperino di Carl Barks, ma questo non ci impedisce di apprezzare Don Rosa (e vari altri). Chi si ricorderebbe di un oscuro personaggio DC Comics, chiamato The Sandman, se non l’avesse ripreso Neil Gaiman? La lista potrebbe continuare.
La continuità del personaggio è quella del mito; la presenza dell’autore è quella del discorso. La letteratura colta ha bisogno di entrambe le componenti, mentre quella popolare si può accontentare della prima. Non c’è un confine tra le due, oggi, ma solo un passaggio sfumato di modi diversi di ricezione.
Non confondiamo, per finire, le questioni di ricezione con quelle di diritto. Dal punto di vista del diritto conta la creazione, e per creare, al giorno d’oggi, un autore (o più di uno) c’è sempre. Non si potrà mai negare che il personaggio sia stato creato da lui, né disconoscergli i diritti – nemmeno quando il pubblico ignora il suo nome. Il pubblico ha il diritto di ignorarlo, perché in certi casi per la sua ricezione l’autore è davvero irrilevante. Ma la legge lo deve tutelare perché comunque quella cosa, ormai di pubblico consumo, ha avuto origine da lui.
È un vero peccato che Sergio non ci sia più. Credo che avrebbe apprezzato.
 Olhao, Algarve, Porte (e qualche finestra) Molti anni fa, quando viaggiare in autostop era possibile persino in Italia, avevo una fidanzata che studiava a Salisburgo, in Austria. Ero diventato un esperto dell’autostrada del Brennero, e della deviazione per Salzburg. Una volta mi prese su un tedesco dall’aria rockettara, che aveva una quindicina di anni più di me (ed era effettivamente anche il batterista di un gruppo rock). Si chiamava Wolfgang Lauter, e di mestiere faceva il grafico. Però, a parte il suonare, si era trovato un hobby molto conveniente: girava l’Europa facendo foto, e realizzava con quelle foto dei libriccini pubblicati dalla Taschen, che vendevano piuttosto bene; con il ricavato si pagava il prossimo viaggio, e così via. I libriccini erano monografici: Porte e finestre, Tetti, Scale, Gallerie urbane… Facemmo amicizia, e per il libro sulle scale venne in seguito a Bologna, dove fu mio ospite, perché gli avevo raccontato che nei palazzi bolognesi stavano nascoste (ed è vero) un sacco di magnifiche scalinate monumentali. Si chiamava, e si chiama ancora Wolfgang Lauter. Non l’ho più sentito da allora, ma ho trovato il suo sito Web, che è questo.
Ne parlo perché l’idea di fotografare ossessivamente un tipo di soggetto mi viene da lui, sostanzialmente. Tuttavia, le porte delle case di Olhao, una cittadina dell’Algarve, sono così belle, che magari ne avrei fotografato ugualmente centinaia, anche senza il suo esempio. Io le trovavo incantevoli, per colori e forma, persino quelle semplicissime, magari solo per il contrasto col colore del muro attorno; e persino quelle moderne, con ingenue (ma non troppo) forme funzionaliste.
Se le porte sono da intendere come altrettante promesse di quello che si può trovare varcandole, questa dev’essere una città dove la vita è dolce. Anche per quello che sono riuscito a vedere davvero, non sembrava comunque male.
Falta de mérito
Si yo fuera capaz de entrar por fin
en esa pulcritud del aire inmóvil
que he llamado silencio en el poema:
si yo fuera capaz de nombrar árbol
como esta tarde el árbol se mostraba
a sí mismo en la quietud del parque;
si yo fuera capaz de parecerme
al objeto real de mi escritura
(al agua misma cuando escribo agua
al vaso limpio cuando escribo vaso);
y si fuera posible merecerte,
cosa que ultrajo en tu mudez precisa
al hacerte sonar en mi palabra,
yo entraría en la luz de lo que digo.
——————————————————-
Mancanza di merito
Se io sapessi entrare finalmente
in questa pulizia dell’aria immobile
che ho chiamato silenzio nei miei versi:
se io sapessi nominare l’albero
come stasera l’albero appariva
a se stesso nella quiete del parco;
se io sapessi come assomigliare
all’oggetto reale del mio scrivere
(all’acqua stessa quando scrivo acqua
al terso calice quando scrivo calice);
e se riuscissi mai a meritarti,
cosa che offendo nel tuo stare muta
col farti suono nella mia parola,
nella luce entrerei di quel che dico.
Ho scoperto Armando Rojas Guardia per caso, trovandomi in Venezuela e acquistando qualche libro alla cieca. La dimensione dell’universo dei poeti di lingua spagnola è proporzionale alla diffusione della lingua, anzi di più, perché in quell’universo la poesia continua a godere di una considerazione pubblica un po’ più alta che da noi; ed è quindi ancora più difficile padroneggiarlo un minimo. È stata comunque una scoperta e un innamoramento. Non mi stupisce che Rojas Guardia sia considerato tra i maggiori poeti del suo paese, il Venezuela appunto, mentre mi stupisce che Wikipedia non abbia una voce su di lui nemmeno in lingua spagnola. Rojas Guardia è nato nel 1949; la lirica che citiamo qui appartiene alla sua prima raccolta, del 1979, Del mismo amor ardiendo (Ardendo dello stesso amore).
Mi sono provato a tradurre qualche verso suo (altri forse, oltre a questi, in futuro), e penso che possano essere interessanti alcune considerazioni sulle scelte che ho fatto.
Il criterio di base a cui mi sono attenuto è stato quello di cercare di ricostruire, nella mia lingua, il fascino che i versi di Rojas Guardia hanno esercitato su di me leggendoli nella sua. Credo che sia il criterio più corretto, anzi forse l’unico davvero corretto nel tradurre poesia – ma è tutt’altro che esente da problemi. Per esempio, tra gli aspetti che mi sono rimasti dentro c’è il nitore del suo endecasillabo, musicale e incisivo. Questa breve poesia è scritta in endecasillabi, come molte altre sue, ma la sua opera contiene tipi differenti di versi, tra cui tante composizioni in verso libero. L’endecasillabo è quindi una scelta locale, specifica.
E si tratta di una scelta che ha comunque un valore diverso che per l’italiano. Nella tradizione italiana, l’endecasillabo è il verso lirico ed epico, senza rivali; il settenario, che è forse il secondo verso più usato, è più un compagno di viaggio che un concorrente. Viceversa, nella tradizione spagnola, pur essendo ampiamente usato, l’endecasillabo è comunque un verso di provenienza italiana e petrarchesca, e, anche nella produzione del Novecento, oltre al verso libero, si trova come concorrenti sia l’alessandrino di origine francese, che l’ottosillabo (o doppio ottosillabo) che è il verso epico tradizionale spagnolo. Federico García Lorca, per esempio, nel sua Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, alterna sezioni (o anche solo gruppi di versi) in endecasillabi, ottosillabi, alessandrini e versi liberi. Mentre un poeta italiano del Novecento ha come scelte neutre solo endecasillabo e verso libero (perché tutte le altre sono particolari e meno diffuse), vale a dire – per certi versi – tradizione classica contro tradizione contemporanea, il poeta di lingua spagnola può giocare molto di più, pur senza uscire dallo stretto canone della norma (e senza dichiararsi implicitamente classicheggiante se non usa il verso libero).
Non c’è, nella metrica italiana, un verso che abbia dunque la posizione dell’endecasillabo nella metrica spagnola. Tradurre endecasillabi spagnoli con endecasillabi italiani è quasi inevitabile, ma è comunque un tradimento, perché si traduce un andamento ritmico tra i diversi possibili (e con una debole implicazione di classicità) con un andamento ritmico che è l’unico possibile (e con un’implicazione di classicità molto più forte). Scegliendo un metro diverso tradirei infatti ancora di più l’originale, perché sceglierei un andamento ritmico meno standard, meno normale. Sono rimasto affascinato, leggendo questi versi in originale, dall’endecasillabo di Rojas Guardia, e non c’è altro modo, per renderli in italiano, che riprodurre l’endecasillabo – ma bisogna essere consapevoli della differenza. Tra l’altro, benché lo spagnolo abbia una metrica simile a quella dell’italiano, e pure una prosodia e una sintassi piuttosto vicine alle nostre, le differenze ci sono, e queste differenze permettono una frequenza di effetti specifici che in italiano è più difficile ottenere, e che, riprodotta ad arte, potrebbe apparire artificiosa. Per esempio, lo spagnolo ha più parole tronche dell’italiano, essendo molto meno vincolato alla terminazione in vocale, ed è quindi più facile ottenere endecasillabi che altrove ho definito composti, cioè a tutti gli effetti costituiti da settenario+quinario (o quinario+settenario) grazie alla presenza di una parola tronca con accento in sesta (o quarta) sillaba. Nella poesia citata sopra 8 versi su 14 sono di questo tipo; per avere una frequenza analoga in italiano avremmo bisogno di ricorrere alle apocopi, ovvero al troncamento dell’ultima vocale – ma il Novecento italiano ha ripudiato quest’uso, e riprenderlo comporterebbe un ritorno a un uso passato della lingua che invece in Rojas Guardia non c’è per nulla.
Ho cercato anch’io inizialmente di mantenere la frequenza di versi composti, per rispettare al massimo la musicalità dei versi. In una prima versione avevo tradotto i versi 1, 3 e 5 rispettivamente così:
Se capace foss’io di entrare infine
se capace foss’io di dire l’albero
se capace foss’io di assomigliare
Certo, così avrei rispettato di più il ritmo prosodico dell’originale, ma a costo (come si è detto) di un uso della lingua che sa di arcaico, di petrarchesco, di ottocentesco – tutte sfumature completamente assenti dal testo originale, la cui lingua è sì colta, ma anche del tutto attuale. Per fortuna, ho trovato una soluzione diversa – ma non sempre ci si riesce; e ho comunque dovuto rinunciare a quello specifico ritmo, perché il costo sarebbe stato troppo alto.
Allo stesso modo, per i due penultimi versi, avevo inizialmente ipotizzato le seguenti soluzioni.
cosa che offendo in tua mutezza esatta
col farti risuonare in mia parola
col risuonare nella mia parola
col tuo suonare nella mia parola
con il tuo suono nella mia parola
Reso così, il terzultimo verso rispecchia maggiormente il senso dell’originale, ma la parola mutezza è piuttosto brutta e inconsueta in italiano; e poi, soprattutto, in tua invece che nella tua appare proprio una licenza poetica, che, pure lei, sa di passato.
Lo stesso problema si pone per la prima delle quattro proposte per il penultimo verso. Le successive tre sono migliori, ma si perde il fare (hacer) presente nell’originale, che mette in campo il lavoro del poeta, e mi dispiaceva molto perdere.
Infine, un po’ per gioco, ho provato anche a fare una traduzione del tutto diversa dell’intero componimento, che rispecchiasse al massimo il senso delle parole e delle espressioni, lasciando in subordine la questione del ritmo. Eccola:
Mancanza di merito
Se io fossi capace di entrare finalmente
in questa pulizia dell’aria immobile
che ho chiamato silenzio nella poesia:
se io fossi capace di dar nome albero
al modo in cui stasera l’albero si mostrava
a se stesso nella quiete del parco;
se io fossi capace di assomigliare
all’oggetto reale della mia scrittura
(all’acqua stessa quando scrivo acqua
al bicchiere terso quando scrivo bicchiere);
e se fosse possibile meritarti,
cosa che offendo nella tua mutezza esatta
col farti suonare nella mia parola,
io entrerei nella luce di quel che dico.
È una versione lessicalmente molto più fedele della prima, ma io credo che tradisca l’originale assai più dell’altra. Il verso libero non è l’endecasillabo, e l’occasionale guadagno di senso che otteniamo qui non è compensato dalla perdita di suono. Paradossalmente, il componimento di Rojas Guardia raggiunge, nella misura in cui è possibile farlo, la luce di quel che dice proprio attraverso il suo essere parola che suona, cioè essere se stessa ancora prima che altro, essere suono ancora prima che segno – proprio come sono in sé le cose di cui vorrebbe saper parlare. È questo che la mia versione ha cercato di rendere, che ci sia riuscita o no.
(Un’altra possibilità ancora, che questa seconda versione suggerisce, è di tradurre l’endecasillabo con l’alessandrino – o doppio settenario. Il primo verso è già un alessandrino, e si può lavorare per far sì che anche gli altri lo diventino. Il vantaggio sarebbe – forse – di poter essere più letteralmente fedeli al senso delle singole parole, pur mantenendo un ritmo che alla poesia spagnola è familiare. Non lo è però alla poesia italiana. Quindi, anche a patto di riuscirci con efficacia, il tradimento sarebbe comunque maggiore.)
 Ray Moore (su testi di Lee Falk) The Phantom, dettaglio dalla striscia del 23.07.1940 Magari Ray Moore non è Alex Raymond, e nemmeno Caniff, e la composizione di queste figure è un po’ goffa, ma trovo che, ugualmente, qualcosa da imparare dai suoi inchiostri ci sia. Sarà per questo effetto tutto pennello (e niente pennino) con pennellate grosse e pastose, sin quasi all’eccesso, ma qui Moore riesce davvero a recuperare con gli inchiostri quello a cui la sua composizione non arriva.
Non è solo l’effetto drammatico delle ombre forti e nette contro le luci altrettanto forti e nette – ma certo c’è anche quello. È anche e soprattutto questa modulazione eccessiva delle pennellate che rende le figure fluide e vigorose – come ha da essere, naturalmente, the Phantom, l’Uomo Mascherato. Così, dove c’è movimento, il movimento fluisce, come nella vignetta in alto; mentre dove c’è tensione, come in quella in basso, tutto si tinge di forza, e la presa dell’eroe sembra quella di un gigantesco serpente che avvolge le sue spire.
Poi, sì, non è difficile trovare un sacco di difetti a questi disegni, realizzati molto probabilmente in tempi assai brevi, ma gli inchiostri di Moore, almeno su di me, giocano ugualmente un grande fascino.
Le immagini (ad alta risoluzione) sono prese dall’originale conservato presso il Fondo Gregotti.
 Ray Moore (su testi di Lee Falk) The Phantom, dettaglio dalla striscia del 23.07.1940
 A vela, a fiamma Siate sinceri. Quanto vi ci è voluto per capire che cosa inquadra questa foto? Mezzo secondo almeno i più veloci, direi; un secondo e più gli altri, ammesso che alla fine l’abbiate capito. Se ancora non ci siete arrivati non è un disonore, anche se il faretto in basso a destra è una buona chiave per arrivarci.
Oggi questa meravigliosa volta a vela non è più così. C’è stato un restauro, i muri sono stati ridipinti con un colore più giallastro, le bocche di luce oscurate per permettere le proiezioni. Scelte estetiche (discutibili) e necessità funzionali (inevitabili – peccato!).
Francesco di Giorgio Martini era un genio. Il funzionalismo di 450 anni dopo non ha fatto che riscoprire quello che lui già sapeva – anche se modulato nelle forme del suo tempo. E tra le cose che il suo tempo gli insegnava c’è anche il fatto che nemmeno in architettura è necessario che la ripetizione debba avere necessariamente parametri omogenei. Qualche volta l’omogeneità ci vuole, ma in qualche altro caso possono cambiare distanze e dimensioni (e chissà cos’altro) purché non si perda il senso dell’iterazione e del ritmo – il quale anzi può persino risultarne arricchito.
È un po’ come con le onde del mare. Non possiamo certo sostenere che non definiscano un’iterazione e un ritmo, ma non ci sono due onde uguali o con il medesimo periodo. Lo stesso vale per queste straordinarie bocche di luce nella volta a vela, che sembrano altrettante fiammelle di candela incurvate dal vento.
D’altra parte, se cancellassi qualche dettaglio, e rendessi un po’ più indistinto il tutto in modo da far scomparire la grana dei muri, potrei ben spacciare questa immagine per un dipinto astratto, una sorta di Lucio Fontana curvilineo. Ma chi era fan di chi? Oppure è solo nella mia testa che si creano questi collegamenti?
22 Settembre 2011 | Tags: Alessandro Broggi, avanguardie, critica, poesia | Category: poesia | La raccolta consta di ventisei quartine regolari, costruite giuntando e armonizzando ad sensum versi stringa che sono sintagmi-stemmi (per lo più nominali) ripresi dai media di consumo, e insieme limpidi esempi di liricità esausta da luogo comune della qualità di massa.
Ne risulta un dettato di superficie semplice e falsamente seducente, che cela un’ironia critica ultrasottile.
Sto citando dal blog Slowforward, che a sua volta cita la presentazione del libro di Alessandro Broggi Coffee Table Book (Transeuropa 2009) sul sito dell’editore. Il libro non l’ho letto, e magari è bellissimo. Ma non è di quello che voglio parlare. Mi interessa la presentazione editoriale, che è un genere di messaggio pubblicitario, il cui scopo è, evidentemente, quello di risvegliare l’attenzione del potenziale lettore. Spesso, ma non sempre, la presentazione viene scritta dall’autore medesimo. In ogni caso, certamente, gli deve andar bene.
L’immagine che ricavo del libro di Broggi da questa presentazione è quella di un collage di materiali linguistici esausti, luoghi comuni della qualità di massa, montati con attenzione per costruire un discorso dall’apparenza semplice e falsamente seducente, a rivelare, quando li si legga con profonda attenzione, un’intenzione ironica. È vero che una presentazione deve essere apprezzativa, e che, per mostrare apprezzamento, il testo in oggetto deve essere implicitamente avvicinato a qualcosa di culturalmente già apprezzato (a meno che non se ne dichiari platealmente la novità – ma sarebbe un discorso poco credibile, perché non sufficientemente giustificabile nelle poche righe a disposizione). Solo che qui il riferimento è alle operazioni – anni Sessanta e Settanta – della Neoavanguardia italiana, e in particolare al citazionismo di Balestrini.
È singolare come questo tipo di operazioni, certamente nuove e importanti quando le facevano i Novissimi, non abbiano mai smesso di essere spacciate per nuove da cinquant’anni a questa parte. Oppure anche, quando non necessariamente nuove, come le uniche eticamente ammissibili a una poesia che, di questi tempi, come ci insegnarono Brecht e Adorno, non avrebbe il diritto di parlare di alberi.
Questa poesia post-neo-avanguardista ha ovviamente tutto il diritto di esistere, e di produrre i propri fiori, che per fortuna qualche volta ci sono davvero. Ma io non posso fare a meno di dichiarare la mia stanchezza per un’estetica del negativo di adorniana memoria, come se la nostra vita non fosse fatta d’altro che di formule pubblicitarie e ritornelli di bassa lega, e come se il nostro compito come poeti o lettori non potesse essere altro che quello di farne (lukácsianamente) la critica. È falso, del tutto falso, che al di fuori di questa linea ci siano soltanto il banale e l’inautentico. Se troviamo bella una poesia (o qualsiasi altro prodotto culturale), a qualunque scuola appartenga e comunque sia costruita, è anche perché riconosciamo già il suo sottrarsi – in qualche modo e almeno in parte – proprio al banale e all’inautentico.
D’altra parte non basta davvero dichiarare di farlo per farlo veramente. Se leggete tra le righe della presentazione del libro di Broggi, quello che si vuol dire è proprio questo: questo libro si sottrae al banale e all’inautentico mettendoli in mostra attraverso l’ironia. Non è così facile in verità, e mi auguro che il libro di Broggi ci riesca davvero. In questi cinquant’anni il banale e l’inautentico hanno invaso e colonizzato anche il campo che fu delle avanguardie.
Riconoscere questo non autorizza a condannare automaticamente qualsiasi produzione che si rifaccia a quel campo, ma autorizza a diffidarne, e ad utilizzare nei suoi confronti la stessa prudenza con cui approcciamo ogni ennesima banalissima Vispa Teresa – salvo poi essere anche sempre pronti, ove sia il caso una volta entrati nel testo, ad abbandonarla. Per questo motivo questa presentazione, almeno nei miei confronti, non fa il suo mestiere, e suscita molto più la mia diffidenza che il mio interesse – cercando magari di farmi credere che esiste ancora un’egemonia che, persino nella nicchia in cui davvero c’è stata, si è esaurita ormai da tempo.
 Dario Morgante e Gianluca Costantini - Julian Assange e Wikileaks, BeccoGiallo 2011 Non si può escludere che Gianluca Costantini si sia riletto troppe volte il Città di vetro disegnato da Mazzucchelli, o il Jimmy Corrigan di Chris Ware, però li ha digeriti bene, e questo è il primo libro di BeccoGiallo che non mi faccia pensare che l’impegno sociale fa male ai fumetti.
C’è una storia raccontata per flash back e flash forward che, anche se, inevitabilmente, non ha una fine, narrativamente funziona, e ti tiene lì, senza annoiarti. La sua struttura un po’ contorta (ma non troppo) è persino coerente con i giochi visivi di Costantini, che finiscono davvero per raccontare in maniera molto evocativa.
C’è forse, ogni tanto, un vago odore di esercizio di stile, ma è necessario riconoscere che non è mica facile raccontare una storia vera, politicamente forte, senza diventare retorici – quello che è, in generale, il difetto principale degli altri volumi di questa collana. Un difetto che invece questo volume non ha, e non mi sembra cosa da poco. Magari è anche lo stesso sospetto – occasionale – di esercizio di stile, a tenere alla larga il pericolo, molto più grave, della retorica.
In realtà non lo so, però il libro mi è piaciuto. L’ho letto volentieri dall’inizio alla fine. Mi ha persino fatto venir voglia di scriverne queste righe. Mi ha fatto addirittura rimpiangere che il libro su Amy Whinehouse Fatta di musica non sia che una beffa estiva. Magari Becco Giallo aveva finalmente imbroccato la strada giusta. È davvero un peccato quando su cause giuste si scrivono solo libri sbagliati. Ma magari il cambio di rotta ora c’è stato davvero. Tifiamo per Morgante e Costantini.
 Il riflesso Certo l’hanno fatto apposta. In questo modo Sancos Seguros riesce a risiedere in un edificio moderno pur rivestendosi anche delle forme di uno più antico, inizio Novecento, dando così a chi passa un’idea di persistenza nel tempo e dunque di stabilità che a una compagnia di assicurazioni fa sicuramente comodo.
Bisogna essere maligni per far notare che il riflesso del passato è inevitabilmente deformato dalle modalità del presente, ed è tanto più fascinoso perché in realtà non si capisce bene come sia fatto e dobbiamo comunque aggiungerci del nostro, che sarà sempre come ci piace che sia (proprio come insegnava, già a suo tempo, il Gran Maestro di trucchi di questo genere, Gian Lorenzo Bernini).
Però la statua è vera, e gli alberi in parte anche. Me lo vedrei bene come occasione per una storia di Dylan Dog. E anche la città nel suo complesso forse gli si addirebbe, non meno di Londra.
14 Settembre 2011 | Tags: Dante Alighieri, metrica, poesia, verso | Category: poesia | Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte.
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Permettetemi qualche riflessione vissuta da autore, senza pretesa di confrontarmi con uno con cui qualsiasi confronto è perdente, ma nell’ipotesi di poter sentire, almeno un minimo, alcune cose come lui. Però mi sembra di aver visto qualcosa, in questi versi di avvio della Commedia, che non ho letto da nessuna parte. D’altra parte, non essendo un dantista, può benissimo trattarsi di ignoranza mia. Nel qual caso, se vi è noto qualche approccio simile a questo mio, vi prego di segnalarmelo.
Dico riflessione da autore perché le osservazioni che vado a fare su questi versi derivano da mie specifiche considerazioni sulla scrittura dei versi – e riguardano quasi esclusivamente metrica e prosodia.
Ho bisogno di fare una piccola premessa sull’endecasillabo, il verso della Commedia e il verso principe della poesia italiana. Ci insegnano i manuali di metrica che l’endecasillabo, pur non essendo davvero un verso composto, è tuttavia costituito di due parti: un settenario seguito da un quinario nella versione cosiddetta a majore (accento forte sulla sesta sillaba), oppure un quinario seguito da un settenario nella versione a minore (accento forte sulla quarta). L’endecasillabo non è veramente un verso composto perché 7+5 (come 5+7) fa 12 e non 11, e le condizioni per cui siano davvero leggibili sia il settenerio che il quinario sono particolari e non sempre presenti.
Non sono presenti certamente quando l’endecasillabo non è canonico, ovvero non presenta accento né sulla quarta né sulla sesta sillaba. L’endecasillabo non canonico è raro in Dante come pure in generale nella poesia italiana, perché con facilità suona poco musicale al nostro orecchio.
Al contrario, le condizioni sono effettivamente presenti quando il primo emiverso (settenario o quinario che sia) è tronco, e ha di conseguenza una sillaba in meno, lasciando la sillaba libera a completare il secondo. I primi tre versi della Commedia sono di questo tipo. Per intenderci, chiamerò qui questo tipo di endecasillabo fortemente composto, o anche solo composto (nelle versioni, rispettivamente, a majore e a minore).
C’è un altro modo per far sì che 7+5 (o 5+7) possa fare 11, ed è la sinalefe sulla settima (o sulla quinta) sillaba. Per esempio, nel verso 5 del nostro esempio, la “e” dopo “selvaggia” fa sinalefe con la vocale che la precede, e quindi viene inglobata nella medesima (settima) sillaba. Questo è un modo molto debole per ottenere il verso composto, perché per far sentire l’andamento dell’endecasillabo dovremo far sentire anche la sinalefe, e ridurre di fatto il conto del secondo emiverso a quattro (o sei, se a minore) sillabe. Ma la lettura separata (come se la sinalefe non ci fosse) non è completamente esclusa, e può ritornare ad aver senso in qualche caso. Chiamerò perciò qui questo tipo di endecasillabo debolmente composto.
Chiamerò infine non composto ogni endecasillabo canonico in cui non sia possibile percepire entrambi gli emiversi come settenario e quinario, come succede, per esempio, nei versi 7 e 9 riportati qui sopra (tra “poco” ed “è” c’è dialefe, e “cose” e “ch’i'” sono chiaramente separati).
Il particolare andamento dei versi di Dante riportati sopra non dipende, mi pare, solo dalla distribuzione degli accenti, ma anche dalla loro natura composta o non composta. Per verificarlo, ecco un piccolo esperimento: modificherò i versi 1-3 con alcune piccole sostituzioni, che ne rispettino grosso modo il senso (che comunque non è in gioco in questo discorso), e ne mantengano lo schema di accenti (per il verso 2 dovrò introdurre una voce verbale che non esiste, facendo finta che esista, perché non trovo in italiano un’alternativa sensata che regga alle mie condizioni). Ecco dunque:
Nel mezzo del cammino della vita
mi ritrovetti in una selva oscura,
ché la diritta strada era smarrita.
Anche senza prendere in considerazione il senso leggermente mutato, e nonostante il sistema degli accenti di questi versi sia esattamente lo stesso di quelli originali, essi suonano al mio orecchio molto meno melodiosi di quelli veri. Credo che il punto stia nella perdita della sospensione che gli endecasillabi fortemente composti manifestano in concomitanza della cesura dopo la sesta o la quarta sillaba, nelle versioni rispettivamente a majore e a minore. Nella mia versione alterata i versi sono diventati non composti (1) o debolmente composti (2 e 3), e la cesura è scomparsa.
Con la scomparsa della cesura si viene ad affievolire anche la differenza tra l’endecasillabo a majore e quello a minore:tutti e tre i versi portano infatti accenti sia sulla quarta che sulla sesta sillaba, e possono essere perciò letti in ambedue i modi. Tuttavia, nell’originale dantesco, la natura fortemente composta dei versi permette di sentire chiaramente la cesura, che si trova dopo la sesta sillaba nei versi 1 e 3, e dopo la quarta nel verso 2. Da questo punto di vista, dunque, la terzina propone la medesima struttura ABA che si trova anche nella rima, secondo la successione: proposta-variante-ripresa. Aggiungiamo che le sillabe accentate messe in evidenza dal troncamento contengono nei versi 1 e 3 la stessa vocale “i” della rima finale, mentre è diversa quella del verso centrale – e anche questo contribuisce a rafforzare la struttura della ripresa.
Considerando le cose in questo modo, ecco come sono organizzati questi primi dodici versi:
A majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore fortemente composto)
a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a majore non composto)
a majore fortemente composto (ma anche debolmente leggibile come a minore non composto)
A majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore debolmente composto
a minore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
A majore non composto (ma anche leggibile come a minore non composto)
a minore fortemente composto (ma anche leggibile come a majore fortemente composto)
a majore non composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
A majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore debolmente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore fortemente composto)
a majore fortemente composto (ma anche, forse, leggibile come a minore non composto)
Eccetto il verso 5, tutti gli altri portano accenti sia su quarta che su sesta sillaba, con generalizzato ritmo dunque giambico, e seconda diversa lettura possibile. Tra l’altro, è interessante osservare come la rottura del ritmo giambico cada sulla forte paronomasia di “esta selva selvaggia”, e si situi in un verso interno della terzina, sempre a conferma della struttura ABA riconosciuta sopra.
La struttura ABA è dunque presente in tutte e quattro le terzine in esame, ma cambiano gli elementi di diversificazione: nella prima terzina è il rapporto a majore/a minore; nella seconda è la presenza/assenza del ritmo giambico (o l’assenza/presenza della paronomasia); nella terza è la natura non composta/composta, insieme al rapporto a majore/a minore; nella quarta la natura fortemente/debolmente composta.
La varietà di ritmi si trova dunque organizzata in schemi di ricorrenze, che non riguardano solo le singole terzine al proprio interno: la prima e la terza terzina, per esempio, sono entrambe caratterizzate da una comune alternanza di endecasillabi a majore e a minore, anche se la terza introduce un’ulteriore differenziazione. Ma la prima e la terza terzina sono avvicinate anche dalla comune opposizione alla seconda, che gioca sulla presenza di un cambiamento assai più forte degli accenti al suo centro.
Se ora mettiamo in ordine i versi in cui è presente il momento di sospensione determinato dalla cesura (endecasillabi composti), otteniamo questo schema (che include anche alcune terzine successive, sino al verso 36):
+++ –+ -+- +-+ +– -++ -++ ++- +-+ -+- — +-+.
Versi non giambici oltre al 5 sono il 15, 20, 22, 25, 29, 32, 33, ottenendo lo schema:
+++ +-+ +++ +++ ++- +++ +-+ -++ -++ +-+ +– +++. I versi con ritmo non giambico si fanno più frequenti dopo le prime terzine, e perdono in parte la forza accentuativa dovuta alla loro particolarità.
A partire dalla quinta terzina la struttura ABA non si presenta più così stabilmente, e il gioco (come si vede anche dagli schemi qui sopra) diventa più irregolare. Ma con la quinta terzina incomincia anche la narrazione vera e propria e si è già concluso questa sorta di piccolo prologo, che ha avuto anche la funzione di impostare gli andamenti ritmici. A questo punto il lettore è già entrato nel gioco delle sospensioni e dei rilassamenti, del ritmo accentuativo standard (giambico) e delle sue rotture, delle varie alternanze tra a majore e a minore. L’endecasillabo si è mostrato nelle sue tre facce (endecasillabo indivisibile, settenario e quinario) e nelle loro possibili combinazioni. La varietà metrica è stata esibita, ma anche il quadro in cui può essere comunque organizzata.
 Attilio Micheluzzi, Johnny Focus, dettaglio Le vacanze sono terminate, ma la mia testa non se ne è ancora accorta. Se non si sveglia finirò per essere un po’ latitante dal blog – tanto più che in questo periodo gli impegni si accumulano. Per questo colgo l’occasione che mi ha offerto qualche tempo fa Andrea Queirolo, di fare qualche riflessione sugli inchiostri di Attilio Micheluzzi, a partire da una tavola di sua proprietà, da cui è tratto il dettaglio che vedete qua sopra. Ovviamente per seguire il discorso consiglio di aprire l’immagine a piena risoluzione (che è piuttosto alta) in una diversa finestra. (la tavola nella sua interezza può invece essere vista qui)
Intanto, un’osservazione di massima: resto colpito da come queste belle immagini perdano di incisività quando le si guarda troppo nel dettaglio. Ovviamente questo non è in sé un difetto, perché non sono fatte per essere guardate tanto da vicino. Ci sono linee che appaiono troppo deboli rispetto ad altre vicine che sono invece forti, zone molto lavorate vicino a zone appena abbozzate, luoghi dove le linee sembrano intrecciarsi troppo, con effetti persino fastidiosi (come nel volto dell’uomo coi baffi della vignetta di sinistra). Nella vignetta di destra, lo sguardo della ragazza è certamente il punto maggiormente rilevante, e ingrandendo quella zona si può vedere quanto lavoro di pennello e biacca ci sia, su quegli occhi, che finiscono in questo modo per diventare una zona fortemente contrastata in mezzo al bianco piatto del volto di lei: focalizzazione narrativa e focalizzazione visiva che collaborano e si rinforzano a vicenda.
Questi inchiostri “trasandati” lasciano pensare che Micheluzzi voglia concentrare l’attenzione del lettore su altro. Questo altro potrebbe essere, per esempio, la composizione, che è notevole in entrambe le vignette e anche nel loro accostamento. La vignetta di sinistra, più concitata, mostra la grande diagonale bianca in primo piano in basso, a contrasto con l’altra struttura diagonale di fondo delle strisce bianche e nere della veneziana. A destra, nella medesima vignetta, i due personaggi si trovano in verticale, a dare presenza statica alla composizione, mentre a sinistra le tre teste formano a loro volta una diagonale dinamica, e il dinamismo implicito (perché di fatto nessuno dei personaggi si sta muovendo gran che) è assicurato dallo zigzag che parte dalla striscia bianca in basso, si inverte nel braccio della morta, ancora si inverte nel braccio dell’uomo a destra, e poi ancora dalla sua testa a quella dell’uomo coi baffi, e poi indietro alle due teste sul fondo: alla progressione dal basso verso l’alto corrisponde quella dal primo piano verso lo sfondo.
La vignetta di destra è più calma, e dominano le linee bianche e nere delle veneziane, ora diventate orizzontali, a contrasto con le figure verticali dei due personaggi. Ma anche qui – in misura minore – ci sono elementi dinamizzanti: le diagonali bianco-nere a sinistra, il braccio e il seno di lei, la posizione leggermente obliqua della testa e del corpo di lui, e soprattutto le linee bianche, nere e grigie della copertura del divano, che richiamano quelle del fondo contrapponendovisi come irregolarità a regolarità, dinamico a statico (senza contare che queste linee del divano sono la ripresa regolarizzata delle ombre e riflessi della giacca di lui; al tempo stesso lei è tutta pallini, boccoli e occhioni, forme di tipo circolare che la fanno emergere intensamente dal fondo, al quale lui invece appartiene molto di più – persino nel modo in cui sono tracciati gli occhi, non ellittici ma quasi lineari).
La grande diagonale bianca alla base della prima vignetta si ritrova rialzata nella parte sinistra della seconda. La composizione, è infatti, in Micheluzzi, una struttura dinamica, che incoraggia il passaggio rapido dell’occhio alla vignetta successiva. L’inchiostrazione “trasandata” sembra a questo punto assolvere la medesima funzione, impedendo all’occhio del lettore di fermarsi troppo a lungo sui dettagli molto curati, costringendolo a fluire. I tratti di pennello sono sufficientemente precisi per caratterizzare (e anche molto intensamente) i personaggi e le loro emozioni, ma al di là di questo diventano incerti, troppo rapidi, quasi confusi. Più che Raymond sembra di vedere i suoi epigoni (di valore) come Toth o Williamson, che sacrificano la precisione rappresentativa per l’effetto di fluidità. L’inchiostrazione che appare eseguita con rapidità invita a un’analoga rapidità di fruizione visiva.
In altre parole, gli inchiostri di Micheluzzi sembrano per l’appunto quelli di una testualità che chiede di essere letta assai più che guardata, ma letta proprio nella sua componente di immagine. Nel fumetto, di solito, si guarda l’immagine per leggerla, seguendo un filo discorsivo e narrativo predisposto dall’autore: poiché tuttavia guardare e leggere l’immagine non sono azioni davvero distinte, ma polarità di un medesimo comportamento visivo, troveremo fumetti le cui immagini sono più adatte ad essere staticamente guardate e altri che vogliono essere dinamicamente letti anche nelle loro figure. Enfatizzare l’aspetto del leggere (rispetto a quello del guardare) significa aumentare il coinvolgimento potenziale del lettore nella storia, cioè sottolineare attraverso la costruzione visiva la storia stessa e il suo procedere. Questo – mi sembra – è proprio ciò che fa Micheluzzi sia con le sue composizioni dinamiche che con i suoi inchiostri.
 Bianco, giallo e azzurro Finita l’estate, le vacanze, questa foto presa in un luogo che ne potrebbe essere, per molte persone, una sorta di simbolo.
A doverla commentare, mi vengono riflessioni simili a quelle della scorsa settimana. C’è tutta questa geometria, tutti questi piani giustapposti, queste prospettive sfuggenti e appena accennate, queste tinte da quadro astratto.
Eppure, più forte di tutto questo, c’è il senso di luce e di caldo, di bello, di cielo e magari di mare (anche se non si vede); comunque di sud, di Mediterraneo. La geometria diventa solo il tramite visivo della passione – per quanto strano questo accostamento possa apparire.
Sghignazzate con i galli
Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 1996
Tra i fumetti dall’umorismo travolgente – quelli che muovono al riso incontrollato e spasmodico persino il lettore solitario – ce n’è un gruppo con una caratteristica comune. Il cowboy Lucky Luke, l’indiano Oumpa Pah, il perfido Visir Iznogoud (leggere il nome ad alta voce per comprenderne il significato), il gallico Asterix hanno infatti tutti in comune un autore, il francese René Goscinny.
Purtroppo, il più geniale sceneggiatore umorista che il fumetto francese abbia avuto è scomparso nel 1977, quasi venti anni fa, ad appena 51 anni, lasciando un patrimonio di storie che avevano fatto epoca, e la direzione di un giornale, Pilote, su cui si erano formati i migliori autori della generazione successiva, da Gotlib a Fred alla Claire Bretecher. In Francia tante delle sue creazioni continuano a fare cassetta, ma all’estero almeno Lucky Luke e, soprattutto, Asterix, sembrano vivere un successo infinito.
Quest’anno, il piccolo gallo invincibile compie la bellezza di trentacinque anni, e appare davvero strano che, con tutta la sua freschezza e la sua immutata capacità di far ridere di cuore, tanti anni siano passati da quando per la prima volta, nel 1961, le sue storie vedevano la stampa. Goscinny aveva trentacinque anni allora, e già un passato glorioso: quest’anno ne compirebbe settanta.
Asterix inaugurava un modo di far ridere diverso, basato su un paradossale che faceva leva sulle piccolezze del quotidiano. Impossibile dimenticare, per esempio, le folgoranti parodie dei vari popoli europei (o dei loro stereotipi) che, storia dopo storia, si sono susseguite: dai Britanni che interrompono le battaglie per bere la loro tazzina di acqua calda (il tè non è ancora stato scoperto), agli Elvezi isterici per le pulizie, le casseforti e le fondute di formaggio – per non dire della puntualità delle clessidre (gli orologi, ahinoi, non essendo ancora stati inventati) al punto di svegliare con regolarità gli ospiti dell’albergo ogni ora affinché ciascuno possa girare la propria…
(E come dimenticare poi i vari tormentoni? Dai pirati, destinati ogni episodio a rimetterci una nave alla fame epocale di cinghiali di Obelix; dalla distruzione delle centurie romane all’imbavagliamento prudenziale del bardo. Si è trattato della creazione, episodio dopo episodio, di una serie di aspettative intratestuali, sulle modalità della cui soddisfazione si sono innestate poi le più esilaranti invenzioni umoristiche.)
Il cinema non ha fatto che consolidare un successo già enorme, con meriti assai minori di quelli delle storie originali, se pure il pubblico ricorderà soprattutto l’epopea di Asterix e Cleopatra, che certo principalmente nel cinema può fare evidentemente il verso al film con Liz Taylor. Campanilisti senza sciovinismo, i fumetti di Asterix ci mostrano, a noi italiani, una romanità risibile proprio per la sua grandezza – mai negata, ma soltanto contrapposta a una semplicità astuta e fiera della propria autonomia.
Due occasioni ci permettono di segnalare questo trentacinquennale, e il settantennio dalla nascita di Goscinny. Una è l’uscita dell’ennesimo volume della serie, passata interamente nella mani di Albert Uderzo, che ne era stato in precedenza solo il disegnatore. Il volume Asterix e la galera di Obelix, appena pubblicato per i tipi della Mondadori, aggiunge alcune spassose battute e situazioni alla lunga serie che già conoscevamo, confermando tuttavia una volta di più che la maestria di Uderzo come sceneggiatore non è pari a quella che ha sempre dimostrato come disegnatore.
L’altra occasione è una piccola mostra sul piccolo gallo ad Aosta, nella chiesa di San Lorenzo, aperta sino al 24 novembre, di cui abbiamo avuto gradita notizia.
Così Calvin ricomincia da zero
Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 1996
La notizia, di qualche mese fa, che Bill Watterson aveva smesso di disegnare Calvin & Hobbes, è di quelle che lasciano i lettori confusi e scontenti. Certo, come dargli torto, dal punto di vista personale? La vita di un autore di comic strip deve essere veramente uno stress: sei strisce originali più una storiella di una pagina ogni settimana. Per quanto originali si possa essere, e per quante variazioni permetta il tema, dopo dieci anni, tremilacentoventi strisce e cinquecentoventi pagine autoconclusive, si ha il diritto di essere stanchi del proprio personaggio – anche se ci ha portato fama e ricchezza!
E tuttavia l’abbandono di Watterson fa notizia. Calvin & Hobbes è nota come la striscia più originale che parli di bambini dopo i Peanuts di Charles M. Schulz, e Schulz continua a disegnare Snoopy e Charlie Brown da oltre quarant’anni. Ma Watterson non è il primo ad abbandonare: si inserisce in una tendenza di cui fanno parte anche altri autori della sua generazione, come Garry Trudeau (autore di Bloom County e del pinguino Opus) e Gary Larson. La tendenza preoccupa: nel giro di pochi anni hanno abbandonato il campo una larga maggioranza proprio di quei disegnatori di comic strip e vignette che si erano meritati il successo per innovatività e arguzia. E la motivazione è comune a tutti: “sono stanco”.
Mentre, con rammarico, ci rassegnamo a non poter più leggere strisce nuove di Calvin & Hobbes (così come era accaduto con quelle di Bloom County, e con le vignette di The Far Side) gli editori provvedono tempestivamente a consolarci. La rivista Linus, su cui la striscia di Watterson è pubblicata quasi da quando è nata, non ne ha interrotto l’uscita neppure per un mese, passando direttamente dalle strisce del 1996 alla riproposizione di quelle del 1986. E queste medesime strisce iniziali ci vengono proposte anche in volume dalla casa editrice Comix.
Scopriamo così che, al di là di qualche incertezza nel disegno – che scompare comunque molto rapidamente – il mondo umoristico di Watterson è completo ed esilarante sin dal primissimo inizio. Il rapporto tra il bimbo Calvin e il suo tigrotto di pezza Hobbes è già quello che, negli anni successivi, si svilupperà in innumerevoli variazioni. Hobbes è il vivissimo compagno di giochi e di malestri del bimbo (con un pizzico di ragionevolezza in più del suo padrone), salvo quando viene visto dagli occhi degli adulti, i quali lo vedono per quello che è, un inerte pupazzo. Calvin è il bambino che vede il mondo attraverso la lente deformante della propria dilagante fantasia, facendo disperare i genitori che ovviamente non capiscono mai che “un tirannosauro non può mangiare gli spinaci”, o che la camera da letto, di notte, è piena di terribili mostri.
Per chi non lo conosce, Calvin & Hobbes non è una comic strip per bambini, pure se – e con un certo successo – è stata proposta anche su riviste per l’infanzia. E’ semmai, una striscia che riflette (mi si perdoni il termine, e la sua – in questo contesto – un po’ grottesca seriosità) sulla capacità di interpretare il mondo con fantasia, e sul rapporto degli adulti con l’immaginario dei bambini. Non escludo che se ne possa fare anche un proficuo uso pedagogico: ma non sarebbero i bambini i destinatari di questo uso.
Bill Watterson, Calvin & Hobbes, Comix, Modena
128 pp. £.19.000
Un topo cattivo aiuta Telefono Azzurro
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 1996
Quando un tema è così drammatico e intenso come la violenza sui minori, è fin troppo facile cadere nell’eccesso e nella retorica dei buoni sentimenti e del rispetto. E’ facile scambiare moralità e moralismo, e credere che una qualsiasi storia di condanna possa essere una buona storia. Il tema, trattato da autori mediocri, diventa facilmente un tema “di tendenza” come tanti altri, e la condanna morale, affidata ad un testo noioso, appare come l’ennesima ripetizione di un copione ribadito ossessivamente dai media.
Non che se ne parli troppo, certo: di violenza ai minori non si parlerà mai abbastanza. Il fatto è che, per quanto importante e tragico sia, qualsiasi problema, qualsiasi dramma troppo ripetuto ci rende ciechi e sordi nei suoi confronti, a meno che il modo in cui ci viene presentato non sia in grado di risvegliare il nostro interesse. Per quanto cinico questo possa apparire, il mondo delle comunicazioni di massa funziona così.
La pubblicazione in italiano de “La storia del topo cattivo” di Bryan Talbot è per questo una molteplice occasione di interesse. E’ una storia sull’adolescenza e sul riscatto dalla violenza subita, affrontata con delicatezza e originalità; è una storia che varrebbe la pena di leggere anche se il suo tema non fosse quello che è; ed è una storia a fumetti, che segna il ritorno di un grande autore inglese a temi più specificamente suoi – dopo anni di, pur spesso notevolissime, produzioni seriali americane.
Di Bryan Talbot abbiamo parlato ancora, nel 1993, quando uscì in italiano Luther Arkwright, prototipo di un’avanguardia fumettistica britannica (l’originale inglese è dei primi anni Ottanta) con poco da invidiare alle avanguardie letterarie o artistiche. La storia del topo cattivo, invece, non ha nulla di avanguardistico: è una storia scritta e disegnata per essere letta anche da persone non abituate a frequentare i fumetti. Vi si racconta di una ragazza fuggita di casa, dopo anni di abusi sessuali da parte del padre, alla ricerca di qualcosa che nemmeno lei sa; o alla ricerca della forza, della consapevolezza per affrontare la situazione, e risolvere il nodo pauroso, l’angoscia e il senso di diversità e di colpa che le impediscono di vivere.
Il suo nome è Helen Potter, e la coincidenza con il nome di Helen Beatrix Potter è il secondo motore della storia. Helen vive la propria storia attraverso l’immaginario della sua più famosa omonima, copiandone i disegni e il senso ambiguamente tenero e tragico della vita. Troverà una via d’uscita dal suo dramma proprio attraverso i simboli dei personaggi della Potter. Troverà la forza di affrontare il padre quando, in qualche modo, si sarà ricongiunta con i simboli della propria infanzia.
Anche il disegno è un oggetto interessante, in questo “Topo cattivo”. Nessun virtuosismo, nessuna fuoriuscita da un realismo narrativo dall’apparenza semplice, elementare. Eppure un disegno del tutto fuori tendenza, di estrema efficacia persino quando i personaggi rappresentati ricordano in qualche modo (sempre discreto) gli animaletti della Potter. Il dramma della ragazza ne esce descritto con intensità, senza che mai si abbia l’impressione che l’immagine voglia impadronirsi di quello che la storia ci dice.
Pubblicato con il patrocinio del Telefono Azzurro (cui è destinata una parte dei ricavi delle vendite) “La storia del topo cattivo” è una miniserie di quattro albi, in vendita nelle edicole e nei negozi specializzati.
Bryan Talbot, La storia del topo cattivo, Phoenix, Bologna
Ritrovate Alack Sinner
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 1996
Per circa un decennio, dalla metà degli anni Settanta alla metà degli Ottanta, il fumetto italiano ha vissuto una stagione magica, per creatività degli autori e attenzione del pubblico. In quegli anni il racconto a fumetti è diventato in Italia un prodotto adulto e raffinato, spesso libero di esprimere al meglio una vocazione espressionista ed intimista, un tentativo di raccontare quello che a fumetti non si era mai raccontato.
All’origine di questa fioritura sta, con particolare rilievo ed enorme rispetto da parte di tutti gli autori che ne hanno seguito le tracce, una coppia di autori argentini, allora esuli politici, venuti a pubblicare sulle nostre riviste – invertendo una tradizione che vedeva gli autori italiani emigrare a Buenos Aires, con Hugo Pratt tra i tanti. Si tratta di José Muñoz e Carlos Sampayo, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore di una serie iniziata nel 1975, e intitolata Alack Sinner.
Benché si trattasse di una serie poliziesca di ispirazione chandleriana, sin dall’inizio Alack Sinner aveva colpito più per l’intensità emotiva, caricata magistralmente dal segno difficile di Muñoz, che non per l’intricatezza degli enigmi. Nel giro di qualche anno dei temi classici della detective story in Alack Sinner restava sempre meno, e una dopo l’altra le storie diventavano vicende di umanità, amicizia e disperazione metropolitana. Il nome del protagonista (che, in inglese suona come: io, povero peccatore) corrispondeva sempre di più al programma narrativo che veniva svolto.
Con la storia Trovare e ritrovare, del 1981, l’introverso, difficile Alack lascia la professione di investigatore. Per la prima volta non c’è nemmeno più la falsariga della detective story a condurre la trama. La vicenda di questo lungo racconto procede per episodi: Alack va a trovare il padre, che non vede da lungo tempo, e con cui non ha molto da dire, incrocia la sua indifferenza con la fama di Frank Sinatra, e gli eventi lo portano a reintrecciare la sua vita con quella di Enfer, una donna di colore con cui aveva avuto tempo prima una relazione. Sarà la notizia di aver avuto con lei una figlia a scuoterlo dalla propria melanconia, proprio mentre un poliziotto ubriaco cerca di ammazzarlo per antichi rancori e Sinner è costretto a difendersi, finendo in galera per omicidio.
La vicenda ha un finale problematico ma positivo. L’ex detective recupera un senso alla propria esistenza, anche attraverso le storie che apprende dai compagni di cella nel periodo in cui si trova in prigione. La paternità non si annuncia facile, ma è un occasione per non ripetere il rapporto da lui avuto con il proprio padre.
Il segno di Muñoz è tagliente, impietoso. Riempie i volti dei personaggi di segni di vita vissuta, oppure li lascia spogli, come maschere senza sentimento. I bianchi e neri netti, senza tinte intermedie disegnano spesso figure grottesche, violentemente caricaturali. E Sampayo racconta la storia di Sinner facendola attraversare da mille altre storie, così che la New York che ne esce appare davvero come un intrecciarsi di vite.
Dopo quindici anni dalla sua pubblicazione su rivista, questo testo cruciale, tanto amato da una generazione di autori e lettori di fumetti, esce finalmente in volume. Lo si rilegge con la stessa emozione di allora, con, in più, come l’impressione di ritrovare un vecchio e caro amico.
José Muñoz, Carlos Sampayo, Alack Sinner. Trovare e ritrovare, Milano, Hazard Edizioni
pp. 118, £. ***
Mano
Inedito per Il Sole 24 Ore, scritto il 18 marzo 1996
E’ un percorso di rigore quello che porta Maria Giovanna Anceschi e Stefano Ricci a creare Mano, fumetti scritti disegni, una rivista il cui primo numero è apparso da poco in libreria, e che contiamo di ritrovarvi ogni quattro mesi. Risalendo all’indietro in questo percorso potremmo reincontrare il lavoro di Ricci come illustratore, dotato di un segno difficile, ma davvero di rara profondità, creatore di immagini che richiedono una lettura attenta e ricompensano il loro lettore con intuizioni inquiete, echi e suggestioni che appaiono espresse e trattenute al tempo stesso.
Più di recente incontriamo un lavoro comune di promozione culturale, il caso singolare di una serigrafia che diviene al tempo stesso galleria, e dove le opere si trovano esposte nelle stesse sale dove si compie il lavoro di stampa. E’ la galleria Squadro di Bologna, dove si producono e si espongono le cartelle di serigrafie curate dalla Anceschi con la grafica di Ricci. Gli autori di queste serigrafie sono pittori, illustratori, fumettisti. Magnus, il grande disegnatore bolognese recentemente scomparso, è l’autore dell’ultima cartella prodotta. Seguirà Lorenzo Mattotti.
Con la stessa cura tenace, quasi ossessiva, con cui si realizzano le serigrafie, prova dopo prova, effetto materico dopo effetto materico, è stato realizzato questo primo numero di Mano. Il nome stesso è un programma, una dichiarazione di intenti a favore di una visione unitaria della comunicazione verbale e per immagini. La stessa mano scrive e disegna, produce significanti verbali e significanti visivi con la stessa leggerezza o con la stessa profondità. E’ ovvio che al centro di un programma di questo genere non può che esserci il fumetto, linguaggio verbo-visivo per eccellenza. Ma non è meno ovvio che letteratura e poesia, cinema, disegno e pittura siano i suoi compagni di strada inevitabili.
Contro l’analfabetismo dell’immagine, si potrebbe dire. Contro, cioè, l’abitudine di assorbire le immagini senza comprenderle, oscillando tra il voyeurismo della pubblicità e il feticismo dell’arte. Contro l’atteggiamento secondo cui la riflessione passa solo attraverso la parola, e l’immagine ne è, al più, un superfluo abbellimento.
Mano inizia con alcune rivisitazioni: vi sono Alfred Kubin e Diane Arbus che raccontano episodi cruciali della loro iniziazione all’immagine; e vi è un dialogo intrecciato tra Artaud e Balthus, del quale vengono presentati anche una serie di disegni per Cime Tempestose di Emily Brontë. Vi sono poi i disegni di Joseph Beuys e di Igort, cui fa seguito una nutrita sezione di fumetti per palati dal gusto educato: gli autori sono Jacques Faton e Philippe de Pierpont, Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky, Gabriella Giandelli e Lilia Ambrosi, Francesca Ghermandi e Massimo Semerano, Stefano Ricci, Onze e Francesca Astori. Conclude la sezione un giovane autore serbo, Aleksandar Zograf.
Il discorso prosegue abbordando il cinema e il suo rapporto con lo story-board, ovvero la versione disegnata della sceneggiatura. Ne parlano Thierry Groensteen, Terry Gilliam e Peter Greenaway. In fondo, ancora a cavallo tra la verbalità e la visività, Gianluigi Toccafondo, Ben Shahn, Alastair Reid e un sarcastico recupero di Osip Mandel’stam percorrono un evocato universo infantile.
Rivista di fumetti né più e né meno che d’altro, ma soprattutto rivista di cultura dell’immagine, nata in un momento difficilissimo per il fumetto italiano, Mano porta la propria proposta in libreria. Se vogliamo vedere la contrapposizione tra libreria ed edicola come una tra il duraturo e l’effimero (almeno in termini di memoria storica), la scelta di campo dei suoi ideatori è evidente. Da parte nostra, l’augurio di tutto cuore è che la rivista possa essere veramente duratura, e non soltanto come memoria.
 Il triangolo rosso Di questa foto, scattata proprio qui, mi piacciono certamente la composizione geometrica e quella cromatica. Ma ciò che davvero mi turba è quel triangolo rosso sotto l’arco, verso destra, a cui non sono capace di dare un senso reale.
Non ricordo che cosa ci fosse lì, e non capisco che cosa ci possa essere, di quel colore, in quel punto. Resta, ai miei occhi, come il triangolo di una composizione suprematista, piovuto quasi arbitrariamente in mezzo alle case. Eppure, d’altra parte, non smette neppure del tutto di avere un senso reale: magari c’è, lì, un pezzo di muro rosso illuminato, oppure è un pezzo di un’insegna rossa visto di sbieco.
In questa tensione irrisolta si condensa il senso dell’immagine nel suo insieme: è una foto, e quindi testimonia qualcosa che è stato davvero così; ma è anche, insieme, una composizione geometrica, e quindi rimanda a un universo visivo puramente umano, intellettuale e finzionale.
Chissà perché, a me queste cose danno moltissimo gusto. È come quando scopri la continuità dove prima vedevi solo rottura. E tutto acquista di colpo un sacco di altri sensi.
I nuovi supereroi umani, troppo umani
Il Sole 24 Ore, 17 marzo 1996
Nell’anno del centenario del fumetto, Treviso Comics ha dedicato la sua Rassegna Internazionale del Fumetto e delle Comunicazioni Visive a un tema tra i più fortunati della storia del racconto per immagini: il supereroe. Vi sono dunque Superman, Batman, l’Uomo Ragno e Capitan America, ma non solo loro; e il fumetto di supereroi non è soltanto quello che normalmente si crede.
Intanto, dalla metà degli anni Ottanta in poi il fumetto americano di supereroi ha visto nascere al suo interno un fronte critico che ne ha modificato sostanzialmente l’impostazione complessiva, permettendo e spesso favorendo la nascita di testi di alta qualità. In questo genere di fumetti, spesso la tematica del superomismo è diventata un pretesto per parlare dei miti e della società americana – o del superomismo stesso, in quanto a sua volta mito americano. Non di rado dunque la qualità sia narrativa che grafica dei fumetti di supereroi ha raggiunto in questi anni livelli di grande interesse, documentati con una notevole scelta di esempi in due belle mostre di tavole originali nella manifestazione trevisana. Autori come John Bolton, Kent Williams, Stuart Immonen e Dave Mc Kean possono testimoniare il grado di maturità degli artisti che si misurano oggi con questa materia.
Ma il tema ha geminato. Visto il successo che questo genere di fumetti riscuote in Italia, c’è chi ha pensato che si poteva tentare la carta dei supereroi made in Italy, riprendendo il tema ma ammorbidendolo e approfondendolo con caratteristiche un po’ più “europee”. Protagonista di una mostra sui supereroi italiani – personaggi dalla vita assai più tormentata e difficile di quella dei cugini di oltreoceano – è la casa editrice Phoenix, che negli ultimi anni ha puntato molto sulla creazione di un universo superomistico autonomo, ottenendo una serie di interessanti risultati con personaggi come Examen, Sebastian o Team Adriatica, e con la ripresa di Ramarro, l’anti-supereroe inventato da Giuseppe Palumbo per Frigidaire già negli anni Ottanta. L’ambiente in cui questi personaggi si muovono è un’Italia del ventiduesimo secolo, ricca di conflitti e di angosce metropolitane. Conflitti che, nella migliore tradizione dei supereroi di questi ultimi anni, dilaniano anche la psicologia dei protagonisti: vi è l’eroe che fatica ad accettare il proprio superiore potere, e quello combattuto per un’omosessualità in singolare contrasto con il proprio stile di vita; vi è la squadra di giovanissimi in fuga, che non accettano il sacrificio cui è stato costetto il loro corpo per innestarvi i poteri, e vi è la squadra governativa, ricca di personaggi contrastanti, da quello ligio a un dovere a cui non ci si può sottrarre all’altro per cui sterminare o sedare è un piacere.
Tra le produzioni italiane non Phoenix si distingue invece Gabriel, di Riccardo Secchi, pubblicato da MBP, dove il supereroe è nientemeno che una giovane suora, che, nella migliore tradizione delle investiture di superpoteri, è rimasta vittima di un incidente con un apparato sperimentale, ed è in grado, da quel momento, di volare e di proiettare grandi quantità di energia dalle mani. E’ un fumetto ben sceneggiato e discretamente disegnato, anche se un po’ succube di molte storie americane degli ultimi anni.
Singolare, ma stimolante, è l’accostamento con la versione Disney del superomismo, non tanto con Superpippo (del quale nella mostra “I supereroi Disney” si sentiva un poco la mancanza) quanto con Paperinik, parodia paperinica (di origine italiana) dei giustizieri mascherati. Di Paperinik è stata presentata, tra l’altro, l’imminente versione rinnovata: sta per uscire infatti un albo mensile, formato comic book, che si chiamerà PK, e narrerà le imprese di Paperinik in uno strano mondo di alieni, con un segno davvero inconsueto per la Disney, una sorta di parodia del barocchismo grafico dei principali fumetti americani.
La giornata centrale della manifestazione è stata sabato 9 marzo, e si è conclusa con la premiazione dei volumi a fumetti migliori usciti nel corso del 1995. Per il genere realistico il volume più votato è stato Sogni a occhi aperti, che abbiamo già presentato su queste pagine (9.7.1995), a cura di Daniele Brolli, Michele Canosa e Franca Di Valerio, un omaggio collettivo all’amore dei surrealisti per il cinema. Per il genere comico-umoristico è stato invece premiato il divertente volume di Giorgio Cavazzano Capitan Rogers e il calumet della guerra.
Nell’anno del centenario del fumetto non è tuttavia solo un festival così amato dagli addetti ai lavori come quello di Treviso a far parlare di sé. Imminente è infatti l’apertura di una grande mostra celebrativa a Ferrara, che si propone di presentare una grande e dettagliata panoramica dei dieci decenni che sono stati attraversati da questa forma espressiva. Gulp! 100 anni a fumetti aprirà i battenti nella sede del Castello Estense il 3 aprile, per rimanere a disposizione del pubblico sino al 30 giugno.
La mostra sarà divisa in dieci sezioni, corrispondenti ai decenni del secolo, e mostrerà originali e copie d’epoca, accompagnati da una nutrita documentazione, con evidenti scopi al tempo stesso spettacolari e didattici. L’organizzazione è di Ferrara Arte, cioè del Comune e della Provincia di Ferrara. Sul catalogo sono previsti interventi di Abruzzese, Brancato, Calabrese, Caprettini, Castelli, Frezza e Pignatone. Un’apposita Guida per Ragazzi sarà realizzata da Silver, e sarà Lupo Alberto a condurre il discorso per i giovanissimi.
|
Post recenti
-
Babel, Connessioni: due antologie
-
No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?
-
La spigolatrice callipigia
-
La disalterità di Lella De Marchi
-
Lo scrutare nel buio di Laura Liberale
-
Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni
-
Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti
-
Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet
-
Dopo Mafalda
-
Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)
-
Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale
-
Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti
-
Storie di polli e di donne sedute
-
La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)
-
Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere
-
Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)
-
Scrivono di me, su Bologna in Lettere
-
Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare
-
Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito
-
Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria
|
Some Books of Mine ------------------
 ------------------
 ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog











|










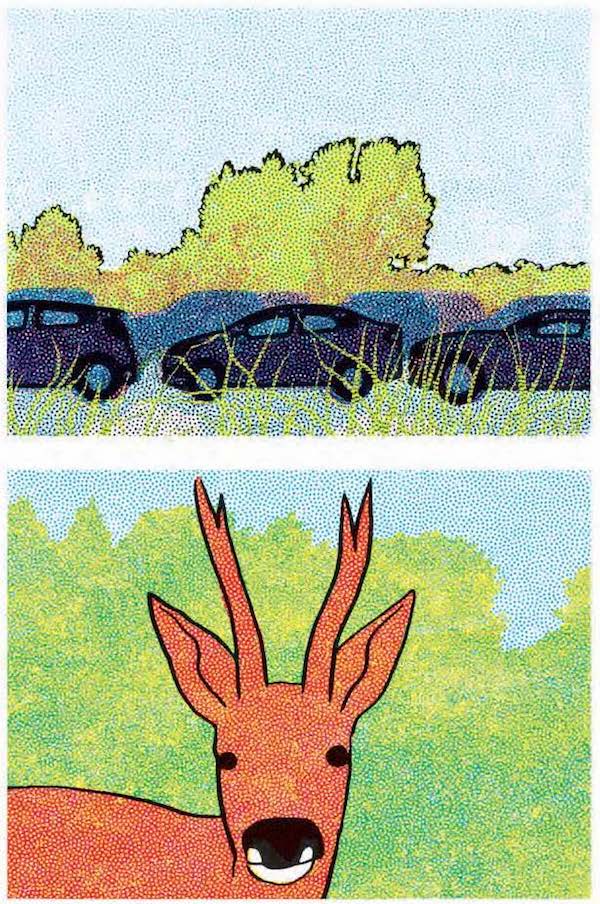
 Feed dei post
Feed dei post Feed dei commenti
Feed dei commenti Ricevi i post per Email
Ricevi i post per Email





























 Lo spazio bianco
Lo spazio bianco







Commenti recenti